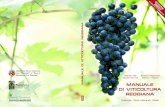INDICE - italiadelvino.com viticoltura camuna... · LA VITICOLTURA DELLA VALCAMONICA NEL BASSO...
Transcript of INDICE - italiadelvino.com viticoltura camuna... · LA VITICOLTURA DELLA VALCAMONICA NEL BASSO...

INDICE
NATURA E SCOPI DELLA RICERCA pag. 2
INTRODUZIONE pag. 3
LA VITICOLTURA DELLA VALCAMONICA NEL BASSO MEDIOEVO pag. 6
IL CINQUECENTO pag.12
IL SEICENTO pag.16
IL SETTECENTO pag.18
pag.21L’ OTTOCENTO Sistema di conduzione delle aziende dell’ottocento:
La mezzadria pag.26
VITICOLTURA CAMUNA DALL’INIZIO DEL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI pag.29
Ipotesi di sviluppo della viticoltura effettuata negli anni novanta pag.45
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DAGLI ANNISETTANTA AD OGGI pag.51
Varietà e portinnesti pag.52Forme d’allevamento pag.53
OPERAZIONI COLTURALI pag.58
IL RILANCIO DELLA VITICOLTURA IN VALLECAMONICA pag.61Proposta di riconoscimento della I.G.T dei vini Valcamonica pag.64
VINI PRODOTTI IN VALCAMONICA pag.69

NATURA E SCOPI DELLA RICERCA.
La presente ricerca intende percorrere la storia della viticoltura camuna dal
basso medioevo ai giorni nostri, con l’obbiettivo di dimostrare come una
coltura da sempre considerata marginale, possa essere una valida alternativa
ai comparti agricoli “storici” rappresentati dalla selvicoltura, dai prati e dai
pascoli.
La viticoltura, nonostante sia una tradizione secolare in Valcamonica, ha
subito nel passato più recente profonde trasformazioni, con una riduzione
delle superfici vitate, un generale abbandono della pratica di coltivazione e
dei territori con il successivo ed inevitabile degrado ambientale.
Nel futuro il comparto vitivinicolo per sopravvivere dovrà specializzarsi il più
possibile, ciò richiederà investimenti considerevoli, i cui benefici andranno a
favore non solo degli agricoltori ma di tutta la comunità; non bisogna infatti
dimenticare che il ruolo fondamentale dell’agricoltura di montagna non è solo
quello produttivo ma anche di conservazione del suolo, del paesaggio e
dell’ambiente ecologico.
Lo sviluppo della viticoltura in questa valle permetterà: il recupero e il
mantenimento dei versanti con miglioramento dell’ambiente rurale e
prevenzione del dissesti idrogeologici e degli incendi.
La possibilità di un concreto ritorno all’agricoltura di nuovi addetti
provenienti da settori diversi (industria, terziario) che hanno abbandonato o
ridotto la coltivazione della vite negli ultimi decenni.
2

La possibilità di abbinare ai prodotti agroalimentari un vino prodotto in
Valcamonica che riporterà sulle tavole il gusto inconfondibile di un prodotto
nato dalla terra degli antichi camuni.
INTRODUZIONE
Prima di esaminare la coltura della vite in valle, è doveroso soffermarsi
brevemente sulle caratteristiche della Valcamonica, per comprendere come la
coltivazione della vite abbia sempre rivestito un ruolo marginale
nell’economia dell’agricoltura valligiana.
Le cause di questa marginalità possono essere imputate in particolar modo al
clima, all’orografia ed al tipo di flora, come già riportato in uno scritto
dell’inizio del secolo XX.
“Chi attraversa il lago d’Iseo vede sullo sfondo, verso nord, tra Lovere e
Pisogne, un’ampia insenatura sbarrata da colli e da cupe foreste, dietro di cui
s’innalza una paurosa catena di montagne ardue e ghiacciate: quella è la
Valcamonica.”
La Valcamonica è racchiusa dalle due catene di monti che scendono dal
picco dei Tre Signori ed ha per confine: a nord-nord-ovest la Valtellina ed i
monti della Valle di Scalve (Bergamo); a nord-nord-est il Trentino; ad ovest
la Valle di Scalve; ad est il Trentino e le valli bresciane Sabbia e Trompia; a
sud il lago d’Iseo, con una lunghezza di circa 81 km ed una superficie di circa
1301 kmq.
La sua speciale configurazione orografica la divide in tre bacini: il primo va
da Pisogne a Cividate e comprende la parte più piana, fertile con clima mite;
il secondo va da Cividate a Edolo ed è più angusto, meno fertile, più aspro; il
terzo si estende da Edolo a Ponte di Legno ed è il più freddo, con coltivazione
ridotta a pochi cereali e dove è maggiormente sviluppata la pastorizia.
3

Il territorio camuno comprende, tra il fondo della valle e le cime più alte,
quasi tutte le zone vegetative individuate dai botanici e cioè: la zona di
collina (da 100 a 600 m), zona montana (da 600 a 1500 m), zona subalpina
(da 1500 a 2500m) e zona alpina (da 2500 a 3500 m). Secondo le varie
stagioni, poi, entro tali zone, le piante sono raggruppate in varie
“associazioni” d’aspetto e composizione diversa. Infatti dove il terreno è
piano prevale la coltura dei cereali, come granoturco e frumento, mentre
nelle parti più elevate della valle troviamo segale, orzo, grano saraceno.
Viceversa lungo i pendii dei colli, resi più agibili alla coltura mediante
terrazzamenti stretti, sostenuti da muriccioli a secco, domina la coltivazione
della vite: ottime qualità di vini sono fornite soprattutto dalle vigne di
Erbanno, Malegno e Losine.
Il terreno agrario rispetto alla sua origine può essere classificato in:
Terreno di trasporto dai fiumi e torrenti: originato dall’azione dell’Oglio,
costituisce e presenta, per quanto riguarda la composizione fisica e
mineralogica, caratteri diversi secondo il punto del corso del fiume, e secondo
le rocce che principalmente contribuiscono a costituire il materiale trasportato.
Terreni di trasporto dei ghiacciai: presenti in gran parte sulle sponde della
Valle e nelle vallette laterali, si mostrano in tutti i meandri dove l’antica
forma della roccia ha trattenuto il materiale trasportato dal ghiacciaio.
Si riconoscono facilmente per la forma e per la natura mineralogica dei massi
che vi si trovano, spesso assolutamente diverse da quelle delle rocce che
costituiscono il bacino locale.
Terreni in posto: situati nelle parti più alte di tutte le montagne camune,
rappresentano quel tanto del prodotto di disfacimento della roccia sottostante
che la forza di gravità, l’acqua e il vento non trascinano in basso.
4

Il clima è quello tipico semicontinentale che rappresenta la zona transitoria tra
il dominio dell’olivo (clima mediterraneo) e quello delle steppe e praterie
(clima continentale), tuttavia, a causa della particolare orografia della
Valcamonica, si verificano condizioni climatiche variabili da zona a zona.
Infatti, l’influenza mitigatrice del lago d’Iseo, anche se si fa sentire in tutta la
valle, è prevalente nella zona a sud di Breno mentre là dove si esaurisce il
benefico effetto del lago, il clima diventa sempre più di tipo montano fino ad
arrivare al tipo alpino alle quote più elevate. Le escursioni termiche, in
Valcamonica, sono normali però, in alcune zone, la presenza dei venti
dominanti può provocare sbalzi piuttosto elevati. Riguardo ai venti, occorre
precisare che esiste un vento dominante periodico che spira da NNE-SSO, di
mattino dal lago d’Iseo verso Edolo, e di pomeriggio in senso opposto. Altro
vento che si ha in valle è il Favonio, che scende dalla Alpi ed è tipico di tutte
le vallate alpine.
Secondo i dati pluviometrici forniti dalle quattro stazioni della Valcamonica
(Breno, Annunciata, Sacca ed Angolo Terme), le piogge raggiungono in
media i 1250 mm annui con le punte maggiori in primavera (400 mm) ed in
estate (350 mm).
5

LA VITICOLTURA DELLA VALCAMONICA NEL BASSO MEDIOEVO
Da antiche pubblicazioni si ha notizia che in Lombardia la viticoltura era già
presente in età romanica ma è soprattutto nel periodo del basso medioevo che
s’iniziano a gettare le basi di quella che sarà la coltura moderna altamente
specializzata che noi oggi conosciamo.
Nel X e XI secolo la coltivazione della vite era prevalentemente attuata vicino
alle città, lungo il corso del Po, nelle basse pianure e nelle terre pesanti delle
aree paludose. Tutto questo sta ad indicare che la coltivazione della vite non
era specializzata ma che veniva effettuata un po’ in tutte le zone senza tenere
conto della loro vocazione. Infatti la vigna si piantava dove la richiesta era più
forte ed era più facile il trasporto e non dove le condizioni pedologiche erano
più favorevoli. Un’altra causa dell’inurbamento di questa coltura era dovuta
all’instabilità politica del tempo ed alla minaccia di distruzione delle colture
rappresentata dalle bande armate.
Anche nel caso di Bergamo e Brescia la presenza della vite era tipicamente
antropica e legata allo sviluppo urbano ma, a differenza del resto della
Lombardia, la vite si coltivava in aree pedologicamente favorevoli,
determinando, in tempi assai precoci, una produzione differenziata e d’alta
qualità. Nei secoli undicesimo e tredicesimo la ripresa della viticoltura è
coincisa con un notevole sviluppo economico.
Intorno al secolo undicesimo infatti, passato il pericolo delle invasioni
barbariche e in concomitanza con i moti comunali, anche intorno a si assiste
ad un nuovo fervore d’opere agricole e all’estendersi delle terre coltivate,
6

poiché vengono concessi, sempre di più, terreni “ ad runcandum” e “ad
pastinandum” cioè da dissodare e piantare.
È probabilmente nell’epoca comunale che viene introdotto l’uso dei
terrazzamenti nella sistemazione dei terreni collinari, facendo assumere ad
essi l’aspetto che ancora oggi hanno. I dissodamenti, avviati lentamente fra il
X e l’XI secolo, che diventarono sistematici fra il XII e i primi decenni del
XIV secolo, erano finalizzati esclusivamente all’impianto di nuovi vigneti
specializzati nella forma caratteristica della clausura o della braida chiusa
artificialmente (porzioni di vigneto racchiuse da muri a secco o alte siepi).
E’ quindi in questo contesto che si sviluppa la viticoltura camuna come viene
indicato in alcuni scritti di quell’epoca. Documenti relativi a questo periodo,
infatti, ci indicano come già alcuni vigneti in Valcamonica rientravano nel
patrimonio di S.Pietro in Monte; inoltre notizie sulla presenza di vigneti ad
Artogne, Lozio e Berzo risalgono al giugno del 1041, mentre per Pisogne si
deve arrivare al settembre del 1045. Questi dati vengono confermati anche
dalle carte dei secoli seguenti relativi ai possedimenti della Mensa Vescovile
di Brescia la quale riscuoteva numerosi canoni in vino.
La conferma che la vite era presente in Valcamonica già nel 1100 viene dalla
notizia della distruzione a Borno di oltre quattordici torchi, bruciati in seguito
ad un’incursione degli abitanti della Val di Scalve. Questo evento starebbe
anche ad indicare che la vite cominciava ad assumere una certa importanza in
un’economia agricola precaria come quella della Valcamonica. Altra
testimonianza della presenza nel secolo X di terreni vitati in Valcamonica ci
viene da un privilegio di Papa Callisto del 1123, in cui venivano confermati
all’abate Pietro tutti i possedimenti del cenobio che comprendevano quattro
petias vinearum nel pievato di Cividate. Tuttavia, se nel XII secolo la
viticoltura in questa valle rimaneva una realtà marginale, la maggiore
ampiezza della valle, la migliore esposizione dei pendii all’ azione del sole, il
7

clima temperato e la disponibilità di più ampie zone alluvionali pianeggianti
coltivabili, consentivano buone rese e discreti livelli qualitativi alle vigne
collocate nei siti più adatti.Principali zone viticole del territorio Bresciano
durante il XII secolo
8

Nelle quattro corti di Edolo, Cemmo, Cividate e Pisogne la messa a coltura
della vite rispondeva essenzialmente ai bisogni alimentari del posto e le viti
venivano collocate vicino alla pieve, al castello o nelle clausure (vigne
9

protette da siepi o muri a secco) realizzate ai margini del borgo in condizioni
privilegiate, tanto da consentire all’episcopato di riscuotere i canoni
direttamente in vino. Tali entrate venivano consegnate dai coltivatori presso la
cantina signorile posta all’interno della corte, dove i vini potevano essere
conservati e dove esistevano anche strutture per la vinificazione. Infatti nel
castello di Mu era presente la cantina in cui venivano sistemati i fitti del
vescovo. Facevano, inoltre, parte delle prerogative signorili della corte di
Edolo la raffia alla vendemmia, che consisteva nella raccolta dei tralci di
potatura e nella loro consegna alla curia, la riscossione della “decima vini” e
la consegna, da parte di qualunque abitante della corte che lavorava la vigna,
di una certa quantità di vino. Infatti in un inventario della curia di Cemmo si
trova una rubrica dedicata ai “fitti del vino” dove si apprende che nel 1299
erano stati riscossi dalla corte 40 cogi e mezzo di vino. La maggioranza dei
vigneti era posta in una località soleggiata denominata”via cava”, ma
frequenti erano anche le vigne sistemate accanto alle case, come è ad esempio
quella di Giacomo di Bonfato o quella di Belasetia Girioli che erano coltivate
nell’orto accanto alla loro casa .
Procedendo in direzione del lago d’Iseo, si trova inoltre la curia di Cividate,
caratterizzata dalla presenza di numerosi ronchi (terrazzamenti sostenuti da
muri a secco) in buona parte occupati da porzioni di vigneto. La pieve di
Cividate possedeva un brolo di cento tavole cui non mancavano filari di
pergole vitate e la stessa cosa si può dire per la breda dominicale, frazionata
in lotti contigui e data in fitto.
Per quanto riguarda le colture praticate nei terreni del vescovo nella corte di
Cividate, alcuni calcoli hanno portato a valori cosi riassumibili.
Tab. 1 COLTURE PRATICATE SUI TERRENI VESCOVILI DI CIVIDATE
10

DESTINAZIONE
COLTURALE
SUPERFICE IN MQ %
Coltivo 285.222 87Vigneto 34.275 11Brolo 4.232 1Prato 3.450 1Totale 327.179 100
Le cifre devono essere intese come indicative, dal momento che, per alcuni
fondi, nel documento si dà una descrizione complessiva; perciò non è
possibile stabilire esattamente per questi casi quanta parte sia effettivamente
coltivata a vigneto e quanta lasciata a prato.
L’approssimazione è comunque contenuta in pochi punti percentuali.
La coltura viticola, come emerge dalla documentazione della Mensa nella
curia di Pisogne non sembra più diffusa che a Cividate, anche se le condizioni
climatiche più miti, dovute all’influenza del lago d’Iseo e confermate dalla
presenza dell’olivo, potrebbero far pensare ad una situazione più favorevole.
Accanto alla consueta vigna o pergolato domestico, più o meno ampio, la vite
si trovava associata ad alcune colture arboree (castagno), al prato oppure in
coltura pura nel “ Vinetum”, zona del posto particolarmente vocata per la
viticoltura.
Nel medio evo si seguivano due forme di allevamento: vigna coltivata bassa,
attuata prevalentemente in collina, nelle clausure, nei broli e negli orti e
vigna coltivata alta attuata soprattutto in pianura. La vite bassa era sostenuta
da tutori morti (pali, canne, rami), quella alta poteva appoggiarsi, oltre che su
sostegni secchi, su gli alberi verdi, da cui la denominazione di “alberata” o
“pianta”.
Le due tecniche di allevamento si distinguevano anche per il modo di
potatura,corta la prima e lunga la seconda, dalla quale dipendevano la
differente capacità vegetativa e produttiva della vite, come pure il livello
11

qualitativo delle uve prodotte. Infatti dalla vigna alta si otteneva una maggiore
produzione ma le uve avevano un minore tasso zuccherino, per questo si
ottenevano vini poco persistenti. Le vigne basse, invece, erano meno
produttive ma più robuste e vigorose, con un maggior contenuto in zuccheri,
per cui si ricavavano vini di migliore fattura.
I documenti del duecento inoltrato indicano che il vigneto poteva essere
coltivato in coltura specializzata (vinea, terra vithata) o in coltura promiscua
con arativo, prato, bosco, olivo o castagni.
In questo secondo caso non sempre è, però, facile capire la reale disposizione
dei vitigni sul coltivo. Le viti potevano essere piantate nei seguenti modi: in
filari sparsi fra le colture o nel prato; raggruppate in qualche parte
dell’appezzamento; delimitanti i bordi dei prati; situate nei pressi della siepe
di cinta; appoggiate ad alberi d’olivo oppure a quelli di castagno che
lambivano l’inizio del bosco sullo spazio appena dissodato.
IL CINQUECENTO
Nonostante le scarse notizie in merito, si può dire che il Cinquecento,
rappresenta un’ importante tappa per l’agricoltura della Valcamonica, poiché
12

in questo periodo si assiste ad una diminuzione delle attività manifatturiere e
mercantili, molto fiorenti nel secolo precedente, con il conseguente aumento
delle attività legate all’agricoltura.
Questo secolo è legato ad importanti dominazioni per la Valcamonica: quella
dei francesi che, se pur breve, ha portato un cambiamento soprattutto nel
campo della vinificazione, e quella, di più lunga durata, della Repubblica di
Venezia. Per la Serenissima,l a viticoltura era una fiorente fonte di guadagno
attraverso il pagamento delle tasse; da qui l’incremento di vigneti anche in
valle.
L’interessamento verso la viticoltura era dimostrato dall’emanazione di
disposizioni riguardanti gli osti, ai quali si imponeva di vendere solo vino e si
vietava di mescolare il vino vecchio con quello nuovo, imponendo severe
multe o la galera a chi si sottraeva a queste regole.
All’inizio del secolo ci fu un breve periodo in cui in molti territori della
provincia di Brescia, compresa la Valcamonica, subentrò al governo della
Serenissima quello dei francesi.
Essi, da buoni estimatori di vino e forti della loro antica pratica enologica,
introdussero delle importanti modificazioni nell’enologia del Bresciano,
portandola ad un nuovo ed insperato aumento. Infatti i francesi, abituati ai
loro vini più chiari e leggeri ottenuti con una bollitura di tre o quattro giorni,
non gradivano i vini locali, duri, con una colorazione molto intensa dovuta
alla più lunga maturazione, per cui introdussero i loro metodi, insegnando ai
bresciani a svinare il più presto possibile. Nacquero così anche in Italia vini
più accetti e adatti all’invecchiamento.
Tali metodi vennero introdotti anche in Valcamonica ma i locali, abituati al
loro vino, non gradirono le innovazioni cosicché i viticoltori non
abbandonarono le loro antiche consuetudini e tradizioni, staccandosi così
dalla viticoltura praticata in tutto il bresciano.
13

Il ritorno della dominazione veneta dopo quella francese ha fatto sì che la
viticoltura della Valcamonica vivesse una nuova vita, tanto che sempre più
zone furono sottratte al bosco per essere coltivate a vite. Per quanto riguarda
le viti coltivate in valle, notizie interessanti, verso la metà del Cinquecento,
provengono da Agostino Gallo.
In questo secolo non si parlava ancora di vere e proprie schede
ampelografiche e le notizie che venivano fornite sulle singole varietà, si
limitavano a considerare alcuni aspetti ritenuti di maggior rilievo e, in modo
particolare, venivano elencate le caratteristiche dei vini ottenuti, come si può
notare dalle schede sulle uve nere e bianche allegate , scritte da Agostino
Gallo.
UVE NERE
Groppelle: le groppelle gentili sono più delicate da mangiare e fanno il
miglior vino, benché sia poco, ma sono più sensibili alle avversità e alla fersa
(una specie di ruggine sulle foglie, chiamata in gergo dialettale anche nèbbia).
Vernacce: vernacce nere mediamente buone, ma costanti nella produzione; è
meglio mescolarle con le trebbiane bianche o con le Groppelle.
Schiave nere: grosse di grano, molto produttive, ma danno un vino debole,
che migliora accompagnandolo con le Groppelle.
Marzemine: fanno graspi lunghi e grani grossi, sono molto produttive e danno
un vino gentile, tendente all’amabile, ma carico di colore.
Besgane e Rossore: buone, di media grandezza, di tenerezza e sapore danno
un vino debole e di poco colore; è consigliabile vinificarle con Groppelle o
Marzemine .
14

Valtoline: producono molto vino apprezzato da tutti per la bontà e per il
colore; si possono vinificare da sole o con altre uve. Sono chiamate cosi
perché il vino si travasa più volte nell’anno, anche perché sembra guasto; ma,
dopo due giorni dall’operazione, ritorna normale e si mantiene in seguito più
a lungo di ogni altro vino.
Pignole: buone , perché non solo sono molto produttive, ma anche perché
danno un buon vino, sia vinificate da sole che con altre uve.
Correre e Corvarole: produttive, il vino è molto insipido e crudetto, perché
maturano troppo tardi.
UVE BIANCHE
Trebbiane: graspi grandi ed acini grossi, producono molto. Danno buon vino
potente; se impiantate in collina con buona esposizione danno un vino
delicato.
Il periodo di grande sviluppo della viticoltura, che interessò la prima metà del
Cinquecento, si arrestò bruscamente nel 1567, quando una gravissima crisi
colpì la vite camuna, provocandone la moria, descritta da Padre Gregorio di
Valcamonica, che, nei suoi testi, però non cita quali cause la provocarono;
molto probabilmente all’epoca non esistevano ancora gli strumenti e le
conoscenze per spiegare questo fenomeno.
Interessante è notare che questa moria si limitò solo al territorio della
Valcamonica e non si diffuse nelle vallate confinanti. In conseguenza di ciò la
superficie vitata e la produzione della zona diminuirono in modo sensibile,
spingendo i reggenti della valle , verso la fine del secolo, a chiedere il
permesso alla Repubblica di importare il vino dalla Valtellina.Il permesso fu
concesso, ma la decisione fu contrastata dai podestà di Tellio e di Tirano in
15

Valtellina, che lasciarono così la zona Valcamonica posta al di sopra di
Cedegolo senza vino per un lungo periodo.
La situazione si aggravò a tal punto che il consiglio generale della valle,
anche su proposta degli abitanti della zona sopra Cedegolo, inviò a Coira il 29
dicembre del 1601, il dottor Francesco Bassanese per chiedere all’Assemblea
delle Tre Leghe che fosse rimosso l’impedimento. Finalmente il 5 gennaio
1602 il dottor Francesco Bassanese otteneva dall’assemblea delle Tre Leghe a
Coira la rimozione dell’impedimento di acquistare vino dalla Valtellina.
Non si è potuto analizzare questo secolo in modo più specifico ed
approfondito, perché le informazioni ritrovate si riducono solamente a quanto
sopra descritto.
La documentazione relativa alla Valcamonica, relativamente a quel periodo,
appare assai modesta, perché, al di là di Padre Gregorio di Vallecamonica e
Agostino Gallo, nessun altro descrisse la situazione viticola della zona .
IL SEICENTO
16

Indicazioni relative a questo periodo si possono trovare nel Catastico di
Giovanni da Lezze, del 1610, il quale ci fornisce un quadro generale di della
viticoltura camuna . Il da Lezze riprendendo quanto già attuato nel medioevo,
suddivise la valle interessata alla viticoltura in tre zone principali:1) Alta
Valcamonica da Edolo a Ponte di Legno , dove si coltivavano in prevalenza
castagne, mele e pere assenti le vigne dell’uva. La mancanza della vite era
imputabile sia all’altitudine , tutta al di sopra dei 700 m, sia al clima
spiccatamente continentale ed ostile ad una coltura mediterranea come la vite;
2) Bassa Valcamonica, da Darfo a Pisogne, dove si trovavano i comuni di
Artogne, Gianico e Pisogne terreni vitati. La produzione di questa zona era
qualitativamente mediocre, in quanto si producevano prodotti di bassa
gradazione, aspri, acerbi e fumosi; 3) media Valcamonica, nella zona sulla
sponda destra del fiume Oglio, nei luoghi ben esposti al sole, si trovavano la
maggior parte dei terreni vitati della valle; ovviamente queste viti fornivano
un prodotto qualitativamente valido.
Il da Lezze fece anche una classificazione dei paesi che producevano vino, da
cui è emerso che i vini migliori erano prodotti nel comune d’Erbanno, che a
quei tempi comprendeva anche Angone. Seguiva poi, il comune di Gorzone,
con i vini meno forti ma più saporiti, più sani e poco fumosi. Buoni vini erano
prodotti nei territori di Malegno il cui vino era considerato buono, generoso
ed inebriante; in fine Borno, dove si producevano vini graditi al palato.
Vini di buona qualità poi si ottenevano anche a Cividate, Breno, Berzo
inferiore il quale era l’unico comune viticolo della media valle che si trovava
sulla sinistra del fiume Oglio.
Tuttavia, come si ritrova nel Catastico, la produzione di vini di buona qualità
era piuttosto limitata, tanto da non poter soddisfare le esigenze del mercato
locale per più di due mesi; per questo motivo s’importava molto dalle vicine
zone viticole della Franciacorta e della Valtellina.
17

Che la zona più vocata per la viticoltura fosse quella della media
Valcamonica, posta sulla destra del fiume Oglio, viene confermato da uno
scritto del 1698 (Trattenimenti contenenti ragguagli sacri e profani dei popoli
camuni).
Infatti la Valcamonica è descritta come un territorio dove, nei luoghi esposti
al sole fino al paese d’Edolo, si produceva in abbondanza vino.Trovava
inoltre conferma il fatto che i terreni che producevano vino di maggior fama
erano sempre quelli indicati nel catastico; a Gorzone erano situati quelli che
producevano “i più delicati”, a Malegno quelli famosi per le uve moscatelle e
schiavate, seguiti da Berzo Inferiore e Losine.
In queste zone si producevano soprattutto vini rossi, ma non mancavano
quelli bianchi derivanti dal moscato. Questi vini erano caratterizzati da una
certa resistenza, per cui si conservavano in grotte per molti anni e
sopportavano lunghi trasporti senza alterare le loro caratteristiche.
I vini coltivati sulle pendici davano erano più “gagliardi e generosi “ di quelli
del piano, per questo motivo erano tra i migliori quelli coltivati a Gorzone,
Erbanno e sulla costa di Losine. Le vigne nelle zone in pendio venivano
coltivate su terrazzamenti creati artificialmente sostenuti da muri di pietra a
secco, creando quel paesaggio tipico ancora oggi riscontrabile in certi tratti
della valle. Le vigne nelle zone piane come nei terreni intorno a Cividate,
erano invece circondate da muri che delimitavano le proprietà, rimarcando il
concetto nato nel medioevo di clausura, oppure disposte a pergola intorno alle
case e sopra strade.
La viticoltura così come è stata tramandata dagli scritti di questo secolo,
continua ad incrementare il suo sviluppo, assumendo quelle caratteristiche
che sono arrivate fino ai giorni nostri.
18

IL SETTECENTO
Dopo secoli di continua crescita della viticoltura, nel Settecento avviene un
gran rallentamento, dovuto soprattutto a fattori climatici e all’introduzione di
nuove coltivazioni ed allevamenti che hanno distolto l’attenzione degli
agricoltori dalla coltivazione della vite.
Il motivo principale di questo rallentamento fu l’abbassamento climatico che
nel 1705 colpì l’intera Europa, cancellando letteralmente dal vecchio
continente e dall’Italia settentrionale tale coltivazione.
In Valcamonica scomparirono tutti i vigneti che si trovavano a settentrione di
Edolo, e quelli a quote più elevate, mentre subirono numerosi danni i vigneti
situati nei comuni di Cemmo, Berzo Demo, Sonico e Cedegolo. Quelli invece
situati nelle zone più esposte al sole, caratterizzate da un clima più
mediterraneo, come quelli della bassa valle, si salvarono. I danni subiti dalle
viti nell’alta Valcamonica erano aggravati dal fatto che in questa zona gli
ettari coltivati a vite erano molto pochi e la produzione qualitativamente
molto scarsa, per cui con la scomparsa delle viti scomparì anche il vino locale
prodotto. Questo causò la necessità di comprare vino nelle vallate vicine, con
il conseguente notevole aumento del prezzo nell’anno successivo (cinque
volte).
L’aumento del prezzo del vino incoraggiò i reimpianti in molte zone e
vennero messi a dimora vitigni che erano stati scelti fra quelli più resistenti e
produttivi.
In pochi anni il volto della produzione viticola cambiò completamente, in
modo addirittura più profondo di quanto accadde tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento, a causa dell’invasione della fillossera.
Oltre alle cause climatiche, la crisi della viticoltura è legata all’introduzione
della coltivazione del gelso e l’allevamento del bacco da seta. La vite venne
19

un po’ trascurata, soprattutto nei territori meridionali della Valcamonica
compresi fra i comuni di Pisogne e di Cividate.
Infatti in quel secolo la vendita dei bozzoli di seta era molto più redditizia di
quella del vino, per cui di solito tutta la famiglia era impiegata per quaranta
giorni nell’allevamento e nella cura dei bachi trascurando quei lavori che nei
vigneti erano importanti per una buona produzione.
Occorre ricordare che, per lungo tempo, la coltivazione della vite e la
fabbricazione del vino erano affidate ai contadini camuni, in prevalenza
mezzadri, perché la maggior parte dei possidenti non s’interessava
direttamente della coltivazione dei fondi. I camuni, in prevalenza agricoltori,
erano gran bevitori, essendo il vino considerato più che bevanda, sostanza
energetica soprattutto necessaria per i lavori pesanti.
Tale dato è confermato da un rapporto della Commissione preparatoria del
Sinodo del 1873, che denuncia frequenti problemi d’ordine pubblico per
eccesso d’ubriachezza nella nostra valle.
I principali vitigni coltivati nel settecento in Valcamonica sono stati segnalati
da Tomini Foresti e descritti di seguito.
UVE NERE
Balsamina: di grano mediocre e rado, le uve danno un vino dolce. Se ne
hanno due specie, delle quali una più produttiva perché ha grappoli più lunghi
e pesanti; il vino è molto carico di colore.
Pignola: è molto diffusa, si ha un vino che si conserva per lungo tempo ed è
anche molto carico di colore; produce abbondantemente. Ama i luoghi ben
esposti.
Vernazza rossa: si adatta bene ai luoghi ben esposti, fornisce un vino molto
delicato ma poco colorito. Se le uve vengono vinificate con quelle provenienti
dai due vitigni sopra citati forniscono un ottimo vino.
20

Valtellina: il vino è carico di colore ed è buono.
Merera: dà uve di buone qualità.
Bresciana: il grano è più grosso della pignola, ma meno acuminato, fa un vino
delicato e durevole, ama il colle in cui dà vino più copioso e di dolcezza
particolare.
Schiava: è assai feconda in ogni terreno e produce un vino dolce e generoso,
ma di poco colore. Unita ad altre uve può servire per uso domestico a chi ama
un vino saporito e delicato.
UVE BIANCHE
Moscatello bianco: dà un vino bianco dolcissimo di qualità, pari a vini
forestieri più pregiati.
L’OTTOCENTO
21

Da uno scritto del notaio Gian Antonio Guarneri, si apprende che la
Valcamonica, nella prima metà del secolo, era divisa in quattro zone (spartiti)
che si differenziano tra loro per il clima ed i prodotti.
La prima zona, che andava dal lago a Cividate, caratterizzata dal clima dolce,
produceva del vino squisito e molto ricercato, soprattutto nei terreni posti alla
destra del fiume e nelle costiere sovrapposte, ben esposte al sole, fino ad un
altezza massima di 700 metri. Invece nella zona a sinistra del fiume, con
l’eccezione del comune di Berzo Inferiore ed in parte nel comune di Bienno,
il vino era duro, leggero ed aspro.
Nella seconda zona o spartito, che andava da Cividate a Cedegolo, le
campagne erano discretamente feconde ed era presente la vite. Il vino
prodotto in questa zona era però duro ed aspro, ad eccezione del vino di
Breno, Losine, parte di Cemmo e Sellero.
Il terzo spartito, che andava da Cedegolo a Edolo, era poco vitato e il vino
prodotto era appena sopportabile a riserva delle viti di Demo, delle quali il
vino era passabile, e del vino di Edolo, che, nonostante la sua durezza, aveva
gran forza e colore; per cui, misto con vino molle bresciano, riusciva buono,
ed aveva molta diffusione nelle osterie.
Nel quarto spartito, che andava da Edolo a Pontedilegno le viti non
allegavano, a causa della quota e per il clima continentale sfavorevole a
questa coltura.
I vitigni più diffusi in questo secolo in Valcamonica erano per quanto
riguarda le varietà d’uva rossa la Bresciana, la Pagana, il Cropello, il
Balsamino e la Vernaccia moscata, dalle quali si otteneva un ottimo vino
saporito, resistente, di corpo e con un colorito maggiore di quello degli altri
vini ottenuti da uve gentili.
Le varietà d’uve bianche invece erano rappresentate dalla Moscatella e
dall’Alliana. Queste avevano il difetto d’essere poco feconde e presentavano
22

difficoltà di maturazione.In conclusione i vini più famosi di quel periodo
erano quelli di Volpino, Rogno, Gorzone, Erbanno, Pian di borno, Malegno e
quelli della costa di Losine.
La seconda metà dell’Ottocento per la Valcamonica, come per tutta l’Europa,
fu uno dei secoli più difficili per la viticoltura, in quanto vide la comparsa di
malattie che segnarono profondamente il patrimonio viticolo.
Il primo a comparire fu il “mal bianco” causato dall’Oidio, la cui rilevazione
avvenne in Inghilterra nel 1845, mentre i primi danni in Valcamonica si
ebbero nel 1851. Nel giro di due anni la produzione andò distrutta.
L’Oidio, dall’inizio della sua comparsa e per molti anni a venire, fu indicato
come “la crittogama” o “mal bianco”; quest’ultima definizione resiste tuttora
presso i viticoltori. Dopo la sua comparsa in Inghilterra, gli studiosi trovarono
che lo zolfo era un mezzo efficace nella lotta contro il parassita.
È solo dal 1860 che lo zolfo fu impiegato in Valle, dopo la spedizione dei
Mille, e da quel momento la lotta antioidica si diffuse rapidamente tanto che
le produzioni ebbero un notevole aumento. Per parecchio tempo fu utilizzato
solo in polvere e nei nostri ambienti si consigliava di impiegarlo almeno per
quattro volte in un anno alla dose di circa 200 Kg di zolfo sublimato o 280 Kg
di zolfo macinato molto fine per ettaro. I primi trattamenti prevedevano la
distribuzione sulle viti mediante sacchetti di garza o tela, successivamente
furono impiegate le macchine solforatrici, dapprima i soffietti sorretti a mano,
poi le solforatrici a zaino. Con il procedere della sperimentazione si passò agli
zolfi bagnabili, poi a quelli colloidali e quindi a prodotti organici specifici.
In Valcamonica l’impiego dello zolfo ha incontrato notevoli ostacoli non solo
economici ma anche psicologici. Infatti, viticoltori ed allevatori dei bachi da
seta non vollero difendere le loro viti e cosi facendo persero la produzione di
seta e di vino e furono costretti a vendere i loro possedimenti.
23

Dai risultati del Comizio Agrario Bresciano (1869) si apprende che la
coltivazione della vite si estendeva per 1841,81 ettari, di cui 1484,21 su
terreno arativo, 357,60 ettari su terreno a prato stabile.Fra i 52 comuni del
Circondario se ne contano 16 nei quali la vite non può essere coltivata.
Tab. 2 PRODUZIONI ALL’INTERNO DEL CIRCONDARIO NELL’ANNO 1869
TIPO DI COLTIVAZIONE ETTOLITRIGRANO TURCO 55.000SEGALE 22.500FRUMENTO 15.200CASTAGNE 32.000VINO 6.000
Questa tabella ci fa comprendere come la produzione di vino sia ancora una
volta poco rilevante in Val Camonica, dove i comparti principali sono
rappresentati dalla pastorizia e dalla silvicoltura, al punto che si doveva
importare come nei secoli precedenti il vino da zone più vocate, come la
Valtellina e la Franciacorta.
Nel 1881 arrivò dalla Francia un'altra malattia crittogama chiamata
Peronospora che, in gergo dialettale, prese il nome di “Mal negher”.
All’inizio la malattia si manifestò solo in autunno, colpendo esclusivamente le
foglie, successivamente i sintomi comparvero anche nelle altre stagioni
danneggiando tutti gli organi aerei della pianta. I danni furono gravissimi sino
a quando non vennero trovati adeguati mezzi di lotta non si poté contrastarla.
La prima sostanza che dimostrò una certa efficacia fu il latte di calce
impiegato a dosi molto elevate (3-4%), ma furono i sali di rame a contrastare
maggiormente il fungo.
Molti furono i fungicidi rameici utilizzati ma la più efficace è stata la
poltiglia bordolese (solfato di rame neutralizzato con idrato di calcio) studiata
24

e formulata dallo scienziato francese Millardet nel 1885; nel 1887 fu
introdotto l’uso della poltiglia di borgogna (solfato di rame e carbonato di
sodio), successivamente dell’ossicloruro di rame, degli ossidali di rame e di
molti altri prodotti.
Quando ormai la viticoltura camuna andava risollevandosi dalla profonda
crisi causata dal “Mal Bianco” e dalla peronospora arrivò dall’America la
“Phillossera vastratix”. Quest’insetto provocò ingenti danni perché, a
differenza di quanto avveniva in America, cioè la presenza di generazioni che
colpivano l’apparato fogliare e quello radicale, in Europa l’attacco maggiore
e più virulento si aveva sulle radici con la completa distruzione della pianta.
Ciò provocò il timore che si potessero estinguere le viti autoctone; da qui il
via alle ricerche. La soluzione del problema fu trovata con uno stratagemma,
probabilmente il primo esempio di lotta biologica della storia dell’umanità,
vale a dire quello di utilizzare come porta innesto della vite europea la vite
americana, più resistente agli attacchi della fillossera, oppure di fare impianti
in terreni sabbiosi non idonei alla generazione radicale.
La figura riportata di seguito rappresenta il metodo sopra descritto:
Nel 1897 poi fu costituito il Consorzio Antifilosserico bresciano di cui faceva
parte anche la Valcamonica, con lo scopo di esercitare vigilanza contro la
25

diffusione del parassita e far eseguire delle operazioni di difesa nell’area di
competenza. Compito di questo consorzio era anche l’esplorazione dei
vigneti, al fine di controllare l’eventuale infestazione, l’istituzione di vivai di
viti resistenti, per rimpiazzare i vigneti infestati, la diffusione mediante scritti,
conferenze ed esercitazioni, delle notizie riguardanti il nuovo tipo di vite.
Per la lotta contro la fillossera il Ministero dell’agricoltura nominò in ogni
zona persone delegate alla sorveglianza per la ricerca del parassita, che
dovevano dare direttive tecniche per le diverse operazioni in materia.
SISTEMA DI CONDUZIONE DELLE AZIENDE NELL’OTTOCENTO:
LA MEZZADRIA
Nelle zone viticole della Valcamonica, la forma prevalente di conduzione fu
la mezzadria, che cominciò a modificarsi sostanzialmente solo verso il 1950,
per poi scomparire completamente verso il 1970. I patti colonici, molto
diversi secondo le zone altimetriche, la natura dei terreni e la ripartizione
delle colture nelle aziende, sono illustrati dettagliatamente, comune per
comune, nelle premesse del Catasto Lombardo Veneto (1817-1853) e poi
nelle relazioni che i comizi agrari inviavano al ministero dell’Agricoltura,
Industria e Commercio.
26

Di seguito vengono riportate le norme che regolavano la mezzadria nel
periodo1882-1890.
Costituzione – La costituzione della mezzadria avviene per scrittura privata,
ma è più generale farla verbalmente.
Durata-la durata di tali contratti è annuale, a partire dall’11 novembre
Obblighi del proprietario- Dove si lavora con l’aratro, il proprietario dà
gratuitamente al colono qualche ara di prato, o divide a metà il prodotto del
fieno, restando a carico del colono i relativi lavori. Il proprietario dà in affitto
un po’ di prato e un po’ di terra da coltivare a trifoglio, da consumarsi sul
fondo. I pesi del fondo sono a carico del proprietario, che non bonifica il
colono dei miglioramenti non avvenuti.
Obblighi del colono- Nelle località in cui si coltiva la vite, sono a carico del
proprietario tutte le spese per paleria all’impianto; le spese successive sono
sostenute per metà da ciascuna delle parti. Il proprietario preleva una porzione
dell’uva più scelta a titolo di regalia, e ciò per indennizzarsi in piccola parte di
quella consumata dal colono e dalla sua famiglia prima della vendemmia; nei
riguardi del vino il colono paga generalmente la decima. Nelle poche zone
della valle dove il prodotto dell’uva è principale, il contratto è modificato nel
senso che le spese per paleria, vimini ecc. invece di essere divise per metà tra
colono e padrone, sono a carico, in proporzione più o meno forte, del primo.
Per lo più sono addetti alle possessioni coltivate principalmente a viti, ai cedui
che forniscono la paleria per le viti; in questi i coloni possono tagliare i pali a
loro occorrenti senza compenso, o pagano un canone d’affitto per il bosco, o
pagano in parte i pali.
In queste zone i proprietari hanno introdotto l’uso di dividere l’uva prima che
sia fatto il vino, acquistando anche la parte del colono, e ciò per essere più
liberi nella trasformazione dell’uva.
27

Pochi sono i contratti in cui non si accolli al colono l’affitto della casa da lui
abitata. Nei casi dove succede il tasso di tale affitto varia da luogo a luogo e
secondo i proprietari.
Le controversie tra proprietari e mezzadro sono generalmente risolte
privatamente, o per via d’arbitro (persona che ha fiducia da ambo le parti),
difficilmente per via giudiziaria.
Disdetta: le forme che regolano le disdette dipendono dalle condizioni
speciali della scrittura o dall’uso comune.
Si è parlato di mezzadria per comprendere meglio quanta influenza abbia
avuto questo sistema di conduzione, sul progresso della viticoltura e
dell’enologia camuna, che è stato lento soprattutto perché la conduzione delle
aziende era affidata per lo più a contadini, poco istruiti e capaci di agire solo
empiricamente e secondo la tradizione.
D’altra parte, è però merito di questi contadini , se i pendii sono stati condotti
a coltura e sono stati sistemati a terrazzi sostenuti da muri a secco o da
scarpate inerite.
Ciò ha impedito franamenti e smottamenti ed ha permesso di coltivare la
montagna anche in fortissimo pendio, creando un paesaggio naturale
veramente suggestivo.
28

VITICOLTURA CAMUNA DALL’INIZIO DEL NOVECENTO AI GIORNI
NOSTRI.
All’inizio del Novecento la Valcamonica era, come il resto della provincia di
Brescia, alle prese con la lotta contro la fillossera, incominciata verso la
fine dell’Ottocento e coordinata dal consorzio antifillosserico istituito
appositamente per debellare in modo unitario la malattia infestante. Il
consorzio sopramenzionato inizio' una vera e propria campagna
antifillosserica su tutto il territorio proponendosi con:
• Conferenze
• Pubblicazioni popolari diffuse in migliaia di copie
• Analisi dei terreni
• Istituzione di squadre ambulanti d’innestatori
29

• Studi di selezione su vite americane e relativo adattamento del terreno
• Pubblicazione dell’opuscolo “l’attuale questione fillosserica in Italia”
tradotto anche in francese, in cui si esponeva il programma di lotta
contro la fillossera intrapreso.
• Furono distribuite gratuitamente migliaia di talee di viti americane già
selezionate.
Infatti il metodo usato per la lotta si basava principalmente sul reimpianto
dei vigneti e sulla creazione di vivai per l’innesto delle pianticelle di vite
Europea su piede americano. Questa malattia portò inevitabilmente
all’abbandono dei terreni più marginali ma, nello stesso tempo, si operò
una selezione che migliorò il patrimonio viticolo locale. In quegli anni,
infatti, furono portati dalla Francia vitigni già innestati per sostituire quelli
malati; ecco spiegato il perché ancora oggi in Valcamonica si coltivano
vitigni come Cabernet e Merlot.
Grazie all’opera di reimpianto attuata nei primi anni del Novecento, la
superficie vitata diminuì solamente di un centinaio d’ettari rispetto al secolo
precedente, passò dai 1842,81 ettari del 1869 ai 1777 del 1929 come
evidenziano i rapporti del Catasto Agrario del 1929 dai quali si possono trarre
elementi ben precisi sull’entità della viticoltura camuna dell’epoca.
Tab 3 SITUAZIONE SUPERFICE VITATA COME RISULTA DAL CATASTICO
AGRARIO DEL 1929
VALLE CAMONICA DI EDOLO
COMUNE
COLTURA SPECIALIZZATAFORMA
ALLEVAMENTO
COLTURA PROMISCUA
Ha PIANTE/Ha
PRODUZIONE ql/Ha
PRODUZIONE TOT Ha ql/Ha TOT
Cedegolo 24 2800 45 1080 spalliera - - -
30

Corteno - - - - - - - -Edolo 15 2800 36 540 spalliera - - -
Incudine - - - - - - - -Malonno - - - - - - - -
Paisco Loveno - - - - - - - -Temù - - - - - - - -
Val di Saviore - - - - - - - -Vaezza d'Oglio - - - - - - - -
Vione - - - - - - - -
TOTALI 39 5600 81 1620 _ 0 0 0
VALLE CAMONICA DI BRENO
COMUNE
COLTURA SPECIALIZZATAFORMA
ALLEVAMENTO
COLTURA PROMISCUA
Ha PIANTE/Ha
PRODUZIONE ql/Ha
PRODUZIONE TOT Ha ql/Ha TOT
Bienno 24 1.250 26,0 624 pergola 208 13,3 2766,4Borno 57 1.000 35,0 1.995 pergola - - -Breno 50 3.000 20,0 1.000 spalliera 213 16 3408
Capo di Ponte 17 2.600 35,0 595 pergola 84 6 504Ceto-Cerveno 25 2.700 30,0 750 pergola 172 10,4 1788,8
Cimbergo-Paspardo - - - - - - -Cividate-Malegno 76 2.600 35,0 2.660 guyot 99 5 495
Esine 11 2.500 35,0 385 spalliera 124 3,7 458,8Ossimo 24 1.200 24,0 576 pergola - - -
TOTALI 284 16850 240 8585 900 54 9421
31

VALLE CAMONICA DI PISOGNE
COMUNE
COLTURA SPECIALIZZATAFORMA
ALLEVAMENTO
COLTURA PROMISCUA
Ha PIANTE/Ha
PRODUZIONE ql/Ha
PRODUZIONE TOT Ha ql/Ha TOT
Angolo 40 2.400 40 1.600 spalliera 70 15 1050Darfo 132 2.000 35 4.620 spalliera 56 20 1120
Gianico - - - - - 85 6 510Plan d'Artogne 1 2500 60 60 spalliera 141 10 1410
Pisogne 15 2000 40 600 spalliera 14 14 196
TOTALI 188 8900 175 6880 366 65 4286
TOTALIGENERALI 511 31350 496 17085 1266 119 13707
32

La viticoltura della valle subì poi un incremento fra gli anni Trenta e gli anni
Cinquanta, con l’eccezione di un piccolo momento di stasi durante la seconda
guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra. A partire dagli anni cinquanta
la locale Camera di Commercio si rese promotrice di diverse iniziative a
favore della viticoltura, attraverso molti bandi di concorso per una razionale
realizzazione degli impianti. Per questo motivo si passò dai 1777 ettari
documentati nel catasto agrario del 1929 ai 2608 dell’anno 1956, documentati
da Melotti e Tarsia nel loro libro riguardante la Valcamonica, e di seguito
riportati.
Tab 4 SUPERFICI VITATE ANNO 1952
REGIONI DEL
COMPRENSORIO
COLTURA PRIMARIA
Ha
COLTURA
SECONDARIA HaTOTALE Ha
VALLE CAMONICA DI
EDOLO156 10 166
VALLE CAMONICA DI
BRENO1571 282 1853
VALLE CAMONICA DI
PISOGNE428 161 589
TOTALI Ha 2155 453 2608
Negli anni Cinquanta comunque la viticoltura era gestita ancora secondo
criteri tradizionali e nei vigneti erano consociati vitigni diversi, ed i vini
prodotti cominciavano a non essere apprezzati dal consumatore. Per questo
motivo la Camera di Commercio tenne una riunione con lo scopo di studiare e
indicare i vitigni più adatti alle diverse zone del bresciano.
Nella relazione illustrativa di detta riunione si evidenziò il disagio della
viticoltura camuna dovuta a frequenti crisi di mercato, scarsi redditi unitari,
33

produzioni spesso quantitativamente e qualitativamente scarse, in quanto gran
parte della produzione era rappresentata da vini rossi comuni da pasto,
eccessivamente tannici, acidi e carichi di colore, che non potevano soddisfare
i gusti del consumatore.
I vitigni coltivati erano troppi ed, accanto alle vecchie varietà già collaudate,
se ne trovavano alcune di recente introduzione, ma non sempre adatte al
clima, per cui la maturazione non era completa o si aveva scarsa produzione
come nel caso del Cabernet Franc e Sauvignon.
Lo scarso rendimento delle varietà pregiate, contribuì alla diffusione di vitigni
più rustici, ma produttori di uve spesso mediocri, la camera di commercio
così consigliò per i nuovi impianti vitigni come Merlot, Incrocio R. Terzi n. 1,
Marzemino gentile e Schiava grossa. Purtroppo questi consigli in
Valcamonica non furono accettati e gli agricoltori preferirono continuare con
le loro antiche tradizioni, lasciando la viticoltura camuna in un grado di
arretratezza che ancora oggi esiste.
Degli anni sessanta e sessanta vi sono delle informazioni molto più
dettagliate dovute alla creazione di un C.A.T.A (Centro di assistenza tecnico
agraria) che aveva sede a Breno presso la Comunità Montana di Valcamonica.
Il centro considerata la situazione di arretratezza ed abbandono della
viticoltura camuna ritenne opportuno, per rilanciare lo sviluppo, svolgere
delle ricerche riguardanti l’entità delle superfici vitate e le caratteristiche
fisico chimiche dei terreni nelle zone interessate dagli impianti.
Per effettuare l’indagine sulle superfici vitate il territorio della Valcamonica
venne suddiviso in sotto regioni, come di seguito riportate; da cui risultò che
le superfici erano diminuite ulteriormente arrivando a 2212 ettari totali
34

Tab 5 SUPERFICI VITATE ANN0 1962
REGIONE N° SOTTOREGIONISUPERFICIE
VITATA (Ha)
VALLE CAMONICA DI EDOLOI EDOLO, SONICO, MALONNO
2,00
II BERZO DEMO, CEDEGOLO, SELLERO 127,00
VALLE CAMONICA DI BRENO
I
CAPO DI PONTE, ONO SAN PIETRO,
CETO, CERVENO, BRAONE, LOSINE,
NIARDO, BRENO 677,00
II OSSIMO, PIANCOGNO 135,00
IIIMALEGNO, CIVIDATE, BIENNO,
PRESTINE, BERZO INFERIORE, ESINE 594,00
VALLE CAMONICA DI
PISOGNE
I ANGOLO TERME 77,00
IIDARFO B.T., GIANICO, ARTOGNE,
PIANCAMUNO, PISOGNE
TOTALE PARZIALE 1.612,00 IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI 600,00
TOTALE GENERALE (Ha) 2.212,00
Un altro dato importante relativo all’indagine sulle superfici vitate, fu quello
che evidenziò come in Valcamonica ci fosse ancora una notevole superficie
investita a vite “americana” con assoluta preminenza dell’ibrido produttore
diretto Isabella, la cui produzione era pressoché totalmente destinata ad uva
da tavola. Solo in alcune annate, quando a causa della grandine o per
eccezionali attacchi parassitari la produzione si presentava molto scadente,
sorgeva il problema del collocamento di tale uva, notoriamente inadatta alla
vinificazione.
L’area di estensione di tale coltura era posta in sinistra orografica, fra i
comuni di Darfo Boario Terme e Pisogne ed interessava un area di circa 600
ha.Si trattava di vigneti promiscui allevati e collocati alla distanza di 10-20
35

metri, con piante poste a 4-8 m nella fila; la consociazione più frequentemente
adottata era prato stabile, patata e mais.
Anche per l’analisi chimico fisica dei terreni la Vallecamonica venne divisa in
tre zone caratteristiche:
Media Valcamonica- Destra orografica: terreni autoctoni o su detriti di
falda, formati da rocce sedimentarie calcaree, di tipo rendzina, con
abbondante scheletro, ricchi d’argilla, pH alcalino, calcare attivo molto
elevato, indicato come zona A.
Media Valcamonica- Sinistra orografica: terreni autoctoni o diluvionali,
formati da rocce porfiriche od arenarie, pH subalcalino, calcare regolare,
chiamata zona B.
Media- bassa Valcamonica- Fondovalle : terreni alluvionali, molto umidi
per difficile sgrondo delle acque, di tipo Ranger, scarsi di scheletro ed argilla,
pH subacido, calcare scarso od assente, chiamata zona C.
Il risultato delle analisi del terreno fu il seguente:
Composizione fisica meccanica
Dalle analisi è emerso che, mentre la zona A presentava terreni di medio
impasto, le zone B e C erano caratterizzate da un maggior contenuto in
sabbia.
36

Tab. 6 RISULTATI DELL’ANALISI FISICO-MECCANICA
ZONE SABBIA
%
LIMO
%
ARGILLA
%
SCHELETRO
%A 52.4 24.6 23.0 59B 63.9 20.1 16.0 35C 70.6 17.1 12.3 15
Composizione chimica
Azoto: nel complesso i terreni analizzati erano ben forniti di N totale, che è
variato da un minimo di 1% ad un massimo del 5,59.
La zona B si è rivelata la più ricca, con 2.99 ,mentre la zona C la più povera
con 2.04.
Anidride fosforica assimilabile:il contenuto di fosforo nei terreni camuni è
piuttosto variabile, ma solo in pochi è presente in quantità insufficiente;
infatti il contenuto medio è di 174 ppm. Questo dato è da considerarsi molto
buono ed è superato da circa il 40% dei terreni, i rimanenti presentano una
dotazione di anidride fosforica assimilabile sufficiente.
Per questo elemento zona B era la più ricca con 230 ppm, la più carente era la
zona C.
Ossido di potassio assimilabile: anche per il potassio i terreni sottoposti ad
analisi hanno presentato una notevole variabilità; solo 3-4 hanno accusato
una dotazione insufficiente.Il contenuto minimo è stato 0.68 mg/100 gr di
terra fine, mentre il massimo è stato di 19.25 mg/ 100 gr di terra fine.
La zona A era la più dotata di questo elemento con 8.45 mg/100 gr di terra
fine.
37

Ossido di magnesio: sostanzialmente quasi tutti i terreni della Valcamonica
sono sufficientemente dotati di ossido di magnesio; fanno eccezione quelli
compresi nella zona C, nei quali il tenore medio 8.60 è insufficiente.
Calcare attivo: si notano evidenti differenze nelle tre zone. Dato che la zona
A manifesta un contenuto del 8.19% e quindi è ricca, mentre le zone B e C
sono molto povere avendo rispettivamente l’1.05 e 0.19. La zona C quindi
risultava quasi totalmente sprovvista di calcare attivo.
Sostanza organica: nei terreni camuni è variata da un minimo dell’1.94% ad
un massimo del 9.93%. Le zone A e B sono le più fornite , la media generale
della valle è del 4.67%.La notevole presenza di sostanza organica in quasi
tutti i terreni della valle può essere giustificata dalle frequenti letamazioni che
si effettuano e dal clima che non favorisce la mineralizzazione.
Reazione o pH :le tre zone considerate presentano valori diversi tra loro.
Dalla zona A subalcalina con ph 7.6, si passa alla zona B con pH 7.4 neutra,
ed alla zona C subacida con pH subacido.Si sono riscontrati terreni con ph
massimo di 7.8 e terreni con pH minimo di 5.6, ma la grande maggioranza a
un pH neutro.
Fabbisogno di calcio :essendo legato alla concentrazione idrogenionica del
terreno, è stato determinato solo per i terreni con un pH inferiore a sette, quasi
tutti concentrati nella zona C. In questa zona la sostanza organica è più bassa
mentre il fabbisogno di CaO è risultato il più elevato, essendo minore il
potere tampone dell’humus.
38

Tab 7 COMPOSIZIONE FISICO CHIMICA DEI TERRENI VITATI
REGIONI DEL
CO
MPR
ENS
ORI
O
pH
CA
RB
ON
AT
I TO
TA
LI %
CA
LC
AR
E A
TT
IVO
%
SOST
AN
ZA
OR
GA
NIC
A %
AZO
TO
TO
TA
LE
%
AN
IDR
IDE
FO
SFO
RIC
A %
AN
IDR
IDE
FO
SFO
RIC
A p
pm %
POT
ASS
IO A
SSIM
ILA
BIL
E m
g710
0 g
terr
,
MA
GN
ESI
O
CL
OR
UR
I
ZONA A 7.60 32.60 8.19 5.04 2.75 2.76 174.00 8.45 16.16 0.07
ZONA B 7.40 4.40 1.05 5.27 2.29 3.06 260.00 7.00 20.65 0.06
ZONA C 6.90 0.90 0.19 3.71 2.04 1.93 88.00 2.92 8.60 0.07
Il C.A.T.A arrivò alla conclusione che i terreni sottoposti all’analisi chimico
fisica fossero ricchi di scheletro e di sostanza organica, poco profondi e
poveri d’argilla, sufficientemente dotati degli elementi fondamentali della
fertilità per le vigne. Mentre le giaciture della destra orografica ed in alcune
zone della sinistra erano molto forti, ad eccezione dei conoidi di deiezione del
monte Concarena nei comuni di Losine, Cerveno, Ono S. Pietro e Capo di
ponte; il fondovalle presentava giaciture piane.
Generalmente l’esposizione era considerata buona in destra orografica ed in
Val Grigna, meno buona in sinistra orografica ed in fondovalle, ad eccezione
di Cividate Camuno.
Per cui si evidenziava come tutto il territorio della media e bassa valle era
adeguato alla coltivazione della vite.
39

Il C.A.T.A oltre allo studio in precedenza citato descrisse anche le
caratteristiche delle aziende agricole presenti negli anni sessanta e settanta.
Le aziende agricole del comprensorio erano in quegli anni nella grande
maggioranza dirette coltivatrici, nella maggior parte dei casi affidate ad
affittuari.
I problemi di tali aziende erano costituiti dalle superfici molto limitate, dallo
spezzettamento delle aziende, dai fabbricati rurali insufficienti e dalla scarsa
preparazione degli addetti. Per gli affittuari i problemi erano aggravati dai
miglioramenti fondiari e dal riempianto di vigneti più vetusti quando, caso più
frequente, non si trovavano concordi con i proprietari del terreno.
Si trattava nelle generalità dei casi di aziende ad indirizzo produttivo misto
zoootecnico- viticolo, in cui nell’azienda d’inverno c’era il lavoro di stalla,
d’estate con la monticazione del bestiame, il lavoro consisteva nella
fienagione e nei trattamenti nel vigneto.
Di aziende ad economia diretta c’era solo un esempio a Piamborno;
quest’azienda occupava una zona molto ben esposta al sole nella destra
orografica, per un estensione complessiva di circa dieci ettari.Qui si preparava
un vino da bottiglia debitamente invecchiato, denominato “LANZATO”, la
cui produzione era di 300 ettolitri all’anno.
FIG. 4 ETICHETTA DELL’EPOCA
40

I vigneti erano costituiti principalmente da Barbera, Bonarda, Marzemino ed
uva rara; allevati nella forma tradizionale ad “opoi” .Le cure colturali e le
concimazioni venivano seguite razionalmente con la consulenza del C.A.T.A.,
mentre le operazioni di vinificazione erano seguite da un enologo. Questo fu
l’unico esempio di azienda nel territorio della valle, che ha valorizzato in
modo adeguato e razionale la sua produzione, e che dovrà essere preso ad
esempio da coloro che vorranno intraprendere l’attività viticola in questa
zona. Questa azienda purtroppo oggi è scomparsa, così come tutte le aziende
a conduzione diretta di proprietari ed affittuari, mentre in tutto il
comprensorio sono rimasti i vigneti lavorati da agricoltori part-time,
rappresentati da pensionati od operai delle fabbriche locali. Queste superfici
vitate sono però le più soggette all’abbandono, poiché i giovani non amano
tale forma di attività e, nelle piccole aziende rimaste, il vino prodotto è
destinato soprattutto all’autoconsumo.
Queste aziende producono per la maggior parte vini rossi da pasto con acidità
elevata, colore intenso, sapore tannico e profumo caratteristico. La loro
gradazione alcolica in genere è scarsa e variabile da un anno all’altro in
41

relazione all’andamento climatico, e dalla zona e può oscillare da un minimo
di 8,5° ad un massimo di 12°.
Nel decennio che va dal 1962 al 1972, nonostante la preziosa opera del centro
di assistenza tecnico agraria la viticoltura andò incontro ad un’ennesima crisi
che portò ad una riduzione delle superfici vitate di quasi 1000 ettari.
Numerosi terreni infatti furono sottratti all’agricoltura per la costruzione di
ferriere, con conseguente spostamento della manodopera dal settore agricolo
verso quello industriale.
L’agricoltore in quegli anni preferì il lavoro della fabbrica, dove lo stipendio
era più alto ed inoltre si svolgevano attività meno pesanti rispetto al lavoro
nei campi.
I dati relativi alle superfici vitate ricavati dal censimento generale
dell’agricoltura svolto nel 1970 dall’I.S.T.A.T. confermano la situazione
suddetta.Tab 8 DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE 1970
COMUNE N°AZIENDESUP.VITATA (Ha)
COLTURA PRIMARIA COLTURA SECONDARIA
ANGOLO 50 14,29 9,87ARTOGNE 1 0,49 11,13BERZO DEMO 93 14,51 BEZO INFERIORE 99 42,88 35,02BENNO 184 112,73 1,38BORNO 18 4,72 BRAONE 80 14,44 BRENO 127 26,66 CAPO DI PONTE 222 101,97 CEDEGOLO 97 11,91 CERVENO 135 61,28 CETO 177 37,54 CEVO 6 0,8 CIMBERGO 1 0,13 CIVIDATE 140 37,38 16,49DARFO B.T. 257 77,24 101,05ESINE 162 73,15 41,45GIANICO 29 29,48 77,6
42

LOSINE 156 73,57 MALEGNO 139 34,81 0,3NIARDO 140 33,48 ONO S. PIETRO 128 54,77 OSSIMO 36 4,66 PIANCAMUNO 14 8,87 26,98PIANCOGNO 81 33,95 PISOGNE 35 22,66PRESTINE 37 10,26 0,4SELLERO 138 27,1 TOTALE 2782 943,07 344,33La crisi della viticoltura camuna continuò anche negli anni ottanta e novanta,
nonostante la chiusura di molti siti industriali della zona, la manodopera non
ritornò più in agricoltura, che ormai era diventata nella maggior parte dei casi
un attività part-time, ma incominciò a dare inizio a quello spostamento
giornaliero verso le zone industriali delle città che tutt’ora occupa un elevato
numero di addetti della Valcamonica.
Tutto questo è sempre da mettere in relazione ai bassi redditi del settore
agricolo che soprattutto nelle zone di montagna è fortemente penalizzante.
Oltre alla continua diminuzione di manodopera nel settore agricolo la seconda
motivazione che porto alla riduzione delle superfici vitate fu la speculazione
edilizia che favori l’espansione degli agglomerati urbani che occuparono i
vecchi terreni agricoli ormai diventati nella maggior parte dei casi “aree
fabbricabili”.
Questa situazione viene messa in evidenza nelle prossime due tabelle tratte
da fonti I.S.T.A.T. sulle superfici vitate negli anni 1982 e 1990, dove si nota
una riduzione di circa 200 ettari di terreno coltivato a vite nel decennio preso
in considerazione.
43

Tab 9 SUPERFICE VITATA ANNO 1982
COMUNE N° AZIENDE SUP.VITATA(Ha) ANGOLO 31 10,13ARTOGNE 8 3,03BERZO INFERIORE 73 28,52BIENNO 105 24,9BORNO 10 1,39BRAONE 42 6,01BRENO 75 18,16CAPO DI PONTE 51 43,79CEDEGOLO 62 7,74CERVENO 41 9,57CETO 73 11,66CIVIDATE 102 12,01DARFO B.T. 144 41,65ESINE 74 27,58GIANICO 118 50,44LOSINE 110 37,82MALEGNO 44 14,96NIARDO 49 11,47ONO S.PIETRO 80 15,38OSSIMO 7 2,6PIANCAMUNO 15 4,46PIANCOGNO 58 19,85PISOGNE 17 2,78PRESTINE 1,43
44

SELLERO 15,76 TOTALE 1389 423,09 (Ha)
Tab 10 SUPERFICI VITATE ANNO 1990
COMUNE N°AZIENDE SUP.VITATA (Ha)
ANGOLO 16 3,34ARTOGNE 19 1,66
BERZO INFERIORE 83 21,6BIENNO 50 12,45BORNO 8 1,12
BRAONE 17 2,8BRENO 53 15,06
CAPO DI PONTE 28 7,54CEDEGOLO 5 0,77CERVENO 47 7,39
CETO 63 8,13CIVIDATE 81 13,1
DARFO B.T. 49 19,02ESINE 58 14,89
GIANICO 69 21,67LOSINE 33 12,21
MALEGNO 33 8,15NIARDO 11 1,47
ONO S.PIETRO 17 4,41PIANCAMUNO 7 1,45PIANCOGNO 29 8,16
PISOGNE 18 2,7
45

PRESTINE 3 0,96SELLERO 41 4,33
TOTALI 838 194,38 (Ha)
Ipotesi di sviluppo della viticoltura effettuata negli anni novanta
Per cercare di fermare questo continuo declino della viticoltura camuna, verso
la fine degli anni novanta furono individuate delle zone “vocate” per
composizione del terreno, esposizione, altitudine e giaciture, verso cui si
intendeva spostare l’attenzione di quegli enti e di quelle associazioni che
incominciavano a maturare l’idea di un rilancio di questi settore.
Si noto che le aree prese in considerazione erano le stesse individuate dal
C.A.T.A negli anni settanta; sostanzialmente la valle venne divisa in tre zone:
ZONA A: Comprende i terreni vitati posti nelle zone meno favorevoli per
esposizione ed altitudine, le cui limitate pendenze e la giacitura piana
rappresenterebbero però un fattore favorevole alla meccanizzazione della
coltura. Pertanto in tale zona vi sarebbero buone possibilità economiche per la
produzione di vino da pasto tuttavia, viste le limitate estensioni delle
superfici vitate, si può correre il rischio di non poter competere con i grandi
produttori di vino comune da pasto, per cui quest’idea, nata negli anni passati,
deve essere abbandonata, incominciando a pensare di produrre vino di qualità
anche in questi terreni. In questa zona sono compresi i terreni situati nei
comuni e nelle località di Cemmo, Ono S. Pietro, Cerveno, Losine (parte
46

nord); quelli situati nelle zone pianeggianti di Cividate ed Esine, e quelli posti
nelle parti collinose di Darfo, Gianico, Artogne, Piancamuno.
ZONA B: comprende le zone migliori per esposizione ed altitudine, in cui le
forti pendenze del suolo determinano elevati costi di produzione e per
sopravvivere economicamente, la coltura della vite è possibile attuarla se
viene prodotto vino rosso di qualità, possibilmente a denominazione di
origine.
In questa zona sono compresi i territori situati nei comuni di Losine (parte
sud), Breno (destra orografica), Malegno, Cogno, Angone, Angolo, e nelle
zone collinari di Cividate, Bienno, Berzo inferiore, Esine.
Non importa se in questa zona le superfici sono limitate e con forti pendenze,
perché producendo del vino di qualità, i maggiori costi di produzione
verrebbero ripagati con la vendita di un prodotto caratteristico di nicchia, il
cui prezzo sarebbe superiore rispetto ai vini da pasto. In questo modo si
risponderebbe all’esigenza del consumatore, il quale è disposto a spendere
qualcosa in più, pur di gustare dei prodotti di qualità e rari come potrebbe
essere il vino qui prodotto.
ZONA C: comprende tutte le altre zone non delimitate, meno facili per
esposizione ed altitudine, dove la coltura della vite resterà come fatto di
autoconsumo con tendenza alla riduzione.
Nella cartina allegata sono state indicate le zone in cui è consigliata l’
estensione, o la riduzione, o la riconversione o l’abbandono della
coltivazione della vite in Valcamonica.
47

CARTA N 1
48

Nuovi dati sulle superfici vitate si trovano grazie al catasto viticolo del 2000,
nel quale si mette in evidenza come la diminuzione di questa coltura nella
nostra valle continua.
In questi anni però la sensibilità degli enti locali e degli agricoltori stessi è
cambiata perché si incomincia a credere alla viticoltura come un fattore di
possibile rilancio dell’agricoltura di montagna.
Il centro vitivinicolo bresciano ha dato molta importanza a questo catasto,
spiegando agli agricoltori come fondamentale fosse la denuncia di tutte le
superfici vitate realmente presenti, per poter avere, dopo l’approvazione
dell’I.G.T. VALCAMONICA, un buon numero di diritti di impianto e
riempianto senza aggravarsi dei loro costi.
Questa direttiva purtroppo non è stata ben recepita dai viticoltori in quanto sui
circa 143 ettari presenti solo 85.22 sono stati realmente dichiarati come si
vedrà nella tabella successiva.
Mentre negli anni novanta si era solo potuto fare un ipotesi sullo sviluppo
della viticoltura ora, grazie all’intervento degli enti preposti si incominciano a
vedere dei fatti reali.
Gli agricoltori su suggerimento dei tecnici hanno incominciato ad convertire
le vecchie forme di allevamento verso quelle più moderne come il guyot, i
nuovi impianti vengono effettuati con varietà che verranno messe nel
disciplinare di produzione, si cerca di specializzare il più possibile questa
coltura per poter dare in futuro degli alti redditi agricoltori in modo da poter
convogliare nuova manodopera verso il settore agricolo che nelle zone di
montagna è importante non solo per il suo ruolo produttivo ma anche per la
protezione dell’ambiente e del territorio.
49

Tab. 11 DICHIARAZIONI SUPERFICI VITATE 2001
COMUNE SUP. Ha VITATA
SUP. Ha VITATA
% SUPERFICIE PEND. MEDIA
DICHIARATA REALE DICHIARATA VIGNETI
ANGOLO TERME 1,40 2,73 51,28 15-40% ARTOGNE 0,54 1,50 36,00 BERZO INFERIORE 5,93 9,03 65,60 10-30% BIENNO 5,75 8,10 70,98 12-35% BRAONE 0,38 1,40 27,14 6-20% BRENO 3,24 6,50 49,84 12-40% CAPO DI PONTE 3,68 5,50 66,90 6-15% CERVENO 8,72 12,70 68,60 6-20% CETO 5,26 5,50 95,63 8-20% CIVIDATE CAMUNO 5,85 7,71 75,87 DARFO BOARIO TERME 6,54 19,83 32,98 15-40% ESINE 3,14 11,41 27,51 0-30% GIANICO 3,94 6,50 60,61 LOSINE 12,10 12,90 93,80 6-15% MALEGNO 7,58 9,50 79,78 15-40% NIARDO 0,39 2,30 16,95 6-20% ONO SAN PIETRO 1,93 5,80 33,27 6-15% OSSIMO 0,20 0,20 100,00 0-20% PIANCOGNO 3,39 6,97 48,63 15-40% SELLERO 5,26 6,90 76,23 10-40%
TOTALE (Ha) 85,22 142,98
La successiva tabella ci dà un idea del trend di diminuzione delle superfici
vitate in Valcamonica dal 1869 al 2001 per tutta quella serie di fattori che
sono fin ora stati oggetti di questa relazione. Tuttavia anche se le superfici
sono rimaste solo circa ottantacinque ettari, visto l’andamento della
vitivinicoltura attuale in Italia che tende a favorire le produzioni di alta
qualità, il dato definitivo del censimento dell’anno scorso non ci deve
50

scoraggiare perché è ancora possibile trarre redditività da questa coltura
anche con numeri così ridotti.
Redditività che potrà essere raggiunta solo producendo vini di alta qualità che
permetteranno di creare una nicchia di mercato nella quale sarà possibile
collocare un prodotto ad alto valore aggiunto.
Tab. 12 ANDAMENTO DELLE SUPERFICI VITATE DAL 1869 AL 2001
ANNO COLTURA COLTURA TOTALEPRIMARIA SECONDARIA HA
1869 357,60 1484,21 1841,811929 511,00 1266,00 1777,001956 453,00 2055,00 2508,001962 2212,00 2212,001970 934,07 344,33 1278,401982 423,09 423,091990 194,38 194,382001 85,22 85,22
GRAFICO DI RAFFRONTO
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
1869
1929
1956
1962
1970
1982
1990
2001
ANNI
HA
51

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DAGLI ANNI SETTANTA
AD OGGI
Varietà e portinnesti: nel 1970 venivano utilizzati portainnesti diversi a
seconda dell’anno dell’impianto. Nei vecchi impianti erano utilizzati la
Rupestris du Lot, la Riparia e il Mourvedre x Rupestris 1202 (Couderc),
mentre negli impianti più moderni erano impiegati il Berlandieri x Riparia
420/A nelle zone più calcaree e ,per il resto, era utilizzato il Kober 5 BB.
Dagli anni novanta in poi nei terreni con mancanze minerali; è stato proposto
l’utilizzo del Berlandieri x Riparia SO4 Berlandieri x Rupestris 140 Ruggeri,
1103 Paulsen e Chasselas x Berlandieri 41B per i terreni della destra
orografica ricchi di calcare.
Per quanto riguarda i vitigni erano praticamente assenti quelli bianchi ad
eccezione del Moscato che dagli anni novanta ha destato un certo interesse,
mentre per i vini rossi esisteva una notevole confusione varietale.
Le varietà più diffuse negli anni settanta erano:
• L’Uva rara o Bonaria novarese, denominata localmente “Balsamina”
• ”Bressana” o “Valcamonec”;
• Il Marzemino gentile (Balsamì dal merz negher)
• La Schiava Lombarda (Sciass negher)
• Barbera d’asti
• Schiava grigia
A seguito dei risultati conseguiti in appositi vigneti d’orientamento varietale,
in quegli anni furono poi introdotti nuovi vitigni: Merlot e Ciliegiolo nel
52

fondo valle, Incrocio Terzi (Barbera x Cabernet) e Schiava gentile nelle zone
più alte, con terreno calcareo ed asciutto.
Considerato che nella zona erano più diffusi vitigni tardivi, si è cercato allora
di introdurre varietà più precoci che fossero in grado però di giungere
regolarmente a maturazione. Il Barbera d’Asti, benché capace di dare buone
gradazioni zuccherine, dagli anni novanta in poi non è stato più impiantato
poiché ha dimostrato di produrre, specie nei terreni calcarei e poco argillosi,
vino troppo ricco d’acidità.
Alcuni vitigni locali, come il “Barbera” e la Schiava Lombarda, presentavano
alcuni difetti, e precisamente il primo è sensibile al freddo invernale, il
secondo è facilmente attaccato dalla muffa grigia; Questi vitigni, se oggetto di
un’opportuna selezione clonale, possono essere molto interessanti per
sviluppare in futuro produzioni di vini locali caratteristici.
Nel censimento I.S.T.A.T. del 1990 i vitigni presenti in Valcamonica sono:
• Marzemino
• Merlot
• Incrocio Terzi
• Ciliegiolo
• Cabernet
• Barbera
• Schiava Lombarda
• Moscato
• Valcamonec
53

Nel 2002 nella proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica
Tipica dei vini “VALCAMONICA” i vitigni presi in considerazione sono i
seguenti:
• Riesling Renano
• Incrocio Manzoni
• Muller Thurgau
Marzemino
• Merlot
Forme d’allevamento
Le forme d’allevamento presenti in Valcamonica sono principalmente
quattro: Spalliera e Tendone le più frequenti, Guyot e Pergola semplice
presenti in minima parte.
Oggi il Centro Vitivinicolo Bresciano consiglia il passaggio al guyot sulle
varietà utilizzate per la produzione del vino I.G.T per la migliore resa
qualitativa delle uve, anche se i quattro sistemi d’allevamento sopra citati
sono ancora tutti in uso ed in alcuni casi hanno subito localmente delle
modificazioni.
54

FOTO 1 FORMA ALLEVAMENTO“OPOI”
La forma di allevamento più antica attuata nella valle, ed ancor oggi presente
in alcuni terreni era chiamata “opoi”. La particolare caratteristica di questa
forma di allevamento sono i pali di sostegno che sono fatti di un materiale
insolito: il granito; per il resto è molto simile all’attuale spalliera con una
distanza sulla fila delle piante di circa due metri
L’ ”opoi” presenta il vantaggio di resistere bene ai venti ed ai temporali
frequenti nella stagione estiva, per contro non è adatta ad alcune varietà quali
il Nebbiolo i cui tralci, se non sono assicurati ad un secondo filo, si staccano
facilmente dalla loro inserzione sul cordone permanente.
55

FOTO 2 FORMA ALLEVAMENTO “TENDONE”
La forma di allevamento più diffusa è una specie di tendone. Esso consiste
nell’allevare nei terreni più poveri e siccitosi, piante singole o a coppie, con
un cordone verticale alto 180-220 cm alla sommità della quale si dipartono,
ortogonalmente tra loro, quattro capi a frutto appoggiati su altrettanti fili, in
modo da costituire un tetto orizzontale continuo. Il sesto d’impianto è in
quadrato con una distanza di 4 x 4 m. L’impalcatura è costituita da pali in
legno o cemento armato, la cui parte fuori terra deve superare i 2,20 m,
distinti in pali d’angolo, di maggiori dimensioni, pali di corona perimetrali e
pali rompitratta all’interno dell’impianto, posti accanto alle viti. I pali sono
collegati tra loro per lungo e per traverso da fili di ferro, cosi come la maglia
56

interna.Questa forma di allevamento viene utilizza soprattutto nelle zone dei
comuni di Losine, Cerveno, Ono S. Pietro e Breno.FOTO 3 FORMA ALLEVAMENTO “ SPALLIERA”
La seconda forma di allevamento per diffusione è una spalliera con potatura a
Sylvoz modificato, con un sesto d’impianto di 2,5-3 m tra le file e 2-2,5 m
sulla fila. L’impalcatura è costituita da pali robusti, distanti 8 metri, in parte
interrati (circa 1 metro) collegati tra loro da quattro cinque fili di ferro. Di
questi quello più basso serve per legare il capo a frutto; il secondo, posto a
circa 50 cm dal precedente, serve per sostenere il cordone verticale, il terzo
posto a 40 cm ha la funzione di sorreggere la vegetazione dell’annata, ed
infine l’ultimo, che scorre alla sommità dei pali e presenta un calibro
maggiore, serve a collegare e sostenere l’intero filare.Questa forma di
57

allevamento è adatta specie nel fondovalle per varietà molto vigorose ed
espanse come il Merlot ed il Ciliegiolo.
FOTO 4 FORMA ALLEVAMENTO “GUYOT”
Il Guyot è un sistema di allevamento che in questi ultimi anni viene utilizzato
sempre più di frequente. Con questo sistema la pianta in produzione è
costituita da un ceppo, alto circa un metro, portante all’estremità una branca
molto corta di due anni su cui sono inseriti in alto, un tralcio di 6-12 gemme
(capo a frutto) disposto orizzontalmente sul filo e, in basso, uno sperone di 2-
3 gemme.Il sesto d’impianto è di solito 1,2 x 1.I sostegni sono forniti da
robusti pali, distanziati di circa 10 m, parzialmente interrati, emergenti per
1,5-2 m, collegati tramite tre fili: il primo è posto alla sommità del ceppo, che
sostiene, e su di esso viene legato il tralcio produttivo; il secondo e il terzo
sono posti rispettivamente a m 0,40 e 0,90 dal primo ed hanno la funzione di
sorreggere i germogli fruttiferi.
58

OPERAZIONI COLTURALI
Le operazioni colturali attuate in questa zona consistono nella potatura e
legatura invernale e primaverile, rara la potature verde. Le lavorazioni del
terreno riguardano: lo scasso, l’aratura, l’erpicatura e la rullatura per i nuovi
impianti ed erpicature e arature effettuate molto negli anni passati sulle file e
tra le file, mentre oggi per rientrare nella “misura F” sulla lotta integrata si
consiglia l’inerbimento totale.
Per quanto riguarda la concimazione, l’impiego del letame è ancora oggi assai
generalizzato per la presenza di molti allevamenti nella valle, la quantità da
distribuire varia da 100 a 300 quintali ad ettaro a seconda delle necessità il la
letamazione dovrebbe essere effettuata nel mese di dicembre.
L’uso di concimi chimici è andato aumentando con gli anni,si preferisce
utilizzare solfato di magnesio o di potassio nel mese di dicembre a causa della
loro lenta cessione e complessi ternari distribuiti alla dose di 2-3 quintali per
ettaro a febbraio. L’utilizzo dell’uera si consiglia sugli impianti novelli a
ripresa vegetativa e successivamente nel mese di giugno con una dose 1-3-
quintali ad ettaro. La concimazione fogliare con prodotti contenenti, oltre agli
elementi fondamentali della fertilità, alcuni dei principali oligoelementi quali
ferro, magnesio, boro ecc.., le cui carenze hanno determinato la comparsa di
numerose fisiopatie, diede soprattutto negli anni settanta ed ottanta risultati
apprezzabili, si consiglia anche oggi il suo utilizzo visto la facilità di
abbinamento con gli interventi fitosanitari.
Dal punto di vista delle avversità, nella zona sono frequenti attacchi di
peronospora, oidio e saltuariamente di botritis e disseccamento del rachide;
per quanto riguarda i parassiti animali la tignola è in genere ben controllata,
presente in maniera non significativa per il momento la cicalina della
flavescenza dorata. La lotta viene effettuata tramite l’utilizzo degli
59

antiparassitari, di cui molte volte nel corso degli anni precedenti si è abusato,
creando numerosi problemi di resistenza. Ad esempio si ricorda che negli
anni settanta, a causa del persistente uso di anticrittogamici acuprici e di
insetticidi polivalenti, era diventato un grosso problema quello degli acari, in
particolare il ragnetto rosso; però con il ritorno all’uso del rame dopo
fioritura, con l’impiego di insetticidi specifici ed acaricidi, il fenomeno fu
ridimensionato.
Purtroppo rari in valle sono gli esempi di lotta biologica integrata, effettuata
solo nella coltivazione delle mele, più per moda che per convinzione, da parte
dei pochi coltivatori che la effettuano.
Nel campo dei trattamenti antiparassitari importante è stata l’attività
divulgativa promossa negli anni settanta dal C.A.T.A, che diffondeva con
scadenza di 10-15 giorni un manifesto murale in tutti i comuni e le frazioni
della zona viticola, nei quali erano riportati i prodotti e le relative dosi
consigliate per i trattamenti antiparassitari del momento. Attività che dopo la
scomparsa di questo centro non venne più ripresa, lasciando ancor oggi i
viticoltori della valle ad eseguire i trattamenti in modo certe volte casuale.
Un altro dato importante sta nel fatto che la meccanizzazione dei lavori nel
vigneto è molto limitata, per quanto riguarda la lavorazione del terreno, la
distribuzione dei concimi e la raccolta dell’uva. Si contano però numerosi
atomizzatori, sia a spalla sia trasportabili da trattori, per i trattamenti
antiparassitari.
Un altro miglioramento fondamentale per avere una coltura sempre più
specializzata è quello dell’irrigazione, che dovrà essere portata sulle pendici
della media montagna che sono soggette maggiormente alla siccità. Ad
esempio nei conoidi di deiezione sulla destra orografica, costituiti da terreni
poco profondi, calcarei, con sottosuoli ciottolosi. L’espansione
dell’irrigazione possibilmente polivalente, sarà favorita dall’abbondanza di
60

acque che consentono impianti a caduta naturale con bassissimi costi
d’esercizio.
Non vanno scordate altre opere di costo minore ma altrettanto importanti
quali: spianamenti, spietramenti, regimazione dei torrenti e le moderne difese
antigrandine.
Da non dimenticare che tali miglioramenti inducono ad un aumento ingente
del valore fondiario tanto che, in certi casi è proprio questo aspetto a rendere
economici alcuni investimenti, come è successo nelle vallate vicine.
61

IL RILANCIO DELLA VITIVINICOLTURA IN VALLECAMONICA
Preso coscienza del fatto che la ridotta estensione dei vigneti camuni non è un
fattore limitante in una viticoltura che ormai oggi punta sui vini di altissima
qualità, per la cui produzione basta un investimento di superfici limitato per
essere competitivi in un mercato di nicchia molto redditizio, e che comunque
questo comparto vanta di una certa tradizione ed in molte zone rappresenta
ancora oggi l’unica alternativa al bosco ceduo, alcune realtà camune private e
consociate hanno accettato di affrontare questa sfida che ha successivamente
portato, all’approvazione di un disciplinare di produzione per i vini camuni .
Tutto questo è stato possibile anche per l’interessamento degli enti locali che
hanno messo a disposizione tecnici esperti del settore una volta resosi conto
che il futuro viticolo della valle è legato alle decisioni della programmazione
poiché, in linea generale, si ritiene che i singoli produttori siano incapaci da
soli di risolvere i numerosi problemi tecnici ed economici inerenti e partendo
dal presupposto che questa coltura per sopravvivere economicamente, dovrà
essere più specializzata e quindi richiederà investimenti considerevoli, i cui
benefici andranno a favore non solo degli agricoltori, ma di tutta la comunità,
infatti non bisogna dimenticare che il ruolo fondamentale dell’agricoltura di
montagna non è solo produttivo, ma anche di conservazione del suolo, del
paesaggio e dell’ambiente ecologico.
Partendo da questi presupposti alcune realtà locali, private ed associate,
convinte della bontà dell’idea hanno deciso di intraprendere la strada della
Vitivinicoltura tra queste un elogio va dato all’A.P.A.V. Associazione
Produttori Agricoli di Vallecamonica e all’Azienda Agricola Sorelle Rebaioli
che nonostante le grandi difficoltà iniziali stanno tentando di fare del settore
viticolo camuno una realtà.
62

L’associazione produttori Agricoli di Vallecamonica è nata nel 1996 da un
piccolo gruppo di agricoltori, oggi conta oltre 170 iscritti e nel 1999 ha dato
inizio ad una serie di attività legate al rilancio della vitivinicoltura in
Valcamonica.
Questo progetto è incominciato con la vendemmia del 2000 con la creazione
di una cantina nella quale sono stati conferiti da vari produttori circa 150
quintali di uva per una vinificazione associata, che potesse essere meglio
curata; il vino prodotto è stato poi ritirato dagli stessi conferitori dell’uva.
Questa iniziativa ha dato modo di individuare alcuni vitigni che, oltre ad
essere tradizionalmente presenti nella nostra valle, sono in grado di produrre
un vino dalle qualità molto interessanti.
Per l’anno 2001 visto il buon esito della precedente esperienza, effettuata in
un piccolo ambiente nel comune di Darfo B.T., si è deciso di attrezzare l’ex
caseificio comunale di Cerveno. Nella nuova cantina hanno conferito uva i
produttori di tutta la Valcamonica da Artogne a Capo di Ponte a Ossimo a
Bienno, per un quantitativo complessivo di circa 300 quintali.
I prodotti derivanti da questa vinificazione sono stati suddivisi in tre tipologie:
• Vino base prodotto con uve di diverse varietà e di minor pregio
• Vino in bottiglia non invecchiato, prodotto in prevalenza con uve
Merlot, Marzemino e in piccola parte con uve di diverse varietà.
• Vino in bottiglia da invecchiamento, prodotto in prevalenza con uve
Merlot e Marzemino, in parte lasciate appassire su graticci.
Per l’esecuzione di tali operazioni ci si è affidati alla consulenza di tecnici
agronomi ed enologi professionisti che hanno seguito la filiera produttiva in
tutte le sue fasi, dal vigneto in campo alla cantina.
Per la vendemmia del 2002 si è continuato nei miglioramenti sia in vigneto
che in cantina, lavorando secondo il disciplinare che sta alla base della
63

domanda di riconoscimento della Vallecamonica come zona I.G.T. per la
produzione di vino.
Per gli anni futuri, proprio in vista di tale riconoscimento, si ritiene
indispensabile un evoluzione di tale attività con: l’aumento di nuovi impianti
realizzati secondo le moderne concezioni con conseguente incremento delle
produzioni di qualità che richiederà una struttura in grado di accogliere le
produzioni viticole di tutti coloro che vorranno conferire il prodotto.
Il secondo esempio Azienda Agricola Sorelle Rebaioli nasce da un iniziativa
imprenditoriale privata con l’intenzione di valorizzare una serie di prodotti
agroalimentari locali camuni tra cui il vino i quali vengono proposti ogni
giorno sulle tavole del loro ristorante, tutto questo per restare legati alle
tradizioni contadine camune.
Il vigneto di proprietà presente già da trent’anni si estende per una superficie
di circa 2,50 ettari tra un altezza che va dai 250 ai 300 m.l.m. , le varietà
coltivate sono: Barbera, Schiava, Merlot e Marzemino.
Il sistema di allevamento negli ultimi anni su consiglio dei tecnici del settore
è stato cambiato trasformando la vecchia Spalliera in Guyot, tutto questo per
migliorare le rese quali/ quantitative delle uve.
Dalla vinificazione delle uve in precedenza descritte si ottiene un vino da
tavola rosso chiamato Lambrù la cui produzione sfiora le dodicimila bottiglie.
Per la prossima vendemmia si è pensato di migliorare la qualità della
produzione vinificando a parte ogni singola varietà presente nel vigneto e
cercando di migliorare il prodotto qualitativamente con l’utilizzo di nuove
tecnologie in cantina e di barriques per l’affinamento dei vini.
64

Proposta di riconoscimento della indicazione Geografica Tipica dei vini “VALCAMONICA”
Il 12 novembre del 2002 presso la Comunità Montana della Valcamonica è
stato fatto un passo importantissimo per il futuro della viticoltura di questa
zona attraverso la proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
dei vini ad Indicazione Geografica Tipica alle autorità competenti, con un
udienza aperta al pubblico. A sottolineare l’importanza di questo evento erano
presenti numerosi politici, i tecnici del Centro Vitivinicolo Bresciano e della
Comunità Montana di Vallecamonica, alcuni giornalisti, il presidente e alcuni
membri dell’ Associazione produttori agricoli di Vallecamonica e numerosi
agricoltori della zona.
Il disciplinare presentato è il seguente:
Articolo 1
L’Indicazione geografica tipica “Valcamonica” accompagnata da una delle
specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai
mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti di seguito
indicati.
Articolo 2
L’Indicazione geografica tipica “Valcamonica”è riservata ai seguenti vini:
bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.
I vini ad indicazione geografica tipica Valcamonica Bianco e nella versione
passito devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca:
Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60%
65

Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei
vini sopra indicati, le uve da vitigni a bacca di colore analogo non aromatici,
idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del
40%.
L’ indicazione geografica tipica Valcamonica Rosso è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai
seguenti vitigni a bacca rossa:
Marzemino e Merlot: minimo 60%
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti o dei
vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di analogo colore non aromatici,
idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del
40%.
L’indicazione geografica tipica Valcamonica con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni: Merlot, Marzemino, è riservata ai vini rossi ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni. Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti o dei vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di
analogo colore, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un
massimo del 15%.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a
essere designati con l’indicazione geografica tipica Valcamonica comprende
l’intero territorio amministrativo dei comuni di:Berzo Demo, Cedegolo, Cevo,
Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto,
66

Barone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine,
Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo,
Prestine e Angolo Terme tutti in provincia di Brescia.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini di cui all’articolo 2 devono essere quelli tradizionali della zona .
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’elenco delle
Vigne
di cui all’art.15 comma 2 della Legge 10 Febbraio 1992 n° 164 unicamente i
vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana
di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 800 metri s.l.m.
con l’esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi.
I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi
ad ettaro non inferiore a 4.000 calcolati sulla base del sesto d’impianto.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,
nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione
geografica tipica Valcamonica senza la specificazione del vitigno a tonnellate
11 per ettaro, qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa
massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica
Valcamonica devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
10,00 % per il bianco;
67

11.00 % per il passito;
10,00 % per il rosso;
11.00 % per il Marzemino
11.00 % per il Merlot
Nel casi di annate particolarmente sfavorevoli detti valori possono essere
ridotti dello 0,5% vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini
le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve
essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia
passito.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica Valcamonica, all’atto dell’immissione al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Valcamonica bianco 11,50 %
Valcamonica rosso 11,50 %
Valcamonica passito 14.00 %
Valcamonica Merlot 12,00 %
Valcamonica Marzemino 12.00 %
68

Articolo 7
All’indicazione geografica tipica Valcamonica è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non
siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino ad Indicazione geografica Tipica
“Valcamonica” passito, Marzemino e Merlot è obbligatorio riportare l’annata
di produzione.
Il disciplinare potrà in futuro essere ratificato nel caso in cui nuovi terreni si
dimostrino idonei alla coltivazione della vite, con l’inserimento di nuovi
comuni e quindi l’ampliamento della zona di produzione.
Si potranno anche introdurre nuove varietà se le prove di microvinificazione e
di adattamento ai terreni della zona daranno risultati positivi. Il traguardo a
cui in futuro si vuole arrivare è la produzione di un vino Di Origine
Controllata
69

VINI PRODOTTI IN VALCAMONICA
Dal 2000 sono presenti sulle tavole dei ristoranti Camuni bottiglie di vino
locale la cui evoluzione qualitativa in questi ultimi due anni ha fatto
passi da gigante.
I produttori sono: A.P.A.V e le Sorelle Rebaioli
Di seguito verranno descritte la modalità di produzione e le analisi sensoriali
di ogni singolo vino fino ad oggi prodotto.
I vini da tavola rossi prodotti ed imbottigliati dall’ A.P.A.V. sono:BALDAMI’
Prodotto in prevalenza con uve Marzemino e in quantità minore Merlot,
Barbera e Incrocio Terzi provenienti dai vigneti meglio esposti della
Vallecamonica.
Il vino viene affinato in botti di acciaio inox ed imbottigliato dodici mesi
dopo la vendemmia a una gradazione alcolica del 12,5%
70

Alla vista si presenta di colore rosso rubino di media intensità con sfumature
granata.
Al naso presenta sentori di frutta matura, di sottobosco e violetta tipici del
vitigno.
In bocca l’ingresso è deciso con tannini rotondi, una buona struttura e
persistenza, leggermente amarognolo il retrogusto.
CAMUNNORUM
Prodotto con uve Merlot, Marzemino, Cabernet Sauvignon, provenienti dai
vigneti meglio esposti della Vallecamonica.Le uve vengono raccolte e poi
lasciate ad appassire per circa due mesi in piccole cassette di legno e
vinificate con il sistema tradizionale.
Affina in barriques di rovere per circa tredici mesi, a una gradazione alcolica
del 14%
Alla vista presenta un colore rosso porpora intenso.
Al naso sprigiona profumi conferiti dall’appassimento con nette sensazioni di
ciliegia e frutti di bosco, sono presenti sfumature di spezie e vaniglia legate
all’invecchiamento.
In bocca si presenta con grande struttura, tannini molto fini e lunga
persistenza.
Il vino rosso prodotto ed imbottigliato dalle sorelle Rebaioli è stato chiamato:
71

LAMBRU’
Ottenuto da uve Barbera 60%, Merlot 30% e Schiava 10% coltivate in zona
collinare ad un altezza di 230 m.l.m.,vendemmiate in epoca tardiva, dopo una
maturazione con clima temperato di giorno e freddo di notte.
La fermentazione avviene in vasche di cemento mentre l’affinamento in
vasche di vetroresina, il prodotto viene imbottigliato dopo un anno
d’invecchiamento con una gradazione alcolica del 12,5% .
Alla vista si presenta di un colore rosso rubino.
Al naso presenta profumi provenienti dalla maturazione in epoca tardiva con
prevalenza di profumi di frutta matura e sottobosco.
In bocca presenta una moderata struttura, dei tannini molto fini ma poco
persistenti.
72

BIBLIOGRAFIA
AA.VV., 1970. I Vini Bresciani - CCIAA Brescia Ed Fausto Gardini, Bornato
Franciacorta .
ARCHETTI G., 1998. “ Tempus Vindemie ” per la storia della vite e del vino
nell’Europa medioevale. Ed. Fondazione Civiltà Bresciana.
BIANCHI A., MACARIO F., ZONCA A, 1999. “CIVIDATE” l’abitato e il
territorio di Cividate camuno in età medioevale. Ed Tipografia Camuna,
Breno.
COMPAGNONI M., 1976. Costa Volpino. Ed. f.lli Ferrari , Clusone .
GUIDE DE AGOSTINI, 1990. Conoscere la Vallecamonica. Ed. Cartografia
De Agostini, Novara .
Indagine conoscitiva sulla viticoltura in Vallecamonica, 1973. Ed. C.A.T.A.
di Vallecamonica
MARENGONI B., Le terre della vite bergamasca. Ed. stamperia editrice
commerciale, Bergamo .
MARENGONI M., 1996. Vite e Vino in terra bergamasca dai tempi più
antichi ai giorni nostri. Ed. stamperia editrice commerciale, Bergamo.
MELOTTI G. , TARSIA F. , 1956. Valle Canonica . Ed. tipografia camuna,
Breno.
73

Monografia illustrata di Brescia e provincia, 1957. Ed. Prodotto Nazionale e
Commercio Estero, Brescia.
NASI F., LAZZAROTTO R., GHISI R., 1989. Coltivazioni arboree. Ed.
Liviana editrice.
PEDERSOLI G. S., RICCARDI M., 1992. Grande guida storica di
Valcamonica, Sebino, Valle di Scalve. Ed. Toroselle.
RIZZI B., 1870. “In Valcamonica… illustrazione della Valcamonica “. Ed. P.
Ghitti.
ROSA G., 1886. La vite, il Vino, la Caccia notizie storiche. Ed. Pavoni,
Brescia.
SIGALA A., 1998. Viaggio nella memoria, Vallecamonica e Lago d’ Iseo.
Ed. la Cittadina.
Statistica agraria del circondario di Breno, 1896. Ed. Sentinella Bresciana n°
167-168-169.
TAMAGNINI D., 1960. Il Vino Racconta, storie di bianchi e rossi bresciani.
Ed. del Moretto.
VITALI G., 1977. A.D. 1609 Dossier sulla Vallecamonica, il catastico di
Giovanni Da Lezze. Ed. San Marco, Cividate Camuno.
74