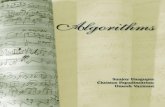aga13
description
Transcript of aga13
-
Seminario sull'Agamennone
Breve riassunto degli incontri trascorsi(per chi vuole ripassare e per chi stato assente)
13 incontro, 4 Marzo 2008
Primo episodioDopo il prologo e la parodo iniziamo oggi un'altra delle parti () della tragedia: l'episodio. Anche questa volta preferisco non fare un'introduzione teorica, tanto impareremo che cos' un episodio leggendo via via quelli dell'Agamennone. Ma, quando si parla delle parti della tragedia, c' un'opera che prima o poi si deve pur citare: la Poetica di Aristotele.La Poetica una delle opere antiche pi studiate e pi commentate, piena di considerazioni acutissime e anche strapiena di problemi esegetici di ogni tipo. L il filosofo definisce episodio "quella intera parte della tragedia che si trova in mezzo a due interi canti corali" (1452b): una definizione neutra e puramente formale, nella quale per colpisce la sudditanza della parte recitata dagli attori, l'episodio, rispetto a quella cantata dai coreuti, il coro. Infatti per la nostra mentalit normale il punto di vista opposto: il canto corale che ci appare "in mezzo" a due episodi. Quale pu essere il motivo della definizione aristotelica? Probabilmente esso ha a che fare con la storia del genere tragico, cos come Aristotele la ricostruisce. Nella visione aristotelica sulle origini della tragedia, infatti, la nasce come pura , canto; solo in un secondo tempo sarebbe stato introdotto un singolo attore, che dialogava col coro; in seguito il numero degli attori sarebbe stato portato a due proprio da Eschilo, il quale avrebbe ridotto le parti corali e assegnato alla recitazione (al , dice Aristotele) e dunque al dialogo tra gli attori il ruolo principale (1449a). Nella successiva evoluzione del genere tragico, che osserviamo abbastanza chiaramente nelle opere rimaste di Eschilo, Sofocle ed Euripide, il coro ridusse continuamente il suo spazio e il suo ruolo nel dramma a favore degli attori; cosicch ai tempi di Aristotele la gerarchia tra le due componenti della tragedia era in realt rovesciata rispetto a quella che la sua definizione di episodio lascia intravedere.Anche l'etimologia del termine (che per non sappiamo quanto sia antico, dato che compare per la prima volta proprio in Aristotele) sembra suggerire un ruolo secondario degli attori rispetto al coro: indica
-
un'aggiunta, un inserimento e un percorso; dunque significherebbe qualcosa di inserito secondariamente in una trama preesistente. E anche l'uso del termine al di fuori della tragedia illuminante: sempre Aristotele definisce "episodio" il Catalogo delle navi di Iliade II, a rimarcare che esso una digressione che potrebbe essere eliminata senza toccare la struttura portante del poema.Tornando all'Agamennone, queste poche osservazioni possono farci notare una cosa a mio avviso interessante. Se confrontiamo la parodo col primo episodio, che ora leggeremo, osserviamo che la parodo ben pi drammatica dell'episodio: pi drammatica proprio in senso etimologico, cio pi dotata di azione ( = agisco). La bellissima descrizione del percorso seguito dal segnale di fuoco da Troia ad Argo, che forma il cuore del primo episodio, ben poca cosa, sul piano drammatico, rispetto agli eventi di Aulide narrati dal coro. Insomma, l'Agamennone forse ci testimonia uno stadio arcaico del genere tragico non solo per l'enorme estensione della parodo, ma anche per il fatto che il canto del coro mantiene un notevole ruolo drammatico.
Sticomitia e rhesisIn un episodio di tragedia possiamo naturalmente trovare sia dialoghi che monologhi.Il dialogo il pi delle volte non segue un andamento libero, in cui ciascuno degli interlocutori utilizzi per ogni battuta un numero variabile di versi, ma strutturato rigidamente in una sticomita (): due attori, oppure un attore e il corifeo, si scambiano battute di un singolo verso ( = verso). Nel primo episodio abbiamo una sticomitia nei versi 268-281 (14 versi); nel secondo ai vv. 538-551 (di nuovo 14 versi); nel terzo episodio ai vv. 931-944 (ancora 14) e cos via. Le battute possono essere anche di due versi ciascuna (vv. 620-635); in tal caso si parla di disticomitia. Le sticomitie sono parti vivaci sul piano drammaturgico, di ritmo incalzante.Il monologo spesso costituito da un lungo racconto nel quale un attore, non di rado un araldo () o un messaggero (), informa gli altri personaggi di eventi avvenuti in altro luogo o in altro tempo. Un monologo del genere si chiama rhesis (). Le rheseis sono spesso parti di grande effetto nelle quali l'arte della parola dispiega i suoi mezzi per evocare vividamente eventi che non potevano essere rappresentati sulla scena, innanzitutto per restrizioni di luogo e di tempo. Difatti la tragedia antica rispetta la cosiddetta unit di luogo e di tempo (che molti secoli dopo assurger a dogma per i teorici del Rinascimento) per cui non vi cambio di scena dall'inizio alla fine
-
del dramma e non ci sono salti temporali: le rheseis permettono quindi di arricchire la trama con eventi che avvengono o sono avvenuti altrove. Inoltre ci sono anche dei fatti che sono raccontati nelle rheseis per motivi di opportunit: per esempio le scene di morte (la morte non viene mai rappresentata sulla scena nella tragedia greca). Nel nostro primo episodio leggeremo la celebre rhesis in cui Clitemestra descrive il "viaggio del fuoco" che ha portato da Troia ad Argo l'annuncio della vittoria.
Traduzione e commento vv. 258-280Ricorda che nel coro si distinguono i coreuti (, danzatori) e il corifeo (, capo); i primi cantano, quest'ultimo pu dialogare con gli attori che sono sulla scena. Dal v. 258 i trimetri giambici sono del corifeo, che si rivolge a Clitemestra.
258 cor. Giungo venerando la tua autorit, Clitemestra:259 di un uomo che sovrano infatti giusto onorare260 la moglie, quando il trono privato del maschio.261 Ma tu se essendo informata di qualcosa di buono oppure no,262 per speranze dal buon annuncio, sacrifichi,263 ti ascolterei benevolo; ma se tacessi non te ne vorrei.264 Cl. Dal buon annuncio, come dice il proverbio,265 sia l'alba che nasce dalla madre notte.266 Ma apprenderai un gaudio pi grande della speranza ad udirsi:267 gli Argivi infatti tengono la citt di Priamo.268 cor. Come dici? Dall'incredulit mi sfuggita la tua parola!269 Cl. Che Troia degli Achei. Parlo chiaramente?270 cor. Mi invade una gioia che suscita le lacrime.271 Cl. Difatti il tuo occhio denuncia la tua benevolenza...272 cor. Ma qual la garanzia? Hai una prova di queste parole?273 Cl. L'ho, perch non dovrei? A meno che un dio non m'abbia ingannato.274 cor. Forse rispetti persuasive apparizioni di sogni o...275 Cl. Non accetterei il pensiero di una mente appesantita dal sonno.276 cor. Ma ti ha per caso saziato una voce senz'ali?277 Cl. Hai proprio biasimato la mia mente come quella di una bambina!278 cor. Ma precisamente, da quando la citt distrutta?279 Cl. Dico dalla notte che or ora ha generato questa luce.280 cor. E quale tra i messaggeri potrebbe giungere a questa velocit?
-
258 : il participio presente viene inteso come finale, ma difficile che lo scopo della venuta del coro sia venerare la regina; pi probabilmente il valore implicito causale: il coro si presenta davanti alla reggia poich venera la regina e dunque ha obbedito subito alla sua richiesta di venire (richiesta che dobbiamo presupporre).
: anche la vedetta aveva usato lo stesso vocabolo parlando dell'autorit di Clitemestra (v. 10 ).259 : equivalente a ma non prosastico.
: non confondere , , "uomo", con , (279, 292) forma contratta di (300, 302, 311), "luce". La traduzione di con "uomo" quasi inevitabile, ma come in tanti altri casi la traduzione appiattisce la grande ricchezza lessicale della lingua poetica greca. Infatti i poeti disponevano di tanti sinonimi, originati anche dal fatto che la lingua poetica si era formata con una stratificazione progressiva in cui non andava perso nulla del passato, a partire da tutto il patrimonio lessicale dell'epica omerica. Vedrai in seguito quale variazione lessicale ci sia nel racconto di Clitemestra. L'aggettivo ( + ) in genere usato dando ad il significato di "inizio" e dunque nel senso di "primario, iniziatore, fondatore"; Eschilo lo usa prendendo nel significato di "comando" e dunque nel senso di "capo, sovrano".260 : il genitivo assoluto (part. aor. passivo) , mentre l'altro genitivo (, maschio) reggenza del verbo piuttosto che specificazione di . Di qui ricomincia la schermaglia esegetica tra Frnkel e Page/Denniston: il primo sostiene che il coro si rivolge alla regina in maniera deferente, i secondi invece che nell'accenno al trono privo del re c' uno svilimento dell'autorit della regina.261 ...: part. perfetto di ; se = apprendo, vengo a sapere, = sono venuto a sapere e quindi sono informato. Le "speranze dal buon annuncio" (con aggettivo di ) sono naturalmente le speranze di un buon annuncio ( ).262 : significa in sostanza "sacrifico", ma con in pi l'idea di movimento: , grado forte di (), propriamente un movimento rotatorio, difatti si applica alla volta celeste, all'asse terrestre (da cui il nostro polo). Ma la radice produttiva di diversi sostantivi che indicano un movimento "in qua e in l" fatto da chi attende a un mestiere: il capraro ( = capra), (il dovuto a ragioni fonetiche) il bovaro.
-
Dunque il coro domandando alla regina se essa riprende esattamente la domanda che le aveva fatto in absentia (senza che lei fosse presente) al v. 286: , "per la persuasione di quale annuncio sovrintendi a sacrifici disposti tutt'intorno?".263 : naturalmente complemento predicativo del soggetto.
: un periodo ipotetico della possibilit con protasi implicita () e apodosi ellittica del verbo ( = ); il participio al dativo, invece che un pi ovvio (per noi) genitivo assoluto, si spiega col fatto che (malevolenza), come il verbo , regge il dativo di colui a cui diretto il sentimento; dunque l'espressione completa sarebbe , "non ci sarebbe malevolenza contro di te se tacessi". Beninteso, nulla vieta di ricostruire un periodo ipotetico dell'eventualit: , "non ci sar malevolenza contro di te qualora tacessi". Nota anche l'uso dell'aoristo per un'azione che cronologicamente futura: uso del tutto regolare, dato che il participio aoristo non ha di per s valore temporale.264 : la regina palesemente riprende l'aggettivo usato dal corifeo, inserendolo in un proverbio (). Anche i greci, come noi, erano appassionati di proverbi, e la paremiografia fu addirittura un genere letterario, del quale sono rimaste numerose raccolte. Questo proverbio per non ci testimoniato altrove e il suo significato non molto chiaro. Secondo Frnkel significa: "stanotte abbiamo ricevuto il buon annuncio: possa il futuro (l'alba, , viene dopo la notte, che sua "madre") essere altrettanto buono". Ma mi sembra una spiegazione debole: appunto perch l'annuncio gi arrivato, che senso ha augurarsi che il futuro sia dal buon annuncio? Io sospetto che nella risposta della regina ci sia qualche allusione sinistra, che per non riesco a determinare: me lo fa pensare la posizione di , che sembra voler ribattere al coro rovesciando in qualche modo le sue parole.265 : raro vocabolo poetico per "notte", lett. "la benevola". Frnkel nega che ci possa essere un riferimento a di due versi prima, io non ne sono sicuro (come ho detto, sospetto che ci sia qualcosa che non abbiamo ancora capito).266 : futuro ind. II sing. del solito .
: un sinonimo, pi raro, di , che usato quattro versi dopo. Ho reso "gaudio" per mantenere la sinonimia e usare una parola pi letteraria.
: auditu. Abbiamo gi osservato come nella lingua di Eschilo l'infinito semplice sia usato con grande libert: consecutivo, finale, qui limitativo. Osserva l'accento e nota la raffinata congettura di West: i codici
-
hanno , infinito presente, ma qui serve l'azione in s stessa, aoristica, non l'aspetto durativo.267 ... : nota il solenne iperbato (separazione di due termini di un sintagma), qui molto evidente perch le parole in iperbato sono collocate alle estremit del verso, quindi in posizione di rilievo. Il perfetto esprime, come da manuale, la condizione presente derivata da azione passata: allo stesso modo v. 30.268 ; inizia la sticomitia. Il corifeo incredulo () e non crede alle sue orecchie. Frnkel osserva che l'allitterazione in p ( ; ) sembra esprimere concitazione, e pu citare passi paralleli. crasi per .269 ... : il participio all'accusativo dipende da un implicito nel precedente. Rispetto alla comune costruzione con l'infinitiva ( ), il participio sembra pi espressivo, pi diretto. una particella interrogativa analoga al latino -ne; lo stesso avverbio che la vedetta aveva usato dicendo di voler annunciare a Clitemestra l'avvistamento del segnale di fuoco ( ): etimologicamente qualcosa di "penetrante".270 : da ed , gemello del latino serpo, indica un sentimento che si diffonde quasi indipendentemente dalla volont di chi lo prova, quasi furtivamente.271 : i commentatori notano che il verbo non ha qui il consueto significato di "accusare". Ma forse sbagliano, come ha visto Elena: infatti, dal punto di vista della regina, la benevolenza del coro rivolta ovviamente ad Agamennone pu essere una colpa, che lo sguardo di gioia tradisce e rivela. Sintatticamente il pronome , che specificazione di , vale anche come oggetto di , che regge il genitivo: "il tuo occhio accusa te che sei benevolo".272 : termine tecnico. Nelle battute di un dialogo il ha spesso un valore asseverativo, diverso da quello esplicativo e difficilmente traducibile; in genere si spiega con una ellissi: "certo (una garanzia deve esserci): qual ?"273 : genitivo assoluto con valore ipotetico; dall'apodosi si ricostruisce una protasi della realt, dalla conoscenza della vicenda una protasi al passato: . 274 : inizia una interrogativa diretta disgiuntiva (... ), che per non sar completata perch nella sticomitia la regina toglie la parola al corifeo; la seconda parte della domanda sar posta subito dopo in forma semplice. Dall'allusione di Clitemestra a un possibile "inganno" da parte di un dio, gi
-
avvenuto (), il coro trae la ragionevole conclusione che ella sia stata visitata da un sogno: non ci dimentichiamo che il sole sorto da poco e fino alla sera precedente non c'era stato nulla che potesse far sospettare alcunch di nuovo.275 : non genitivo assoluto ma specificazione di , col participio in funzione attributiva. un rarissimo verbo hapax legomenon in Omero (cio "detto una volta sola") e ripreso solo da Eschilo; forse parente di , che significa "sono pesante", e indica la pesantezza indotta dal sonno.276 : espressione enigmatica. In Omero comune la frase , "diceva parole alate", che viene interpretata in vari modi. La parola pu essere alata perch vola dalla bocca all'orecchio; perch veloce come un uccello; perch va dritta al bersaglio come una freccia dotata di alette stabilizzatrici del volo. E una parola senz'ali? In teoria, pu essere 1) una parola che non vola dalla bocca all'orecchio, quindi resta inespressa; oppure 2) una parola che non colpisce il bersaglio, una parola che vaga, quindi una parola vaga. Negli antichi grammatici troviamo altre interpretazioni: 3) "improvvisa/rapida" e 4) "piacevole", che non so da quali indizi siano corroborate. Potremmo anche cambiare lo spirito e prendere l'alfa come copulativo, non privativo: significherebbe 5) "ben alato" e pertanto si renderebbero disponibili i vari significati di ... Se non abbastanza, sappi che compare una volta nell'Odissea in un'espressione ( ) che, anche lei, ancora attende di essere risolta.
: aoristo di . Ho tradotto "saziare" ma nel verbo, che significa propriamente "ingrasso", forse c' il concetto contrapposto a quello della sottigliezza, dell'acutezza: pertanto significherebbe qualcosa come "stordire, instupidire".277 : la preposizione in anastrofe (per questo ha l'accento).278 : il genitivo semplice di tempo determinato va di regola inteso diversamente, non "da quale tempo, da quando" ma "in quale tempo, quando"; qui invece, col perfetto , necessario intenderlo come , da quando (la citt distrutta). Il non vale n "e" n "anche", ma qualcosa come "appunto".279 ...: la sintassi intrecciata: ( ) .280 : la domanda del coro scontata, data la distanza tra Troia e Argo. Ci rende ancora pi sorprendente la risposta che Clitemestra dar al verso seguente.
-
Traduzione e commento vv. 281-316Nella rhesis di Clitemestra, che ripercorre le tappe del segnale di fuoco da Troia ad Argo, il poeta aveva l'esigenza di menzionare molte volte di seguito le stesse cose: il segnale di fuoco, il monte al quale giunge di volta in volta, la vedetta che lo osserva e lo trasmette. Anche se gli antichi non avevano per le ripetizioni lessicali lo stesso terrore che noi, italiani di oggi, maturiamo a scuola, resta vero che soltanto nell'epos omerico esse sono tollerate gradite, addirittura senza alcun limite; altrove i poeti variano l'espressione, in maggiore o minore misura, ricorrendo ai sinonimi. Anche Eschilo ha qui usato sapientemente parole sinonime per ravvivare il lessico. Per noi (e chiss, forse anche per i greci) non facile determinare precisamente la differenza di significato tra i vari sinonimi, ma bisogna almeno rendere la variet lessicale evitando di tradurre due diversi termini greci con la stessa parola italiana. Anticipo, anche per leggere con pi facilit il commento, i sinonimi usati da Eschilo e le rese che ho adottato.Monte (285, 309), altura: dai passi poetici in cui compare l'aggettivo si
ricava che l'idea principale quella di altitudine, forse anche di ripidezza. (283, 298), rupe: l'etimologia sembra ricondurre al significato di
scabro, non liscio ( la buccia di un frutto, o la squama di un pesce, o le scaglie di un animale; la scabbia, e poi la lebbra); dunque evoca non tanto l'altezza quanto l'aspra conformazione del suolo.
(303), monte: qui la resa italiana obbligata.Fuoco (287, 296), fiaccola: da , splendo, si specializza nel senso di
fiaccola ma potenzialmente qualsiasi fonte di luce. (284), face: forma senza aspirazione (rara, e recuperata dalla tradizione
indiretta) del pi comune (da , la luce), che indica una fiaccola o torcia; rendo face, latinismo, perch fiaccola e torcia sono gi impegnati da altri sinonimi e anche per tradurre una parola che rara in greco con una rara in italiano.
(282, 299, 304, 311), fuoco: termine comune. (281, 289), bagliore: si usa per luci molto forti, come quella del sole o di
un lampo. (306), fiamma: termine comune. (282), torcia: da , che significa brucio, arrostisco, e
probabilmente un verbo onomatopeico. (292, 300, 302, 311), luce: termine comune.
-
Vedetta (289, 309), osservatrio: , vedere, una radice molto prolifica;
a quanto pare il luogo (osservatrio) piuttosto che la persona (osservatre, che si dice propriamente ).
(301), guardia: il termine usato anche per presidi militari che devono controllare un luogo conquistato.
(293), vedetta: in c' l'idea di guardare per difendersi, di guardarsi da qualcosa. Un'alternativa pu essere sentinella.
281 Cl. Efesto, inviando dall'Ida uno splendente bagliore:282 e la torcia con un'altra torcia qui lo invi, a partire283 da quel fuoco messaggero. L'Ida, verso la rupe Erma284 di Lemno; e la grande face che proviene dall'isola per terza285 accolse l'Ata altura di Zeus,286 e sublime cos da varcare la schiena del mare287 la forza della fiaccola viaggiatrice con piacere
...288 il pino come un sole il bagliore luminoso d'oro289 annunciando agli osservatri del Macisto.290 E lui non indugiando in nulla n sconsideratamente 291 vinto dal sonno trascur la sua parte di messaggero,292 ma lontano la luce della torcia sopra le correnti dell'Euripo293 annuncia di esser giunta alle vedette del Messapio.294 E quelle lampeggiarono di rimando e trasmisero avanti il messaggio,295 accendendo col fuoco un mucchio di vecchia erica;296 e la fiaccola conservando la sua forza e non ancora oscurandosi297 balzata sopra alla pianura dell'Aspo come298 una lucente luna verso la rupe del Citerone299 dest un'altra vicenda del fuoco messaggero.300 La guardia non rifiut la luce inviata da lontano,301 bruciando pi delle precedenti;302 e la luce piomb sopra la palude Gorgpide303 e giungendo sul monte Caprvago304 incit a non trascurare l'ordine del fuoco:305 e ardendola con vigore abbondante inviano306 una grande barba di fuoco, e dello stretto307 Saronico l'adiacente promontorio superare in avanti308 bruciando; poi piomb, poi giunse
-
309 sull'altura Aracna, agli osservatri vicini alla citt;310 e quindi piomba in questo tetto degli Atridi311 questa luce non priva di avo del fuoco dell'Ida.312 Tali (sono state) per me le leggi dei tedfori,313 l'uno colmato dall'altro nei loro scambi:314 e vince il primo e l'ultimo che ha corso.315 Tale prova e segno ti dico316 di mio marito che da Troia mi ha trasmesso l'annuncio.
281 : il dio della metallurgia e quindi del dominio sul fuoco; per antonomasia il fuoco stesso, ma qui la figura retorica non annulla del tutto il significato proprio, dato che Efesto definito un messaggero e compie l'azione di inviare un bagliore; insomma in qualche modo dietro al fuoco si sente ancora la presenza del dio.
: il genitivo di moto da luogo retto da , preverbo di . L'Ida il massiccio montuoso della Troade pi volte menzionato nell'Iliade, il luogo dove Zeus si pone per osservare pi da vicino gli eventi di Troia.282 : poliptto. Il dativo una congettura che rende necessario sottintendere il precedente come oggetto di : i codici hanno , che sarebbe il compl. oggetto espresso (la torcia invi qui un'altra torcia).
: ovviamente qui ad Argo. : l'aggettivo stato recuperato dalla
tradizione indiretta, mentre tutti i codici hanno il pi banale . La parola viene usata da Erodoto per indicare i postini del celebre servizio postale persiano; pi genericamente indica (come il sostantivo ), una persona che costretta a un lavoro per conto dello stato (un'anghera...). suggestivo che Eschilo abbia usato, per indicare la fiaccola di partenza situata nella Troade, un termine che poteva ricordare i Persiani, che ai suoi tempi controllavano quella regione.283 : sottinteso .
: nei commenti non trovo informazioni sul rapporto tra Ermes e l'isola di Lemno. Lemno, la maggiore tra le isole al largo della Troade, spesso citata nell'Iliade: gli Achei vi hanno lasciato Filottete, che poi dovranno andare a riprendere perch altrimenti Troia non potr essere espugnata (2, 722); da essa giungono rifornimenti di vino (7, 467); Era vi giunge dall'Athos e vi incontra il Sonno (14, 230), poi i due volando giungono sull'Ida (14, 281). Quest'ultimo passo per noi molto significativo, perch il segnale di fuoco
-
dell'Agamennone fa in senso inverso le medesime tappe: l'Ida, Lemno, l'Athos.285 : il monte situato sul promontorio pi orientale dei tre che si dipartono dalla penisola Calcidica, a sud della Macedonia. Il percorso verso nord-ovest sembra illogico, dato che la meta finale Argo, ma da Lemno sarebbe stato impossibile tagliare verso sud-ovest in direzione dell'Eubea. L'altura, , veramente alto: 1935 metri. Prezioso il frammento 709 di Sofocle, nel quale si dice che al tramonto l'ombra dell'Athos giungeva fino a Lemno.286 : con la congiunzione inizia una nuova frase che ha per soggetto , ma il verbo manca; per questo stata postulata una lacuna. Inoltre sembra anche che, dal monte Athos alla tappa successiva, la distanza sia troppo grande: si suppone quindi che nella lacuna fosse menzionata una tappa intermedia. L'aggettivo viene spiegato da Denniston come che si innalza al di sopra, mentre Frnkel propende per che va oltre l'ordine: in ogni caso rimarca che il terzo fuoco particolarmente imponente, tanto da superare il mare ( ). A causa della lacuna resta in sospeso anche il complemento , un costrutto tragico che equivale a (avevamo gi trovato = , v. 130).288 : il pino, qui per sineddoche una catasta di legno di pino. un legno resinoso che d una fiamma viva, molto brillante: , il bagliore luminoso d'oro. Il verbo principale di questa frase , come quello della frase precedente, scomparso nella lacuna: rimane il participio congiunto al verso seguente, che regge il dativo .
: pi oltre (297) la similitudine sar con la luna, .289 : non si hanno notizie di questo monte, ma dai versi seguenti si pu forse dedurre che esso si trovava sull'isola di Eubea: infatti nella tappa successiva il segnale di fuoco passa sopra le correnti dell'Euripo, cio sopra lo stretto che divide l'Eubea dal continente. Non deve essere un monte di poco rilievo, data l'ovvia etimologia ( superlativo di , che vale normalmente lungo ma anche grande, e a volte significa alto). 290 : sembra un pronome relativo neutro che riprenda ( sott. , il monte Macisto), ma i due participi congiunti e sono maschili; pertanto la forma del dimostrativo , , . Proprio da questo dimostrativo, frequente in Omero, nato l'articolo , , che ha maschile e femminile proclitici (senza accento). Di conseguenza per Eschilo anche Macisto maschile.292 : l'avverbio va con (annuncia lontano) o con (di
-
esser giunta lontano). Soggetto . : lo stretto tra l'Eubea e la Grecia continentale. usato
anche se propriamente ci vorrebbe (senza contatto, over); il complemento di moto per luogo dipende da , participio aoristo neutro di . Bisogna dire per che, vicino a , + accusativo vale pi normalmente come moto a luogo: in tal caso l'espressione significherebbe annuncia di essere giunta sullo stretto dell'Euripo, che sarebbe la destinazione; di conseguenza il misterioso monte Macisto potrebbe trovarsi anche lontano dall'isola di Eubea () e pi vicino al monte Athos.293 : il monte menzionato (se l'integrazione giusta: il papiro lacunoso) in un frammento di un'altra tragedia di Eschilo, il Glauco Potnio: l definito un e , una rupe brulla e alta, situata dirimpetto a Calcide (citt dell'isola di Eubea che a sua volta dirimpetto ad Aulide, il porto da cui sarebbero partiti gli Achei; dunque il monte Messapio sarebbe vicino ad Aulide). Secondo altre fonti era un monte dell'Eubea, secondo altre addirittura tra l'Eubea e la Beozia, il che significherebbe in acqua...295 : dal grado forte della radice di , ci che stato posto. L'erica vecchia, cio ben secca, un altro combustibile idoneo a sviluppare una fiamma intensa e poco duratura.296 : l'espressione e non ancora oscurandosi ha creato problemi, in quanto ci chiesti perch Eschilo dovrebbe insinuare proprio in questa tappa il dubbio che il segnale di fuoco si oscuri, mentre non lo ha fatto nelle prime tre che sono ben pi lunghe. Probabilmente ancora si spiega con l'idea che il segnale, perpetuato di tappa in tappa, sia in sostanza il medesimo che partito da Troia: pertanto a questo punto, dopo un percorso che gi cos lungo, diviene significativo rimarcare che esso non si ancora indebolito.297 : da , balzo al di sopra. Rispetto alla radice il presente ha metatesi () e apofonia quantitativa () pi il suffisso . L'Asopo il fiume principale della Beozia; oltrepassando la sua pianura si giunge dall'altra parte della regione, verso il monte Citerone.299 : da , ricevo, propriamente la ricezione; ma spesso la parola usata a proposito di una successione e quindi vale essa stessa successione, vicenda. Il Citerone un altro monte importante nel mito: su di esso fu abbandonato il piccolo Edipo.301 : due le interpretazioni possibili: 1) bruciando pi di quelle dette, cio dei segnali di fuoco precedenti; per non si capisce perch la fiamma del Citerone debba essere pi grande delle precedenti; 2) bruciando pi degli ordini ricevuti; questo a me non piace affatto, perch
-
dovremmo supporre da un lato che Agamennone avesse preordinato la quantit di legno da bruciare, dall'altro che le vedette siano state prese da un eccesso di zelo: assurdo. In entrambi i casi, il participio sostantivato pesante e suona prosastico. Una congetturina:
, gioendo pi delle predette302 : la palude (o il lago?) Gorgopide non stata identificata, e neppure il monte Caprvago che costituisce la tappa successiva al Citerone. In mancanza di specchi d'acqua dolce si fatta anche l'ipotesi che la prima sia il tratto di mare tra l'Attica e l'Argolide, noto come Golfo Saronico; in tal caso il monte potrebbe essere (con un gioco di parole) l'isola di , un luogo familiare per gli Ateniesi; e per finire lo stretto Saronico menzionato al v. 306 sarebbe precisamente il braccio di mare tra Egina e l'Argolide.303 : il significato che ci deve essere lo intuiamo (sempre che non siamo troppo presuntuosi), ma non ci sono ancora congetture abbastanza buone per il testo che sicuramente corrotto.305 : una forma sincopata per . significa propriamente do fuoco e sembra (a partire dal suo valore etimologico di moto verso l'alto) suggerire l'idea della nascita, dello svilupparsi delle fiamme (come in , dal semplice ).306 : un'immagine molto efficace, che sar imitata da Euripide. Naturalmente si deve pensare a una barba rovesciata. 306 ...: ci sono due gravi problemi di sintassi: 1) il participio femminile non ha un nome cui riferirsi; 2) l'infinito non ha un verbo che lo regga, e se lo si intende come autonomo (valore consecutivo) diviene assurdo il . Ci sono varie congetture.307 : lo stretto, per cui improbabile che per Eschilo intenda, come si fa oggi, tutto il golfo tra Attica e Argolide; una prominenza, sporgenza e tipicamente un promontorio. Il sostantivo (da e , vedere, col suffisso - dei nomina agentis, cio di chi compie l'azione) vale colui che guarda verso: qui apposizione di e regge il genitivo del luogo geografico nel senso di prospiciente (prospiciente ha un'etimologia analoga, da pro e specio, guardo avanti).308 ... : trattandosi di un segnale luminoso, sono per forza due momenti che nella realt non potevano essere granch distinti; per Frnkel sono cos poco distinguibili che egli ritiene corrotto il testo e pone le croci; e naturalmente non mancano le congetture.
-
309 : siamo arrivati! il monte Arna, dice Frnkel, situato tra Argo ed Epidauro e alto circa 1200 metri.311 : la staffetta dei segnali di fuoco ora vista come una genealogia in cui un fuoco il padre dell'altro; l'ultimo quindi ha nel primo il suo avo ( propriamente il nonno).312 : un termine molto significativo. Ad Atene ogni anno si svolgevano alcune gare nelle quali squadre di corridori, rappresentative delle diverse della citt, dovevano portare una fiaccola dall'altare di Prometeo, situato nei sobborghi, fino a un tempio del centro. Prometeo il dio che ha rubato il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini: la gara era dunque anche un rito nel quale i fedeli riportavano agli dei quel fuoco che loro apparteneva. La gara era notturna e procedeva a staffetta, con i corridori disposti in punti fissi del percorso. Si pu immaginare quale suggestione essa emanasse e come lo scenario della (o ) fosse familiare a ogni ateniese. Eschilo scriveva per i suoi concittadini e nella rhesis di Clitemestra sapeva di ridestare in loro immagini forti e suggestive.
: le leggi possono essere intese come disposizioni, ordini (cf. , ordine, al v. 304), ma l'espressione non convince del tutto; altri scrive , sedi, con allusione ai monti che hanno segnato le tappe del percorso.313 ...: il verbo forse vale rifornire, anche se non sembra adeguato per l'azione di accendere una fiaccola da un'altra; oppure completare, nel senso che i segnali di fuoco si completano l'un l'altro.314 : un bel verso che per ha creato difficolt. Chi il primo e chi l'ultimo, e in che senso entrambi vincono? Varie ipotesi:1) sono la stessa persona: il primo, cio colui che giunge al traguardo, in una staffetta anche l'ultimo, nel senso di quello che ha corso l'ultima frazione;2) il primo chi giunge al traguardo, l'ultimo quello che ne resta pi lontano, cio chi ha corso la prima frazione: ma entrambi vincono allo stesso modo perch la squadra che vince;3) il primo chi ha corso la prima frazione, l'ultimo chi ha corso l'ultima ed giunto al traguardo, ma entrambi vincono (come n. 2).315 : lo stesso termine che il corifeo aveva usato nel chiedere una prova alla regina (272); quest'ultima ha risposto esaurientemente e lo fa notare.