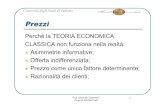· Web viewIl corpo del soggetto con disturbo grave di personalità reca i segni di questa...
Transcript of · Web viewIl corpo del soggetto con disturbo grave di personalità reca i segni di questa...

II CAPITOLO
IL CORPO TRA NATURA E CULTURA
I bear a charmed life which must not yield
To one of woman born.
(“Possiedo una vita incantata, che non dovrò cedere a nessun nato da donna”)
William Shakespeare, Macbeth, V, vii 41-42.
NATURA, CULTURA, E IN-BETWEENESS CORPOREA ED
EPIGENETICA
Il corpo è il luogo in cui si inscrivono sia la Natura, come genetica e patrimonio biologico ereditato,
che la Cultura, come ambiente fisico e relazionale. La ricerca nell’epigenetica (Hofer,1984; Meany,
2001; van Ijzendoorn et al., 2011; Schore, 2013, in Narvaetz et al., 2013; Alexander, 2015) ci ha
permesso di comprendere come l'espressione del patrimonio genetico (ciò che è alla fine espresso o
silenziato nel DNA) può essere modificato da meccanismi come la metilazione, che si sviluppa
appunto attraverso influenze dovute all'ambiente. Come nota Allan Schore, nelle interazioni tra il
bambino e la persona che si prende cura di lui, quest’ultima fornisce esperienze che modellano il
potenziale genetico del bambino, agendo come regolatori (o disregolatori) psicobiologici di ormoni
che influenzano direttamente la trascrizione genica. Attraverso questi meccanismi, processi psico-
neuroendocrini che si verificano durante periodi critici danno origine a effetti permanenti a livello
genomico, che influiscono sullo sviluppo dei circuiti cerebrali (Schore 1994).
La continuità nello sviluppo implica cambiamenti progressivi in risposta a vari aspetti biologici e
ambientali. La vita richiede la continua negoziazione tra questi due termini, la Natura da un lato,
con la sua base biologica, e la Cultura, con le sue costruzioni legate all'ambiente, alle relazioni e a
più astratte e simboliche configurazioni dell'altro.
Concetto straordinariamente complesso (Geertz, 1998; Paul, 2015; Schore, 1996), la “Cultura”
racchiude l'insieme delle pratiche simboliche e materiali, con tutte le richieste poste al soggetto
attraverso il corpo, dal modo in cui ci vestiamo a come ci tagliamo i capelli, a seconda del genere,
dell'età, dello status, del ruolo e della posizione in società, fino alle aspettative costruite attorno alla
nostra appartenenza a un sesso biologico, in ciò che rimane tradizionalmente una cultura binaria.
1

La cultura stessa fa parte di un binarismo di cui l'altro termine, la Natura, è stato visto spesso come
l'“altro”, il termine svalutato. Antropologi culturali infatti hanno investigato gli aspetti simbolici e
sociali di questo binomio: nella maggior parte delle culture conosciute, la dicotomia Natura/Cultura
replica l'opposizione stessa e la proiezione di un potere che sanziona la dominanza del maschile sul
femminile, fondamentalmente la questione posta già quaranta anni fa da Sherry Ortner quando
chiedeva “ La Femmina sta al Maschio come la Natura sta alla Cultura?” (Ortner, 1974).
Esempi di questa complessa interrelazione tra cultura, corpo e società sono ben visibili in varie
manifestazioni culturali, nel campo artistico, nel teatro, come nella pittura o nella letteratura.
Valga, a riprova di queste inscrizioni culturali, il semplice esempio di Macbeth, composto da
Shakespeare probabilmente attorno al 1603, in cui l’eroe che ucciderà Macbeth deve essere un “non
nato da donna”, ovvero Macduff, “estratto anzi tempo dal grembo materno” in quanto nato con
parto cesareo, e perciò, secondo la costruzione culturale misogina del tempo, non contaminato
dall’impurità degli orifizi femminili (secondo una visione del femminile costruito culturalmente che
ho esplorato, per il periodo elisabettiano, in Mucci 2001 e Mucci 2009), seguendo la traccia
culturale ben nota di Mary Douglas e del suo magistrale Purezza e pericolo (2003), a cui rimando.
Luoghi marginali di radicale in-betweeness, in cui potere e dominazione vengono imposti (si
veda il loro uso privilegiato in senso sadico nelle torture medievali e la ricerca di segni particolari
corporei nelle streghe e negli eretici, gruppi marginali e sovversivi), gli orifizi corporei, aperture
che connettono interno ed esterno, sé e altro, diventano facilmente luoghi di dominazione culturale,
visioni di potere basate sul genere e ad alta densità psicologica. Come aperture verso un mondo
esterno carico di significati, in cui posizioni simboliche di potere patriarcale sono inscritte in un
corpo che, se è femminile dovrebbe essere in posizione di passività e al fondo della scala sociale, se
è maschile dovrebbe essere (culturalmente) caratterizzato da attività e predominio, gli orifizi
sanciscono un territorio liminale che, come tale, è particolarmente fragile e soggetto all’iscrizione
del potere e di quello che quel potere pone al suo centro, o nel suo "alto". Un ottimo esempio di
queste pesanti iscrizioni culturali è rappresentato da Elisabetta I d'Inghilterra, corpo paradossale,
perché incarnava contemporaneamente l'alto e il basso di quella struttura gerarchica rinascimentale,
come sovrano e capo politico e al tempo stesso come donna, la cui "debolezza" simbolica è legata al
corpo-segno per millenni della corruttibilità del femminile, con la sua carne così prona a debolezze
e a vulnerabilità fisiche e morali, secondo una cultura che nel medioevo faceva della donna una fe-
minus, meno degna di fede, e la avvicinava alle possessioni demoniache e alle seduzioni del diavolo
(si veda Mucci, 2009).
Il corpo, preso nelle reti culturali di dominanza e sottomissione, specie nelle sue zone di
vulnerabilità e nei suoi limiti corporei e nelle sue aperture, (di solito considerate peccaminose o
2

lascive o sporche), sancisce, in modo visibile, interno ed esterno, inclusione ed esclusione,
accettazione e rifiuto, dominanza e sottomissione, e perfino abiezione, con una generalizzata
tendenza, in tutte le culture di cui sono a conoscenza, alla sottomissione del femminile (ciò che è
costruito come femminile, dalla cultura, non in senso biologico né come essenza, e quindi riguarda
anche ciò che è più tenero, sensibile, accidente)1 al maschile. Vedo, pertanto, il corpo come
soggetto a forze culturali di dominazione e luoghi sensibili di negoziazione di potere collettivo e
individuale. Il fatto che la maggior parte dei disturbi di personalità borderline sia costituito da
pazienti donne mi sembra un chiaro segno di un disagio che, attraverso la dominazione, la
repressione culturale e la violenza, agiscono sul femminile. Il corpo reca queste tensioni culturali, e,
purtroppo, le replica in un meccanismo di vittima-persecutore (in cui il soggetto traumatizzato e già
vittima rende il proprio corpo o il proprio figlio vittima nuovamente), in una ripetizione che non è
certo ripetizione di un inconscio astratto, ma casomai culturale. La distruttività a cui questi corpi
sono sottoposti/si sottopongono è un chiaro segno delle tensioni che vengono giocate su questi
soggetti sofferenti attraverso i loro comportamenti distruttivi.
Il corpo, luogo di radicale in-betweenness (liminalità e zona di transizione), abitato da e tra Natura e
Cultura, tra filogenesi e ontogenesi, tra eventi e inscrizioni storiche personali e riflessi collettivi e
culturali, tra genetica ed epigenetica, reca le sue irrimediabili e dense iscrizioni e stratificazioni
soggettive, interpersonali e intergenerazionali, che sono lì esposte all'altro perché le legga e ne
faccia qualcosa. La pratica dell'attaccamento, non limitato agli esseri umani, è il primo veicolo di
questa rete intricata di scambi e iscrizioni, un veicolo intergenerazionale che collega processi
epigenetici e interpersonali.
Se teniamo a mente questa interconnessione di Natura e Cultura così come si manifesta nel
soggetto, ciò può aiutarci a capire perché certe patologie mentali e psicologiche diventino così
diffuse in certi momenti storici, come era il caso delle isteriche alla fine dell'Ottocento, e come sta
accadendo oggi per i disturbi di personalità e i disturbi alimentari nel mondo occidentale. Vale la
pena di investigare il fatto che sia le isteriche che la maggior parte dei pazienti borderline e con
disturbi alimentari siano donne, tenendo conto anche delle dinamiche di rappresentazione del
genere, della sessualità e del potere.
CORPI NATURALI, CULTURALI E DEFINITI DAL GENERE IN SEDUTA
1 Ho chiarito questi concetti anni fa con A memoria di donna. Psicoanalisi e narrazione dalle isteriche di Freud a Karen Blixen, Roma, Carocci, 2004, e I corpi di Elisabetta. Sessualità, potere e poetica della cultura al tempo di Shakespeare. Pisa, Pacini, 2009.
3

Il corpo è anche fondamento della relazione nel campo bipersonale della seduta terapeutica: la
seduta è, infatti, il luogo in cui, prima di tutto, due corpi, due individui, uno o più generi, due
identità e storie, di età diverse o simili, si incontrano. Dall'incontro anche corporeo dato dallo
sguardo, dalla voce, dai fattori prossemici, dalle transazioni sensoriali e psicomotorie, due soggetti
si incontrano nello spazio-tempo definito della terapia. È significativo che fino alla sua ultima opera
(Compendio di Psicoanalisi, 1938), Freud abbia sottolineato come, nella terapia, i processi di natura
somatica siano in realtà ciò che costituisce lo psichico e che questo preesiste alla qualità della
consapevolezza.
Dal lato radicale del costruzionismo, Judith Butler aggiungerebbe che il sé corporeo è
sempre a rischio di percepire ciò che è stato dato via allo scopo di aderire al lato desiderabile (di
solito culturalmente imposto) del genere sessuale, un genere che "non è uno", non nel senso ben
noto esemplificato da Luce Irigaray negli anni '70 (Irigaray, 1977), ma nel senso che "quel che resta
dell'Edipo" (se posso dire così) non può rappresentare la questione fondamentale della nostra epoca,
come spero di charire, in quanto il genere stesso è basato su una riduzione all'unità di ciò che è di
per sé una molteplicità, come il corpo-sé borderline ben esemplifica.
CORPI E DISTURBO DI PERSONALITÀ
For sufferance is the badge of all our tribe
(“Perché la sofferenza è il distintivo di tutta la nostra stirpe”)
(William Shakespeare, The Merchant of Venice, I.3.106)
Seems, madam? Nay, it is. I know not ‘seems’….
But I have that within which passes show
(Sembra, signora? No, è. Non conosco “sembra” …
Ma io ho dentro qualcosa che supera la possibilità di essere mostrato.)
(William Shakespeare, Hamlet, I.2.76, 84)
Per alcuni soggetti, il corpo diventa il luogo in cui le storie dolorose delle relazioni e delle
successive introiezioni, proiezioni e identificazioni sono inscritte ancora più dolorosamente.
Pensiamo a chi ricorre in modo massiccio a manipolazioni che del tatuaggio, come iscrizione e arte,
hanno poco: si pensi a massicci e dolorosi piercing, a pratiche di scarificazione non per motivi
religiosi e a operazioni chirurgiche che risultano in veri e propri massacri della carne. Se nessun
4

corpo nasce e cresce in un vuoto, come scrive Alessandra Lemma (2011), direi che la patologia del
Sé nel corpo borderline reca tracce ancora più dolorose e disturbanti dell’essere transito tra processi
di crescita a volte talmente distruttivi da risultare nell’annientamento, nella distruzione. Collocato al
confine primigenio dell'esperienza (“Primitive edge of experience ", Ogden 1990), “testamento
della relazionalità” (Lemma 2011), il corpo nel disturbo di personalità reca i segni drammatici di
questa fondamentale dicotomia tra voler essere e non potere essere, di una radicale lotta tra la vita e
la morte, che insiste sulla carne e sulla pelle o sul sangue, tra espressione e soppressione, tra
silenzio e grida, per così dire. Limite tra desiderio di essere (finalmente) vivi e desiderio di "non
essere" (ma un’esistenza al limite che a loro sembra ancora più vera, essenziale ed autentica di un
essere al mondo, che sentono come finzione, in modo non dissimile dal "seems", dal "sembrare", di
Amleto, I.2.76), è entro questi confini che si svolge la battaglia del disturbo grave di personalità, tra
un disperato desiderio di vivere (Correale 2006) e un impulso a farsi del male e a distruggersi (e
talvolta a distruggere l'altro). Come scrive suggestivamente Ogden, fisiologicamente è essenziale
che la propria pelle “penetri continuamente in uno strato di tessuto profondo, che funge da strato più
esterno che preserva la vita corporea. In questo modo (come nel concetto di Freud dello stimolo
barriera), la vita umana è fisiologicamente incapsulata dalla morte” (1996, p. 181, trad. mia,
corsivo mio).
É interessante che Ogden citi a questo riguardo proprio la definizione che Freud dà di trauma in Al
di là del principio di piacere (1920), sottolineando come nel corpo sia inscritto uno stimolo barriera
oltre il quale c'è traumatizzazione per il soggetto, e attraverso il quale si definisce il confine (parole
di Ogden) tra la vita e la morte (psichica).
Il corpo del soggetto con disturbo grave di personalità reca i segni di questa battaglia, e il prezzo
continuamente pagato per la sopravvivenza (il prezzo, direi, pagato a un carnefice, spesso solo
interno, ma radicato nella rappresentazione di sé con l’altro). Freud parlava di una regione
intermedia che era la malattia (ma anche il transfert in terapia) e poneva i segni e il confine del
trauma in una barriera tra corpo e mente. Definirei questo limite nel corpo come una zona di in-
betweenness (Mucci, 2013), un transito, in cui la relazione sé-altro si incide perfino nella storia
degli attacchi ad esso o delle sue patologie (come nei disturbi psicosomatici, in presentia, o nella
ipocondria, in absentia). Il corpo, per il borderline, diventa il luogo di questa continua battaglia e
perfino esilio da se stesso o se stessa, la tormentata dimora in cui risiede, come in un paradossale
quanto desiderato ubi consistam, la possibilità di consistenza, anche se è continuamente dislocata e
cancellata.
Come descrive molto efficacemente Antonello Correale, quella del borderline è sempre e
comunque una vita traumatica, una vita cioè in cui "l’elemento esperienziale negativo e
5

frustrante, in particolare la non disponibilità, quando sarebbe necessario, dell’oggetto, induce
un vissuto catastrofico di perdita totale e irreparabile di ogni ricchezza, di ogni potenzialità, di
ogni possibile sviluppo" (Correale et al., 2001, p. 18).
Il paziente borderline abita un corpo instabile per definizione, spesso troppo magro o troppo
grasso, segnato da ferite e punto da tatuaggi e piercing, i cui limiti sanzionati dalla pelle
vengono inscritti con particolari valori e significati, sempre alla ricerca di un’identità sessuale
e un sé sentito come finalmente autentico, un confine da inventare che sia una forma di
rinascita (come le fantasie di rinascita di alcune dinamiche preposte al tatuaggio secondo
Lemma, 2011). Il paziente borderline deposita nel corpo, come altro, la traccia del suo esilio
(rispetto a quello che avverte talvolta come sé) e delle particolari transazioni da un luogo
inattingibile di consistenza per la sua identità.
Il borderline, quando entra “nell’esperienza traumatica, perde tutto, ricordi, legami, speranze e
si trova nella sensazione penosissima di essere qualcosa di sradicato, inutile, battuto dal vento
e dalla tempesta, senza appoggi e senza prospettive. (Correale, 2006, p. 79).
Di questa condizione particolare di esilio e doloroso sradicamento (da Sé e altro), il corpo
borderline reca testimonianza, con la sua esperienza, con il suo particolare essere al mondo,
anche corporeo–troppo magro o troppo grasso, ricoperto di massivi tatuaggi e piercing o
alterato da operazioni chirurgiche spesso non necessarie, pieno di tagli e cicatrici, sempre alla
ricerca di una definizione di sé che deposita nell'altro, sempre mancante la traccia del proprio
esilio. Se Jacques Lacan diceva che il soggetto "incontra nell’altro la traccia del proprio
esilio", questo esilio, come impossibilità di consistere (di una vera costanza di oggetto o
oggetto interno buono), traccia della sua condizione, è collocato dal soggetto con disturbo
borderline proprio nella sede corporea e identificatoria del suo essere. Parafrasando Il
mercante di Venezia, e in particolare le parole dell'ebreo Shylock, la sofferenza, come
espressa nei corpi perpetuamente instabili dei borderline, con le loro tempeste esistenziali, è il
loro "marchio" vitale, il segno dell’inconsistenza costantemente esperita, della fluttuazione di
coscienza e instabilità. I corpi borderline, con le loro tracce corporee, recano testimonianza
alla loro modalità conflittuale e unica di esistenza.
EPIGENETICA, STRESS PRENATALE E METILAZIONE IN CONDIZIONI DI ABUSO
Per tornare alla questione della genetica e dell'epigenetica, ansie legate alla gravidanza sembrano
correlate alla metilazione del gene recettore dei glucocorticoidi (tra cui il cortisolo). Sappiamo che
lo stress materno può esitare in cambiamenti che provocano il silenziamento o l'espressione genica
6

di un gene del DNA nel bambino. Il più comune meccanismo è quello della metilazione (si veda ad
es, van Ijzerndoorn, et al. 2011; vedi Schore, 2017a).
Il maltrattamento infantile (insieme ad altre forme di avversità, come la perdita di un
genitore o una grave deprivazione) è associato a metilazione dei recettori dei glucocorticoidi, che
porta a inadeguati livelli di cortisolo in reazione allo stress. La metilazione in adolescenti e adulti è
associata a problemi di salute, tentativi di suicidio, impulsività e aggressività. Avversità diverse
portano a diversi processi di metilazione. Inoltre, povertà, guerra, abuso di alcol e di sostanze,
PTSD e anche stress da lavoro sono associati alla metilazione, con un aumento nella vulnerabilità a
fattori di stress in futuro e perfino alla possibilità di trasmettere questi fattori di vulnerabilità ai
propri figli.
ANCORA SU MADRI E PADRI PER LA TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE
“How say you by that? Still harping on my daughter”
(Cosa può voler dire? Insiste a parlare di mia figlia”)
W. Shakespeare, Hamlet, II. ii. 187-188)
Finora ci siamo occupati soprattutto di madri come caregiver, cosa che nella maggior parte delle
culture è la regola; ma molti studi condotti su non umani, ad esempio roditori, evidenziano
l'importanza del ruolo del padre o di un terzo elemento che rompa la prima diade caregiver-
bambino, come elemento fondamentale per lo sviluppo successivo ai due anni. Nel secondo anno di
vita, infatti, l'attaccamento che il bambino instaura con il secondo caregiver, di solito un padre, è
cruciale per il successivo sviluppo del cervello (Schore, 1994; Schore, 2013, in Narvaetz et al.,
2013) specialmente per la formazione di quelle qualità sociali, relazionali, linguistiche e cognitive
che si consolideranno nel terzo anno di vita e che richiedono lo sviluppo di funzioni superiori, che si
estendono fino alle aree orbitofrontali, ventromediali e frontali.
È stato visto che, se il padre in famiglie di roditori è stato esposto a stress cronico, ciò può condurre
a una modificazione dello sperma, a sintomi depressivi e ad ansia, perfino nei piccoli. Altri studi
mostrano che un miglioramento delle condizioni dei padri porta al miglioramento delle condizioni
dei piccolo, e perfino a un miglioramento (non sorprendentemente) nella capacità di accudimento
della madre.
Come si è detto, l'attaccamento è la prima forma di trasmissione intergenerazionale del trauma,
come dimostra la forte correlazione tra l'attaccamento del genitore e quello dei figli (Fonagy, Steele,
Steeele, 1991). In aggiunta, il fatto che un bambino possa avere attaccamento sicuro con un genitore
e insicuro con un altro, prova l'irrilevanza della genetica nell' attaccamento.
7

Figli di genitori maltrattanti hanno attaccamento disorganizzato nell' 80% dei casi contro il 20% del
gruppo di controllo (Carlson, et al., 1989; Lyons-Ruth, et al., 1987). Questi bambini sono
predisposti a sviluppare disturbi dissociativi (Liotti, 1992; 2014). Alcuni di questi bambini hanno
madri che, nei primi due anni di vita del bambino, hanno subito un grave lutto non elaborato (Liotti,
Intreccialagli, Cerere, 1991) e presentano livelli di cortisolo alterati.
Studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) mostrano che pazienti con attaccamento
disorganizzato presentano livelli di attivazione limbico-corticale diversi da quelli del gruppo di
controllo, specialmente quando il compito dato implicava immagini traumatiche (Buchheim, et al.,
2006).
Per questi bambini (con attaccamento disorganizzato), l'ambiente è una forma potenziale di
trauma, e danneggia la connettività dell'emisfero destro e quella tra emisfero destro e sinistro.
Inoltre, esperienze traumatiche non risolte (Liotti, 2005, p. 138) possono riflettersi nella
disorganizzazione e nelle tendenze dissociative anche in assenza di esplicito maltrattamento.
L'attaccamento disorganizzato è considerato la base per una vulnerabilità che può mediare lo
sviluppo di un disturbo di personalità (Liotti, 2014).
Se esaminiamo generazioni traumatizzate, sopravvissute a traumi sociali massivi, genocidi e
stermini come la Shoah, la trasmissione del trauma viene influenzata sia dalla sicurezza che
dall’insicurezza dell'attaccamento nei genitori e tra genitori e figli (Ban-On et al., 1998; Sagi-
Schwartz et al., 2003; Sagi-Swartz et al., 2008).
L'avanzamento delle ricerche nella biologia molecolare, nella genomica e nell’epigenomica ci
permette di studiare e comprendere gli effetti a lungo termine dello stress anche in casi di trauma
sociale massivo, come tra i sopravvissuti della Shoah, dove nella generazione successiva troviamo
cambiamenti che in se stessi non significano patologia, ma ci aiutano a comprendere i fattori di
rischio delle future risposte traumatogene al trauma (Yehuda et al., 2008; Yehuda et al., 1998).
Questi fattori sono mediati dalle dinamiche dell'attaccamento (Fonagy et al., 1992, in Ammaniti &
Stern, 1992; Lyons-Ruth, Bronfman & Atwood, in George & Solomon, 2007).
CONNECTEDNESS, ATTACCAMENTO, RESILIENZA E LA PERSISTENZA
DELL'UMANO
Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri
bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri
vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i
bagagli, e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad
8

asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose
che esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi
altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da
mangiare?
(Primo Levi, Se questo è un uomo, p.13).
Siamo così sbadati, senza cura. In qualche modo il valore della vita è scaduto ai nostri
occhi. La santità della vita, la dimensione sacra dell’esistenza umana, è assente, non esiste
più.
(Wiesel and Heffner, Conversations with Elie Wiesel, 2001, p. 4, trad.
mia per questa edizione)
La perdita ha reso il noi molto precario (Judith Butler, Vite precarie, p. 41)
Le madri nella descrizione di Levi, che lavano e accudiscono i loro piccoli come al solito, appena
prima della deportazione, espongono la loro vulnerabilità umana, mentre mostrano aspetti di
resilienza rispetto alle avversità.
La resilienza è imbevuta di elementi di fede e speranza, fede non nel senso religioso, ma nello
spirito umano o in quella che chiamo, con Wiesel, la "sacralità della vita umana" (Mucci, 2017b,
Wiesel, 2001), la fiducia nella capacità di sopravvivenza e di superare le difficoltà.
Il concetto e la dinamica di “connectedness”, (Mucci, 2013, 2014), che vedo come fondamentale
negli scambi sociali e nel mantenimento di un legame alla vita, è in se stessa una forma di resilienza
ed è alle radici di questa rete intergenerazionale di storie, patrimonio di esperienze e relazioni
epigeneticamente ereditate e inscritte nei nostri corpi e in noi stessi, a cui raramente diamo la nostra
attenzione conscia, ma che comunque regolano implicitamente e istrutturano il nostro posto nel
mondo, il nostro insieme di valori, al tempo stesso sociali, culturali, familiari, economici e storici,
vale a dire racchiusi in una cornice temporale, che va oltre la dimensione strettamente individuale e
privata della nostra vita.
Siamo gettati (e avviluppati) in una rete di significati e valori costruiti socialmente e culturalmente.
In questa rete, il trauma esemplifica questa interconnessione e realtà della vita umana ancora più
chiaramente. Allo stesso modo, l'insieme di valori individuali e collettivi attorno alle
traumatizzazioni massive può costituire un successivo livello di vittimizzazione o, al contrario, un
fattore di liberazione, riparazione e cura (come ad esempio accade alle donne oggetto di violenza in
Bosnia che hanno visto cumulare al proprio trauma di vittime di stupro la successiva violenza di una
9

cultura che a causa di ciò le considerava disonorate, ovvero portatrici di disonore ai maschi dei loro
gruppi; questo perché queste donne nella loro cultura non sono neanche soggetti degne del concetto
di onore; la “femmina”, in certe culture, è vista come quella che, col proprio comportamento, reca
onore o disonore ai maschi della famiglia, ma di per sé non ha nessun valore). Oppure, per quanto
riguarda i significati culturali che si cumulano ai traumi individuali, possiamo ricordare la
differenza nella reazione allo tsunami che colpì nel 2006 l’Indonesia e altri Paesi del Sud-Est
asiatico: i turisti europei accusarono un PTSD molto più grave di quello delle comunità locali,
probabilmente a causa dell’influenza di visioni culturali e religiose che si cumulavano al trauma
stesso, ad esempio, la prevalenza di culture buddiste in quei luoghi privilegiava una risposta
collettiva e non individuale al trauma, che veniva lenita da una visione in cui la natura non colpisce
in modo maligno il singolo, colpendolo nel suo destino, ma è appunto una forza naturale, e la forza
della collettività corre in soccorso delle singole vittime.
TRAUMA, EMOZIONI E PATOLOGIA PSICOLOGICA E FISICA
L'elaborazione e il controllo degli affetti rimane l'area di maggiore difficoltà per i pazienti
borderline. Le emozioni costituiscono il tramite tra corpo e mente, corpo e cervello. La base
molecolare delle emozioni è costituita da elementi biochimici, i peptidi. I recettori dei peptidi sono
localizzati in aree del cervello particolarmente legate alle emozioni, alla memoria e alla ricezione di
stimoli che sono inviati al sistema nervoso centrale; questi recettori del corpo sono presenti
nell'organismo specialmente attraverso il sistema neuroendocrino e le cellule del sistema
immunitario. I neuropeptidi e i loro recettori si connettono alle ghiandole del sistema immunitario
in una rete di comunicazione che rappresenta il substrato biochimico tra mente e corpo. In altri
termini, i sistemi maggiori del corpo sono organizzati in una rete più ampia che unisce sintomi
corporei e elementi di comunicazione subsimbolica, per usare il linguaggio di Wilma Bucci (Bucci,
1997a, 1997b), o "elementi beta” non trasformati in "elementi alfa", o “apparati per pensare”, come
si direbbe nel linguaggio di Wilfred Bion (Bion, 1962). I sintomi fisici, come vedremo in alcuni dei
casi presentati, possono essere visti come l'espressione subsimbolica non verbale (vedi Bucci,
1997a, 1997b) o la via psicosomatica che il corpo ha trovato per parlare il linguaggio concreto
operazionale (come direbbero gli psicoanalisti francesi) per dare parole alla sofferenza; sono forme
incorporate di ciò che Bollas (1989) chiamerebbe “conosciuto non pensato”. Donnel Stern li
collocherebbe nell'ambito della "esperienza non formulata" e Jacques Lacan (1966) li
considererebbe come lo “scandalo del corpo parlante”, per citare, tra l'altro, un famoso studio di
Shoshana Felman (Felman, 1983), tra letteratura e psicoanalisi.
10

Figura 2.1 Risposta allo stress e attivazione dell'asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene)
Tra la reazione corporea, la neurobiologia e lo stato mentale, l’attivazione fisiologica degli organi,
stimolata dalle risposte neuroendocrine allo stress, è responsabile della reazione disfunzionale
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), con conseguente aumento di cortisolo e indebolimento
del sistema immunitario cosicché è più probabile che si verifichino malattie infettive e croniche
come herpes, HIV, allergie e altre malattie autoimmuni o perfino formazioni neoplastiche, oltre a
malattie cardiovascolari, del fegato, dei reni e del metabolismo, come il diabete. Questa aumentata
vulnerabilità verso organi bersaglio (che di solito implicano una familiarità) è confermata dai
risultati della ricerca epidemiologica chiamata ACE (Adverse Childhood Experiences), iniziata
negli anni ‘90 dal Kaiser Permanent Department of Preventive Medicine in San Diego insieme al
Center for Disease Control and Prevention (CDC) della emory Unviersity, Atlanta e alla Geogia
State University (vedi Felitti, Anda et. al., 1998; Felitti & Anda, 2010).
Questa ricerca costituisce il più ampio studio epidemiologico in corso condotto finora su più
di 18.000 soggetti e correla traumatizzazioni interpersonali gravi occorse nell'infanzia in pazienti
con problemi mentali (specie depressione, ansia, abuso di sostanze, dipendenze e comportamenti
suicidari) con disturbi fisici che hanno sviluppato in seguito (malattie cardiovascolari, problemi ai
reni o al fegato, diabete, cancro e malattie autoimmuni).
(Figura 2.2)
11

Da Felitti, Anda et al., 1998.
I sette fattori traumatici investigati hanno a che fare con abuso psicologico, fisico o sessuale,
insieme a fattori traumatici in famiglie disfunzionali, ovvero famiglie in cui sono presenti malattia
mentale, specie depressione, abuso di alcol e dipendenze varie, violenza e comportamenti
antisociali (alcuni dei familiari erano in carcere). Lo studio ha evidenziato come ad un più alto
livello di traumatizzazione infantile corrisponda un maggior numero di malattie o condizioni di
salute più gravi, sia nel senso di malattie mentali (disturbi borderline, depressione, suicidalità,
dipendenze) che nel senso di malattie fisiche o addirittura di gravi incidenti e morte precoce.
Il trauma fornisce le prove di come le circostanze esterne avverse, vale a dire relazioni come
attaccamento disturbato e maltrattamento, risultino in affetti negativi che danneggiano il corpo,
l'autostima e la salute mentale. Fornisce anche le prove fisiche che non solo il funzionamento è
danneggiato ma anche che aree del cervello sono rimpicciolite, il che è segno di morte cellulare (ad
esempio, ricerche provano che veterani del Vietnam con vari sintomi post-traumatici presentano
riduzione volumetrica dell'ippocampo a sinistra, mentre donne abusate da tempo e depresse
presentano riduzione volumetrica dell'ippocampo a destra (vedi Mucci, 2014).
L'importanza di ridurre il rischio di abuso in famiglie e di riparare prima possibile le conseguenze
del trauma relazionale infantile dell'abuso è evidente. Le famiglie e i caregiver devono essere aiutati
in un compito che è della più grande rilevanza non solo per la salute di tutti, ma per la salute della
società, se consideriamo come il più grave abuso e deprivazione conducano a morte cellulare
dell'amigdala e preparino vite in cui empatia e sensibilità per l'altro sono inesistenti, oltre a
predisporre a violenza, aggressività e delinquenza. Non solo queste conoscenze se tenute da conto
12

abbatterebbero i costi delle spese mediche per malattie e disturbi mentali, ma verrebbero alleviate
sofferenze e sarebbero ridotti comportamenti violenti distruttivi ad altri livelli, non ultimo verso
l'ambiente e verso gli animali. Chi è stato maltrattato e abusato non riuscirà a vedere nemmeno nel
pianeta terra un elemento da conservare, amare e custodire, con danno per tutti (specie se questi
soggetti sono i cosiddetti “Signori della terra”).
Criminalità e comportamenti violenti e aggressivi potrebbero essere ridotti con un sostegno precoce
a famiglie a rischio e con la possibilità di formare forme di "connectedness" (Mucci, 2013, 2014), di
sostegno sociale individuale e collettivo, creando quello che Dori Laub (Laub, 2005) ha chiamato
"una comunità di testimonianza" (di cui si parlerà meglio a partire dal terzo capitolo).
Pertanto, parliamo di una "ereditarietà" che è ambientale, relazionale e traumatica, passata non
geneticamente, ma attraverso l'attaccamento e le modalità identificative.
Myron Hofer (1984) e Michael Meany (2001), nelle loro straordinarie ricerche epigenetiche, hanno
mostrato come in famiglie di roditori, a migliori cure primarie (licking e nutrimento con una
particolare posizione del corpo, arch-backing) corrispondeva ridotto cortisolo, mentre nei piccoli
maltrattati o deprivati i livelli di cortisolo erano pericolosamente alti, con le conseguenze che
conosciamo sull’elaborazione della dopamina e della serotonina. In aggiunta, piccoli che avevano
ricevuto cure migliori, da adulti erano in grado di alleviare i livelli di ansia dei loro piccoli, di
ridurre comportamenti di freezing e iperattività, dotandoli di migliori parametri di salute per il resto
delle loro vite. In altri termini, i programmi di maturazione del cervello sono geneticamente
programmati, ma questi stessi programmi sono forgiati dall'esperienza, che è ambientale,
interpersonale, intersoggettiva e relazionale (Schore, 1994, Siegel, 1999).
L'importanza dell'attaccamento, in un modello psicobiologico integrato per la malattia fisica, è stato
riconosciuto da Jude Cassidy, dell’Università del Maryland, che propone un modello in cui
l'attaccamento insicuro correla con malattie del sistema immunitario e i valori dell'asse HPA con i
livelli di infiammazione nel corpo (Proteina C reattiva), cosicché vari organi possono diventare
l'organo designato, o bersaglio, in combinazione di vulnerabilità familiari.
Cassidy (Erlich, Miller, Jones & Cassidy, 2016) preferisce usare il termine Base Sicura proposto da
Bowlby piuttosto che parlare di livelli traumatici, come indicato di seguito.
13

Figura 2.3 Base sicura e risposta allo stress
Per “mancanza di base sicura” (Bowlby, 1999), Cassidy intende il bambino che non può rivolgersi a
un genitore quando fronteggia una difficoltà; l'asse 2 si riferisce ai livelli cognitivi e affettivi; l'asse
3 sottolinea l'attivazione del SNA, che può (asse 4) produrre livelli di infiammazione nel corpo, con
un aumento di Proteina C reattiva (CRP). Alti valori di CRP presentano il rischio che un organo
bersaglio (attraverso vulnerabilità familiare) venga attaccato.
Jude Cassidy sottolinea il fatto che nelle famiglie di roditori, caregiver e piccoli, nelle loro relazioni,
arrivano a una regolazione senza la componente delle rappresentazioni mentali della relazione.
Sebbene la rappresentazione negli umani sia non solo cognitiva ma su base affettiva, tuttavia la
componente simbolica delle facoltà superiori è specifica e ha suscitato spiegazioni da vari punti di
vista. Per la psicoanalisi, la rappresentazione mentale sé-altro, nella forma delle relazioni oggettuali,
è fondamentale per lo sviluppo del sé e della personalità (sia sana che disturbata). Schore le
definisce “rappresentazioni del sé immagazzinate mentalmente che dirigono l'affetto verso un
oggetto esterno emotivamente significativo" (1994, p. 314, trad. mia), in cui si uniscono processi
cognitivi e affettivi. Per Kernberg, le varie rappresentazioni del sé e dell'altro in una diade sono
unite da un affetto (positivo o negativo), e queste rappresentazioni internalizzate vengono ripetute o
riattivate nella relazione con il terapeuta, legate da un affetto dominante nella seduta, e
costituiscono posizioni che paziente e terapeuta prendono rispettivamente in ciascuna diade messa
in atto (Clarkin, Yeomans & Kernberg, 1999). Queste immagini di sé e dell’altro sembrano essere
rappresentate nell'emisfero destro e sembrano maturare attorno ai 18 mesi (Watt, 1990; Epstein,
1978).
mancanza di base sicura
meccanismi cognitivi e non
cognitivi
risposta allo stress con
attivazione del sistema nervoso
Conseguenze infiammatorie, con alti livelli di Proteina C
reattiva e rischio di
sviluppare malattie
14

I DISTURBI DI PERSONALITÀ SONO PARTICOLARI DISTURBI DELL'EMISFERO
DESTRO?
Parlare di emozioni e affetti senza la regolazione degli affetti è impossibile. È la parte superiore
delle aree orbitofrontali che gioca una funzione particolarmente importante nei processi di
adattamento regolatorio (Schore, 2003a). Per esempio, l’elaborazione dell'informazione visiva e
prosodica che viene da un viso (informazione esterocettiva processata corticalmente), che riguarda
l'ambiente esterno, viene integrata con informazioni enterocettive, processate a livello subcorticale,
che riguardano l'ambiente viscerale interno (Schore, 2003a; Porges, 2011). Il sistema orbitofrontale
è situato all'apice del sistema limbico, che è maggiormente sviluppato nell'emisfero destro; il suo
compito è la regolazione delle strutture subcorticali implicate nell’elaborazione dell’informazione
socioemotiva; per Schore, si tratta di una specie di sistema preconscio (perciò presimbolico) che
organizza stati inconsci di livello inferiore del sistema corpo-mente. Nella spiegazione di Kaplan-
Solms and Solms (1996), questa zona funziona come agente di organizzazione interna e capacità di
riflessione.
L'emisfero destro è per Schore il "substrato neurobiologico dell'inconscio dinamico” (1999, p. 53),
la base di ciò che è stato chiamato psicoanaliticamente “inconscio”, basato su una modalità di
funzionamento del processo primario; mentre l'emisfero sinistro è la base del processo secondario,
razionale, conscio, la sede del linguaggio e della visione del dettaglio (invece che della globalità).
Mentre emozioni negative o eccessive sono processate dall'emisfero destro, il sinistro elabora
emozioni più positive o neutrali. Infine, un’ulteriore modulazione è attribuita al corpo calloso, che
mette insieme le emozioni integrandole con il linguaggio e l’analisi. Per Schore, la regione
orbitofrontale è “unicamente implicata nel comportamento sociale ed emotivo, e nella regolazione
omeostatica degli stati del corpo e motivazionali” (Schore 1994, 1996)” (2003, p. 195). In una
posizione in-between, (di mezzo e transito) tra strutture superiori e inferiori, regola l'adattamento tra
interno ed esterno, per esempio processa stimoli visivi, uditivi e prosodici, insieme a informazioni
viscerali. Questa regione è alla base di ciò che Michael Gazzaniga definisce squisitamente "umano",
determinando intenzionalità, agency e identità (Gazzaniga, 2009). Per il suo ruolo fondamentale
nella regolazione affettiva e nell'attaccamento, il sistema orbitofrontale è essenziale in tutti i livelli
della patologia, specialmente quelli risultanti in disturbi del sé e disturbi affettivi in relazioni
interpersonali (si veda anche Grotstein, 1986). Questo sistema, probabilmente, domina la capacità di
generare relazioni oggettuali o diadi nel senso indicato da Kernberg: il sistema mette insieme la
rappresentazione del sé con la rappresentazione dell'altro, con un affetto che li collega (Kernberg,
1975; 1985).
15

L'apprezzamento e l'espressione di emozioni, secondo Schore, sono mediate dai circuiti limbici del
Sistema Nervoso Centrale e, allo stesso tempo, dalle componenti parasimpatiche del Sistema
Nervoso Autonomo. Pertanto, le emozioni connettono il corpo alla mente e viceversa in un modo
non troppo diverso dall'idea di Freud: il cervello funziona come un complesso adattatore che pone
in relazione corpo e mente.
Nel suggerire una similitudine tra il funzionamento dell'emisfero destro e l'inconscio
dinamico, Schore (2003a) sottolinea come solo una prospettiva evolutiva o di sviluppo, non una
prospettiva basata sulla localizzazione, può registrare le prime esperienze socioemotive registrate
nella memoria implicita-inconscio, influenzando dinamicamente l'informazione inconscia per il
resto della vita. Studi neurobiologici sottolineano il ruolo essenziale delle funzioni adattive nei
centri di controllo dell'emisfero destro sull'ipotalamo (Schore, 1994), e indicano nell'emisfero destro
il controllo degli elementi fisiologici ed endocrinologici (Wittling & Pfluger, 1990). L'ipotalamo
regola l'attività dei sistemi autonomi simpatici e parasimpatici. In accordo con Schore, Mauro
Mancia (Mancia, 2006, 2007) ritiene che l'inconscio sia lateralizzato nell'emisfero destro (si veda
anche Joseph, 1992; Galin, 1974; Hoppe, 1977; McLaughlin, 1978).
Nella sua posizione intermedia tra zone corticali e subcorticali nell'emisfero destro, la corteccia
orbitofrontale influenza il ruolo dell'emisfero destro nel controllo delle funzioni vitali, che regolano
la sopravvivenza e permettono all'organismo di sopravvivere allo stress e alle situazioni estreme.
Questo sistema è, in una parola, capace di superare situazioni distruttive e di integrare un senso di
sé in momenti di transizione, diventando la base di un senso stabile di sé (esattamente ciò che i
pazienti borderline fanno fatica a raggiungere). Secondo Mauro Mancia (2006, 2007), la corteccia
orbitofrontale rappresenta la base della memoria implicita e gioca un ruolo decisivo nel
discriminare ciò che l'amigdala può o non può fare. L'area accanto alla corteccia orbitofrontale,
dietro e al di sopra, è il cingolato anteriore, di cui abbiamo già parlato, e si ritiene sia la base
neuronale del comportamento materno, del sé implicito ed esplicito e della consapevolezza delle
emozioni (Wallin, 2007; Damasio, 1999; Cozolino, 2002; Allen & Fonagy 2002). In aggiunta a
queste due aree, una terza area della corteccia prefrontale mediale sembra abbia un’importanza
essenziale in terapia, anche questa molto legata al corpo e ai suoi legami con la mente: si tratta
dell'insula, o corteccia insulare. Come già accennato, l'insula è fondamentale per la consapevolezza
che il soggetto ha del proprio corpo, inclusi gli organi interni. Sembra inoltre regolare la sensibilità
che ci permette di provare empatia, così come sembra mediare l'attivazione dei neuroni specchio.
Sembrerebbe che i disturbi di personalità, con la loro disconnessione della corteccia orbitofrontale
con l'amigdala e la prevalenza di difese dissociative, siano fondamentalmente disturbi dell'emisfero
destro (Schore, 2003 a, 2003b; Meares, 2014; Mucci, 2017a).
16

LONTANI DA CARTESIO
Damasio (1995) definisce la corteccia orbito-prefrontale “il sé neurale”, fondamentale nella
bioregolazione e nei domini sociali. Genera ciò che egli chiama "marcatori somatici" che si
esprimono attraverso le emozioni, in un modo non dissimile da quanto Arnold Modell ha indicato,
quando dice che "la continuità e la coerenza del sé sono un requisito omeostatico della psiche-
soma", implicando “la frontiera tra psicoanalisi e biologia”, concetto non troppo distante da quanto
riteneva Freud (Modell, 1993).
Infatti, per Freud le pulsioni pongono il regno psichico a contatto con il somatico, la mente in
contatto con il corpo. Damasio, che enfatizza il legame tra mente e corpo quando dice che i
sentimenti (feelings) sono potenti manifestazioni delle pulsioni e degli istinti, pone l'accento sulla
componente motivazionale implicata. Secondo Damasio, le pulsioni e gli istinti operano sia
generando un comportamento particolare in modo diretto, oppure attraverso l'induzione di stati
fisiologici che portano l'individuo a comportarsi in un certo modo (Damasio, 1995). Dobbiamo
stare attenti, in altri termini, a non cadere nell'errore di Cartesio, il quale seguiva un modello
psicologico che negava il fatto inevitabile della nostra unità psicosomatica e psicofisica.
Nel suo testo del 1891 Sull'Afasia, Freud introduceva il termine ‘rappresentazione di oggetto’ e
scriveva che la rappresentazione non è una struttura, ma un processo. Kernberg, seguendo Edith
Jacobson, enfatizza la presenza di un affetto che unisce la rappresentazione dell'oggetto e la
rappresentazione del sé. Ciò è congruente con quanto Beebe e Lackmann hanno dimostrato, ovvero
di come l'esperienza affettiva delle prime relazioni sociali nell'ambiente sia immagazzinata in
rappresentazioni interattive del sé, unite, a livello emozionale, ad un oggetto significativo. Questi
modelli relazionali e affettivi guidano il nostro comportamento interpersonale e contengono
informazioni riguardo al nostro stato psicobiologico, e implicano strategie che aiutano il corpo ad
adattarsi alle richieste dell'ambiente esterno; più che mentali, dunque, sottolinea Schore, le
rappresentazioni internalizzate sono psicobiologiche (e il sistema polivagale ne descrive il
funzionamento al di fuori del Sistema Nervoso Centrale), esattamente ciò che Freud cercava di
raffigurare con il concetto di pulsione. Ciò che oggi sappiamo è che l'intero sistema non può
esistere se non è in una continua regolazione intersoggettiva tra sé e altro.
Abbiamo evidenze scientifiche del fatto che la rappresentazione dei genitori e del sé si sviluppa in
sincronia (Bornstein, 1993), e che queste rappresentazioni diventano modelli che influenzano
aspettative e comportamenti nei confronti dell'ambiente. Come già notato in precedenza e come
dimostrato da Hofer, queste rappresentazioni internalizzate diventano regolatori interni. Schore
17

contribuisce a queste discussioni specificando che queste rappresentazioni interattive sono
distribuite nella corteccia orbitale, con le sue connessioni corticali e sottocorticali. Questi modelli
guidano il comportamento interpersonale, contengono informazioni sulle transizioni in stati
psicobiologici e recano all'interno la codifica per le strategie che servono a modificare il corpo in
risposta ai cambiamenti dell'ambiente esterno percepiti come significativi. Come sostiene Schore,
più che rappresentazioni biologiche, sono psicobiologiche. Pertanto saranno riattivate negli scambi
che intercorrono nella relazione terapeutica.
NEUROIMAGING E GENETICA DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ
Studi recenti di neuroimaging e genetica (Donegan et al., 2003; Lis, Greenfield, Henry, Guilè &
Dougherty, 2007; per una review, Guorong Hongying, Chanchan & Wei, 2016) confermano quanto
abbiamo detto.
Questi studi associano i disturbi di personalità borderline con l'iperattivazione dell'amigdala e del
sistema limbico (dominanti per il controllo della rabbia, della paura e delle reazioni impulsive
automatiche). Queste aree, nei pazienti borderline, non erano controllate e integrate dalle aree
orbitofrontali. L'amigdala e l'ippocampo, in alcuni casi, erano fino al 16% più piccole del gruppo di
controllo, un fatto spiegato dal trauma in questa zona e dalla morte cellulare (dovuta a eccesso di
glucocorticoidi). Nella PET, questi soggetti mostravano ipometabolismo del glucosio nelle aree
prefrontali e nell'area limbica, indicando una possibile carenza nel funzionamento della corteccia
razionale prefrontale nel regolare l'impulsività del sistema limbico.
Il ruolo delle aree frontolimbiche nel controllare gli affetti negativi nei disturbi borderline è
stato sottolineato da studi recenti. Nell’interazione tra inibizione del comportamento (compito go,
no-go) sotto impulso di emozione negativa, i pazienti borderline mostravano diminuita attività
prefrontale ventromediale (incluse le aree orbitofrontali mediali e del cingolato anteriore) in
confronto a soggetti sani; mostravano, inoltre, un’aumentata attività dell'amigdala ventrale striata
che correlava ampiamente all'aumento di emozioni negative.
Altri studi mostrano ipermetabolismo nel giro cingolato anteriore, nel giro frontale
superiore, nel giro frontale inferiore destro e nella parte opercolare del giro precentrale destro. Studi
effettuati con la PET hanno ulteriormente mostrato iperattivazione della corteccia prefrontale
dorsolaterale bilaterale e nel cuneo di destra, e diminuita attivazione nella corteccia prefrontale
mediale in pazienti borderline con storie di abbandono.
18

Durante la riattivazione di memorie traumatiche, pazienti borderline senza PTSD
mostravano una minore attivazione della corteccia orbitofrontale in entrambi gli emisferi e nell' area
di Broca rispetto a pazienti con disturbo borderline e PTSD. Questi dati supportavano i risultati
della PET e mostravano l’attivazione delle strutture limbiche. La mancanza di attivazione nell'area
di Broca è interessante perché potrebbe spiegare come mai per i pazienti traumatizzati sia così
difficile mettere in parole la loro esperienza, e verbalizzare le emozioni.
Altre ricerche condotte con differenti tecniche di neuroimaging mostrano altre anomalie.
Pazienti con disturbo di personalità mostrano deficit nella concentrazione di N-acetil-aspartato
(NAA) nella corteccia prefrontale dorsolaterale, che può essere attribuito a una diminuita densità
cellulare e a un metabolismo squilibrato (usando spettroscopia di risonanza magnetica). In aggiunta,
vi era una riduzione del volume dell'amigdala basolaterale.
Inoltre, sono stati rilevati altri deficit nell' emisfero destro: usando la SPECT (tomografia a
emissione di fotone singolo, ovvero una tecnica di imaging che usa una sostanza radioattiva e in
grado di fare fotografie tridimensionali), pazienti con diagnosi borderline o antisociale mostravano
ridotto flusso sanguigno cerebrale regionale nella corteccia temporale laterale destra, nella corteccia
prefrontale e nel polo ventrolaterale destro, il che suggerisce che queste aree sono collegate a
impulsività, ma queste anomalie non sono specifiche del disturbo di personalità. Questi dati si
aggiungono ad altri risultati anatomici e fisiologici.
Infine, a livello genetico, altri studi mostrano che il gene più importante per lo sviluppo di
un disturbo di personalità è il gene trasportatore della serotonina 5-HTT, che è associato a livelli
inferiori di serotonina e maggiore impulsività e aggressività. Erano inoltre evidenti minori
connessioni con il gene recettore della dopamina. La questione è se il legame genetico evidenziato
da queste ricerche sia responsabile della disfunzione o sia invece causato da fattori genetici e
ambientali. Ad ogni modo, gli studi presentano discrepanze poiché differenze minime in pazienti
con disturbi di personalità (per esempio, in presenza o assenza di disturbo dell'umore) rendono i
pazienti diversi negli esami. Un paziente potrebbe essere incapace di stare fermo, per esempio. È
possibile che la riduzione volumetrica in alcune zone sia dovuta all'ipometabolismo e, nel caso
dell'amigdala, i neuroni inibitori possono essere stati danneggiati, causa di comportamento
impulsivo e mancanza di inibizione.
Le domande poste da questi studi sono per lo più rivolte a chiarire come anomalie in certe
aree possano essere associate ai disturbi di personalità, e a come, per esempio, l'abuso cronico
versus l'abuso acuto possa essere collegato a risultati differenti. Un'altra importante questione
19

sollevata da questa ricerca riguarda le differenze neuroanatomiche tra pazienti che guariscono in
tempi diversi. Pochi studi di neuroimaging o di genetica includono una componente longitudinale.
Links, Heslegrave e van Reekum (1998) hanno trovato che, dopo 10 anni, circa metà dei pazienti
borderline guariscono. Paris e Zweig-Frank (2001) hanno notato che questa percentuale aumenta
con l'età: a partire dai 40 anni, la maggior parte dei pazienti borderline non presentano più i criteri
per la diagnosi. La maggior parte dei partecipanti alla ricerca avevano tra i 20 e i 30 anni di età,
cosicché è facile immaginare che alcuni di loro fossero più vicini all'età di remissione. Questo, a sua
volta, solleva la questione dei possibili cambiamenti neuroanatomici negli anni.
TRATTAMENTO BASATO SULL'EMISFERO DESTRO PER I DISTURBI DI
PERSONALITÀ
Molti studi sottolineano come l'emisfero destro (quello maggiormente implicato nei processi di
attaccamento, e che reca le tracce o le maggiori ferite del trauma relazionale infantile) sia il più
implicato nel trattamento psicoterapeutico in genere, e in particolare per il trattamento dei disturbi
di personalità, a causa della riattivazione di dolorose memorie traumatiche.
Come nota Wallin (2007), l'esperienza somatica è fondamentale nel contesto
dell'attaccamento; di conseguenza, è essenziale l'attenzione al sé somatico in trattamenti in cui
l'attaccamento sia alla base. Le comunicazioni implicite, interattive, inconsce sono, nei termini di
Schore, “processi somatici psicobiologici”, che verranno riattivati negli scambi terapeutici.
Pertanto, i sintomi evidenti nel sé somatico dei pazienti gravi, come sono i disturbi di personalità,
sono un segno e devono essere letti come una traccia nel ricostruire le relazioni precoci inscritte
sulla superficie o dentro il corpo così come nelle strutture neuronali del cervello, e sono quegli
scambi precoci (e impronte neuronali) che devono essere riparate nel trattamento, a partire dai
circuiti impliciti del sé. Vedremo come sia fondamentalmente un viaggio di testimonianza, se posso
usare un termine così carico di riferimenti alla Shoah e alle grandi traumatizzazioni sociali, termine
presente anche nella psicoterapia al trauma in Ferenczi (vedi Ferenczi, 1988, sul terapueta
“testimone”), poi ampiamente ripreso per la psicoterapia del trauma grave (Laub, 2005; Mucci,
2013, 2014). È un lavoro sul corpo che va fatto attraverso le memorie implicite incarnate in
sensazioni, emozioni e attraverso vaghe rappresentazioni, tutte inscritte, o precocemente nel trauma
dell'attaccamento o nelle relazioni successive con un altro, che avrebbe dovuto essere un caregiver
ma ne ha segnato l'esistenza. Il lavoro andrà dunque alle memorie implicite (accolte dal terapeuta
come un testimone sensibile e attento) incarnate nel corpo e nei sensi, in un processo lento di
progressiva verbalizzazione che va di pari passo con una accettazione della storia ricostruita sulla
20

verità traumatica, a volte disconosciuta per lungo tempo o dissociata dal paziente. Il cammino sarà
da implicito ad esplicito, da emisfero destro a sinistro e viceversa, in un sottile lavoro continuato di
reintegrazione; a strati maggiori di accettazione e di conoscenza succedono possibilità di
espressione e di ricordo diverse (e quindi di chiarezza e ulteriore accettazione e riconnessione in un
quadro più ampio, di solito anche intergenerazionale).
Per concludere, se con Winnicott (1965) possiamo dire che la madre porta il mondo esterno
al bambino, e con Sasso (2007, 2011) che la madre porta la coscienza al bambino, con Damasio
diremmo che il cervello rappresenta il mondo esterno nel senso delle modificazioni corporee che
genera. Dal corpo e dalle sue difficoltà, pertanto, possiamo tracciare il livello di capacità di
relazione e di adattamento, sia funzionale che disfunzionale, in risposta a stimoli esterni. Acting out
dovuti a impulsività e distruttività, tagli e suicidalità o attacchi al corpo in generale, distruttività
attraverso eccesso di cibo o restrizione eccessiva sono tutte espressioni della disorganizzazione
della risposta del sistema mente-corpo-cervello nei disturbi di personalità (un discorso a parte
merita l'anoressia, che può presentarsi in strutture diverse, gravi ossessivi -che io non considero
disturbi di personalità - o psicotici).
.
21