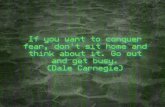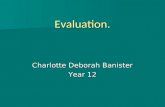FINAL
-
Upload
enrico-bagnoli -
Category
Documents
-
view
83 -
download
1
Transcript of FINAL

Analisi cinematica ed elettromiografica del gesto di sollevamento pesi in atleti disabili
Bagnoli Enrico, D’Angelo Giorgia, Pampaloni Alessandra, Urbini Giacomo, Valle Giacomo
Abstract
Nell’ambito di competizioni sportive di sollevamento pesi risulta di fondamentale importanza la perfetta esecuzione del gesto motorio. Una prova mal eseguita può infatti determinare la squalifica dell’atleta dalla competizione stessa. Nel caso di atleti disabili è quindi assai rilevante capire se il movimento risulta simmetrico, fluido, ben eseguito. In tale articolo vengono analizzate le prove di sollevamento pesi di quattro atleti con disabilità diverse. Sono analizzati sia i dati cinematici, provenienti da marker, sia i dati elettromiografici, relativi alle attivazioni muscolari.
Materiali e Metodi
Abbiamo analizzato il gesto di sollevamento pesi in quattro soggetti. Ogni soggetto ha effettuato tre prove. Il peso è stato scelto in modo da avere uno sforzo massimale.
Strumentazione
Le acquisizioni sono state effettuate presso il Laboratorio di Analisi del Movimento dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). Il laboratorio (Fig. 1) è dotato di un sistema integrato per analisi del movimento composto da:
- Un sistema optolettronico con 8 telecamere infrarossi e markers passivi; - Un elettromiografo di superficie; - 2 pedane dinamometriche; - 2 telecamere digitali per riprese video tradizionali;
�1

Fig 1. Laboratorio di analisi del movimento dell’Ospedale Santa Corona (Pietra Ligure) Un sistema integrato (Fig. 2) per analisi del movimento è composto da una serie di strumenti interfacciati tra loro allo scopo di indagare in maniera complementare i vari aspetti del movimento, fornendo in tal modo un quadro clinico completo ed esauriente.
!
Fig 2. esempio di sistema integrato all’interno di un LAM
Il sistema centrale di cattura del movimento acquisisce e sincronizza i segnali di cinematica, elettromiografia e videocontrollo provenienti dai vari strumenti di acquisizione. In questo studio preliminare il nostro obiettivo era quello di registrare, durante il gesto di sollevamento del peso il movimento di braccia e bacino e l’attività elettromiografica di alcuni muscoli di spalla e gomito. Abbiamo quindi utilizzato un sistema con videocamere ad infrarossi e marker passivi (SMART DX, BtsBioenginnering, Italia) per la prima analisi ed un elettromiografo per elettromiografia dinamica di superficie (FREEEMG300, BtsBioengineering, Italia) per la seconda analisi. Il sistema optoelettronico di videocamere consente di misurare le coordinate cartesiane (x,y,z) di un punto nello spazio. In particolare esso acquisisce la posizione 3D di marker di materiale riflettente (Fig.3) che vengono posizionati su particolari punti di repere del paziente durante l’esecuzione del movimento al fine di rendere possibile al sistema l’identificazione della figura del soggetto e dei suoi segmenti corporei. Il sistema in dotazione utilizza marker passivi: sono elementi di forma sferica o semisferica ricoperti di materiale catarifrangente. I markers vengono illuminati da sorgenti di luce infrarosso posizionate attorno all’obbiettivo di ciascuna telecamera. La luce generata si riflette sui marker e viene ripresa dalle videocamere come un punto luminoso, corrispondente al marker che l’ha riflessa. La loro posizione è identificata dal sistema attraverso la determinazione del centro dell’area luminosa registrata. E’ necessario per una corretta analisi del movimento essere molto precisi nel posizionare i marker sul paziente.
�2

Per poter estrarre le informazioni provenienti da attività complesse che includono ad esempio movimenti di tipo rotatorio o per ottenere dati tridimensionali è indispensabile poter disporre di più punti di osservazione: perciò secondo lo standard attuale il sistema centrale per l’elaborazione è collegato ad un sistema tridimensionale di analisi del movimento composto da otto telecamere opportunamente posizionate all’interno del laboratorio. Un software dedicato partendo da queste coordinate calcola traiettorie e grandezze angolari, nonché informazioni riguardanti i momenti, le forze e le potenze generate a livello delle articolazioni.
! !
Fig. 3 Telecamera ad infrarossi e markers del sistema optoelettronico
Per acquisire l’attività muscolare abbiamo utilizzato un dispositivo diagnostico integrato per l’analisi elettromiografica dinamica (Fig 4) : esso consente di acquisire durante il movimento fino a 16 muscoli in contemporanea e 8 aree di basografia (durante la Gait Analysis).
Fig. 4: elettromiografo e solette basografiche
In questo tipo di analisi gli elettrodi per l’acquisizione possono essere sia di superficie sia a filo. Gli elettrodi di superficie sono costituiti di base da due piccoli dischi metallici fissati alla cute, ciascuno fornito di un cavo sottile che consente la connessione all’amplificatore. Gli elettrodi a filo registrano il segnale direttamente
�3

dal muscolo, il materiale più comune è un filo che lega nickel o cromo ricoperto da nylon, la parte finale del filo è ricurva e le sue estremità sono isolate per evitare corto circuiti. Per la loro invasività gli elettrodi a filo vengono utilizzati nell’elettromiografia dinamica quando il muscolo da esaminare non è superficiale, in tal caso il suo segnale risulterebbe non rilevabile con elettrodi di superficie. Ovviamente gli elettrodi di superficie sono più confortevoli essendo semplicemente fissati sulla pelle, i fili al contrario devono essere inseriti nel muscolo con la penetrazione nella cute; questi ultimi hanno però il vantaggio di essere maggiormente selettivi. I segnali provenienti dagli elettrodi (sia di superficie che a filo) sono acquisiti dall’unita paziente, così definita perché è indossata dal paziente durante il movimento ed inviati al sistema centrale. A supporto dell’indagine clinica, il sistema include un videocontroller digitale, composto da 2 telecamere per consentire l’osservazione simultanea del soggetto nei piani frontale, sagittale. Durante le nostre acquisizioni le telecamere sono state posizionate in modo appropriato (una dietro e una frontale al soggetto) in modo da avere una buona indagine osservazionale a completare l’indagine strumentale
Protocollo e Setup Sperimentale
Nel caso della nostra analisi abbiamo utilizzato telecamere infrarossi marker passivi, per analizzare variabili di tipo cinematico ed elettromiografia di superficie. Abbiamo posizionato 8 marker passivi sui soggetti esaminati, sui seguenti punti di repere:
- Acromion (bilateralmente); - Epicondilo laterale del gomito (bilateralmente); - Processo stiloideo dell’ulna (bilateralmente); - ASIS (bilateralmente);
Inoltre 4 marker sono stati posizionati sull’asta, 2 ai capi esterni rispettivamente a destra e sinistra e due più internamente.
Il modello in figura (Fig.5)rappresenta il posizionamento dei marker.
! Fig. 5. Modello di posizionamento dei marker
�4

Abbiamo analizzato, attraverso elettromiografia di superficie l’attività dei seguenti muscoli, bilateralmente:
- Trapezio Trasverso; - Deltoide Anteriore; - Grande Pettorale; - Tricipite Brachiale; - Bicipite Brachiale; - Retto Addominale.
Tutte le acquisizioni sono stati riprese, in modo sincronizzato al sistema di acquisizione, da due telecamere digitali, poste davanti e dietro al paziente (piano frontale, Fig 6)
!
Fig. 6. Esempio di ripresa video
I dati di cinematica ed elettromiografia sono stati prima elaborati con il programma Smart Tracker (BtsBioengineering, Italia) e successivamente analizzati in Matlab (MathWorks, Natick, MA, US).
Convenzioni
Gli assi sono stati scelti nel seguente modo:
�5

Fig. 7. Sistema di riferimento
L'asse y e' diretto verso l'alto, perpendicolare al corpo del paziente, l'asse x e' diretto longitudinalmente al paziente e l'asse z e' diretto trasversalmente al paziente.
Per convenzione in tutte le figure mostrate il rosso rappresenta il segnale destro, il blu quello sinistro. Inoltre le lunghezze sono in metri.
Sviluppo Software
I dati sono stati analizzati in ambiente Matlab. Sono state sviluppate diverse funzioni per il processing dei dati. In generale l’analisi è comune per tutti i pazienti, ma ci sono leggere differenze legate ai diversi tempi di esecuzione delle prove. Sono stati così creati 4 diversi script, uno per ogni paziente, ma il metodo di analisi è comune per tutti i soggetti. ! 6
Filtraggio
Il primissimo step è stato quello di filtrare il segnale cinematico proveniente dai marker per eliminare le componenti di rumore, prima della segmentazione. Per fare ciò si è usata la funzione sav_golay che effettua un filtraggio polinomiale secondo il metodo Savitsky e Golay. Tramite tale funzione calcoliamo anche la velocità, derivando nel tempo il segnale di posizione. Il filtraggio e il calcolo della velocità vengono effettuati solo per il marker posto sul bilanciere esterno, quello usato per la segmentazione. Infatti il segnale cinematico risulta in generale poco rumoroso, il filtraggio elimina però possibili picchi rumorosi potenzialmente fuorvianti per la segmentazione.
Segmentazione
Il secondo passo nell’analisi è stato quello di segmentare il movimento, tagliando e considerando successivamente solo l’effettivo gesto motorio di sollevamento pesi. Per fare ciò abbiamo utilizzato il dato relativo al marker situato sul bilancere esterno sx. Esso infatti rappresenta lo spostamento verticale del bilancere ed è facilmente
�6

intuibile quale sia il movimento vero e proprio. Inoltre il dato è chiaro e pulito in tutte le prove e in tutti i pazienti.
! Fig. 7. Esempio di segmentazione, sono stati analizzati solo i dati compresi tra il primo e
l’ultimo asterisco rosso (relativa al primo paziente, seconda prova)
Per effettuare la segmentazione è stata usata la funzione findpeaks per rilevare i due picchi più pronunciati del segnale, corrispondenti all’inizio e alla fine del movimento. E’ stato inoltre rilevato il picco minimo per verificare che sia compreso tra i due picchi precedenti.
Plot Marker
Il passo successivo è quello di andare a graficare i dati cinematici relativi ai marker. Non tutti i dati sono poi rilevanti, ma verranno discriminati in un secondo momento. Il risultato è una serie di finestre, una per ogni marker, con 3 grafici relativi ai tre assi cartesiani. All’interno dello stesso grafico sono plottatte due tracce, una per il marker destro (rosso) e una per quello sinistro (blu).
�7

! Fig. 8. Output della procedura plot_marker relativo al marker del gomito nella terza prova
del primo paziente.
Analisi segnale elettromiografico
Per estrarre informazioni utili dal segnale elettromiografico (EMG) sono necessarie alcune operazioni di elaborazione.
1. Filtraggio con un filtro passa-banda tra 30 e 450 Hz. In tal modo vengono eliminati gli artefatti di movimento (con frequenze tipiche minori di 30 Hz). Il limite superiore è imposto a 450 Hz dal teorema di Nyquist poiché i dati sono campionato a fc = 1000 Hz.
2. Rettificazione del segnale filtrato. Vengono eliminate le componenti negative. 3. Calcolo dell’inviluppo (dato finale) attraverso un filtro passa-basso con
frequenza di taglio a 5 Hz.
Tutte le operazioni di filtraggio avvengono utilizzando la funzione filtfilt che non introduce cambiamenti di fase nell’operazione.
�8

!
Fig. 9. Esempio di segnale elettromiografico riferito al muscolo del trapezio trasverso destro.
Plot Emg
Procedura simile a plot_marker per graficare i segnali EMG. Nella stessa finestra sono accoppiati i segnali di due muscoli: trapezio trasverso e retto addominale, tricipite e bicipite brachiale, deltoide anteriore e pettorale maggiore. Abbiamo cercato di accoppiare i muscoli per studiare la sinergia muscolare. Nei grafici abbiamo inserito un onda quadra di ampiezza uguale alla massima attivazione muscolare destra che delimitasse l’area di movimento. Abbiamo comunque deciso di visualizzare tutti i dati, senza tagliare la parte esterna al movimento (come fatto nel caso cinematico) per non perdere informazioni sull’eventuale pre o post attivazione muscolare.
�9

!
Fig. 10. Segnale EMG del secondo paziente, relativo alla seconda prova. Si nota un picco nell’attività muscolare del retto, soprattutto destro alla fine del movimento, che coincide con il
riposizionamento del bilanciere sulla sbarra.
Varie
Abbiamo creato anche una funzione per calcolare la funzione di costo del jerk, un indicatore sulla fluidità del movimento. Tale funzione richiede il calcolo della durata del movimento e dell’ampiezza. Infatti il jerk non normalizzato secondo tali valori non fornisce alcuna informazione utile.
�10

Risultati Primo Paziente
Il primo soggetto solleva un peso di 80 kg.
Analisi cinematica
Dai grafici riguardanti i marker posti sulla spina iliaca anteriore superiore (ASIS) notiamo un offset significativo, ma in fase; durante le tre prove non vi sono spostamenti significativi ne lungo l'asse x ne lungo l'asse y. Lungo l'asse z non vi sono spostamenti ciò significa che la posizione delle gambe del paziente e' corretta in quanto durante il sollevamento hanno permesso di controllare l'equilibrio del corpo evitando spostamenti laterali del bacino.
!
Fig. 11. Spostamento ASIS nella prima prova.
Nelle tre prove le variazioni sono minime, indicando una costante e corretta posizione sulla panca. Analizzando i marker posti sulle spalle notiamo che non vi sono spostamenti significativi lungo l'asse y, infatti per eseguire correttamente l'esercizio le spalle devono restare rilassate: un innalzamento delle spalle dalla superficie della panca non causa nessun beneficio all'esercizio, causa solo uno spreco di energie, con il rischio di esaurire i fasci del deltoide anteriore prima di portare a termine l'esercizio per i pettorali. Lungo l'asse x invece l'andamento dei marker e' alquanto variabile e confuso, come se il paziente avesse difficoltà nel sollevare il bilanciere
�11

! Fig. 12. Spostamento su x del marker della spalla. Notiamo un tracciato confuso, indice di un
posizionamento non perfettamente parallelo delle spalle.
Dai grafici riguardanti i marker posti sui gomiti possiamo affermare che durante le tre prove il paziente esegue correttamente il movimento lungo l'asse y; lungo l'asse x vi sono piccoli spostamenti, significativi per il marker sx.
! Fig. 13. Spostamento su y del marker del gomito. Movimento perfetto.
Analizzando i marker posti sui polsi confermiamo che durante le tre prove il paziente esegue correttamente il movimento lungo l'asse y e che lungo l'asse x vi sono spostamenti significativi che riguardano principalmente il marker sx. Se andiamo ora ad analizzare il movimento del bilanciere, grazie ai marker posizionati sull'asta, due agli estremi e due più internamente, possiamo affermare che lungo l'asse y il movimento compiuto dal paziente e' corretto in quanto l'asta viene mantenuta parallela al pavimento (i tracciati dx e sx coincidono). Lungo l'asse x invece, soprattutto durante la fase di risalita, vi è una differenza significativa tra i tracciati di marker dx e sx: i marker sul lato dx del bilanciere si spostano significativamente lungo l'asse x.
! Fig. 14. Spostamento su x del marker bilanciere esterno. Anche in questo caso vi è una
significativa differenza tra marker destro (rosso) e sinistro (blu)
�12

Analisi elettromiografica
Analizzando, attraverso i dati elettromiografici, l'attività muscolare del paziente, notiamo una differente attivazione del deltoide anteriore: il muscolo risulta significativamente più attivo nell'emicorpo dx, soprattutto nelle prime due prove; per quanto riguarda invece il gran pettorale, nell'emicorpo dx, abbiamo una debole attivazione in corrispondenza dell'eccessiva attivazione del deltoide anteriore, questo forse dovuto al fatto che il paziente ha accompagnato con la spalla il bilanciere durante la risalita e questo ha fatto lavorare il pettorale in accorciamento e passato molto lavoro al deltoide anteriore che, oltre a non essere il muscolo target, è di dimensioni modeste quindi debole.
! Fig. 15. Attivazione muscolare del deltoide anteriore e gran pettorale. Notiamo uno
sbilanciamento a favore del deltoide dx e del pettorale sx
I muscoli quando il paziente è a riposo non sono attivi, si attivano poco prima del movimento (quando il paziente afferra la sbarra) e poco dopo la fine dello stesso. Se analizziamo invece i muscoli antagonisti bicipite brachiale e tricipite brachiale notiamo un'attivazione anticipata del bicipite brachiale sx e, durante il movimento di risalita del bilanciere, una maggiore attivazione del tricipite brachiale dx. Da questi grafici si evince come il bicipite abbia un picco di attivazione durante la transizione tra il movimento di discesa e di salita. Il tricipite, invece, ha la sua massima
�13

attivazione in fase di spinta, ma è attivo per un periodo più lungo rispetto al bicipite, conferendo rigidezza e resistenza al peso in fase di discesa. Tra le varie prove soltanto nella seconda prova il bicipite mostra un’ inversione nel muscolo più attivo rispetto alle altre due (da sx a dx)
!
! Fig. 16. Attivazione muscolare del 1) tricipite nella seconda prova 2) bicipite nella seconda prova 3) bicipite nella prima prova. E’ evidente il picco di attivazione del bicipite a metà
movimento e l’inversione di attivazione del bicipite nell’immagine 2
Riguardo il trapezio trasverso si ha un'attivazione anticipata nell'emicorpo sx e, durante la risalita del bilanciere, una maggiore attivazione del trapezio trasverso dx. Il retto addominale risulta invece attivo tonicamente durante tutta l'esecuzione dell'esercizio, anche se nell'emicorpo sinistro si ha una maggiore attivazione. Inoltre è presente un picco molto marcato a fine movimento presumibilmente legato alla fase di appoggio del bilanciere, fase in cui è necessaria una contrazione addominale
�14

maggiore. L’addome risulta tonicamente attivo durante tutta la fase di studio, stabilizzando il tronco e aiutando a sopportare lo sforzo. Tuttavia una cosi marcata attivazione è riscontrata solo in questo paziente sottolineando o uno sforzo eccessivo o un possibile problema a livello muscolare Nell’ultima prova il tracciato del retto risulta migliore, meno tonico a indicare un minor uso di tale muscolo.
! Fig. 17. Trapezio e retto. Attività tonica del retto e picco a fine movimento.
Conclusioni
Integrando i dati cinematici con i dati elettromiografici possiamo dire che squilibri nell’attivazione muscolare causano un alterato gesto motorio. In particolare le variazioni maggiori si riscontrano lungo l’asse x, dove notiamo un andamento poco costante e errato, dovuto principalmente allo scompenso nell’attivazione del deltoide e del trapezio sinistro rispetto al destro. Il movimento lungo l’asse verticale y invece risulta abbastanza preciso. La posizione del bacino durante la prova risulta corretta, forse grazie all’ipertonicità del retto addominale.
�15

Risultati Secondo Paziente Il secondo soggetto solleva un peso di 60 kg.
Analisi cinematica
Come per il paziente 1, i dati relativi ai marker sulla cresta iliaca anteriore superiore non danno informazioni che possano essere sintomo di qualche problematica. In entrambe le tre prove è presente un offset significativo ma in fase: solo lungo l’asse y sembra scomparire questa coerenza di fase, segno forse di uno scorretto posizionamento del bacino sulla panca.
Fig. 19. Spostamento ASIS nella terza prova.
I dati cinematici relativi ai marker posti sulle spalle sono indicatori di un loro ottimo posizionamento durante tutto il movimento: le tracce, in tutti e tre gli assi, sono pulite nel tempo forse anche grazie al fatto che il carico non è troppo elevato (60kg).
Fig. 20. Marker sulle spalle nella terza prova. Indicatori di un ottimo movimento.
�16

Anche i dati relativi ai polsi sono indicatori di un buon movimento e di una buona coordinazione durante tutte le tre prove e lungo tutti e tre gli assi: solo lungo x, nella terza prova, si nota un movimento un po’ confuso probabilmente però dovuto ad un generale affaticamento del paziente; cosa che peraltro si riscontra anche dai dati relativi agli altri marker.
Fig. 21. Evoluzione, lungo l’asse x, dei marker relativi al polso. Si nota generalmente una buona coordinazione nelle prime due prove mentre nell’ultima la non perfetta coordinazione è
forse dovuta ad un affaticamento del paziente.
Analizzando infine i dati dei marker posti nel bilanciere notiamo un leggero offset lungo y, segno del fatto che il paziente sbilancia leggermente il bilanciere; ed è forse questo il motivo della non perfetta adesione del bacino alla panca. Questo offset però tende a ridursi con l’avanzare delle prove. Lungo x e z invece i tracciati sono buoni con l’eccezione però che lungo x, nell’ultima prova, i tracciati tendono a peggiorare: ma questo, come abbiamo detto prima, è forse dovuto ad un affaticamento del paziente ed, in effetti, si poteva intuire anche dall’andamento del polso.
�17

Fig. 22. Marker posti nel bilanciere durante la prima prova. Si nota tutto sommato una buona coordinazione del movimento nonostante un leggero offset lungo l’asse y.
Analisi elettromiografica
Passando ora all’analisi elettromiografica e vagliando i vari muscoli interessati durante il movimento possiamo dire che per quanto riguarda il deltoide anteriore si ha una maggiore attivazione nell’emicorpo dx con un picco di attivazione durante l’inizio della fase di risalita del bilanciere; cosa plausibile del resto.
Fig. 22. Attivazione muscolare del deltoide anteriore e gran pettorale durante la prima prova. Notiamo due picchi di attivazione del deltoide anteriore dx prima e dopo il movimento.
�18

Mentre invece nel gran pettorale non vi è una significativa differenza fra emicorpo dx e emicorpo sx segno del fatto che il paziente ha lavorato bene. Anche qui, come nel caso del primo paziente si può notare un attivazione dei due muscoli poco prima dell’inizio e poco dopo la fine del movimento. Significativi sono però i due picchi di attivazione del deltoide anteriore dx prima e dopo il movimento, probabilmente dovuti al fatto che durante la fase di stacco e la fase di rilascio del bilanciere sulla sbarra il paziente usa molto di più la spalla dx rispetto alla sx.
Fig. 23. Attivazione muscolare del bicipite brachiale e del tricipite brachiale durante la seconda prova.
Riguardo i muscoli antagonisti bicipite brachiale e tricipite brachiale si nota generalmente una buona simbiosi fra emicorpo dx e emicorpo sx segno del fatto che il paziente ha fatto lavorare i muscoli in maniera equilibrata. Come si evince dai tracciati, infatti, entrambi i muscoli sono tonicamente attivi durante tutto il movimento con una breve fase di attivazione pre-moto e una picco di attivazione post-moto, probabilmente dovuto al riposizionamento del bilanciere da parte del paziente. I muscoli del trapezio trasverso, invece, risultano, dai dati elettromiografici, sempre attivi durante tutto il movimento con una generale maggiore attivazione nell’emicorpo sx rispetto all’emicorpo dx. Mentre, invece, dai tracciati del retto addominale notiamo una generale assenza di segnale per tutto il movimento con un picco di attivazione a fine moto dovuto forse al riposizionamento del bilanciere (picco che tra l’altro si osserva anche nel muscolo del trapezio trasverso). Il segnale
�19

risulta di bassissima ampiezza e dove tale ampiezza è significativa prevale nettamente il muscolo destro. Questa assenza di segnale potrebbe forse essere dovuta al fatto che il paziente mostrava, nei dati cinematici della cresta iliaca superiore anteriore, un generale squilibrio lungo l’asse y in tutte e tre le prove.
Fig. 24. Attivazione muscolare del trapezio traverso e del retto addominale durante la terza prova. Si nota un’assenza di attivazione del retto addominale che si mantiene durante tutto il
movimento.
Conclusioni
In questo paziente l’andamento di tutti i tracciati risulta piuttosto buono, probabilmente anche grazie al fatto che il paziente solleva un peso non troppo eccessivo (60 kg). Sia i dati cinematici che i dati elettromiografici infatti sono coerenti con quello che è il movimento e generalmente si ha una buona coordinazione fra emicorpo dx e emicorpo sx.
�20

Risultati Terzo Paziente
Il terzo soggetto solleva un peso di 120 kg.
Analisi cinematica I dati cinematici relativi ai marker posti nella cresta iliaca superiore anteriore (ASIS) sono in linea con quelli dei pazienti precedenti: come prima, infatti, in tutte e tre le prove notiamo un offset significativo fra emicorpo dx e emicorpo sx; ma il tutto è in fase. Ciò significa che la posizione del bacino del paziente sulla panca durante il movimento è corretta, a differenza del paziente 2 dove si notava una perdita dell’offset lungo l’asse y.
Fig. 25. Spostamento ASIS durante la prima prova. Si può notare come l’offset rimanga in fase durante tutto il movimento.
I dati che ne derivano dai marker posti sulle spalle fanno presupporre un loro scorretto posizionamento durante tutto il movimento; ma questo, forse, è anche dovuto al fatto che il paziente solleva un carico molto pesante, ben 120 kg, e quindi non presuppone necessariamente una condizione di una qualche patologia. Specialmente lungo l’asse x, però, si nota un movimento che pare un po' a scatti e un offset significativo; il che significa uno squilibrio delle spalle e quindi della distribuzione del peso. Lungo gli altri assi, invece, le cose vanno molto meglio con l’eccezione, però, di un notevole peggioramento nell’ultima prova: cosa che può essere dovuta ad un generale affaticamento del paziente.
�21

Fig.26. Dati relativi ai marker della spalla durante la terza prova. Sembra esserci un generale
affaticamento del paziente forse dovuto al notevole carico sollevato
I dati dei marker sui polsi e sui gomiti sono molto buoni in tutte e tre le prove e in tutti e tre gli assi. Si sporcano leggermente con l’avanzare delle prove, forse a causa dell’affaticamento del paziente. Inoltre, relativamente ai marker posti sui gomiti, lungo l’asse x, notiamo un andamento un po' tremolante che potrebbe essere dovuto dal carico eccessivo; comunque si tratta di variazioni veramente poco significative e che possono risultare del tutto normali con un carico così elevato.
Fig.27. Spostamento dei polsi lungo, rispettivamente, l’asse x ed y durante la terza prova. Nonostante un generale affaticamento il movimento è pressoché perfetto.
�22

Fig.28. Spostamento dei gomiti lungo, rispettivamente, l’asse x ed y durante la prima prova. Si può notare un leggere tremore lungo l’asse x forse dovuto al carico eccessivo ma comunque si
può affermare che il movimento è tutto sommato molto buono.
Dai dati relativi ai marker posti sul bilanciere si evince che il paziente, durante tutto il movimento, mantiene ben in equilibrio il bilanciere: sia lungo x che lungo y, infatti, i tracciati coincidono quasi perfettamente segno del fatto che il paziente, nonostante il carico di 120 kg, svolge un movimento corretto.
Fig.29. Tracciati dei marker posti internamente al bilanciere, durante la prima prova.
�23

Analisi elettromiografica
Per quanto riguarda l’analisi dei dati elettromiografici del paziente notiamo, nei tracciati del deltoide anteriore, un maggiore utilizzo del’emicorpo dx rispetto all’emicorpo sx con un picco di attivazione durante la fase di risalita del bilanciere, così come lo avevamo notato nel paziente 2. A differenza, però, dei due pazienti precedenti non si nota una attivazione del deltoide anteriore prima e dopo il movimento. Nei tracciati relativi al muscolo del gran pettorale, invece, si nota tutto sommato un’attivazione equilibrata fra i due emicorpi con una attivazione piuttosto marcata anche alla fine del movimento probabilmente dovuta allo sforzo fatto durante il riposizionamento del bilanciere sulla sbarra.
Fig.30. Dati elettromiografici dei muscoli deltoide anteriore e gran pettorale riferiti alla terza prova.
Riguardo ai tricipiti si nota, come nel paziente 2, un buon equilibrio fra emicorpo dx ed emicorpo sx ed una generale attivazione che si mantiene pressoché costante durante tutto il movimento; cosa che peraltro è plausibile in quanto questo tipo di movimento richiede un lavoro costante dei muscoli tricipiti. Anche in questo caso si nota un’attivazione marcata alla fine del movimento, dovuta allo sforzo del paziente per riposizionare il bilanciere sulla sbarra. Per quanto riguarda i bicipiti, invece, si nota una generale assenza di attività con un picco di segnale a metà movimento, poco prima della fase di risalita del bilanciere, cosa che è in linea con il tipo di movimento
�24

fatto dal paziente. La cosa particolare che ne risulta dall’analisi di questi tracciati però è l’eccessivo utilizzo del bicipite destro rispetto al sinistro: sembra infatti che il paziente sopporti il peso del bilanciere soprattutto con l’emicorpo dx anche se generalmente questo trend sembra migliorare con l’avanzare delle prove.
Fig.31. Evoluzione dell’attivazione dei bicipiti durante la prima e la seconda prova. Si nota, con l’avanzare delle prove, una migliore distribuzione del peso fra emicorpo dx ed emicorpo
sx.
Analizzando, infine, i dati elettromiografici del trapezio trasverso notiamo nelle prime due prove una generale assenza di segnale che invece compare marcatamente durante la terza prova: il carico eccessivo ed un generale affaticamento del paziente probabilmente lo hanno portato ad un maggiore utilizzo di questo muscolo. Lo sforzo causato dal carico elevato e l’affaticamento si possono notare, tra l’altro, anche dai dati relativi al muscolo del retto addominale: con l’avanzare delle prove, infatti, il segnale, che si mantiene atttivo durante tutto il movimento e anche dopo, risulta più a scatti segno del fatto che serve un gran lavoro dell’addome per stabilizzare il paziente sotto il grosso peso.
�25

Fig.32. Attivazione dei muscoli trapezio trasverso e retto addominale durante la terza prova.
Conclusioni
Sia i dati cinematici che quelli elettromiografici risultano molto buoni. E’ evidente, però, un lieve peggioramento con l’avanzare delle prove segno però dell’affaticamento del paziente che deve sollevare un peso elevato. Comunque dai dati cinematici si nota che il paziente svolge il movimento in maniera corretta mentre dai dati elettromiografici si evince tutto sommato un buon lavoro dei muscoli con una buona distribuzione del peso fra emicorpo dx e sinistro.
�26

Risultati Quarto Paziente
Il terzo soggetto solleva un peso di 90 kg.
Analisi cinematica
Analizzando i dati dei marker sulla cresta iliaca superiore anteriore (ASIS) risalta subito all’occhio un andamento anomalo del tracciato lungo l’asse y: mentre, infatti, lungo gli altri assi si nota, come nei pazienti precedenti, un offset che rimane in fase durante l’esecuzione di tutto il movimento, lungo l’asse y i due tracciati (relativi a marker dx e marker sx) si incrociano varie volte segno del fatto che, durante il movimento, il paziente sbilancia il peso lungo il piano trasversale.
Fig.33. Andamento dei marker della cresta iliaca superiore anteriore lungo l’asse y durante la prima prova. Si nota uno sbilanciamento continuo del peso.
Fig.34. Tracciati dei marker della spalla nella terza prova.
�27

I dati dei marker sulla spalla sono poco significativi nel senso che è difficile trarne considerazioni in quanto nella prima prova sono presenti pochi dati mentre nelle successive prove sono presenti praticamente solo i dati relativi alla spalla sx con qualche comparsa, a tratti, dei dati relativi alla spalla dx: ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il paziente, nello sbilanciare il bilanciere, possa in qualche modo coprire il marker della spalla dx generando una scomparsa del segnale. Il movimento dei polsi, invece, in contrasto ai dati precedenti, sembra pulito, specialmente lungo l’asse y dove i due tracciati relativi a marker dx e sx coincidono quasi perfettamente: lungo l’asse x, invece, c’è un piccolo offset probabilmente dovuto allo sbilanciamento del peso.
Fig.35. Tracciati dei marker dei polsi nella seconda prova. Si nota tutto sommato un buon equilibrio fra parte dx e sx e un movimento tutto sommato buono.
Questo stesso andamento si riscontra anche dai tracciati dei marker posti sui gomiti con la differenza però che l’offset presente lungo x è più marcato; questa cosa però non ci stupisce particolarmente in quanto, se è vero, che c’ è uno sbilanciamento del peso, esso influenza maggiormente il movimento dei gomiti rispetto a quello dei polsi. Il movimento lungo y, invece, risulta buono.
Fig.36. Tracciati dei marker dei gomiti nella seconda prova.
�28

Anche dai dati relativi ai marker posti sul bilanciere notiamo un andamento dello stesso tipo dei due precedenti: offset lungo x, segno dello sbilanciamento del peso lungo il piano trasversale, e andamento buono lungo y, segno che il paziente svolge un movimento corretto lungo il piano coronale.
Fig.37. Marker posti internamente al bilanciere. Seconda prova.
Analisi elettromiografica
Le attivazione muscolari del paziente risultano ben bilanciate tra emicorpo destro e sinistro. Ciò avviene in generale per tutti i muscoli eccetto che per il deltoide. Esso infatti mostra in tutte e tre le prove un eccessiva attività dell’emiparte sinistra. L’attivazione della parte destra è coerente con quanto visto per gli altri pazienti, ma il segnale sinistro invece appare confusionario, caotico e casuale.
�29#104
0 0.5 1 1.5 2 2.5
#10-4
-1
0
1
2
3
4
5Deltoideus anterior
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5
#10-4
-1
0
1
2
3
4
5Pectoralis Major
RightLeftMovement

Fig.38. Evoluzione dei tracciati elettromiografici relativi al deltoide anteriore.
Il pettorale invece pare avere un’attivazione corretta, con un picco a circa metà esercizio, coincidente con la transizione da fase di discesa a quella di spinta. Per quanto riguarda i muscoli del braccio quali bicipite e tricipite si nota che il tricipite si attiva prima del gesto motorio e rimane attivo anche dopo. Ciò comporta una rigidezza eccessiva del braccio poco favorevole al compimento del task. Per quanto riguarda il bicipite, invece, si ha in generale un buon andamento con un picco di attivazione a metà prova, e cioè poco prima della fase di risalita del bilanciere, momento in cui effettivamente è richiesto lo sforzo maggiore da parte dei bicipiti. Si può notare anche un corretto bilanciamento fra i due emicorpi. Per quanto concerne gli ultimi due muscoli presi in esame, il retto e il trapezio, evidenziamo una smisurata attivazione tonica del retto, presente anche in altri pazienti. In tale soggetto anche il trapezio è attivo in maniera tonica. Ma se per il trapezio l’attivazione risulta bilanciata, ciò non avviene per il retto. Infatti è chiara una netta prevalenza del muscolo laterale sinistro.
�30
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
#10-4
-1
0
1
2
3
4
5
6
7Deltoideus anterior
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
#10-4
-1
0
1
2
3
4
5
6Pectoralis Major
RightLeftMovement
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5
#10-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14Deltoideus anterior
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5
#10-4
-1
0
1
2
3
4
5
6
7Pectoralis Major
RightLeftMovement

Fig.39. Dati elettromiografici dei bicipiti e dei tricipiti durante la terza prova.
Fig.40. Dati elettromiografici del trapezio trasverso e del retto addominale relativi alla prima prova.
Conclusioni
In questo ultimo paziente i dati, specialmente quelli elettromiografici, non sono ottimi: l’eccessiva attivazione del retto addominale nell’emicorpo sx serve
�31
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
#10-4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4Triceps brachii caput longus
#1040 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
#10-4
-1
0
1
2
3
4
5Biceps brachii caput longus
RightLeftMovement

probabilmente a stabilizzare continuamente il bacino del paziente, forse dovuto anche al fatto che, come risulta dai dati cinematici lungo il piano trasversale, il paziente sembra sbilanciare il peso del bilanciere. Lungo il piano coronale, invece, l’analisi dei dati cinematici ci porta a dire che, tutto sommato, il paziente svolge un corretto movimento con un buon bilanciamento fra emicorpo dx e sx.
�32