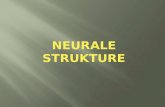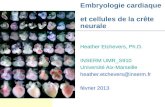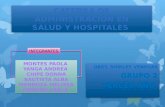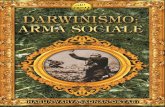Edelman - Darwinismo Neurale
-
Upload
hybridslinky -
Category
Documents
-
view
407 -
download
7
Transcript of Edelman - Darwinismo Neurale
-
6
Titolo originale Neura! Darwinism. Tbe Tbeory ofNeurona! Group Se!eetion. I987 Basic Books, Inc., New York
Pubblicato per getlJ:i1e concessione della Basic Books, una divisione di HarperColiins Publishers, Inc.
I995 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino Traduzione di Silvio Ferraresi
ISBN 88-06-I2752-7
'" "
Gerald M. Edelman Darwinismo neurale
La teoria della selezione dei gruppi neuronali
Prefazione di Giulio Tononi A cura di Silvio Ferraresi
ISBCC BIBLIOTECA MARCONI Inventario Q1.3'8..4.2.1-
Einaudi
/ . /"-..,. ,~,;/.! i,,,, ,-"
-
Indice
p. IX Figure nel testo XIII Elenco delle abbreviazioni XIV Elenco dei simboli matematici
XVII Prefazione XXI Prefazione ail'edizione italiana
xxxv Nota del curatore
Darwinismo neurale
Parte prima 3 La selezione somatica
Capitolo primo Riassunto e introduzione storica
5 I. Introduzione 6 2. Un profilo sintetico della teoria
I I 3. Il pensiero popolazionistico in neurobiologia 13 4 Selezione naturale e pensiero popolazionistico in relazione al comporta-
mento 14 5 Declino e rinascita delle idee selezioniste 18 6. Alcune concezioni di selezione somatica 22 7. Distinzioni critiche tra le teorie selezioniste 25 8. Selezione e istruzione nelle teorie globali del cervello
Capitolo secondo Struttura, funzione e percezione
28 I. Introduzione 3 I 2. Categorizzazione percettiva e generalizzazione
-
VI Indice
P.38 3. Variabilit e connessioni sovrapposte nelle strutture neurali 43 4. Sfide critiche ai modelli istruzionisti o a elaborazione d'informazione
Capitolo terzo La selezione dei gruppi neuronali
50 I. Introduzione 53 2. Degenerazione e la definizione di un gruppo 65 3. Siti di variabilit 68 4. Il rientro: perch necessaria la sua struttura e la sua funzione 75 5 La forza esplicativa della teoria 79 6. Il significato adattativo della selezione dei gruppi neuronali
Parte seconda 8 I I meccanismi epigenetici
Capitolo quarto I fondamenti della variabilit nello sviluppo: il repertorio primario
83 I. Introduzione 85 2. Le CAM e la modulazione della superficie cellulare nel corso della morfo-
genesi 96 3. Le sequenze di espressione delle CAM nel corso della embriogenesi e della
neurogenesi 102 4. Gli effetti della funzione delle CAM 108 5. L'ipotesi dei regolatori I 15 6. Variabilit e conservazione della configurazione nella struttura neurale
Capitolo quinto La dinamica cellulare delle mappe neurali
121 1. Introduzione 123 2. Rappresentazione e mappaggio 127 3. I vincoli dello sviluppo nella formazione delle mappe 135 4. E venti cellulari primari e selezione 140 5. L'organizzazione delle mappe durante lo sviluppo 146 6. Le mappe nell' adulto: competizione stabilizzata in circuiti fissi 160 7. Conclusioni
Capitolo sesto Evoluzione e funzione dei sistemi distribuiti
162 1. Introduzione 165 2. Variazione evolutiva nelle reti neurali
Indice VII
p. 172 3. Un esempio di rete 175 4. La variabilit tra specie: l'origine evolutiva di nuclei, lamine e circuiti pa-
ralleli 180 5. Sviluppo ed evoluzione: il rapporto tra ipotesi dei regola tori ed etero-
cronia 186 6. La conservazione evolutiva della degenerazione nei sistemi distribuiti 188 7. Arborizzazioni sovrapposte e mappe rientranti 200 8. Funzione delle mappe ed eterocronia
Capitolo settimo Una concezione popolazionistica delle sinapsi: le basi del repertorio secondario
204 I. Introduzione 206 2. Lo sfondo per un modello popolazionistico 2 I I 3. Un esempio formale della regola postsinaptica e una applicazione alla for-
mazione delle mappe 220 4. Una trattazione formale delle modificazioni presinaptiche 224 5. Le due regole e i loro effetti popolazionistici in una rete 228 6. Gli effetti di un modello popolazionistico che segue le due regole 232 7. La logica dei trasmettitori 234 8. La relazione tra variazione sinaptica e memoria
Parte terza 237 Le funzioni globali
Capitolo ottavo Azione e percezione
239 1. Introduzione 243 2. Il complesso motorio 245 3. Considerazioni evolutive 253 4. Le basi funzionali dei gesti 259 5. Gesti e selezione dei gruppi neuronali 264 6. Gli influssi dell' attivit motoria sulle lamine sensoriali: correlazione dei
caratteri e campionamento parallelo 270 7. I mappaggi globali 272 8. Riassunto
Capitolo nono Categorizzazione e memoria
275 1. Introduzione 278 2. Restrizioni e definizioni 280 3. La categorizzazione 283 4. La categorizzazione percettiva
-
VIII Indice
p. 294 5 Riassunto critico 297 6. Organizzazione neurale e generalizzazione 303 7. Il problema della memoria rivisitato
Capitolo decimo Reti selettive e automi percettivi
310 I. Introduzione 3II 2. Darwin II: il sistema 318 3. Darwin II: il comportamento 328 4. I limiti e le prospettive nelle prestazioni
33 1 333 335 338 341 345 35 1
355
357 363 365 372
375 40 7 477
Capitolo undicesimo Selezione, apprendimento e comportamento I. Introduzione 2. L'interpretazione moderna degli esperimenti sull'apprendimento 3. Apprendimento e sorpresa 4. Comportamento e condizionamento 5. Gerarchie selettive nello sviluppo dell' apprendimento: il canto degli uccelli 6. La selezione dei gruppi neuronali nell'apprendimento 7. Dalle reti selettive rientranti all' elaborazione di informazione
Parte quarta Conclusione
Capitolo dodicesimo Riassunto, previsioni e implicazioni L Introduzione 2. Adeguatezza della teoria 3. Previsioni della teoria 4. Aspetti incompiuti del lavoro e implicazioni generali
Glossario Bibliografie Indice analitico
Figure nel testo
p. 19
33 34 34 35 37
4 1
56
57
61
71
86 89
92
I. Un mnemne o singola unit di memoria come l'ha proposta John Z. Young [1965].
2. Schizzo. 3. Contesto. 4. L'illusione di Wundt-Hering. 5. Modelli di foglie dagli esperimenti di Cerella [I 977]. 6. Regola polimorfa per gli elementi di un insieme, da Dennis e
altri [1973]. 7. Variabilit anatomica [Pearson e Goodman 1979; Macagno e al-
tri 1973; Ramon y Cajal 1904]. 8. Dipendenza di due forme di funzioni di riconoscimento dal nu-
mero N di elementi presenti in un repertorio, calcolati secondo un semplice modello.
9. Due casi estremi di repertorio: con un unico elemento (non de-generato) e con elementi completamente degenerati [Schmitt e Worden, The Neurosciences: 4th Study Program].
IO. Confronto fra le funzioni rr teoriche e sperimentali in funzione della soglia di accoppiamento e dell'ampiezza del repertorio in Darwin I [Schmitt e altri, The Organization 01 the Cerebral Cortex].
I I. Una coppia di classificazione operante in tempo reale per mezzo del rientro.
12. Disegni dei processi primari. 13. Schema della struttura della catena lineare di due CAM primarie
(N-CAM e L-CAM) e della CAM secondaria Ng-CAM. 14. Modalit di legame delle CAM e modulazione della superficie
cellulare. 97 15 La sequenza principale nella espressione delle CAM. 98 16. Variazione nella distribuzione delle N -CAM e delle L-CAM nel-
la fase di formazione della piastra (induzione neurale) e della doccia neurale (neurulazione).
103 17. N-CAM nella piastra motoria terminale e variazioni della distri-buzione nel muscolo dopo denervazione [Journal of Cell Biolo-gy, CIII (1986), p. 934, fig. 2].
-
x
p. 105
109 113
130
141 145
148
150
15 2
155
158 173
176 183 191
194
195
199
209 212 21 4 21 4
218
221
226
Figure nel testo
18. Ruolo causale delle CAM nel modulare l'induzione embrionale e nel delimitare i confini.
19. Mappa presuntiva composita delle CAM nel pollo. 20. L'ipotesi dei regolatori esemplificata in un ciclo regolativo delle
CAM e nelle sequenze epigenetiche. 2 I. Disegno schematico di quattro cellule della glia radiale e della
coorte di neuroni migranti associati, come li ha disegnati Rakic [198Ia].
22. La mappa retinotettale nello Xenopus [Fraser 1985]. 23. Gli effetti degli anticorpi anti-CAM sulla organizzazione delle
mappe retinotettali. 24. Normali variazioni nella mappa somatosensoriale [Merzenich e
altri 1984a]. 25. Variazioni temporali nelle mappe somatosensoriali in seguito a
lesioni [Merzenich e altri 1983b]. 26. Variazioni nel campo recettivo della corteccia somatosensoriale
in conseguenza a una lesione periferica [Merzenich e altri 198 3b]. 27. Una afferenza talamica all'area 3b del gatto rivelata da una inie-
zione di perossidasi del rafano [Landry e Deschenes 1981]. 28. Colonne di dominanza oculare [Hubel e Wiesel 1977]. 29. La rete visiva dello Pseudemys, una tipica sfida all'analisi evolu-
tiva [Ulinski 1980]. . 30. La teoria della parcellizzazione di Ebbesson [1980]. 3 I. L'ipotesi dei regolatori. 32. Le tre componenti nella formazione delle mappe secondo la teo-
ria della selezione dei gruppi neuronali. 33. Concettualizzazione schematica dell'ipotetico processo del con-
finamento dei gruppi. 34. Rappresentazione estremamente idealizzata di arborizzazioni af-
ferenti talamiche sovrapposte. 35. Schema delle connessioni rientranti dinamiche verticali e oriz-
zontali attraverso un sistema collegato di lamine e nuclei. 36. Schema degli input ricevuti da un neurone. 37. Proposta di un meccanismo postsinaptico. 38. Limitazioni temporali nella modificazione postsinaptica. 39. Cinetica della modificazione stato-dipendente impiegando, co-
me esempio, un modello di canale a due stati. 40. Simulazione al computer di un modello di plasticit della mappa
somatosensoriale impiegando la regola postsinaptica [Pearson e altri 1987].
4 I. Diagramma di flusso illustrante le modalit operative della rego-la presinaptica.
42. Classi di connessioni tra gruppi.
p.229
23 0
23 1
248
254
256
257 261
285 290
298 300
301 3 13 31 5 320 321 32 4
326- 2 7
353
Figure nel testo XI
43. Rete di connessione impiegata in simulazioni al computer che rappresentano ciascuna regola in azione isolatamente e le regole in azione simultaneamente.
44. Simulazione al computer che illustra gli effetti delle regole sinap-tiche.
45. Illustrazione delle modificazioni a lungo termine che favoriscono una variazione in conseguenza dell' operazione delle due regole.
46. Comparazione dell'attivit elettromiografica dei muscoli mascel-lari e dei movimenti mascellari nel pesce percoide e nel pesce ci-clide [Liem 1974].
47. Come suggerito da Bernstein [1967], i movimenti circolari effet-tuati dal braccio esteso in diverse posizioni sono realizzati da schemi di innervazione completamente differenti per traiettorie dello stesso tipo.
48. Modelli di andatura nella corsa in et diverse (strisce successive) secondo Bernstein [1967].
49. Topologia secondo Bernstein [1967]. 50. Schema di alcune delle componenti che creano un mappaggio
globale. 5 I. L'esperimento di riconoscimento degli alberi di Herrnstein [1982]. 52. Esempi di figure impiegate da Kellman e Spelke [1983] per veri-
ficare la percezione da parte di neonati di quattro mesi di oggetti parzialmente nascosti.
53. Ambiguit nella classificazione secondo Bongard [1970]. 54. La selezione di parti di gruppi neuronali come risultato dei map-
paggi rientranti delle disgiunzioni di parti in insiemi polimorfi di segnali.
55. Schema di una coppia di classificazione che impiega il rientro. 56. Struttura logica di un gruppo in Darwin II. 57. Piano costruttivo semplificato di Darwin II. 58. Le risposte di repertori individuali (R, R di R, e RM). 59. Istogrammi della frequenza di risposta. 60. Visioni schematiche di Darwin II, illustranti tre stadi in un espe-
rimento di richiamo associativo per scopi esplicativi. 61. Risposte di gruppi individuali R di R in un esperimento di ri-
chiamo associativo. 62. Schema illustrante alcune interazioni tra evoluzione (il grande
anello) e diverse condizioni di sviluppo determinate da eventi embrionali e dalla selezione soma tic a dei gruppi neuronali negli individui (il piccolo anello).
-
Il
Si ringraziano la Royal Society e J ohn Z. Y oung per la figura I; la Royal Societye David H. Hubel per la figura 28; l'American Psychological Associa tion e John Cerella per la figura 5; la MacmillianJournals Ltd. e Ian Dennis per la figura 6; la Alan R. Liss, Inc. per le figure 7 A e 27, e Eduardo R. Macagno per la figura 7 B; la Mit Press per le figure 8, 9, IO; la Rockefeller University Press per la figura 17; l'editore Elsevier e Pasko Rakic per la figura 21; la Brain Research Organization per le figure 25 e 26; Milton Fingerman dell' American Zoologist per la figura 29; la Springer-Verlag e Sven O. E. Ebbesson per la fi gura 30; Gary D. Schnell, di Systematic Zoology, e K. F. Liem per la figura 46; la Pergamon Press, Ltd. per le figure 47 e 48; Matthew Wayner, di Neu roscience and Biobehavioral Review, e RichardJ. Herrnstein per la figura 51; l'Academic Press e PhilipJ. Kellman per la figura 52; la New York Academy of Sciences per le figure 57,58,59 e 60.
Elenco delle abbreviazioni
CAM CAR CSV dg dp dps LCAM M NCAM NgCAM NGF PPS SAM SC SnC
molecola di adesione cellulare canali attivati dal recettore canali sensibili al voltaggio grande dominio polipeptidico della NCAM piccolo dominio polipeptidico della NCAM piccolo dominio di superficie della NCAM molecola di adesione cellulare del fegato sostanza modificante molecola di adesione cellulare neurale molecola di adesione cellulare neuroneglia fattore di crescita della cellula nervosa potenziale postsinaptico molecola di adesione del substrato stimolo condizionato stimolo non condizionato
-
"I
Elenco dei simboli matematici
Capitolo VII
i
Tjii
tr
tM tD
tv
Kf
Kb
Kb2
a(V)
b(V)
a~'(V) b(V) N
N1' Nk N!: A (t) A*(t) I(t)
efficacia presinaptica; quantit di neurotrasmettitore rilasciato dalla cellula i in funzione di una certa depolarizzazione efficacia postsinaptica; depolarizzazione locale prodotta in un prolungamento postsinaptico della cellula i in funzione di una certa quantit di trasmettitore rilasciato dalla cellula j intervallo temporale tra l'input omosinaptico e la produzione diM costante temporale per la persistenza della sostanza modificante ritardo temporale medio di conduzione in funzione degli effetti eterosinaptici costante temporale in funzione della persistenza delle variazioni del voltaggio costante di frequenza per la modificazione anterograda da I a 1* nella regola postsinaptica costante di frequenza per la modificazione retrograda dallo stato 1* allo stato I costante di frequenza per la modificazione retrograda da A allo stato A * costante di frequenza voltaggio-dipendente per la transizione da I ad A (la frequenza diminuisce con la depolarizzazione) costante di frequenza voltaggio-dipendente per la transizione da A a I (la frequenza aumenta con la depolarizzazione) costante di frequenza per la transizione da 1* ad A * costante di frequenza per la transizione da A * a 1* numero totale di canali sensibili al voltaggio in una terminazione postsinaptica numero totale dei CSV modificati numero dei CSV delle specie k numero dei CSV delle specie k modificati numero di canali nello stato Attivato al tempo t numero di canali nello stato Attivato modificato al tempo t numero di canali nello stato Inattivato al tempo t
Elenco dei simboli matematici xv
1* (t) numero di canali nello stato Inattivato modificato al tempo t . M (t) quantit di sostanza modificante presente al tempo t g; conduttanza dei canali sensibili al voltaggio di specie ionica k il: conduttanza dei CSV di specie ionica k .dopo la modificazione Ek potenziale di inversione della specie ionica k h corrente sinaptica locale Fi (t) facilitazione al tempo t del neurone i Di (t) depressione al tempo t del neurone i Si (t) attivit della cellula i al tempo t x costante di proporzionalit tra rilascio del trasmettitore e depres-
sione e. costante di proporzionalit tra attivit e facilitazione costante temporale del decadimento della facilitazione
~ costante temporale del decadimento della depressione NI] numero di connessioni tra il gruppo] e il gruppo I SI attivit media delle cellule nel gruppo I SI la media temporale di SI
Capitolo x
Si (t) Cii
Iii
aE
Sk
~
al
N
w
't
ap
attivit o stato del gruppo i al tempo t (O:s S < I) forza di connessione dell'input j-esimo al gruppo i (per Cij> 0, ecci-tatorio; per Cii < 0, inibitorio) numero di identificazione del gruppo connesso all' input i-esimo del gruppo i soglia dell'input eccitatorio; l'input j viene ignorato fino a che Si 2: aE stato del gruppo definito da k, che comprende tutti i gruppi entro una vicinanza inibitoria specificata intorno al gruppo i coefficiente inibitorio; svolge lo stesso ruolo per connessioni inibi-torie geometricamente definite come Cii lo fa per connessioni spe-cifiche, ma lo stesso per tutte le coppie ik in associazioni intorno a ogni gruppo in un certo repertorio soglia dell'input inibitorio; l'input k viene ignorato fino a che Sk 2: al
rumore ricavato da una distribuzione normale con una media e una deviazione standard specifiche parametro di persistenza, che definisce la frequenza di decadimen-to per l'attivit dei gruppi (w = e-l/t) caratteristica temporale per il decadimento dell' attivit, s soglia di scarica positiva; gli input verso un gruppo vengono igno-rati se la loro somma positiva, ma non supera ap
-
XVI Elenco dei simboli matematici
9N
o cf> (C)
9MI 9MJ
R RdiR G RM
soglia inibitoria negativa; gli input verso un gruppo vengono ignorati se la loro somma negativa ma inferiore a 9N in ampiez-za (9 N < O) un fattore costante di amplificazione specificato fattore di saturazione che impedisce a I Ci; I di diventare maggio-re di I[cf>(C) = 1- 2C 2 + c4] soglia di amplificazione postsinaptica soglia di amplificazione presinaptica; il verificarsi e il segno del-l'ampificazione dipendono dalla scelta di una regola che specifica che cosa si verificher in ciascuno di quattro casi a seconda che Si sia maggiore o minore di 9MI e s; sia maggiore o minore di 9MJ repertorio riconoscitore repertorio riconoscitore dei riconosci tori gruppo virtuale repertorio riconoscitore del movimento
Prefazione
Questo libro si propone di descrivere una teoria del funziona-mento cerebrale avendo come obiettivo principale quello di com-prendere i fondamenti biologici della percezione. La teoria della se-lezione dei gruppi neuronali affronta questo problema cercando di rispondere a diversi interrogativi cruciali. Come si formano le con-nessioni in ampie popolazioni di neuroni? Quali principi determina-no l'organizzazione delle rappresentazioni e delle mappe nel sistema nervoso? Quali meccanismi neurali consentono la categorizzazione percettiva e la generalizzazione? La teoria che intendo proporre per rispondere a queste domande stata formulata nell' ambito di una concezione rigorosamente selezionista, dove si incontrano sviluppo ed evoluzione del cervello da un lato, e struttura e funzione dall' al-tro. In questa teoria il pensiero popolazionistico, principio teorico centrale di tutta la biologia, viene applicato al cervello visto nell' arco della sua esistenza. La teoria stessa sostiene che, se desideriamo com-prendere adeguatamente le funzioni cerebrali superiori, dobbiamo prima analizzare quei fattori dello sviluppo che influiscono sull' evo-luzione e da cui scaturiscono la variazione nella struttura e nella fun-zione del cervello. Infatti, ritengo che il principio all' origine del com-portamento sia la selezione di nuove popolazioni neuronali, diverse per funzionalit, originate proprio da questa variazione durante lo sviluppo dell'individuo.
Attualmente questa concezione non accettata ed priva di au-torevoli antesignani nella storia di una scienza pur ricca di specula-zioni attinte in altri campi del sapere.
Date le nostre conoscenze attuali, se desideriamo essere scienti-ficamente attendibili, dobbiamo porci delle condizioni al fine di sta-bilire qualunque relazione tra attivit psichica e cervello, perci, ac-cingendomi a svolgere questo compito teorico, mi sono limitato a quello che uno psicologo cognitivo potrebbe giudicare un insieme as-sai incompleto di funzioni psicologiche. Per esempio, ho sfiorato ap-
-
XVIII Prefazione
pena alcuni dei grandi temi trattati nel magnifico Principi di William James [1890, ripubblicato nel 1950]. Se consideriamo un elenco piu aggiornato [Norman 1981] dei dodici temi essenziali, cio, sistemi di credenza, coscienza, sviluppo, emozione, interazione, linguaggio, apprendimento, memoria, percezione primaria, prestazione, abilit e pensiero, la mia indagine risulter parziale. Invece, tratter gli ar-gomenti nel seguente ordine: sviluppo, percezione (in particolare, ca-tegorizzazione percettiva), memoria e apprendimento. La mia spe-ranza che, una volta concepita una teoria unitaria di questi proces-si, diventi possibile una descrizione piu ampia, che oltre alla catego-rizzazione percettiva comprenda anche l'esperienza percettiva.
T aIe rigore mi sembra necessario se vogliamo avere dei punti di riferimento in questa straordinaria sfida che la comprensione dei fondamenti biologici della psicologia. Per, allo stesso tempo, se de-sideriamo cercare prove pertinenti, non dobbiamo porre dei limiti al-l'oggetto della nostra disamina, ma piuttosto gettare una rete ad ampio raggio che copra le discipline piu diverse. Questa stata la strategia sviluppata nel corso del libro, in quanto credo che una teo-ria solida debba essere compatibile con i fondamenti della biologia dello sviluppo e della biologia evolutiva. Uno dei presupposti che la teoria, per aver successo, debba confrontarsi con molti.nodi anco-ra irrisolti, e mi riferisco ai rapporti tra genetica dello sviluppo, epi-genesi ed evoluzione morfologica. Per cui, nel darle corpo, ho spazia-to dalla biologia molecolare all'etologia, e ritorno.
Qualche parola in piu riguardante l'ordine degli argomenti aiu-ter il lettore. La prima parte del libro descrive in modo generale la selezione dei gruppi neuronali nell'individuo. La seconda parte esa-mina in modo rigoroso i due principali meccanismi epigenetici che controllano tale selezione durante lo sviluppo embrionale e il com-portamento. Questi meccanismi sono parte integrante di fondamen-
. tali acquisizioni della biologia dello sviluppo e della biologia evolu-tiva. Data la generalit degli eventi embrionali esposti nel capitolo IV, potr sembrare che io sia uscito fuori dal tema del libro, cio il si-stema nervoso. Tuttavia, tale capitolo illustra il primo dei meccani-smi epigenetici in grado di spiegare l'origine della variabilit anato-mica e, quindi, l'ho ritenuto importante per correlare i principi dello sviluppo non neurale a quelli dello sviluppo neurale. Il secondo mec-canismo epigenetico della teoria (che spiega la selezione sinaptica) deve essere presentato in termini formali per essere convincente, per cui i lettori che, a una prima lettura, trovassero tedioso il capitolo
Prefazione XIX
VII, possono tralasciare la parte matematica; infatti, troveranno le descrizioni qualitative delle variazioni nell' efficacia sinaptica e i loro effetti sparsi qua e l nel capitolo. La terza parte del libro vuole far comprendere come questi due meccanismi epigenetici si integrino in individui che svolgono un'azione motoria, creano categorie e ap-prendono. Il suo scopo principale definire l'unit selettiva minima in grado di svolgere tali funzioni globali.
Molti argomenti attualmente di grande importanza in neurobio-logia non sono stati approfonditi; per esempio, l'analisi dettagliata del sistema visivo, lo studio della distribuzione regionale dei neuro-trasmettitori, la modulazione del sistema nervoso da parte del siste-ma endocrino e vari aspetti del sistema nervoso degli invertebrati. Il criterio seguito rtella scelta degli esempi 1'eventuale presenza di da-ti riferibili ai punti critici della teoria.
A un rapido sguardo il risultato pu sembrare un assemblaggio piuttosto ardito di esempi ricavati dalle piu disparate discipline bio-logiche, ma la mia speranza che le ragioni della scelta saranno chia-re non appena il lettore avr perfezionato la comprensione di una teoria che di per s ardita. Comunque, mi sono sforzato, l dove stato possibile, nel documentare i concetti o i meccanismi particolari augurandomi che i rischi di questa procedura siano piu che compen-sati dal suo valore euristico. Credo che questo approccio sia utile quando si inizia a comprendere qualsiasi argomento e, a maggior ra-gione, di fronte alla complessit del funzionamento cerebrale. Poich si tratta di un argomento allo stesso tempo complesso e poco familia-re, mi sono valso anche di un mezzo insolito per aiutare il lettore. In-fatti, nell'intestazione di ogni capitolo ho inserito un elenco degli ar-gomenti chiave, degli esempi o dei concetti presenti nel capitolo stes-so; gli esempi principali che contraddicono le idee contenute o sono particolarmente importanti per la teoria sono scritti in corsivo. Que-ste tracce si propongono di essere utili al lettore nell'anticipare e nel riassumere gli argomenti dei capitoli, e non sono state messe in chia-ve nelle intestazioni delle sezioni elencate nell'indice generale. Il ca-pitolo I contiene una breve introduzione con un compendio della teoria e una breve digressione storica riguardante il pensiero popo-lazionistico in neurobiologia, che precedono gli argomenti centrali e le considerazioni approfondite sui concetti guida presentati nei ca-pitoli successivi. Questa tenue descrizione , tuttalpiu, un assaggio di quanto seguir. Dopo aver approfondito nel corpo principale del testo la teoria della selezione dei gruppi neuronali, nella parte finale
-
xx Prefazione
del libro far alcune previsioni con l'intento di definire i limiti della teoria e di mostrarne la verificabilit empirica.
Questo libro sfiora appena il tema della comunicazione sociale, che un importante capitolo della psicologia, ma scrivendolo ne ho sempre tenuto conto. Le assidue interazioni con i miei colleghi al Neurosciences Institute (NSI), in particolare con il suo direttore di ricerca, il dottor W. Einar Gall, sono state un sostegno per il quale sono particolarmente riconoscente. Sono inoltr~ grato a Susan Has-sler, redattrice al NSI, per l'aiuto prestatomi. E stato un privilegio lavorare nell'Istituto con i dottori Leif Finkel e George N. Reeke jr su diversi modelli rivelatisi importanti per la teoria. L'opportunit di un reciproco scambio di idee nell' atmosfera accademica dell'NSI mi incoraggia a sperare che l'Istituto continuer a sostenere lo svi-luppo del lavoro teorico nelle neuroscienze e a incoraggiare gli scien-ziati piti giovani a perseguirlo.
GERALD M. EDELMAN New York, 1986.
Prefazione all' edizione italiana
Istruzionismo e selezionismo sono, innanzitutto, due modi anti-tetici di spiegare la natura delle cose. Per varie ragioni, l'istruzioni-smo sembra essere il piti naturale dei due. Per esempio, storicamente le spiegazioni istruzioniste hanno preceduto quelle selezioniste. Ci accaduto almeno tre volte in biologia: per 1'origine delle specie, per la specificit degli anticorpi, e per il funzionamento del cervello. Ep-pure, sembra che il destino delle spiegazioniistruzioniste sia di rive-larsi errate e di venire soppiantate da spiegazioni selezioniste, come si gi verificato per l'origine delle specie e per la specificit immu-nologica. Se, com' verosimile, ci accadr anche per il funziona-mento del cervello, questo volume, si avvia a diventare un classico. Infatti Neural Darwinism senza dubbio alcuno l'opera fondamen-tale che enuncia, elabora, e documenta il selezionismo applicato al cervello.
Come avviene solo ai pochi libri di argomento scientifico che sanno invecchiare bene, Neural Darwinism esce in edizione italiana a ben otto anni di distanza dall' edizione originale inglese. Cronolo-gicamente, esso rappresenta il primo volume della trilogia di Gerald Edelman su forma, cervello, e mente. Oltre a Neural Darwinism, la trilogia comprende Topobiologia (Bollati Boringhieri, Torino 1993), un saggio sulla biologia dello sviluppo, e Il presente ricordato (Rizzoli, Milano 1991), un'estensione dei principi contenuti in Neural Darwi-nism al problema della coscienza. Un ulteriore volume, La materia della mente (Adelphi, Milano 1993), riassume la trilogia in formato e stile piti accessibili.
Di questi quattro volumi, Neural Darwinism non solo il primo, ma probabilmente il piti importante e, quasi certamente, il piti com-plesso e denso, uno di quei libri cui si ritorna per scoprire ogni vol-ta qualche cosa di nuovo. E anche un libro rivoluzionario. Se non necessariamente l'unico scritto che suggerisce di applicare idee piti o meno selezioniste al cervello, senz' altro il primo a farlo in modo
-
XXII Prefazione all' edizione italiana
adeguato ed esauriente, e a metterne in luce, anche se in modo so-brio, le molteplici implicazioni. Un po' come l'Origine delle specie, Neural Darwinism un' opera cosi ricca di spunti e solidamente do-cumentata che la proposta del cervello come sistema selettivo si pu discutere ma non si pu piti ignorare. ~ Ma cos' il selezionismo? Ed in cosa differisce dall'istruzioni-
smo? La distinzione tra istruzionismo e selezionismo particolar-mente chiara in immunologia. Il problema, in questo caso, era come l'organismo possa produrre anticorpi specifici contro innumerevoli virus e batteri mai incontrati in precedenza, o persino contro pro-dotti chimici di sintesi mai esistiti in natura. Linus Pauling aveva suggerito nel 1940 un'elegante teoria istruzionista: l'anticorpo era di un tipo unico, ma era in grado di plasmarsi attorno all' agente in-vasore, assumendo una conformazione complementare e divenendo cosi specifico: ossia, l'agente invasore istruiva l'anticorpo. MacFar-lane Burnet suggeri invece, negli anni Cinquanta, una teoria selezio-nista: ogni organismo ha a disposizione un immenso repertorio di an-ticorpi diversi, e l'agente invasore si limita a selezionare quelli che sono in grado di riconoscerlo, scatenandone 1'aumentata produzione. Nel 1972 Edelman condivise il Premio Nobel per aver determinato la struttura chimica delle molecole anticorpali e contribuito a confor-mare l'ipotesi della selezione clonale. Da allora Edelman giusta-mente considerato come uno dei campioni del selezionismo, e non
solt~nto in immunologia. E difficile resistere alle tentazioni del cervello. Piti di uno scien-
ziato di successo, abbandonata la disciplina di prime nozze, si ci-mentato con ci che ha fama di essere 1'oggetto piti complesso nell'u-niverso noto. Non sorprende quindi che ben presto lo stesso Edel-man spostasse la sua attenzione sul sistema nervoso, per stabilire se ancora una volta il selezionismo fosse la spiegazione vincente in bio-logia. In un lavoro del 1978, intitolato Selezione di gruppo e segnala-zione fasica rientrante: una teoria della funzione cerebrale superiore, Edelman proponeva le grandi linee di un approccio selezionista al funzionamento del cervello. Dopo una gestazione di quasi dieci anni appariva Neural Darwinism.
Il selezionismo.
In Neural Darwinism Edelman afferma in modo assai chiaro che ogni sistema selettivo si basa su tre principi: I) una sorgente di varia-
Prefazione all' edizione italiana XXIII
zione all'interno di una popolazione; n) il confronto con un ambiente non definibile a priori ed imprevedibile; m) dei meccanismi di am-plificazione differenziale. Un'ampia parte del libro perci dedicata all'analisi di questi tre principi applicati al cervello. La conclusione di Edelman, alla luce di tale analisi, netta: il funzionamento del si-stema nervoso fondato su variazione e selezione. Quest'ultima, co-me nel caso del sistema immunitario, selezione somatica, nel senso che i processi selettivi avvengono durante l'arco di vita dell'indivi-duo. Tuttavia, stabilire che il cervello un sistema selettivo non ba-sta. Come nel caso della selezione naturale e della selezione clonale, necessario identificare caso per caso le sorgenti della variabilit, le peculiarit dell'interazione con l'ambiente, ed i meccanismi di am-plificazione differenziale. Inoltre, vi sono molti importanti problemi o principi di funzionamento che sono caratteristici e specifici di cia-scun sistema, basti pensare alla selezione sessuale nel caso dell' evo-luzione, alla tolleranza nel caso dell'immunologia, e al rientro nel ca-so del cervello. Per queste ragioni, in Neural Darwinism dedicato altrettanto spazio a sostanziare la proposta che il cervello funzioni come un sistema selettivo, e all' analisi di alcuni aspetti fondamentali della sua organizzazione. Conviene quindi riassumere le tesi princi-pali avanzate in Neural Darwinism, per passare poi ad un rapido esa-me di alcuni sviluppi recenti nell' opera di Edelman e dei suoi colla-boratori.
Il mondo senza etichette e la variabilit.
Neural Darwinism inizia notando due problemi fondamentali che mettono in crisi gli approcci convenzionali al funzionamento del cer-vello. Il primo che il mondo si presenta" senza etichette" , il secon-do l'enorme variabilit evidente nel sistema nervoso. Nell'Origine delle specie, Darwin aveva attaccato le concezioni essenzialiste o ti-pologiche secondo cui le specie sono entit immutabili. Secondo Darwin, invece, le specie non sono dei tipi assoluti ma originano tra-mite un processo di variazione e selezione. La variazione, lungi dal-l'essere una superficiale aberrazione o irregolarit, lo strumento piti importante tramite il quale la selezione determina il cambiamento e l'adattamento all'interno di popolazioni di individui (ragione per cui si parla di pensiero popolazionista). Altrettanto importante era l'altra conclusione di Darwin, ossia che l'adattamento delle specie alloro ambiente, per quanto straordinario, non il risultato di un disegno
-
XXIV Prefazione all'edizione italiana
preciso (sia esso creazione o istruzione sotto forma di programma). La soluzione proposta da Darwin in chiave di variazione e selezione consentiva infatti di spiegare 1'adattamento, almeno in linea di prin-cipio, sulla base dell' accumulo graduale di variazioni favorevoli.
In modo analogo, in Neural Da1Winism Edelman attacca in primo luogo le concezioni essenzialiste non delle specie ma delle categorie. Il mondo, argomenta Edelman, non si pu suddividere a priori in ca-tegorie fisse ed immutabili, ossia in oggetti ed eventi caratterizzabili in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Al contrario, il mon-do ambiguo ed interpretabile in modi diversi, a seconda delle carat-teristiche e delle necessit adattive di ogni organismo. La categoriz-zazione percettiva e la generalizzazione sono perci relative ad un dato organismo e ad un dato ambiente, e hanno luogo tramite un processo di variazione e selezione. Analogamente al ruolo della va-riazione nella selezione naturale, la variazione nel sistema nervoso non va concepita come una deviazione irrilevante o erronea rispetto ad una categoria tipica, ma costituisce la base per la formazione, tra-mite la selezione neuronale, delle categorie.
Come noto, per Darwin fu cruciale l'avere sperimentato perso-nalmente 1'abbondanza e l'ubiquit della variazione in biologia. Non a caso, Edelman inizia la sua opera principale illustrando esempi su esempi di variazione, questa volta nel sistema nervoso, tra cui si pos-sono citare le notevoli differenze, dovute a vari processi epigenetici, nella struttura fine delle ramificazioni nervose e gli aspetti stocastici della morte neuronale.
Nonostante queste osservazioni, le concezioni dominanti del fun-zionamento del cervello tendono implicitamente ad assumere, secon-do Edelman, che il mondo si lasci suddividere in categorie univoche (essenzialismo). Inoltre, come esemplificato in intelligenza artificia-le, si assume spesso che il cervello possieda qualcosa di simile ad un programma costituito da codici e regole precise che sarebbero utiliz-zate per rappresentare e manipolare tali categorie (istruzionismo). Se pure si ammette la presenza della variazione, la si considera una spe-cie di rumore di fondo, che un buon cervello deve o ridurre al mini-mo o perlomeno ignorare. La parte iniziale di Neural Da1Winism esa-mina cosi le varie "crisi" cui sono soggette le concezioni essenzialiste ed istruzioniste, e l'inadeguatezza della metafora del cervello come computer. La conclusione che tali concezioni, applicate ad un mon-do "senza etichette" segnato dall'imprevedibilit e dalla novit, e a cervelli segnati dalla variabilit individuale, sono destinate a fallire ancora una volta.
Prefazione all' edizione italiana xxv
La situazione si rovescia, le crisi divengono necessit, e gli svan-taggi vantaggi, non appena si considera un approccio selezionista. Se il mondo non definibile a priori, imprevedibile, ambiguo, e diver-so a seconda del contesto e dell' organismo che lo incontra, la varia-zione seguita dalla selezione esattamente ci che richiesto per ot-tenere una categorizzazione adattiva. Il come ci possa effettiva-mente avvenire il tema della parte centrale di Neural Da1Winism.
La teoria della selezione dei gruppi neuronali (TNGS). Il nucleo della concezione esposta da Edelman in Neural Da1Wi-
nism contenuto nella teoria della selezione dei gruppi neuronali (TNGS). Secondo la TNGS, cosi come il bersaglio principale della selezione naturale sono i fenotipi individuali, il bersaglio principale della selezione neurale sono i gruppi neuronali. Un gruppo neuronale composto di decine, centinaia o migliaia di neuroni fortemente in-terconnessi localmente, che tendono a ricevere ed emettere segnali correlati e a rispondere in maniera cooperativa. Le connssioni si-naptiche ed altre caratteristiche intrinseche o estrinseche sono pe-r assai variabili da un gruppo neuronale all' altro; gruppi diversi hanno perci l-ma propensione a rispondere in manieta diversa a se-gnali diversi. E su questa variabilit di risposte che agisce la selezio-ne neuronale. In sintesi, la TNGS propone tre meccanismi respon-sabili del comportamento adattivo del sistema nervoso: la selezione durante lo sviluppo, la selezione durante l'esperienza, e la segnala-zione rientrante.
Selezione durante lo sviluppo.
Il problema centrale dello sviluppo, come si passi dai geni alla forma, ossia da una sequenza lineare di DNA ad un organismo tridi-mensionale, il tema principale affrontato da Edelman in Topobio-logia, ma trattato ampiamente anche in Neural Da1Winism, perch la comprensione degli eventi epigenetici comporta la comprensione della inevitabilit della variabilitjndividuale. Durante lo sviluppo, la regolazione epigenetica di processi quali divisione, adesione, mi-grazione, morte cellulare, e crescita assonica, produce una serie di re-pertori primari, costituiti da un gran numero di gruppi neuronali e di circuiti varianti. Edelman sottolinea che la variabilit osservata nel
-
XXVI Prefazione all' edizione italiana
sistema nervoso, persino nel caso di gemelli identici, una conse-guenza necessaria di tali processi epigenetici. Nonostante nelle gran-di linee le strutture neuroanatomiche siano simili da un individuo al-l'altro, il genoma non controlla, e non sarebbe in grado di controlla-re, tutti i dettagli degli innumerevoli circuiti nervosi. L'embriogene-si perci non semplicemente il dispiegarsi di un programma gene-tico ma, richiedendo regolazioni molecolari che interagiscono in mo-do complesso a vari livelli di organizzazione, e che hanno risultati di- . versi a seconda del momento, della sede e del contesto in cui avven-gono, un'inevitabile sorgente di variazione. Le molecole di adesio-ne cellulare (CAMs), scoperte da Edelman e dai suoi collaboratori nel 1976, e la regolazione della loro espressione, rappresentano un aspetto importante di tali processi.
Selezione durante l'esperienza.
Una volta formatasi l'impalcatura delle connessioni tra gruppi neuronali sotto forma di repertori primari, avviene l'incontro con il mondo esterno, ossia l'esperienza. Particolari combinazioni di segna-li trovano alcuni gruppi neuronali piu pronti o piu adatti di altri a ri-spondere, e questo fatto scatena eventi selettivi. La selezione avvie-ne a livello di popolazioni di sinapsi, tramite numerosi meccanismi che vanno sotto il nome di 'plasticit sinaptica " e che sono discussi ampiamente in Neural Darwinism. Alcune popolazioni sinaptiche vengono rinforzate, altre indebolite. Ci determina la formazione di repertori secondari di gruppi neuronali. Il rafforzamento o indeboli-mento di popolazioni sinaptiche dipende da complessi eventi biochi-mici locali, che possono differire a seconda della sede. Tuttavia, ci che determinante sono le correlazioni statistiche spaziali e tempo-rale dei segnali sinaptici tra gruppi di neuroni. Per poter contribuire al comportamento adattivo, tali correlazioni statistiche devono ri-flettere le propriet spazio temporali dei segnali che originano nel-l'ambiente. Questo il compito della segnalazione rientrante.
Segnalazione rientrante.
I repertori secondari sono in molti casi organizzati in mappe di gruppi neuronali che si specializzano, tramite i processi selettivi ap-pena menzionati, nel rispondere a particolari tipi di segnali prove-
Prefazione all' edizione italiana XXVII
nienti dall' ambiente esterno. Mappe diverse si occupano di modalit o sottomodalit sensoriali diverse, e rispondono preferenzialmente a caratteristiche diverse degli stimoli. In un sistema selettivp, tutta-via, non vi sono etichette che specifichino la natura o l'indirizzo del-le varie mappe, e data la plasticit sinaptica, le mappe sono sottopo-ste a continui riarrangiamenti. Come possibile pertanto la coordi-nazione di tali mappe? La TNGS propone che le mappe siano coor-dinate tramite un flusso continuo di segnali bidirezionali entro e tra le diverse mappe chiamato rientro. Il rientro definito come la se-gnalazione parallela, bidirezionale e ricorsiva tra gruppi neuronali di-versi, che avviene tramite un gran numero di connessioni anatomi-che ordinate. Il rientro consente di mettere in relazione caratteri-stiche diverse dell' ambiente, raccolte in maniera indipendente (" di-sgiunta") attraverso canali e sottocanali sensoriali. La selezione di popolazioni sinaptiche entro i gruppi neuronali, entro le mappe, o tra mappe diverse, potr quindi riflettere la continuit spaziotempo-rale del mondo esterno,. e garantire un comportamento adattivo. La coppia di classificazione, discussa in Neural Darwinism, un caso ele-mentare di rientro tra due mappe reciprocamente connesse che ri-spondono ad aspetti diversi dello stesso stimolo.
Se si considera l'ubiquit del rientro nell'organizzazione del cer-vello, e si aggiunge che il campionamento dell' ambiente non stati: co, ma modulato dal movimento e dal comportamento, si pu co-minciare a comprendere anche un' altra nozione centrale esposta in Neural Darwinism, la nozione di memoria come ricategorizzazione. La memoria, in un sistema selettivo, non un,deposito di dati che de-scrivono gli oggetti o gli eventi incontrati. E invece un processo di-namico, il cambiamento nel modo di funzionare del cervello e del-l'intero organismo a seguito di innumerevoli eventi selettivi prece-denti. Grazie al rientro, la categorizzazione operata in parallelo da un grandissimo numero di gruppi neuronali infatti costantemente attiva, sia durante la percezione che durante l'immaginazione. La memoria quindi ricategorizzazione e non registrazione.
Sviluppi recenti.
La TNGS comprende altri importanti concetti, come quello di mappaggio globale, o la nozione di degeneranza. Tuttavia, poich questi sono discussi ampiamente in Neural Darwinism, piu oppor-tuno accennare in questa sede agli sviluppi, nella ricerca di Edelman
-
XXVIII Prefazione all' edizione italiana
e dei suoi collaboratori, che hanno fatto seguito alla pubblicazione dell' opera. Infatti, come dichiarato esplicitamente in Neural Darwi-nism, la concezione di Edelman contiene un aspetto programmatico. Non si limita a enunciare dei principi, ad organizzarvi attorno la grande mole dei risultati sperimentali che via via si accumulano, ma procede ad esaminare ipotesi e conseguenze in una serie di modelli neurali sintetici. Si tratta dell'uso sistematico di simulazioni al calco-latore su larga scala, che consentono di costruire strutture simili al cervello nell' architettura e nei principi di funzionamento, nonch di situare tali strutture in un fenotipo e tale fenotipo in un ambiente. I modelli neurali sintetici non servono solo ad esaminare conseguen-ze o previsioni della teoria. Hanno anche un significato euristico che, nel caso del cervello, di cruciale importanza: per comprendere il funzionamento del cervello una delle sfide piu difficili consiste nel fatto che occorre tenere presenti simultaneamente non solo l'azione in parallelo di numerosissimi gruppi neuronali, ma anche l'interazio-ne di molti livelli di organizzazione, dalla neurochimica alla psicolo-gia al comportamento, dai millisecondi dell'attivit neuronale alle ore o giorni richiesti dalle dinamiche dell' apprendimento. Il calco-latore, paradossalmente, lo strumento piu potente non solo per si-mulare tutti questi livelli, ma anche per poterne registrare ogni det-taglio e ricostruire il funzionamento.
Darvin III.
Dopo Darwin I e Darwin II, descritti in Neural Darwinism, il gruppo di Edelman al Neurosciences Institute ha creato un modello neurale sintetico, Darwin III, capace di illustrare simultaneamente molti aspetti della TNGS '. Darwin III un organismo sessile, rela-tivamente semplice, che possiede un occhio mobile ed un braccio con quattro articolazioni. L'ambiente di Darwin III anch'esso si-mulato al calcolatore, e comprende vari oggetti di forme diverse che si spostano all'interno del suo campo visivo. Sia l'occhio che il brac-cio di Darwin III si muovono inizialmente a caso. Con l'esperienza, eventi selettivi nel sistema nervoso di Darwin III producono nume-rose modificazioni sinaptiche, guidate, come vedremo fra poco, dai
, G. N. REEKE JR, L. H. FINKEL, o. SPORNS, e G. M. EDELMAN, Synthetic neural mode ling: A multilevel approach to the analysis 01 brain complexity, in G. M. EDELMAN, w. E. GALL e w. M. COWAN (a cura di), Signal and Sense: Local and Global Order in Perceptual Maps, Wiley, New York 1990.
Prefazione all' edizione taliana XXIX
sistemi di valore. In seguito a questi eventi selettivi, 1'occhio di Dar-win III apprende a seguire gli oggetti che si presentano nel campo vi-sivo. Di li a poco, anche il braccio diviene capace di raggiungere e toccare gli oggetti fissati dall' occhio. Ci particolarmente signifi-cativo, perch il problema della cinematica inversa, ossia la determi-nazione di traiettorie corrette in un sistema caratterizzato da nume-rosissimi gradi di libert, di difficile soluzione in termini istruzio-nisti, ma emerge in modo naturale in termini selezionisti 2. Succes-sivamente, Darwin III sviluppa anche una primitiva ma gi idiosin-cratica categorizzazione degli oggetti che gli sono presentati, affer-randone alcuni e rigettandone altri. Darwin III rappresenta cosi un esempio dei mappagg,i globali descritti in Neural Darwinism.
Darwin IV. Piu di recente, l'evoluzione dei modelli neurali sintetici ha por-
tato ad un automa, Darwin IV, il cui cervello simulato collegato ad un fenotipo reale'. Darwin IV un piccolo robot dotato di teleca-mera, sensori ad infrarossi, sensori di conduttivit elettrica, magneti, e ruote, che libero di muoversi in una stanza a esso riservata. Il cer-vello, simulato al calcolatore, opera secondo principi selezionisti, non dissimili da quelli utilizzati in Darwin III. Come Darwin III, Darwin IV apprende a seguire una luce o un oggetto che si muove al-l'interno della sua stanza. Il compito assai piu difficile nel mondo reale che in un ambiente simulato, basti pensare alle irregolarit del movimento, ai cambiamenti di luminosit, ai cambiamenti di dimen-sione delle immagini e alle distorsioni dovute al variare della distanza e alla posizione obliqua della telecamera. Tuttavia, essendo basato su principi selettivi, Darwin IV in grado di adattarsi sorprenden-temente bene a circostanze variabili. Darwin IV apprende inoltre a suddividere ed accumulare nella sua "tana" dei blocchi metallici dapprima sulla base del "gusto" (conduttivit elettrica) e poi, grazie al formarsi di associazioni, sulla base del colore. Il tutto avviene sen-za che Darwin IV sia programmato esplicitamente, ma esclusiva-mente grazie a modificazioni selettive di riflessi innati e comporta-menti appresi concatenate e guidate dai sistemi di valore.
2 o. SPORNS e G. M. EDELMAN, Solving Bernstein 's problem: A proposal for the develop-ment 01 coordinated movement by selection, in Child Development, LXIV (199 2 ), pp. 960-81.
, G. M. EDELMAN, G. N. REEKE JR, w. E. GALL, G. TONONI, D. WILLIAMS e o. SPORNS, Synthetic neural modeling applied to a realworld artifact, in Proceedings of the National Academy of Sciences of ~he United States of America, LXXXIX (1992), pp. 7267.71.
-
xxx Prefazione all'edizione italiana
Sistemi di valore.
Uno dei risultati emersi dagli studi recenti che, in assenza di si-stemi di valore, sistemi selettivi complessi come Darwin III e IV non potrebbero funzionare adeguatamente. Ancora una volta, lo studio della neurobiologia si rivela essenziale nel suggerirne le caratteristi-che e i meccanismi. Alcuni gruppi neuronali, situati nelle parti piu antiche del cervello, sono in grado di segnalare, tramite proiezioni diffuse a larga parte del sistema nervoso, eventi salienti o rilevanti dal punto di vista evolutivo. Ad esempio, nel caso di Darwin III e IV, un evento saliente potrebbe essere la presenza di qualche cosa nel centro del campo visivo, o il contatto con qualche cosa di com-mestibile (elettricamente conduttivo). L'attivazione dei sistemi di valore mette in stato di all' erta gran parte delle aree del cervello, in particolare quelle interessate alla categorizzazione e reazione all' e-vento, e modifica per breve tempo la probabilit degli eventi selet-tivi nelle popolazioni sinaptiche. Il risultato che attivit neuronali che si traducono in comportamenti adattivi vengono rinforzate. L'importanza dell'azione dei sistemi di valore duplice. Innanzitut-to, essi comunicano un segnale globale (rilevante per l'intero organi-smo) ad eventi selettivi locali (plasticit sinaptica); inoltre, la natura degli eventi che evocano il segnale globale , almeno inizialmente, il risultato della selezione naturale (valori innati). Quest'ultima pu co-si influenzare gli eventi selettivi molto piu rapidi propri della selezio-ne somatica. Il cerchio si chiude, con aspetti ancora piu interes-santi" con la possibilit che, con l'esperienza, una nuova classe di eventi divengano progressivamente capaci di attivare i sistemi di va-lore (valori acquisiti).
Il problema dell'integrazione corticale.
Il concetto piu arduo della TNGS forse quello del rientro. Tut-tavia, il rientro stato recentemente utilizzato per la soluzione di un problema centrale delle neuroscienze, quello dell'integrazione nella corteccia cerebrale. Piu la si studia, piu la corteccia cerebrale si rivela
4 K. J. FRISTON, G. TONONI, G. N. REEKE, O. SPORNS e G. M. EDELMAN, Value-depen-dent selection in the brain: Simulation in a synthetic neural model, in Neuroscience, LIX (1994), n. 2, pp. 229-43.
Prefazione all' edizione italiana XXXI
come un mosaico di aree diverse, specializzate in funzioni diverse. Per esempio, nel sistema visivo si possono distinguere almeno trenta aree, ciascuna delle quali si occupa preferenzialmente di aspetti di-versi del mondo visivo, dalla forma, al colore, al movimento. All'in-terno di ciascuna area, gruppi neuronali diversi hanno caratteristiche di risposta diverse, dimostrando un'ulteriore specializzazione, acqui-sita tramite eventi selettivi. Per questo tipo di organizzazione si par-la di segregazione funzionale. Il problema che, per risultare in un comportamento adattivo, l'attivJt di queste aree e gruppi neuronali segregati deve essere integrata. E necessario che vengano in qualche modo segnalate le relazioni tra i vari oggetti e tra i diversi attributi di ciascun oggetto (forma, colore, posizione). Tutto ci immedia-tamente evidente se si pensa al carattere unitario e coerente di una scena visiva e, piu in generale, dell' esperienza cosciente, in cui sono integrate non solo la visione, ma anche altre modalit sensoriali, il pensiero, il linguaggio, gli affetti.
Eppure, ormai chiaro che nel cervello non c' niente di simile ad un' area esecutiva centrale in cui confluiscano le attivit di tutte le altre aree. Non solo, ma l'idea di un' area esecutiva centrale non neppure sostenibile teoricamente. Di recente stata invece proposta una soluzione al problema dell'integrazione basata sul rientro'. Estese simulazioni al calcolatore di nove aree corticali funzionalmen-te segregate ma reciprocamente interconnesse hanno dimostrato che, grazie al rientro, segregazione e integrazione funzionale possono coesistere e dare luogo ad un comportamento adattivo in un sistema distribuito. Le simulazioni dimostrano anche come molti fenomeni fondamentali della psicologia, come le leggi della Gestalt", e vari aspetti costruttivi e correlativi della percezione, emergano in modo naturale se si presta la dovuta attenzione ai substrati neuroanatomici e neurofisiologici. L'organizzazione del cervello si dimostra cOSI sin-golarmente adatta a garantire l'integrazione in un tutto coerente di fonti diverse di informazione, e a farlo in tempi molto brevi (centi-naia di millisecondi). Non a caso, l'integrazione rapida di una grande quantit di informazione sembrerebbe essere una delle caratteristi-che distintive dell' esperienza cosciente.
, G. TONONI, O. SPORNS e G. M. EDELMAN, Reentry and tbe problem oj integrating mul-tiple cortical areas: Simulation oj dynamic integration in the visual system, in Cerebral Cortex, II (1992), pp. 310-35.
6 O. SPORNS, G. TONONI e G. M. EDELMAN, Modeling perceptual grouping and figure-ground segregation by means oj active reentrant connections, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, LXXXVIII (1991), pp. 129-33.
-
XXXII Prefazione all' edizione italiana
Anche da un breve riassunto delle tesi esposte in Neural Darwi-nism e di alcuni sviluppi successivi dovrebbe risultare ovvia l'ampiez-za e la fecondit della concezione di Edelman. In un' epoca caratte-rizzata dalla segregazione funzionale tra le varie discipline, anche l'integrazione del sapere diviene sempre piu complessa. Considerato il compito, nO,n deve quindi stupire che Neural Darwinism sia un li-bro difficile. E difficile perch raccoglie spunti ed esempi da molti settori diversi della scienza: embriologia, biologia molecolare, immu-nologia, anatomia e fisiologia comparata, psicologia; linguistica, neu-robiologia, intelligenza artificiale. difficile perch non si limita a riassumere lo stato dell' arte in queste varie discipline, ma mira ad una sintesi. La TNGS infatti una teroria globale del funzionamen-to del cervello e, curiosamente, forse ancora l'unica teoria globale disponibile. difficile anche perch stato scritto con un occhio agli attacchi e ai fraintendimenti cui sarebbe stato sottoposto. Ma dif-ficile soprattutto perch si direbbe che il nostro cervello, paradossal-mente, sia stato programmato a non capire o a malinterpretare il se-lezionismo. La nostra stessa eccezionale abilit a categorizzare ogget-ti ed eventi rende arduo immaginare che le categorie si formino tra-mite un processo di variazione e selezione, cOSI come rende arduo immaginare che gli impressionanti esempi di adattamento evolutivo in natura siano opera della selezione naturale. La nostra eccezionale abilit a programmare, pianificare e progettare ci spinge a pensare che le meraviglie di cui abbondano il mondo biologico e quello psi-cologico siano anch'esse, se non create, almeno frutto di un disegno (divino) o di un programma (genetico).
Il rovesciare questa convinzione sulla base di una vasta e solida sintesi scientifica quindi l'obbiettivo e il merito fondamentale di Neural Darwinism. Ma altrettanto fondamentale, una volta accet-tato il selezionismo, non concepirlo come operante al di fuori della forma e della storia. I sistemi biologici sono costituiti di numerosi elementi eterogenei che interagiscono in vari modi, e sono sottoposti a forze esterne. Perci la triade variazione - selezione - amplificazio-ne differenziale non avviene in uno spazio infinito di possibilit, ma limitata dai particolari vincoli intrinseci ed estrinseci che caratte-rizzano ogni sistema dinamico complesso. A causa di tali vincoli, solo alcune delle configurazioni immaginabili sono effettivamente pos-sibili a ogni dato momento. Inoltre, a causa di eventi selettivi e di ac-cidenti storici, delle configurazioni possibili soltanto alcune diven-tano attuali. Il piu delle volte, quindi, la variazione variazione su un tema, anche se, a seconda della forza rispettiva degli eventi selettivi
Prefazione all' edizione italiana XXXIII
da una parte e dei vincoli intrinseci dall' altra, anche il tema pu cam-biare. Il tema poi non semplicemente uno dei tanti temi possibili ma, pur cambiando, mantiene la traccia storica di ci che effetti-vamente avvenuto. Non difficile allora, per quanto Neural Darwi-nism accenni soltanto alle implicazioni culturali e sociali di una con-cezione selezionista del cervello e della mente, comprederne alcune delle conseguenze. Forse la piu importante l'unicit, l'irripetibilit, e il valore dell'individuo e della sua storia.
GIULIO TONONI LaJolla, 25 giugno 1995
-
Nota del curatore
Darwinismo neurale un libro importante, complesso e dibattuto, che viene pubblicato a diversi anni dall'edizione originale, in un pe-riodo fecondo di ricerche sul cervello. Non potevamo ignorare questi fatti, e desiderando offrire dei punti di riferimento per il lettore sag-giando al contempo la "vitalit" del libro, abbiamo pensato di cor-redare 1'edizione italiana di alcuni apparati editoriali che speriamo ne agevolino la comprensione: ~
I) In primo luogo, la Prefazione di Giulio T ononi, collaboratore di Gerald Edelman al Neurosciences Institute a La Jolla in Ca-lifornia, inquadra culturalmente la teoria selezionista di Edel-man, ne sintetizza i punti salienti e ci racconta" in presa diret-ta" i possibili sviluppi per la comprensione del cervello e per la creazione di automi intelligenti.
2) Le note a pi di pagina del curatore segnalano: a) i punti in cui la teoria del libro stata attaccata o, viceversa, accettata come innovativa; b) la compatibilit o meno della teoria con le sco-perte pili recenti nella biologia e nelle scienze cognitive; c) i punti di collegamento con gli altri due libri di Edelman, Topo-biologia e Il presente ricordato; e d) l'evoluzione delle ricerche di Edelman. I riferimenti bibliografici delle note sono conte-nuti nell' apposita Bibliografia delle note.
3) Infine, il Glossario, per spiegare i termini tecnici, abbondanti nel testo, al lettore non specialista.
Sperando di essere riusciti nel nostro intento auguriamo al lettore una buona e proficua lettura.
SILVIO FERRARESI
-
Darwinismo neurale
Supporre che l'occhio con tutti i suoi inimitabili congegni per regolare il fuoco a diverse distanze, per incamerare differenti quantit di luce, per corregge re aberrazioni ottiche e cromatiche, sia il frutto della selezione naturale sembra, lo confesso apertamente, del tutto assurdo.
Quando per la prima volta hanno affermato che il sole immobile e che la terra gli gira intorno, il senso comune del genere umano ritenne falsa questa teoria; ma il vecchio detto vox populi, vox dei, che ogni fi losofo conosce, non vale per la scienza.
CHARLES DARWIN, L'Origine delle Specie
e nell' ampia quiete voglio adornare un roseo santuario di ghirlande intrecciate di pensieri assidui, con bocciuoli, con campanule, e stelle senza nome, con tutto quanto abbia potuto mai fantasia giardiniera immaginare, fantasia che educando i fiori non mai educa gli stessi
JOHN KEATS, Ode a Psiche
-
a
-
Capitolo primo Riassunto e introduzione storica
La nicchia ecologica ambigua, p. 5. - Riassunto e ambizioni del-la teoria, p. 6. - Relazione con lo sviluppo e l'evoluzione, p. 9 - Il bisogno di mappe nella realizzazione della categorizzazione percettiva, p. IO. - La categorizzazione percettiva precede neces-sariamente l'apprendimento esteso, p. IO. - Propriet generali del-le teorie selettive, p. II. - I fondamenti storici del pensiero po-polazionistico applicato al comportamento, p. 13. - Il succes-sivo rifiuto delle idee selezioniste, p. 14. - La rinascita del pen-siero selezionista in etologia, p. 17. - Concetti recenti di selezio-ne somatica, p. 18. - Rassegna delle teorie selezioniste, p. 22. - Teorie glObali su base neuronale: istruzioniste e seleziniste, P25
I. Introduzione.
Per noi difficile immaginare come un neonato percepisca il mondo, qualunque sia la sua specie di appartenenza, compresa quella umana. Tuttavia, le convenzioni sociali, le tracce dell'esperienza sen-soriale e, in particolare, un' educazione scientifica rendono difficile accettare l'idea che l'ambiente in cui tale creatura vivr presenti un'ambiguit intrinseca: anche per animali che, come noi, hanno la facolt di esprimersi con il linguaggio, il mondo si presenta, a un pri-mo impatto, come un luogo senza etichette. In una nicchia ecologica il numero di suddivisioni in "oggetti" o "eventi" potenziali enor-me, se non infinito, e i loro valori, positivi o negativi, sono relativi e non assoluti, anche per un animale che abbia ereditato un sistema nervoso molto complesso. .
I sistemi nervosi, siano essi molto sofisticati o semplici, si sono evoluti per consentire all'individuo di adattare il comportamento alla propria nicchia ecologica in tempi relativamente brevi. Un compor-tamento cosi plasmabile richiede che l'individuo effettui una prima categorizzazione dei tratti ambientali salienti sui quali fondare l'ap-prendimento successivo. Quindi, uno dei compiti fondamentali delle neuroscienze proprio dimostrare come, in una certa specie, strut-tura e funzione del sistema nervoso consentano la categorizzazione
-
6 Capitolo primo ,
percettiva, che il presupposto per apprendere e per adattarsi effi-cacemente. Ne consegue un interrogativo: come possiamo correla-re psicologia percettiva e struttura-funzione del sistema nervoso? Molte spiegazioni si sono imperniate su teorie eterogenee fondate sul concetto di elaborazione dell'informazione. Invece, la proposta, che svilupper nel corso del libro, che una risposta adeguata a que-sta domanda, richieda una teoria di tipo nuovo, che potr ripercuo-tersi sulle neuroscienze e sulla comprensione della collocazione del-l'uomo nella natura. In questo capitolo introduttivo descriver la teoria facendo anche riferimento alle sue radici storiche. Spero cosi di facilitare il percorso del lettore attraverso le tappe che dimostre-ranno la teoria. Devo anche riconoscere che questa descrizione un po' troppo astratta e, quindi, per comprendere pienamente le idee cardinali della teoria, bisogner approfondire le dimostrazioni stesse.
2. Un profilo sintetico della teoria. La teoria della selezione dei gruppi neuronali nata per spiegare
alcune apparenti incongruenze nella nostra conoscenza dello svilup-po, dell' anatomia e della fisiologia del sistema nervoso centrale. Ma, soprattutto, il suo scopo spiegare la possibile origine della catego-rizzazione percettiva scartando l'ipotesi che il mondo sia organizzato a priori secondo schemi informazionali o che il cervello racchiuda in s un homunculus I. I motivi che mi spingono ad abbandonare l'ela-borazione di informazione come teoria del funzionamento cerebrale saranno piu chiari nel prossimo capitolo; per ora il mio obiettivo definire le idee guida di una concezione che alternativa.
La teoria, per spiegare la categorizzazione senza chiamare in cau-sa l'elaborazione di informazione o la computazione>, suggerisce
I Il termine homunculus ha due significati diversi in riferimento al cervello. Il pri-mo indica una rappresentazione nella corteccia cerebrale delle parti corporee in funzione della loro importanza, mentre il secondo, a cui si riferisce Edelman, una sorta di de-miurgo su cui convergono le informazioni sensoriali o da cui partono i comandi motori, e che ha un seguito solo in alcuni filoni della filosofia della mente, ma non nelle scienze del cervello [un'estesa trattazione a riguardo contenuta in Dennett 199r].
2 Il tipo di computazione di cui parla Edelman quella dei computer tradizionali o della Intelligenza Artificiale classica fondata sulla logica, altrimenti definita dall'alto ver-so il basso (top-down). Tuttavia, in anni recenti si sviluppata una computazione alter-nativa, per quanto eterogenea, e un nuovo modo di progettare i sistemi intelligenti. Il principio ispiratore comune la cosiddetta computazione emergente [Forrest 1990], a cui sono accostabili alcuni principi che Edelman' e collaboratori applicano nella progettazio-ne dei loro automi "neurali" [si vedano, a proposito, Finkel e Edelman 1989; Sporns
Riassunto e introduzione storica 7
che la legge preposta al controllo dell' organizzazione del cervello sia di natura popolazionistica e che il cervello, nel suo modo di operare, sia un sistema selettivo. Secondo la teoria [Edelman 1978, 1981; Edelman e Reeke 1982; Edelman e Finkel 1984], il cervello orga-nizzato dinamicamente in popolazioni cellulari che contengono sin-gole reti varianti, la cui struttura e funzione vengono selezionate du-rante lo sviluppo e il comportamento. Le unit selezionabili sono in-siemi di neuroni strettamente interconnessi, compresi tra le centi-naia e le migliaia, definiti gruppi neuronali, i quali possono agire come unit funzionali. La teoria si basa sui tre principi seguenti:
I) Durante lo sviluppo si crea una variabilit epigenetica delle connessioni anatomiche e, grazie alla selezione, si formano i repertori primari di gruppi neuronali diversi nella struttura. La diversificazione tale che due animali non possono avere esattamente le stesse connessioni pur in aree cerebrali corri-spondenti. Questa variabilit strutturale dipende da vari even-ti selettivi di natura meccanico-chimica regolati da molecole di adesione tra cellula e cellula e tra cellula e substrato (CAM e SAM), che controllano la divisione, il movimento, la morte e il differenziamento cellulare durante lo sviluppo.
2) Un secondo processo selettivo si verifica dopo la nascita gra-zie a modificazioni epigenetiche nella forza delle connessioni sinaptiche all'interno e tra gruppi neuronali. In questo modo sono selezionate opportune combinazioni di gruppile cui at-tivit sono in armonia con i segnali via via originati dal com-portamento adattativo. Questa selezione, che si verifica tra gruppi varianti anatomicamente gi presenti alla nascita (il repertorio primario), forma, di conseguenza il repertorio secon-
e altri 1989; Tononi e altri 1992a, 1992b; Edelman e altri 1992; Reeke e Sporns 1993; Friston e altri 1994]. La computazione emergente si ispira da un lato ai sistemi biologici e dall'altro alla fisica dei sistemi complessi, accomunati dalla autoorganizzazione, ossia la formazione di strutture a partire da un sistema amorfo, dalla presenza di fenomeni col-lettivi, cio molte unit (agenti) e molte interazioni tra esse, e dai fenomeni cooperativi, dove, in sintesi, il tutto maggiore della somma delle parti, e dove il parallelismo si so-stituisce alla serialit e alla gerarchia. Un esempio la lA behavior-oriented (Intelligenza Artificiale orientata verso il comportamento) [per delle rassegne si vedano Steels 1994; Maes 1994] che ha molti aspetti in comune con la famiglia di automi Darwin (si veda il capitolo x, e la presente Prefazione di Giulio Tononi) [cfr. Edelman 1992b; Reeke e Sporns 1993], almeno riguardo al concetto di adattamento e di apprendimento, che pos-sono scaturire da un processo selettivo (sorting out) operante nella ridondanza [Maes 1994] in un ambiente dinamico e imprevedibile e, come tale, non traducibile in istruzioni.
-
8 Capitolo primo
dario, il quale a sua volta costituito da quei gruppi attivi che hanno una maggiore probabilit di essere impiegati nel com-portamento futuro. I neuroni nei gruppi neuronali costitui-scono delle popolazioni e i repertori formano popolazioni di ordine superiore.
3) Per mezzo di segnali rientranti si verifica una correlazione scan-dita temporalmente tra recettori sensoriali, complessi moto-ri e gruppi neuronali che interagiscono nelle diverse aree cere-brali. Tale scambio di segnali avviene perch esistono delle mappe neurali reciprocamente connesse. Queste mappe colle-gano i repertori secondari, cio il risultato dinamico di quegli eventi selettivi dello sviluppo e della selezione sinaptica a cui ho appena fatto riferimento, mentre le loro interazioni rien-tranti conservano la continuit spazio-temporale in risposta ai segnali provenienti dal mondo esterno.
molto importante stabilire un legame tra questi processi e i meccanismi specifici dello sviluppo e dell'evoluzione. Durante lo svi-luppo, quando si formano i repertori primari di gruppi neuronali va-rianti, l'anatomia locale dei gruppi stessi viene determinata da fat-tori genetici che regolano la forma cellulare e da eventi epigenetici che regolano i processi primari dello sviluppo, cio, divisione, movi-mento, morte, adesione e differenziamento cellulare. Sebbene, in animali della stessa specie, le strutture di una particolare area cere-brale siano simili per tipo di funzione svolta tuttavia, esiste una no-tevole variabilit individuale nelle ramificazioni assonali e dendriti-che, nella forma, nell'estensione e negli schemi di connessione. Que-sta variabilit, che deriva dalla regolazione dinamica delle molecole di adesione cellula-cellula e cellula-substrato, crea quelle differenze su cui pu agire la selezione somatica. Allo stesso tempo, le mutazio-ni negli elementi che, nello sviluppo, regolano i tempi di comparsa di queste molecole, sono tra le possibili cause dell' evoluzione di speci-fiche regioni del cervello. Tali proprietregolative consentono al sistema nervoso di adattarsi a diverse modificazioni evolutive indi-pendenti nell' organismo come, per esempio, le modificazioni nei muscoli, nelle ossa e nei recettori sensoriali. Queste idee, che met-tono in relazione l'epigenesi e l'eterocronia dello sviluppo neurale all'evoluzione morfologica, sono parte di un'ipotesi fondamenta-le per la teoria, che ho definito ipotesi dei regolatori. Grazie a questi meccanismi epigenetici di sviluppo nel repertorio primario di una regione neurale specializzata si creano numerosi gruppi non identici
Riassunto e introduzione storica 9
e ciascun gruppo pu rispondere con pari efficacia a un input speci-fico. Si parla di degenerazione, un concetto fondamentale per la teo-ria, quando in ogni repertorio vi sono forme varianti in strutture neurali equivalenti dal punto di vista funzionale, ma non isomorfi-che. Il risultato di questi eventi epigenetici di sviluppo la creazione di numerose reti degenerate di gruppi neuronali costituiti da neuroni con alberi dendritici e arborizzazioni assonali distribuite su un' area relativamente ampia e con un notevole grado di intr~catezza. Tutta-via, tali complesse arborizzazioni non implicano l'assenza di contatti neuronali specifici, i quali possono, inoltre, essere localizzati in parti ben definite dei neuroni stessi.
Dopo la nascita, cio quando gran parte del repertorio prima-rio si gi formato, si verifica una seconda selezione epigenetica. I segnali in input vengono astratti e filtrati dai trasduttori senso-riali, dagli estrattori di caratteri e dai correlatori di caratteri (soprat-tutto i complessi sensomotori) inseriti in un mappaggio globale. I gruppi neuronali attivi in quei particolari repertori che ricevono tali segnali sono selezionati in maniera competitiva a vantaggio di altri.
Una selezione vincente modifica l'efficacia sinaptica in quelle parti della rete corrispondenti a tali gruppi, incrementando la proba-bilit di risposta quando segnali simili o identici si ripresenteranno. Il risultato di questa competizione dipende dalla ricchezza struttu-rale del repertorio primario, dall' efficienza di regole pre- e postsinap-tiche indipendenti che determinano le interazioni tra neuroni in un gruppo e, infine, dalla frequenza e dalla sede di segnali simili o iden-tici. I repertori secondari, che sono gruppi neuronali selezionati in modo dinamico, si formano in seguito a una reiterata stimolazione da parte di questi segnali. Le regole sinaptiche responsabili della se-lezione dei repertdri secondari agiscono sulle sinapsi intese come po-polazioni, e, perci, l'operazione di queste regole intimamente con-nessa alla particolare organizzazione e alla densit circuitale di un certo repertorio primario. Come parte integrante della teoria presen-ter uno specifico modello popolazionistico di selezione sinaptica, il cosiddetto modello delle due regole.
L'ipotesi dei regolatori e il modello delle due regole sono, nella selezione, i due meccanismi epigenetici fondamentali per la teoria: il primo riguarda la selezione durante lo sviluppo e forma il reperto-rio primario, mentre il secondo si riferisce alla selezione durante l'e-sperienza comportamentale e induce la formazione del repertorio se-
-
IO Capitolo primo
condario. Tuttavia, se la selezione dei gruppi neuronali si basasse so-lo su questi due meccanismi non potrebbe spiegare la conservazione della continuit spaziotemporale, indispensabile per la categorizza-zione percettiva. A tale scopo, sono richieste diverse forme di map-paggio, ed stato scelto un esempio di formazione di una mappa lo-cale nella corteccia cerebrale per mezzo della: selezione dei gruppi neuronali (il modello confinamento-selezione-competizione).
La teoria sostiene che la coordinazione e il rinforzo dei modelli di selezione dei gruppi neuronali debba verificarsi tra diverse regioni cerebrali, organizzate a mappe. Questo consentito da segnali fasici che fluiscono lungo le connessioni anatomiche rientranti tra queste mappe. Tale rientro fasico consente un legame dinamico tra i diversi sistemi di gruppi neuronali selezionati e attivi parallelamente in tem-po reale. In numerose aree cerebrali sono state osservate configura-zioni anatomiche rientranti (reciproche o di altro tipo) che presen-tano una segnalazione fasica rientrante; possiamo ricordare, a pro-posito, le radiazioni talamocorticali e corticotalamiche, le connessio-ni callosali e varie connessioni tra le aree sensoriali sia primarie che secondarie [Zeki 1975, 1978a; Van Essen 1985], e quelle motorie. Il rientro tra mappe ovvia al bisogno di uno scambio esplicito di mar-catori di tempo e di luogo analoghi a quelli previsti dai sistemi a computazione parallela.
Un postulato centrale della teoria che la categorizzazione per-cettiva debba sia precedere sia accompagnare l'apprendimento. In-fatti, uno dei compiti precipui del sistema nervoso realizzare la ca-tegorizzazione percettiva in un mondo "senza etichette" - in cui l'ordine macroscopico e l'organizzazione di oggetti ed eventi (com-presa la loro definizione e discriminazione) non sono prevedibili da un organismo, tranne la regola che tali oggetti ed eventi obbediscono alle leggi della fisica. La condizione necessaria affinch si verifichi la categorizzazione percettiva il rientro tra sistemi paralleli separati di mappe locali, variamente specializzate, ciascuna delle quali cam-piona in modo disgiuntivo e indipendente lo stimolo. Tuttavia, di solito, si creano le condizioni essenziali per la categorizzazione per-cettiva solo quando un certo numero di tali mappe viene intercon-nesso e forma un mappaggio globale di ordine superiore che coinvol-ge complessi motori e sistemi sensoriali. Il rientro fasico di questi si-stemi paralleli multipli nel cervello il maggiore contributo alla sua attivit ritmica. A sua volta, il comportamento motorio dell' animale in esplorazione la principale fonte di quel campionamento conti-
Riassunto e introduzione storica II
nuo, necessario affinch la selezione dei gruppi neuronali realizzi la categorizzazione percettiva.
Detto questo, importante dimostrare come la selezione dei gruppi neuronali e il rientro nelle mappe possano operare di concerto per realizzare la categorizzazione percettiva. Abbiamo dimostrato la validit intrinseca della teoria della selezione dei gruppi neuronali ai fini della categorizzazione progettando un automa percettivo che in-corpora i fondamenti della teoria. L'abilit dell'automa di crearsi delle categorie basandosi su semplici figure bidimensionali suggerisce che le connessioni fasiche rientranti tra piu repertori organizzati in mappe possono generare funzioni associative assenti nei repertori isolati. Come dimostreremo nel capitolo x, in questo automa la se-lezione, la quale opera su repertori degenerati di gruppi neuronali collegati dal rientro, crea una reale categorizzazione pur senza la ste-sura di un programma atto a definire esplicitamente gli oggetti cate-gorizzati. In sintesi, vedremo come tutte le ipotesi enunciate nei ca-pitoli antecedenti alla descrizione dell' automa si armonizzino con le operazioni fisiche di quest'ultimo. Tuttavia, la teoria della selezione dei gruppi neuronali una teoria biologica e non solo fisica, quindi, per coglierne tutte le implicazioni ci sar d'aiuto una breve digressio-ne sui presupposti biologici. In particolare, la teoria, per avere valo-re, deve essere fondata su solide basi evolutive.
3. Il pensiero popolazionistico in neurobiologia.
A meno di invocare un progetto speciale o la creazione, l'adatta-mento ambientale delle specie animali si basa sulla selezione natura-le, la quale opera sulla variabilit gi presente nelle popolazioni. I di-versi taxa si originano grazie alle variazioni nell' ambiente e ad alcuni meccanismi di isolamento. Un animale con un cervello complesso de-ve adattarsi senza istruzioni a un ambiente multiforme e crearsi delle categorie percettive o una tassonomia interna che ne controlli le ri-sposte al mondo circostante. Inoltre, la teoria propone che tale adat-tamento si attui tramite una selezione somatica operante sulle popo-lazioni di gruppi neuronali dell' animale stesso. In un certo senso non ci sorprende il fatto che la selezione naturale abbia favorito la sele-zione dei gruppi neuronali, in quanto esiste una certa analogia tra l'origine dei taxa nel corso della filogenesi e l'origine di popolazioni di gruppi neuronali e di categorie percettive negli individui. Tutta-via, l'analogia non va forzata sino al punto da considerarla sempli-
-
I2 Capitolo primo
cemente un'imitazione. Infatti, sono enormi le differenze, nei det-tagli e nei meccanismi, tra selezione naturale, selezione dei gruppi neuronali e selezione clonale immunitaria, l'altro processo biologico in cui la presenza di variabili in una popolazione il fondamento dei meccanismi di riconoscimento durante la vita del singolo. Tuttavia, pur con queste differenze, sono comparabili se consideriamo le tre caratteristiche essenziali condivise da tutte le teorie selettive: cio, 1) repertori variabili di elementi le cui fonti di variazione non hanno una relazione causale con i successivi eventi di selezione o di ricono-scimento, 2) opportunit di interagire con un ambiente che si modi-fica indipendentemente, consentendo la selezione di una o piu varia-bili adatte e, infine, per mezzo della trasmissione genetica, 3) stru-menti di riproduzione differenziale o di amplificazione delle varianti selezionate in una popolazione.
A differenza della teoria dell' evoluzione, la teoria della selezione dei gruppi neuronali non ha rapporti con le cause ultime, ma solo con le cause prossime. Tuttavia, analogamente alle tesi addotte riguardo alla selezione naturale nella teoria dell' evoluzione, a sostegno della nostra teoria dobbiamo far confluire prove da molte discipline diver-se. Una breve storia del pensiero popolazionistico in neurobiologia potr opportunamente inquadrare le prove stesse. Spero di riuscire a dimostrare che la teoria della selezione dei gruppi neuronali, pur condividendo i principi di altre teorie selettive, se ne discosta nei meccanismi particolari e nei suoi effetti evolutivi. Andrebbe, peral-tro, al di l delle intenzioni del libro offrire un compendio storico completo delle idee selezioniste o esaurire gli esempi di pensiero po-polazionistico applicato al comportamento. Per quanto riguarda il primo aspetto, il lettore interessato pu consultare l'eccellente libro di Mayr [1982], per il secondo, alcuni compendi di psicologia com-parata e di etologia [Gottlieb 1979; Lythgoe 1979; Gould 1982; Griffin 1982; MacPhail 1982; Terrace 1983].
Nel passato le idee selezioniste in neurobiologia hanno descritto principalmente gli aspetti evolutivi del comportamento o l'evoluzio-ne del cervello e dei suoi diversi centri neurali. Con l'eccezione degli interessi etologici per l'origine neurale di alcuni comportamenti, la maggior parte di questi resoconti ha ignorato o non si pronunciata sulla selezione somatica, cio, la selezione neuronale quale princi-pio esplicativo piu importante per l'ontogenesi e la fisiologia del cer-vello. Le analisi degli etologi si sono essenzialmente concentrate sul grande anello selezione naturale-comportamento, che vedremo nel capitolo XI (si veda la fig. 62), piuttosto che su una selezione operan-
Riassunto e introduzione storica I3
te negli individui secondo le regole della biologia cellulare e della fi-siologia.
L'interesse nell'applicare il pensiero popolazionistico all'origine e alla funzione del singolo sistema nervoso ' relativamente recente. Come ho accennato nei commenti della sezione precedente, uno fra gli obiettivi di un' esauriente teoria somatica correlare la selezione evolutiva delle strutture cerebrali e le funzioni cerebrali via via emergenti, per selezione somatica, durante e dopo lo sviluppo. proprio questo compito che caratterizza il concetto di selezione so-matica dei gruppi neuronali e delle popolazioni sinaptiche rispetto alle idee selezioniste degli etologi. Un breve resoconto storico ci con-sentir una piu agevole distinzione dei diversi livelli in cui stato ap-plicato il pensiero selezionista, e potr aiutarci a evitare la confusio-ne tra i livelli stessi, particolarmente quando ci addentriamo tra le prove che sostengono i concetti di selezione somatica.
4. Selezione naturale e pensiero popolazionistico in relazione al comportamento.
Charles Darwin stato il primo a sostenere che la selezione na-turale modifica il comportamento, e viceversa. Egli ha approfondito il rapporto tra selezione e istinti animali [Darwin 1859] e ha specu-lato sul significato evolutivo delle emozioni e dei sentimenti [Darwin 1872]. Le idee di Darwin furono riprese da un suo contemporaneo, George John Romanes [1884, 1889], il quale ha proposto la teoria secondo cui il comportamento una propriet della specie e la con-tinuit comportamentale filetica. Charles Lloyd Morgan [I 896, 1899,1930] ha osservato una relazione tra la complessit dell'orga-nizzazione neurale e quella del comportamento. Sebbene sottoli-neasse che la complessit del comportamento di un animale ne riflet-te la complessit neurale e, quindi, che le modificazioni anatomiche evolutive possono originare nuovi modelli comportamentali, non chiari i contributi relativi dell'istinto e dell'abitudine.
C. Wesley Milis [1898] stato, probabilmente, il primo a ricono-scere l'influsso dello sviluppo sul comportamento. A quel tempo i tentativi di definire i vincoli imposti dallo sviluppo del cervello sulla funzione cerebrale e sul comportamento sono stati confusi, in parte, con la teoria della ricapitolazione di Haeckel, un falso concetto la cui storia stata esaurientemente analizzata da Stephen Jay Gould [1977]. Tuttavia, James Mark Baldwin [1895, 1902] stato fra i pri-
-
I4 Capitolo primo
mi a cogliere l'importanza delle modificazioni negli individui duran-te l' ontogenesi ed ebbe la lucidit per interpretare la questione in termini darwiniani. Not che, sebbene i singoli animali co specifici vivano esperienze diverse, i comportamenti in tutti gli animali di una specie sono alquanto costanti. Il cosiddetto effetto Baldwin [per un' analisi, si veda Gottlieb 1979] fu forse la prima indicazione che fenomeni verificantisi durante l' ontogenesi possono influenzare la morfologia e il comportamento; le teorie di Baldwin tendevano a spiegare come esperienze successive potessero facilitare e conservare tali modificazioni 3
5. Declino e rinascita delle idee selezioniste.
A questi primi sforzi seguito un notevole declino nell'impiego del pensiero popolazionistico in psicologia, in coincidenza, nella pri-ma parte di questo secolo, con lo sviluppo del comportamentismo'. L'uso occasionale del concetto di selezione per descrivere il compor-tamento nelle fasi di apprendimento pu far pensare a un' eventuale parentela con il pensiero di Darwin. In realt, solo un esile filo so-stiene senza ambiguit questa affermazione, sebbene sia stata pro-posta come analogia [Dennett 1978] per spiegare il paradigma stimo-lo-risposta, o S-R, di Thorndike [19II]. Questo paradigma stato inglobato nella legge dell'effetto, la quale postula che l'associazione tra un certo stimolo e la relativa risposta sia rinforzata in funzione al-l'entit della ricompensa ricavata dall'azione. Secondo questa legge, il comportamento, quando produce risultati soddisfacenti per l' or-
.
3 L'effetto Baldwin una causa indiretta dell'apprendimento sull'evoluzione. Se-condo tale concezione l'apprendimento favorisce una migliore sopravvivenza e, quindi, gli organismi piti abili nell'apprendere generano una prole piti numerosa incrementando la frequenza del gene responsabile di quell'apprendimento. Se l'ambiente rimane suffi-cientemente stabile pu indirettamente favorire la codificazione genetica di un tratto che originariamente ha dovuto essere appreso, e cOSI l'apprendimento pu influire sul-l'evoluzione. L'interazione reciproca tra evoluzione e apprendimento interessa, oltrech gli etologi e gli psicologi, anche gli esperti di algoritmi genetici e di reti neurali [Hinton e Nowlan I987; Ackley e Littman I992; per una rassegna sul tema si veda Nolfi e altri I9921, i quali hanno proposto modelli che simulano e confermano la validit dell'effetto Baldwin, con lo scopo di verificare teorie biologiche, ma anche creare programmi per computer capaci di evolversi ispirandosi alle leggi biologiche (l'intreccio di questi argo menti documentato, tra le altre, nelle riviste, Evolutionary Computation e Arti-ficial Life , pubblicate dalla Mit Press).
, Per una rassegna dove viene evidenziata la riconciliazione tra comportamentismo e neuroscienze si veda Thompson [1994].
Riassunto e introduzione storica I5
ganismo, viene" impresso" nel suo sistema nervoso, mentre, qua-lora provochi disagi e dolori, viene rimosso. Thorndike ha sottoli-neato il ruolo dell' attivit motoria nel ricercare effetti gratificanti con variazioni nelle differenti associazioni interne. Sebbene aves-se colto inequivocabilmente la relazione tra incremento delle dimen-sioni cerebrali e comportamento, tuttavia, da questa intuizione non scatUrl alcuna teoria generale. Esiste un evidente filo conduttore tra questi studi e il comportamentismo; purtroppo, sembra essere sta-ta ignorata la sua relazione meno evidente, ma chiara, con l'evolu-zione darwiniana.
Insieme al lavoro di Pavlov [si vedano Mackintosh 1983; Stad-don 1983; Jenkins 1984], le idee e gli esperimenti di Thorndike han-no segnato !'inizio del comportamentismo nella teoria dell' appren-dimento, un modo di studiare il comportamento animale svincolan-dolo da ogni analisi sui meccanismi interni al suo cervello. Questa metodologia, pur caratterizzata da un significativo perfezionamento sperimentale, ha introdotto un sapore istruzionista nell'interpreta-zione del comportamento, ins