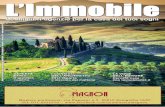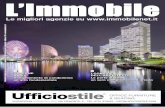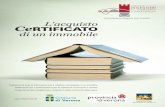Dal Feto al Neonato - anpep.it le caratteristiche personologiche... · sempre immobile e...
Transcript of Dal Feto al Neonato - anpep.it le caratteristiche personologiche... · sempre immobile e...
Napoli, 20 maggio 2016, Hotel Royal Continental
II^ Congresso Nazionale Società Italiana per la Care in
Perinatologia AICIP ”Dal Feto al Neonato”
Relazione: “LE DIFFERENTI CARATTERISTICHE PERSONOLOGICHE
DELL’ESSERE UMANO DAL CONCEPIMENTO”
del Dott. Gino Soldera, Presidente dell’ANPEP (Associazione Nazionale di Psicologia
e di Educazione Prenatale) www.anpep.it
Secondo quattro prospettive: 1) Genetica (relazioni
genetiche)
2) Ecografica (osservazione
del comportamento fetale)
3) Materna (osservazione del
vissuto materno in
gravidanza)
4) Psicologica (profilo
psicologico del neonato)
Dice Maria Montessori (1989): “Siamo ai primi balbettii di una scienza che si deve sviluppare molto, e alla quale l’adulto deve fornire la collaborazione della sua intelligenza per conseguire, attraverso lunghi sforzi, l’ultima parola nella conoscenza della formazione dell’uomo.”
Con Henry Murray (1983/1988) potremmo dire che la PERSONOLOGIA si occupa
della vita umana e dei fattori che la influenzano, indaga sulle differenze
individuali e sui vari tipi di personalità, nel nostro caso, a partire dal
concepimento.
La personalità indica quell’insieme di caratteristiche che rendono ogni uomo un
unico, lo distinguono da ogni altra persona, fanno sì che sia quel che realmente è
(Luccio, 2001).
Per la psicologia e l’educazione pre e peri-natale:
1.La vita inizia dal concepimento e procede secondo un continuum 2.Il concepito è dotato fin da subito di una propria identità, unica
originale e irripetibile 3.Nel concepito sono presenti tutte le potenzialità tipiche dell’essere
umano 4.Non vi è separazione tra la psiche ed il corpo e tra il corpo e la
psiche 5.L’ambiente intra- ed extrauterino svolge un ruolo determinante
nella formazione, crescita e sviluppo dell’individuo. 6.Lo sviluppo procede secondo modalità non lineari, con periodi più
o favorevoli alla maturazione di certe aree rispetto ad altre. 7.Le esperienze pre e peri-natali concorrono alla realizzazione della
struttura psicobiologica dell’essere umano e ne influenzano la vita post-natale.
8.Le buone relazioni creano fin dall’inizio un contesto favorevole alla maturazione, crescita e sviluppo dell’individuo.
E’ dato dall’incontro del maschile con il femminile, dell’uomo con la donna e dell’ovulo (Io femminile) con lo speramatozoo (Io maschile) e questo genera un nuovo Io Personale.
Il concepito è dotato di tutto quanto gli serve per vivere (Parson, 2002) :
1. Identità umana (44+ 2 cromosomi e un totale di circa 3,2 miliardi di paia di basi di DNA contenenti all'incirca 20 000–25 000 geni);
2. Unicità e individualità (sequenza ALU, per distinguere il Genoma);
3. Autonomia biologica (Shift metabolico, energetico);
4. Programma genomico (imprinting genomico, polarizzazione, assializzazione)
Per la psicogenealogia (Langlois, 2007) il patrimonio
genetico, fatto di informazioni provenienti dai propri
progenitori, di cui ognuno di noi è portatore, è in
grado di condizionare le relazioni e quindi il modo di
porsi e di relazionarsi con gli altri.
Secondo la genetica delle relazioni (Soldera, 1993, 1995, 2000, 2002, 2005, 2014) ogni membro della famiglia assume una sua posizione che ha implicazioni genetiche all’interno del sistema famigliare, infatti: “ogni figlio è corrispondente ad uno dei genitori ed è complementare all’altro”.
La madre può percepire il figlio …
-come parte di sé o come estraneo; -con eccesso di interesse e preoccupazione o con una certa
indifferenza interiore o distacco.
Inoltre … - tende a chiudersi o aprirsi all’esterno; - avverte o non avverte il desiderio di coinvolgere il marito; - sente che il figlio manifesta attenzione verso il padre.
NB: Conferma l’importanza del padre verso la madre, ma anche verso la formazione e crescita del figlio nell’armonia e nell’amore.
Il rapporto di corrispondenza e complementarietà tra i genitori ed il figlio si può rilevare nel corso della gestazione attraverso una semplice verifica della relazione che la madre vive con il figlio (Questionario delle relazioni genetiche. Soldera, 2007).
L’analisi della corrispondenza e complementarietà risulta difficile nei genitori affini e nei figli unici.
Le coppie di gemelli sono per definizione complementari tra loro.
Il figlio corrisponde al genitore che più l’ha desiderato con il quale ha un rapporto più intimo e ciò è indipendente dalla differenza di genere maschile o femminile.
Il figlio dimostra avere maggiori elementi di somiglianza con i nonni, gli zii e i cugini di parte corrispondenti e talvolta anche maggiori simpatie.
NB: Questi dati sono molto preziosi per i genitori per permettere loro di
entrare in relazione empatica, conoscere il figlio e interagire con lui, ma sono
molto importanti anche per conoscere le dinamiche relazionali più profonde
presenti nel sistema famigliare.
Sasha Malia
NB: Nelle dinamiche famigliari tutto avviene inconsciamente senza che ce ne accorgiamo: in genere ci avviciniamo alla persone che ci assomigliano e ci allontaniamo da quelle che sentiamo essere diverse.
Obama Michelle
Considerare solamente l’eredità (Genetica Molecolare), le combinazioni tra eredità e ambiente (Genetica del comportamento) o l’influenza dell’ambiente nei geni (Epigenetica) porta a trascurare il ruolo che l’individuo svolge nella modulazione dei geni e delle loro interazioni con l’ambiente.
L’Individualità, secondo Caprara (1998), che rappresenta i tratti dell’individuo, non è riconducibile al rapporto tra natura e cultura. Infatti, ogni individuo è portatore di un proprio repertorio di potenzialità ed è in grado di decidere quali di queste vanno attualizzate. L’individualità può essere conosciuta da ognuno di noi differenziandosi dal padre, dalla madre e dall’ambiente.
◙ E’ un somigliante anche se
diverso dai suoi genitori, avendo
una propria specifica
individualità.
◙ E’ un essere attivo capace di
autoevolversi e autorigenerarsi
(Mercurio, 1989).
◙ E’ il direttore d’orchestra del suo
sviluppo (British Medical Journal,
2000).
◙ E’ dotato di un proprio progetto di
vita che rappresenta la bussola del
suo divenire (Soldera, 2000).
“Individualità Precoce”
Alla 13^ S.d.G. il nascituro reagisce agli stimoli con caratteristiche proprie che mantiene nel tempo anche dopo la nascita (Tajani, 1998).
La preferenza per l'uso della mano destra o sinistra inizia durante le prime 15 SdG. (Hepper, 1991).
Sia in utero, sia fuori dall’utero i gemelli spesso mostrano un profilo motorio indipendente (Gallagher e al., 1992).
A 22^ S.d.G. manifesta una sua intenzionalità nel comportamento di esistenza (Zoia et al., 2007).
A 5 mesi di gestazione il nascituro ha disegnati sulle mani i solchi delle sue impronte digitali, che certificano la sua identità.
Alcune inportanti tappe dello sviluppo prenatale hanno messo in evidenza una sua precoce individualità:
verso la 13 settimane, il feto inizia a manifestare delle preferenze, delle
reazioni e dei comportamenti altamente individuali, con tratti della personalità che continuano dopo la nascita;
il feto può assumere posture e abitudini motorie così specifiche, tanto da offrire possibili indicazioni di quello che sarà il futuro carattere del neonato;
il feto stabilisce relazioni assai complesse con l'ambiente intra-uterino: placenta, cordone ombelicale; alcune formazioni patologiche e difensive possono cominciare a svilupparsi in utero;
comportamenti come la chiusura autistica possono rappresentare fenomeni secondari di per sé patologici;
i gemelli, fin dall'inizio dimostrano chiare differenze temperamentali ed esperienziali nel loro comportamento e sviluppano una specifica modalità di interazione fra loro.
Studi ed osservazioni sul comportamento fetale in ambiente uterino (Milani
Comparetti, 1981; Piontelli, Negri, 1994) hanno permesso di cominciare a
conoscere le caratteristiche comportamentali e quindi personali del
nascituro. Da questi sappiamo che:
Secondo la Piontelli, ogni feto, fin dagli stadi più precoci sembra avere una consapevolezza di esistenza o <<coscienza vitae>>, se non di <<autocoscienza>> dati confermati da molti altri studiosi (Lake, Graber, Chamberlain, Verny, Janov, Janus, Grof, ecc.).
Questo può essere alla base del contatto interiore empatico che il figlio ha con la madre, con il padre e con altri durante la gestazione.
Giulio, ad esempio, un bambino che appariva molto placido e continuamente intento in attività che coinvolgevano la lingua e la bocca, tipo leccare in continuazione e con apparente voluttuosità la placenta o il cordone ombelicale, aveva poi mostrato di provare un enorme piacere dopo la nascita per tutte le attività connesse con il leccare e più tardi con l'«ingurgitare» qualsiasi tipo di cibo e a due anni era già notevolmente obeso.
Gianna, al contrario, si era mostrata una bambina estremamente «chiusa», quasi sempre immobile e rannicchiata su se stessa, tanto che a detta delle stesse parole dell'ostetrico la stretta cavità uterina sembrava fosse «troppo vasta per lei ... sembra quasi farsi una seconda pelle proteggendosi tutta con le braccia e con le mani ... ». L'immobilità e la chiusura di Gianna sembrano continuare in parte tuttora all'età di sei anni, nel suo rigido e ossessivo controllo dei mondo circostante.
Le osservazioni interiori basate sui processi primari del sentire empatico e non tanto della percezione (Solms, 2002) hanno permesso alle madri di cominciare a cogliere le caratteristiche del figlio, fin dalla concepimento (Conoscere il carattere del bambino prima che nasca, 1995).
Questo è stato possibile:
Considerando il vissuto della madre prima, durante e dopo la gravidanza.
Prendendo nota e registrando i suoi pensieri, emozioni e comportamenti durante la gravidanza.
Differenziando i vissuti della gravidanza da quelli propri a quelli riferibili al figlio.
Mettendo insieme i dati per individuare in modo articolato le caratteristiche specifiche proprie del figlio (Soldera, 2014).
Cercando infine di conoscere sul piano esistenziale il suo progetto di vita.
Scrive Saint-Exupéry (1943): “Non si vede bene che con il
cuore. L‟essenziale è invisibile agli occhi.”
TESTIMONIANZA DI S. (Soldera, 2014) il nascituro che vive in me ha dimostrato chiaramente di essere deciso nell’agire, nel buttarsi in esperienze che ritiene utili.
Ho potuto riscontrare questa sua tendenza ogni volta che dovevo decidere se intraprendere o meno una nuova esperienza (ad esempio: mi iscrivo al corso di piscina o meno?).
Ho sentito proprio un’energia e una tranquillità, in relazione all’intraprendere un’azione, che non sono molto tipiche del mio carattere.
Generalmente mi creo molti problemi prima di iniziare ad agire. Il fatto di sentirmi più tranquilla e disinvolta mi dà molta serenità e senso di gratitudine nei confronti di mio figlio/a.
Il figlio stimola forze ed energie, e con esse la voglia di fare, cercare, scoprire, cambiare: egli quindi, come un vero e proprio maestro, ci orienta verso il futuro (Soldera & Mussato, 2010). Ma soprattutto il nascituro apre delle nuove possibilità nell’ambito della Scienza dell’Educazione, con prospettive impensabili fino a poco tempo fa, consentendo il mantenimento e abilità e lo sviluppo di abilità e competenze del bambino che con il metodo tradizionale normativo vengono mortificate.
Compito
dell’educazione è
proprio quello di
“educere” e cioè di
tirar fuori e far
emergere il meglio
che c’è dentro
ognuno di noi.
22
Una vera educazione non può
essere inculcata a forza dal di
fuori; essa deve invece aiutare a
trarre spontaneamente alla
superficie i tesori di saggezza
nascosti sul fondo.
R. Tagore
Realizzare il profilo psicologico del neonato è stata una naturale evoluzione delle conoscenze maturate nell’ambito dell’osservazione interiore ed esteriore del bambino nel corso della vita prenatale.
Accanto a queste possibilità la PSICOLOGIA DEL CORPO da Lowen, Dychtwald, Ambrosi, Painter, Prestera, Rispoli, Liss e altri, ha permesso di leggerne il linguaggio, conoscerne le corrispondenze e scopirne i significati.
Nel nostro caso di grande aiuto è stata la MORFOPSICOLOGIA, una scienza ideata dallo psichiatra francese Luis Corman (1901- 1996), che studia le caratteristiche della persona a partire dai tratti presenti nel volto in un stretto rapporto tra forma e psiche.
Questa si basa sulla legge fondamentale della dilatazione e della ritrazione rispetto all’ambiente favorevole o sfavorevole, per cogliere, al di là della semplice intuizione dettata dall’esperienza, alcune caratteristiche personali dell’essere umano e quindi anche del bambino.
In morfopsicologia (Binet, 1997) si osserva: IL QUADRO: che è la struttura ossea che rappresenta l’Io con il quale la
persona affronta il mondo. IL MODELLATO: che è lo spessore di carne, muscoli e pelli che riveste
l’osso e che dà la forma presente all’esterno. Esso riguarda in particolare il mondo dei comportamenti ed emozioni che regolano il rapporto tra la persona e l’ambiente.
I RECETTORI: sono rappresentati dagli organi di senso che consentono di scambiare le informazioni tra la persona e l’ambiente.
I PIANI CEREBRALE, AFFETTIVO ED ISTINTIVO: il primo in relazione con il sistema neurosensoriale, il secondo con il sistema cardiocircolatorio e respiratorio e il terzo con l’apparato digerente.
LA DIMENSIONI VERTICALE, ORIZZONTALE E ASSIALE: che forniscono indicazioni sul rapporto astratto/concreto, maschile/femminile, attività e passività.
NB: In tutto questo l’obiettivo non è il giudizio, ma la comprensione, in
particolare dei rapporti esistenti tra le diverse parti, vista la influenza
reciproca che compone l’insieme.
TIPOLOGIA: materlineare (la struttura morfogenetica è
assomigliante a quella della madre ed è quindi complementare a quella del padre) definita attraverso il Questionario delle relazioni genetiche (Soldera, 2007).
CARATTERISTICHE PERSONALI: Bambina aperta al mondo, sveglia, loquace, socievole, attenta e capace di cogliere e di vivere le emozioni. Sensibile in generale ai rapporti umani e interessata alle coetanee avendo chiara la sua identità sessuale. Sa quello che vuole, ma anche in grado di aspettare e di sopportare le frustrazioni perché ha un Io sufficientemente strutturato e forte. Sente che non è sola e che si può fidare degli altri. In questa prima fase della vita si aspetta che ci si occupi di lei.
DAL PARTO: dal vissuto psicofisico del parto si può desumere che sia presente una certa tendenza alla preoccupazione e al controllo del proprio comportamento nelle situazioni di stress.
Proprio oggi, rileggendo l'ipotesi del profilo psicologico alla nascita che lei ci aveva mandato, ritroviamo in quelle righe una perfetta descrizione del carattere che si sta delineando nella nostra bambina.
A volte, nel confronto con altri coetanei abbiamo notato come la vivacità, la curiosità e la socialità di Arianna non siano per nulla caratteristiche comuni anche agli altri bambini e rimaniamo sempre stupiti da questo
lato positivo del suo carattere. Naturalmente il mestiere di genitori è davvero difficile, e
noi siamo solo agli inizi, ma sentiamo di dare tanto amore a nostra figlia e di riceverne da lei altrettanto.
La ringraziamo ancora e cogliamo l'occasione per augurarle ogni bene,
Bruno e Marta
Dice Peter Fedor Freybergh (2007):“La consapevolezza che il feto sia già una
personalità, un partner psicologico e sociale per i propri genitori e, grazie a loro,
per la società intera, deve essere messa in primo piano.”
Mutuando David Chamberlain (2004) possiamo dire che: “Se la società fosse informata su
quanto oggi si sa sulla psicologia e sull’educazione prenatale, cambierebbe il suo approccio
alla vita nascente e questo permetterebbe di aprire nuove prospettive nel futuro
dell’umanità.”
Aggiunge Peter Fedor Freybergh (2007): “La storia dell’umanità è infatti anche la storia
dei bambini, e questa storia ha inizio con l’inizio della vita, al momento del concepimento.”