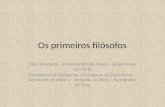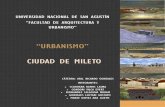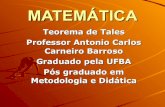CORSO DI FISICA · RADICI: La scuola di Mileto •C’è l’idea di pensare il mondo in termini...
Transcript of CORSO DI FISICA · RADICI: La scuola di Mileto •C’è l’idea di pensare il mondo in termini...

CORSO DI FISICAFisica semplice per menti curiose
luigi catalani

RADICI : La scuola di Mileto
• Da sempre gli uomini si erano chiesti come fosse nato il mondo, che cosa fosse fatto, perché avvenissero i fenomeni della natura. Da millenni si erano dati risposte che si somigliavano tutte: risposte che facevano riferimento a intricate storie di spiriti, dèiiracondi e litigiosi, animali mitologici e immaginari, e cose simili.
• Poi, a Mileto, all’inizio del VI secolo a.c., Talete, il suo discepolo Anassimandro e la loro scuola di Filosofia della Natura ( Phisis, da cui Fisica) scoprono un altro modo per cercare risposte. Un modo che non fa riferimento a fantasiose entità esterne alle cose ma che cerca risposte nella natura stessa delle cose. Questa grande rivoluzione di pensiero è l’alba del pensiero scientifico.
• I milesi scoprono che usando in maniera accorta l’osservazione e la ragione, e soprattutto il pensiero critico, possiamo correggere ripetutamente il nostro punto di vista sul mondo, capire aspetti della realtà apparentemente invisibili e imparare nuove cose.
È più facile capire le idee partendo dalle radici che le hanno fatte nascere…..

• Il risultato è impressionante: Anassimandro capisce che la terra galleggia nel cielo e il cielo continua anche sotto la terra, che l’acqua della pioggia viene dalla evaporazione dell’acqua terrestre, che le cose e i fenomeni del mondo dovessero essere riconducibili a qualcosa di semplice, una sostanza elementare (Apeiron) che comprimendosi e rarefacendosi potesse trasformarsi dall’uno all’altro degli elementi di cui è fatto il mondo (un germe di fisica, elementare e rozzo, ma che va nella giusta direzione), e così via, gettando le basi di metodi di indagine dei fenomeni naturali che sono ancora i nostri.
• A Mileto gli uomini mettono in dubbio l’idea che solo gli dèi possano spiegare i fatti incomprensibili del mondo, discutendo invece di come si possa arrivare a comprenderli con l’osservazione e la ragione.
• Questa luminosa città fu distrutta dai Persiani nel nel 494 a.c. ma rinacque vent’anni dopo quando i Greci respinsero la minaccia persiana. Qui, nel 450 a.c. , Leucippo fondò una scuola scientifica e filosofica alla quale associò un giovane discepolo la cui ombra giganteggia sul pensiero di tutti i tempi: Democrito.
RADICI: La scuola di Mileto

RADICI: La scuola di Mileto
• Leucippo e Democrito capirono che l’Universo è uno sterminato spazio vuoto dove corrono gli Atomi, grani elementari della realtà, indivisibili, che si muovono liberi nello spazio, si scontrano, si uniscono, si respingono. Dal combinarsi degli atomi elementari (92 si scoprirà 23 secoli dopo) deriva l’infinita varietà delle sostanze (la Materia) del mondo, così come combinando la ventina di lettere dell’alfabeto si possono ottenere commedie, poemi, romanzi ecc.
• Questa danza infinita di atomi è alla base della nostra vita, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. La luce che vediamo viene dagli atomi e di atomi siamo fatti noi, la terra e le stelle. E’ una visione immensa, incredibilmente semplice e potente, sulla quale in seguito si costruirà il sapere dell’umanità.

RADICI: La scuola di Mileto
• Su questa base Democrito scrisse decine di libri su tutti gli aspetti della conoscenza del mondo. Fa impressione leggere i titoli di questi libri, solo i titoli perché tutti i libri sono andati perduti: la più grande tragedia intellettuale seguita alla caduta della civiltà antica! Conosciamo il suo pensiero attraverso il De rerum natura (la Natura delle cose) del poeta latino Lucrezio (I secolo a.c.). Lucrezio aderisce alla filosofia di Epicuro, l’allievo di un allievo di Democrito, e ne mette in versi il pensiero e quindi il pensiero atomistico di Democrito. Lucrezio canta gli atomi, il mare, la natura, il cielo. C’è il senso di una profonda unità delle cose che nasce dal sapere che siamo fatti della stessa sostanza delle stelle:
«…siamo tutti nati dal seme celeste, tutti hanno quello stesso padre dal quale la madre terra riceve gocce limpide di pioggia, e quindi brulicante produce il frumento, e gli alberi, e la razza umana, e le bestie selvatiche, offrendo il cibo con cui tutti nutrono i loro corpi per condurre una vita dolce e generare la prole….»

RADICI: La scuola di Mileto
C’è l’idea che il moto casuale delle particelle microscopiche sospese in un fluido sia dovuto agli atomi che vibrano (questa idea sarà usata da Einstein per calcolare la dimensione degli atomi):
«….se guardi con attenzione un raggio di sole che entra per un piccolo foro in una stanza buia, vedrai lungo la via luminosa muoversi tanti piccoli corpi, che si scontrano, si avvicinano si allontanano, senza sosta. Da questo puoi dedurre come si muovono gli atomi nello spazio….Fai bene attenzione, i corpuscoli che vedi vagare e mescolarsi nel raggio di sole mostrano che la materia sottostante ha moti impercettibili e invisibili: infatti puoi vedere che i corpuscoli spesso cambiano direzione e sono sospinti indietro, ora di qua ora di la, ora in alto ora in basso, in ogni direzione. Questo avviene perché gli atomi si muovono in modo autonomo e le cose piccole vengono urtate dagli atomi e il loro moto è determinato da questi urti…..

RADICI: La scuola di Mileto
• C’è l’idea di pensare il mondo in termini semplici. Di poter indagare e capire i segreti della natura. E ci sono strumenti concettuali sui quali costruiranno Galileo, Keplero e Newton: l’idea del moto libero e rettilineo nello spazio, l’dea dei corpi elementari e delle loro interazioni, l’idea dello spazio come contenitore del mondo.
• Il testo di Lucrezio, dimenticato per secoli, fu ritrovato nel 1417 ed ebbe un effetto profondo nel Rinascimento italiano ed europeo ed è richiamato da autori che vanno da Galileo a Keplero, da Bacone a Macchiavelli fino a Newton, Dalton, Darwin e Einstein. Il mondo di Democrito cantato da Lucrezio fu combattuto dalla Chiesa, ne fu proibita la lettura nelle scuole e nel 1551 il Concilio di Trento mise al bando l’opera di Lucrezio. Ma era troppo tardi. Una intera visione del mondo, spazzata via dal pensiero aristotelico medioevale, si riproponeva all’Europa avviando una rivoluzione scientifica senza precedenti.

RADICI: La fisica aristotelica
Per Aristotele la fisica funzionava più o meno così.
Il cosmo
• L’Universo si compone di 8 sfere celesti concentriche che reggono le stelle fisse e i 7 pianeti noti nell’antichità (dall’esterno all’interno: Stelle, Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna). Al centro delle sfere celesti, e quindi del mondo, è posta la Terra (geocentrismo).
• La sfera della Luna separa il mondo celeste, perfetto e incorruttibile (cioè, non soggetto a mutamento), da quello terrestre (sub-lunare), imperfetto e corruttibile, cioè soggetto a mutamento). La Terra è dunque al centro del mondo, ma ne è anche il punto più basso e lontano dalla perfezione.

Terra
Fuoco
Aria
Acqua
RADICI: La fisica aristotelica
La materia
• Tutto il mondo è pieno di materia: lo spazio vuoto non esiste (’la natura ha orrore del vuoto’, horror vacui.)
• Il mondo terrestre (sub-lunare) è composto di 4 elementi (essenze), che tendono a disporsi secondo quattro sfere concentriche (i loro «luoghi naturali»), la terra in basso, l’acqua un po più su, l’aria ancora più su, e il fuoco ancora più su. Quando lanciamo un sasso in aria questo ricade perché tende a ritornare al suo luogo naturale, la terra. Invece le bolle d’aria o il fuoco vanno verso l’alto, sempre per andare nei loro luoghi naturali.
• Il mondo celeste è interamente composto di etere (quinta essenza), incorruttibile per natura. Esso costituisce le sfere celesti e riempie anche lo spazio tra di esse.

1. RADICI: La fisica aristotelica
Il movimento
I moti celesti sono perfetti e immutabili, senza inizio né fine: i moti circolari uniformi (cioè a velocità costante) della rotazione delle sfere celesti. Tutti i moti celesti sono originati da un’unica causa: il motore immobile (la causa prima), che muove direttamente la sfera delle stelle fisse (la più veloce); da essa il moto di rotazione si trasmette di sfera in sfera, diminuendo però progressivamente di velocità.
• I moti sub-lunari
Nel mondo sub-lunare invece i moti sono imperfetti, hanno un inizio e una fine, e si distinguono in naturali e violenti.
oMoti naturali: sono quelli dovuti alla natura del corpo, che tende a raggiungere la propria sfera cadendo (corpi pesanti: terra, acqua) o salendo (corpi leggeri: aria, fuoco). La velocità di caduta è direttamente proporzionale al peso del corpo e inversamente proporzionale alla densità del mezzo (nel vuoto sarebbe infinita→impossibilità del moto nel vuoto).

RADICI: La fisica aristotelica
oMoti violenti: sono quelli causati da una vis (forza), alla quale è direttamente proporzionale la velocità.
Il moto dei proiettili o di una freccia (corpi lanciati) pongono un problema : se l’effetto è proporzionale alla forza, come può il moto continuare per un certo tempo dopo che la forza che lo produce è già cessata? Aristotele ritiene che l’aria agisca come motore congiunto: sospinta dal corpo che la attraversa essa a sua volta lo sospinge da dietro (ecco perché è impossibile il moto nel vuoto!).
Non è fisica sbagliata, come spesso si dice, è solo approssimata. Anche la fisica di Newton è approssimata rispetto alla teoria della relatività. La fisica di Aristotele è coerente e in grado di fare previsioni qualitative, ma èqualitativa, non fa calcoli né sperimentazione, ed è finalistica, cioè assume che le cose accadono in natura per una finalità, oppure in termini di bene e male, confondendo questioni etiche/umane con questioni scientifiche. Questo schema di pensiero si sarebbe rivelato molto inefficace per capire la natura, e non è esagerato dire che ha frenato il progresso scientifico per cica 15 secoli.

I Numeri
GEN
ERA
LIZZAZIO
NE
In matematica e fisica non si manipolano numeri ma simboli o variabili presi dall’alfabeto greco e latino.𝒂𝒃 = 𝒄 ; 𝒂 + 𝒃 = 𝒄 ; 𝒂 − 𝒃 = 𝒄 ; 𝒂/𝒃 = 𝒄 ; Significano che per qualunque a e b reali si ha un certo c ancora reale.
Ricordiamo che valgono le regolette seguenti:𝒂𝒃 = 𝒃𝒂; 𝒂 + 𝒃 = 𝒃 + 𝒂; 𝒂(𝒃 ± 𝒄) = 𝒂𝒃 ± 𝒂𝒄NB : ricordiamo che a e b sono numeri reali, e quindi con segno, cioè : 𝒂 = ±𝑎 ; 𝒃 = ±𝑏 ; 𝒄 = ±𝑐
𝒚 = 𝒌𝒙 significa che un qualsiasi numero 𝒙moltiplicato per un qualsiasi numero costante 𝒌 è uguale ad un certo numero 𝒙. Se sono assegnati 𝒚 e 𝒌, poso ricavare 𝒙 = 𝒚/𝒌.
y = 𝒙𝒏 elevamento a potenza (NB: 𝒙𝟎 = 1)
𝒚 = 𝒙 si può fare solo co 𝒙 ≥ 𝟎 (si può fare con 𝒙 < 𝟎 estendendo il campo dei numeri reali a quelli immaginari, ma soprassediamo)
y = x/0 =∞ (ma NON si può fare in aritmetica)
Con solo 10 numeri noi possiamo contare (misurare) fino a quantità piccolissime (scala atomica) o grandissime (scala cosmica). Grazie a Babilonesi, Maya e Indiani che nell’arco di oltre 2000 anni hanno inventato lo Zero e il sistema decimale posizionale.Provate a fare una banale somma con i numeri romani365+ CCCLXV per non parlare di divisioni e 651 DCLI moltiplicazioni.1016 MXVI
NATURALI
INTERI
RAZIONALI
REALI

La rivoluzione scientifica : LA MATEMATICA
Nel Rinascimento si passa dalla tradizione filosofica aristotelica alla scienza moderna. Ciò che la distingue è il suo carattere quantitativo e oggettivo (i corpi cadono a causa dell’attrazione terrestre) in contrapposizione con il carattere qualitativo e finalisticodella scienza aristotelica (i corpi cadono al fine di ritornare nei loro luoghi naturali). La matematica diventa indispensabile per la quantificazione dei fenomeni naturali. L’uso della matematica è spinto da un imponente lavoro di traduzione in latino dei testi classici (Euclide, Archimede, Platone..) che arrivano in europa dopo la caduta di Costantinopoli (1453).
Il contributo più importante viene da Platone (427-347 a.c.). La scoperta dell’importanza teorica della matematica è di Pitagora (580 a.c.) ma è Platone che fece della matematica il linguaggio adatto per capire e descrivere il mondo. Fu Platone che pose la domanda fatale dalla quale sarebbe emersa la scienza moderna. Egli chiese ai suoi discepoli che studiavano matematica di scovare le leggi che consentono di descrivere e soprattutto di predire i moti dei pianeti. L’esercizio iniziato da Eudosso, e sviluppato nei secoli successivi da Aristarco (disse che la terra si muove intorno al sole e che dista da esso 19 distanze lunari :sono 20!!)
e Ipparco portò l’astronomia antica ad un livello altissimo.
Noi la conosciamo grazie ad un unico libro rimasto : l’Almagesto di Tolomeo, vissuto ad Alessandria nel I secolo d.c., quando la scienza era in declino, travolta dal crollo del mondo ellenistico. Un libro rigoroso, preciso, complesso, capace di descrivere e prevedere con grande precisione i moti apparentemente disordinati (a causa dell’ipotesi Geocentrica) dei pianeti.
La scuola di AteneRaffaello
Il modo delle idee vs il mondo reale nella
ricerca della conoscenza

Prendiamo due assi reali e disponiamoli come in figura. Questo è un sistema di assi cartesiani. Quello orizzontale si chiama ascissa (x) e quello verticale ordinata (y). Un generico punto del piano è rappresentato da una coppia di numeri (𝑥, 𝑦). Per esempio, abbiamo definito 4 punti. Attenzione! Per ogni valore di 𝑥, sono io che scelgo un qualsiasi valore di 𝑦. MA se accade che i valori di 𝑦 dipendono, in qualche modo, dai valori di 𝑥, cioè se fissata la 𝑥 resta determinato uno ed un solo valore di 𝒚, allora si dice che y è funzione di x, e si scrive y=f(x). Questo è un modo simbolico di dire che y è funzione di 𝑥, oppure che 𝑦 dipende da 𝑥. Per ‘’vedere’’ e lavorare con la funzione, occorre definire ‘’in qualche modo’’, cioè stabilire una regola, o funzionetale che, fissato un 𝒙 si può calcolare il corrispondente valore di 𝒚. Per esempio, la regola più semplice è: per
ogni valore 𝒅𝒊 𝒙, 𝒚 = 𝒙. Con questa regola si può rappresentare sul piano cartesiano la funzione con il suo grafico.Per un certo numero di valori 𝒙, si calcolano i corrispondenti 𝒚 con la regola. Si riportano sul piano i punti individuati da ciascuna coppia (𝑥, 𝑦) e si uniscono i punti con una curva.
Le Funzioni
X -3 +1 +3
Y -3 +1 +3
primo quadrante
quarto quadranteterzo quadrante
secondo quadrante
Regola o funzione : y = x

Alcune funzioni importanti
0; 0
3; 3
4; 4
6; 6
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5 6 7x
y
𝑦 = 𝑘𝑥
𝑦 = 𝑘𝑥²
𝑦 = 𝑘/𝑥
E’ la funzione lineare. Faccio il grafico. Scelgo io una serie di valori 𝑥 e per ognuno calcolo la 𝑦 (vedi tabella). Ad ogni coppia corrisponderà un punto sul piano cartesiano. Unisco i punti con una curva. NB: per semplicità ho scelto 𝑘 = 1
E’ la funzione quadratica (o parabolica)Idem c.s. per il grafico
E’ la funzione inversa (o iperbolica)Idem c.s. per il grafico
x y0 0
3 3
4 4
6 6
x y0 0
1 1
2 4
3 9
4 16
0; 01; 1
2; 4
3; 9
4; 16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
x
y
x y0,05 20
0,1 10
0,2 5,00
0,3 3,33
0,5 2
0,05; 20
0,1; 10
0,2; 5,00
0,3; 3,33
0,5; 2
0
5
10
15
20
25
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6X
y