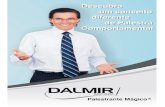sentenza 17 maggio 1983 (causa 168/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Reischl (concl. conf.);...
-
Upload
giuseppe-tucci -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
Transcript of sentenza 17 maggio 1983 (causa 168/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Reischl (concl. conf.);...

sentenza 17 maggio 1983 (causa 168/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Reischl (concl.conf.); CECA c. Fall. soc. Sant'AnnaAuthor(s): Giuseppe TucciSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 12 (DICEMBRE 1983), pp. 403/404-409/410Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176968 .
Accessed: 24/06/2014 20:14
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.2.32.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:14:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE QUARTA
c) Frais et dépens afférents au recours du 24 novembre 1975 au
Tribunal fédéral
50. - Le recours incident du 24 novembre 1975 au Tribunal
fédéral, lui, visait la recevabilité de la plainte et son renvoi devant la Cour d'assises (paragraphe 11 ci-dessus). Il ne se
rapportait done en rien aux décisions relatives à la répartition des frais et son but ne consistait ni à empécher la violation de
l'article 6 par. 2 ni à y remédier. La Cour en déduit, avec le
Gouvernement, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux frais et
dépens correspondants (1.279 FS au total, d'après M. Minelli).
2. Frais et dépens supportés à Strasbourg
51. - Le requérant, qui n'a pas bénéficié de l'assistance judi ciaire gratuite devant la Commission ni auprès du délégué de celle-ci devant la Cour, réclame 2.400 FS pour frais d'avocat et 400 FS pour dépenses personnelles, ainsi que 1.560 FS pour manque à gagner.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des honoraires versés par l'intéressé à Me Kuhn, ni de leurs frais de
voyage et de séjour à tout deux. Il laisse à la Cour le soin d'en arrèter le taux sur la base des preuves que pourrait apporter M. Minelli.
52. - Devant la Cour, le requérant a en personne assistè le
délégué de la Commission; les frais d'avocat en question ne concernent done que la procédure suivie devant cette dernière. La Cour ne juge pas nécessaire de se procurer des pieces justificatives car elle estime plausibile et raisonnable le montant de 2.400 FS.
Cette remarque vaut aussi pour les 400 FS demandés au titre
des frais de voyage et de séjour de l'intéressé à Strasbourg. La
présence de M. Minelli devant la Commission, et plus encore
devant la Cour puisqu'il a comparu lui-mème à l'audience du 26
octobre 1982, offrait une utilité réelle vu la nature de l'affaire
(voir notamment, mutatis mutandis, l'arrèt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere, précité, sèrie A n. 54, p. 11, par. 25). En revanche, il échet d'écarter la pretention relative au man
que à gagner (1.560 FS), comme la Cour l'a déjà fait pour la
procédure devant le tribunal de district et la Cour d'assises
(paragraphe 48 ci-dessus).
Par ces motifs, la Cour, a l'unanimité
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention; 2. Rjetant le demande de satisfaction équitable pour le surplus,
dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant huit mille six cent soixante-huit francs suisses soixante-cinq (8.668 FS 65) pour frais et dépens.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 17 maggio 1983 (causa 168/82); Pres. Mertens de Wil
masrs, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); CECA c. Fall. soc.
Sant'Anna.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Comunità europee — CBE — Corte di giustizia — Questioni pre
giudiziali — Validità di deliberazione della Commissione (Trat tato CECA, art. 41, 49, 50, 92).
Comunità europee — CECA ■— Diritti di prelievo — Privilegi.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente in
via pregiudiziale, a norma dell'art. 41 del trattato CECA, a
giudicare della validità della deliberazione della Commissione
delle Comunità europee, per la quale si afferma la natura
previlegiata dei diritti di prelievo della CECA e si ritengono
opponibili tali cause di prelazione ai creditori di un'impresa
fallita. (1) In mancanza di una specifica norma del diritto comunitario, i
diritti di prelievo della CECA non godono dei privilegi rico
nosciuti ai crediti fiscali dello Stato italiano. (2)
(1-2) Sul significato dell'art. 41 trattato CECA, v. Cass. 13 maggio 1972, n. 2707, foro it., 1972, I, 2775. iPer la competenza in via pre giudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee, v. Corte
giust. 14 febbraio 1980, causa 53/79, id., 1980, IV, 416, con riferi mento alla competenza in via pregiudiziale ex art. 177 del trattato OEE. Sul punto, in dottrina, v. Monaco, La Corte di giustizia, in Manuale di diritto comunitario, a cura di Pennacchini, Monaco, Fer
rari-Bravo, ìPuglisi, Torino, 1983, I, 167 ss.; Grementieri, Il pro
Diritto. — 1. - Con ordinanza 22 aprile 1982, pervenuta alla corte il 14 giugno 1982, il Tribunale di Milano, a norma dell'art. 41 del trattato CECA, ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità della decisione della Commis sione 10 dicembre 1981 n. 1887, nella parte in cui, nell'art. 2, stabilisce che i crediti della CECA verso la società Ferriere Sant'Anna s.p.a. sono crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello iStato.
cesso comunitario, Milano, 1973, 93 ss.; Ferrari-Bravo, Corte di giu stizia, in Commentario, diretto da Quadri, Monaco, Trabucchi, Mi lano, 1970, I, 508 ss.
Con riferimento allo specifico problema affrontato nella sentenza, già Cass. 7 gennaio 1971, n. 2, Foro it., 1971, J, 29, ha affermato che i prelievi, disposti dalla CECA, per scopi d'interesse generale a carico delle imprese, non sono assistiti dai privilegi previsti per i tributi dello Stato italiano. Per le precedenti fasi di merito, v. App. Torino 17 maggio 1969, id., 1969, I, 3294 e Trib. Torino 10 maggio 1963, id., 1963, I, 2052. In dottrina, v. Tesauro, Il finanziamento delle or ganizzazioni internazionali, Napoli, 1969, 191 ss.; .Id., Sulla natura giuridica del prelievo CECA, in Rass. dir. pubbl., 1972, 221 ss.
Per l'operatività del principio di non discriminazione nel diritto comunitario, v. Corte giust. 3 luglio 1979, cause riun. 185-204/78, Foro it., 1980, IV, 57; 5 marzo 1980, causa 265/78, id., 1981, IV, 120; 27 marzo 1980, cause riun. 66, 127-128/79, id., 1981, IV, 118, e in Dir. e pratica trib., 1981, II, 209, con nota di Muratori.
♦ ♦ *
Diritti di prelievo della CECA e privilegi fiscali dello Stato.
1. - La decisione qui riportata della. Corte di giustizia delle Comunità europee si inserisce nel contesto della crisi del settore
siderurgico, che ha attirato l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica per le divisioni manifestatesi tra i diversi Stati europei di fronte alle decisioni degli organi comunitari.
Nel caso di specie, il problema affrontato non riguarda l'oggetto diretto dell'attuale tensione tra il nostro paese e la CECA, cioè gli ampi poteri di intervento riconosciuti alla Comunità con il trattato istitutivo del 1951 in caso di crisi del settore (1).
Esso però si riferisce ad un problema ricorrente nel dissesto delle
imprese siderurgiche, cioè alla natura giuridica ed all'eventuale con
seguente privilegio da riconoscere in sede di procedure concorsuali ai diritti di prelievo della C5ECA, previsti dall'art. 49 del trattato istitutivo della Comunità i(2).
La norma sopra citata del trattato, posta ad apertura del capitolo secondo, destinato alle disposizioni finanziarie, stabilisce che l'alta autorità — ora la Commissione — lè abilitata a procurarsi i fondi necessari per realizzare i suoi compiti stabilendo prelievi sulla
produzione del carbone e dell'acciaio, secondo criteri stabiliti dal n. 2 del successivo art. 50 dello stesso trattato i(3).
II n. 1 dell'art. 50 stabilisce i fini ai quali i prelievi sono de
stinati, sicché, dalle modalità di determinazione e dalle ragioni per le quali le somme sono riscosse, risulta chiara la loro natura di tributi, espressamente previsti dall'ordinamento comunitario attraverso il riconoscimento di una vera e propria potestà tributaria dell'ente che li determina e li riscuote (4).
In base alla sopra indicata natura tributaria, la CECA ha varie volte rivendicato, a tutela dei crediti di prelievo, gli stessi privilegi previsti dalla legislazione dello Stato in cui il procedimento esecutivo si attua per i crediti tributari dello Stato. Ma già i nostri giudici di merito e la Corte di cassazione, come si è detto, hanno dato alla
pretesa una risposta negativa con argomenti simili a quelli usati dalla Corte di giustizia nella sentenza in epigrafe (5).
(1) La controversia, per il suo significato politico, ha attirato l'attenzione della stampa specializzata. Di recente, v. L'Europa sempre più divisa sul « caso » acciaio, in II Sole - 24 Ore del 27 settembre 1983. Sui poteri degli organi comunitari, in presenza dello stato di crisi manifesta del settore di cui all'art. 39 del trattato v. Heusdens, De Horn, Crisis Policy in the European Steel Industry in the Light of the ECSC Treaty, in Common Market Law Review, 1980, 31 ss., e, per il fondamento solidaristico dell'intervento anti-crisi nel settore siderurgico, v. Corte giust. 18 marzo 1980, cause riunite 154, 205-206 e 226-228/78, Riv. dir. europeo, 1980, 101.
(2) ili problema è stato affrontato nella nostra giurisprudenza in occasione della controversia Comunità economica del carbone e del l'acciaio (CECA) c. S.r.l. Officine Elettromeccaniche ing. A. Merli ni. A riguardo v. Cass. 7 gennaio 1971, n. 2, Foro it., 1971, I, 29; App. Torino 21 marzo-7 maggio 1969, id., 1969, I, 3294; Trib. Torino 10 maggio 1963, id., 1963, I, 2052 e in Giur. it., 1964, I, 2, 11, con nota di Berri, Questioni sul diritto a privilegio dei crediti
della CECA per i suoi tributi. Sullo stesso argomento v., anche, Allorio, Intorno alla natura dei prelievi generali effettuati dalla CECA e dei suoi prelievi spettanti a quest'ultima, in Riv. dir. fin., 1964, ili, 3 ss.; Saulle, Sulla natura giuridica dei crediti spettanti alla CECA a titolo di prelievo generale, in >Riv. dir. internaz., 1965, 634 ss.
<3) Per i criteri di determinazione dei prelievi, v. Monnary, Dispo sizioni finanziarie, in Commentario al trattato istitutivo della CECA, diretto da Quadri, Monaco, Trabucchi, Milano, 1970, II, 660 ss.
(4) La natura di tributi dei prelievi CECA e la loro assimilazione alle imposte dirette è messa in rilievo da App. Torino 21 marzo 1969, cit., e, in dottrina, da Berri, op. cit., 15. »
(5) V. nota n. 2.
This content downloaded from 185.2.32.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:14:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
2. - La questione è stata sollevata nell'ambito della controversia
relativa all'iscrizione, come credito privilegiato, al passivo del
fallimento della società Ferriere Sant'Anna s.<p.a. — fallimento
aperto il 14 maggio 1980 dal Tribunale di Milano — della
somma di lire 27.383.405 dovuta da detta società alla CECA a
titolo di prelievi sulla produzione d'acciaio e di maggiorazioni
per il ritardato pagamento degli stessi.
La questione non è pertanto nuova. Originale è invece la prospetti va nella quale si muove la decisione della Corte di giustizia, poiché essa opera come organo giurisdizionale sovranazionale, espressione di un ordinamento autonomo e diverso da quello dei singoli Stati, sicché i problemi relativi al principio del concorso dei creditori e delle eventuali cause di prelazione viene esaminato con riferimento al diritto
applicabile da parte di tale organo giurisdizionale (6).
2. - La controversia che ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di
un'impresa, esercente attività produttiva nel settore dell'acciaio, secon do il disposto dell'art. 80 del trattato.
La CECA comunica alla curatela fallimentare l'importo di un
credito, maturato nei confronti dell'impresa fallita a titolo di prelievo ex art. 49 e 50 del trattato e dalla stessa non pagato, oltre gli interessi di mora, chiedendone l'inserimento nello stato passivo del fallimento come credito privilegiato, in base all'art. 93 1. fall. (7).
di giudice delegato, facendo proprio come si è detto, un orientamen to già manifestato dalla nostra giurisprudenza, ammette il credito allo stato passivo, ma solo in via chirografaria, sicché la CECA propone opposizione a norma dell'art. 98 1. fall. (8).
Nel contesto della normale controversia fallimentare interviene però un fatto anomalo, che modifica i termini della lite.
Mentre è ancora in corso il procedimento di opposizione, la CECA
adotta una decisione, che notifica regolarmente alla società fallita. Con
tale decisione, dopo aver determinato i prelievi ed i relativi interessi di mora, si decide in pratica sulla controversia pendente davanti al
tribunale fallimentare, poiché si qualificano i crediti relativi come
privilegiati ed eguali per rango ai crediti dello Stato della stessa natura.
Sulla base della sopra indicata decisione, la CECA chiede di nuovo
al tribunale fallimentare l'ammissione del credito di prelievo in via
privilegiata e, in subordine, in caso di mancato accoglimento della
domanda, il rinvio alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ex art. 41 del trattato CECA, per ottenere pronuncia sulla validità della decisione presa (9).
ili Tribunale di Milano rigetta la domanda principale, osservando che solo un'inammissibile interpretazione analogica delle norme che
istituiscono i privilegi, rispettivamente, a tutela dei crediti per tributi diretti dello Stato (art. 2752 c.c.) e dei crediti per le imposte sul
reddito (art. 2759 c.c.), potrebbe attribuire, contro il divieto dell'art.
14 preleggi, anche ai crediti della CECA lo stesso rango privilegiato riconosciuto ai crediti dello Stato i( 10).
Il tribunale fallimentare, inoltre, affronta il problema sopra indicato anche sotto il profilo del diritto comunitario, ritenendo che nemmeno all'interno di tale ordinamento esistono norme attributive di uno
specifico privilegio ai crediti di prelievo vantati dalla CECA, salvo a riconoscere natura costitutiva proprio alla decisione emessa dalla OECA in pendenza della controversia fallimentare in esame. Sicché, sulla base di tali presupposti, il tribunale fallimentare sottopone alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale relativa alla validità della decisione sopra indicata, nella parte in cui sancisce che i crediti vantati dalla CECA nei confronti della società fallita, a titolo di
prelievo, e di conseguenti interessi, siano da considerare privilegiati e di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato.
3. - La validità della decisione adottata dalla Commissione nel suo art. 2, cioè nella parte in cui stabilisce per i crediti vantati dalla
CECA, il tipo di prelazione sopra specificato, viene valutata dalla corte alla stregua di quelli che sono i compiti istituzionali suoi propri,
'(6) Per la particolare funzione giurisdizionale della corte, v. di recente, Monaco, La Corte di giustizia, in Manuale di diritto comu nitario, a cura di Pennacchini, Monaco, Ferrari - Bravo, Puglisi, Torino, 1983, I, 151 ss. ed ivi bibliografia.
(7) La determinazione del credito con riferimento agli interessi di mora è ampiamente trattata in App. Torino 21 marzo 1969, cit., ed ivi specificazione sia del procedimento attraverso il quale l'alta autorità — ora Commissione — può applicare sanzioni in caso di ritardo, sia delle eventuali garanzie giurisdizionali ex art. 38 del trattato.
(8) Già in tale momento della controversia la CECA rivendica la natura privilegiata del credito, proponendo opposizione per il mancato riconoscimento del privilegio. 'Per la configurazione dell'opposizione allo stato passivo come sviluppo, in sede contenziosa, della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, v. Cass. 15 giugno 1981, n. 3871, Foro it., Rep. 1982, voce Fallimento, n. 443.
(9) Tale strategia ha fatto ritenere, nel corso del dibattimento, che la Commissione avesse voluto attribuire valore costitutivo del privile gio alla sua decisione. In realtà la presenza della decisione ha legit timato il rinvio alla corte ex art. 41 del trattato CECA.
(10) Sul divieto di interpretazione analogica delle norme istitutive di privilegi l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza è costante. V. per tutti Andrioli, Dei privilegi, in Commentario, a cura di Seiai.O[a e Branca, Bologna-Roma, 19582, 61.
In giurisprudenza v. la già citata Cass. 7 gennaio 1971, n. 2, Foro it., 1971, I, 32.
3. - Dopo la dichiarazione di fallimento della società, la
Commissione, con lettera 19 novembre 1980, ha comunicato al
curatore l'importo del suo credito chiedendo che lo stesso fosse
considerato come credito privilegiato. 4. - Con decisione del giudice delegato 20 maggio 1981, il
credito della CECA è stato ammesso al passivo del fallimento
solo in via chirografaria.
precisati dall'art. 31 del trattato CECA, ripreso poi dall'art. 164 del trattato CEE(ll).
Proprio il tipo di valutazione sopra indicato costituisce, come già si è detto, l'aspetto più significativo della decisione che si riporta e la ragione di interesse della stessa per lo studio del diritto dei pri vilegi (12).
Presenta, invece, un interesse minore l'altro problema, sollevato da diverse parti per contrastare la stessa ammissibilità delle questioni pre giudiziali proposta ex art. 41 del trattato CECA, riguardante la na tura dichiarativa e non costituiva della decisione impugnata.
Dato il contenuto individuale della decisione adottata, è evidente che essa, come ha chiarito la stessa Commissione nel corso del
dibattimento, non poteva non avere valore dichiarativo, dovendosi dedurre il carattere privilegiato del credito ed il suo stesso grado non
già dalla decisione della Commissione, ma dai principi e dalle norme del diritto che la corte è stata chiamata ad applicare (13).
Nella su indicata prospettiva, risulta evidente, come precisa la
corte in motivazione, che il carattere privilegiato dei crediti di
prelievo non può assolutamente dedursi dalla normativa prevista in sede di trattato CECA.
Da tale normativa, infatti, risulta chiara in primo luogo la natura fiscale dei prelievi, poiché essi sono istituiti nell'esercizio di un potere di imposizione sulla produzione del carbone e dell'acciaio, riconosciu to all'alta autorità dal trattato CECA — ora, alla Commissione —
al fine di procurarsi direttamente, come precisa l'art. 49, i fondi necessari per compiere la sua missione.
Inoltre, il contenuto della disciplina previsto in sede di trattato (v., anche, art. 50, n. 2) e l'intervento della nostra Corte di cassazione hanno precisato che il potere di imposizione riconosciuto alla CECA deve considerarsi potestà fiscale autonoma e non già un potere delegato dagli Stati alla Comunità. Naturalmente, essendo i prelievi stabiliti in relazione al valore medio del prodotto d'impresa {art. 50, n. 2, e art. 49), appare corretta la loro qualificazione in termini di imposta diretta o di imposta sul reddito d'impresa, a voler estendere a tali imposte, proprie dell'ordinamento comunitario, una terminologia elaborata nell'ambito del nostro ordinamento statale e riproposta nella materia dei privilegi <14).
Dalla normativa del trattato CECA, infine, risulta una particolare disciplina della realizzazione dei diritti in esame. Ciò in quanto l'art. 92 sancisce che le decisioni istitutive dei prelievi, comportando degli obblighi pecuniari a carico delle imprese, costituiscono titolo esecutivo all'interno degli Stati membri, con il solo limite della verifica dell'au tenticità di tali decisioni (15).
(11) A riguardo v. da ultimo Monaco, La Corte di giustizia, in Manuale di diritto comunitario, cit., 156 ss., e ampiamente Tizzano, La Corte di giustizia delle Comunità europee, Napoli, 1967, 31 ss.
(12) Anche con riferimento ai principi comuni del diritto interno degli Stati membri si realizza il ruolo unificatore della Corte di giustizia delle Comunità. V. a riguardo Cappelletti, Giustizia costi tuzionale soprannazionale, in Riv. dir. proc., 1978, 12 ss.; Tizzano, La Corte di giustizia delle Comunità europee, cit., 41 ss.
(13) La natura dichiarativa della decisione 10 dicembre 1981, con particolare riferimento all'art. 2, è stata espressamente precisata dalla Commissione su invito della corte, come risulta dalla motivazione della sentenza. Per la natura generale o individuale delle deci sioni dell'alta autorità (ora Commissione), secondo una distinzione deducibile dall'art. 15, 2° e 3° comma, del trattato CECA, v. Pocar, Lezioni di diritto delle Comunità europee, cit., 16 ss. Con riferimento all'oggetto della valutazione in via pregiudiziale, ex art. 41 del trattato CECA, v. Ferrari - Bravo, Corte di giustizia, in Commentario, diretto da Monaco, Quadri, Trabucchi, Milano, 1970, I, 508 ss., e, in relazione all'art. 177 del trattato CEE, Grementieri, Problemi attuali della pregiudiziale comunitaria, in L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano, a cura di Cappelletti e Pizzorusso, Milano, 1982, 461 ss.; Bonifazi, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Riv. dir. internaz., 1964, 581 ss.
(14) Sulla natura non delegata dalla potestà fiscale, di cui è titolare la CECA, come ente autonomo di diritto internazionale, insiste partico larmente Cass. 2/71. In argomento, in dottrina, v. Tesauro, Sulla natura giuridica del prelievo CECA, cit.; Fois, Questioni sul « tra sferimento » alla CECA di poteri statali in materia tributaria, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1972, 246 ss., e di recente Pennac chio, Il sorgere dell'Europa comunitaria, in Manuale di diritto comu nitario, cit., 15 ss.; Zaccaria, Finanziamento e bilancio, ivi, 347.
(15) Grazie al meccanismo previsto dall'art. 92 del trattato CECA ratificato per l'Italia con la 1. 25 giugno 1952 n. 766, la legge attribuisce alle decisioni l'efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c. Osserva a riguardo Trib. Torino 10 maggio 1963, cit., che «l'im mediata esecutività delle decisioni impositive è chiara manifestazione del potere tributario di cui è titolare la Comunità, non potendo altro ve rinvenirsi il fondamento di simile effetto. Dall'altra parte — os serva ancora il tribunale — non avviene nemmeno nulla di assimi labile al procedimento di delibazione delle sentenze straniere, ma l'ap posizione della formula esecutiva consegue necessariamente in via am ministrativa, dal mero accertamento dell'autenticità, cioè dalla esi stenza, come tale, della decisione ». Per l'efficacia delle decisioni v.
This content downloaded from 185.2.32.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:14:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE QUARTA
5. - Il 29 giugno 1981, la Commissione, a norma dell'art. 98 1. fall, italiana, ha proposto opposizione avverso la decisione del giudice delegato e ha chiesto al tribunale di riconoscere carattere
privilegiato al suo credito o, in subordine, di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
6. - In pendenza del procedimento introdotto a norma dell'art. 98 summenzionato, la Commissione, in forza degli art. 49 e 50 del trattato CECA, ha adottato una decisione individuale destina
4. - La speciale e privilegiata disciplina esecutiva configurata dall'art. 92 del trattato CECA, non implica però il riconoscimento di alcun privilegio o di alcuna causa di prelazione ai diritti di prelievo in sede espropriativa, allorché essi concorrono con gli altri crediti vantati nei confronti dell'impresa fallita.
La consapevolezza della carenza di una disposizione normativa, idonea a giustificare il rivendicato privilegio del credito, ha indotto la difesa della Commissione, per ottenere il medesimo risultato, a far ricorso ai principi generali di eguaglianza e di non discriminazione, cosi come sono stati elaborati dalla stessa giurisprudenza della corte (16).
Il precedente più significativo, citato a sostegno della tesi sopra riferita, riguarda un caso in cui i principi di eguaglianza e di non discriminazione sono ribaditi in relazione al sistema generale delle disposizioni finanziarie del trattato OBE. In esso si afferma che l'ordinamento giuridico interno di ciascuno degli Stati membri, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, deve prevedere le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari in generale e dei prelievi agricoli in particolare, designando altresì le autorità incaricate della riscossione ed il giudice competente a cono scere delle controversie relative (17).
Tutte le modalità e le condizioni — precisa ancora la corte ■—■ devono essere tali da rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari efficaci allo stesso modo di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo. Dai principi su indicati la corte deduce che non sarebbe conforme al diritto comunitario una normativa nazionale speciale, riguardante la riscossione delle tasse e degli oneri comunitari, che attribuisse all'amministrazione nazionale, per riscuotere le dette tasse, poteri più limitati di quelli alla stessa attribuiti per riscuotere tasse o oneri nazionali di eguale tipo (18).
Dalla giurisprudenza della corte sopra riportata e da altri casi egualmente pertinenti alla materia trattata, anche se meno significativi, non è possibile desumere che i diritti di prelievo, previsti dagli art. 49 ss. del trattato CECA, si possano considerare privilegiati allo stesso grado dei tributi diretti dello Stato (19).
Innanzitutto, si deve ricordare che quei principi, sanciti dalla corte, e le conseguenze relative, riguardano risorse della Comunità la cui riscossione rimane sempre prerogativa dei singoli Stati membri, ma non è affidata alle istituzioni comunitarie (20).
Quello su indicato è chiaramente il caso dei prelievi agricoli, ai
quali si riferisce il precedente della corte. Ma ciò vale anche per i dazi doganali, per i quali l'assimilazione con gli eguali crediti dello Stato è prevista espressamente da una specifica norma di legge, come avviene per l'Italia con il t.u. in materia doganale (21).
il diritti di prelievo CECA, a differenza delle misure fiscali sopr£ indicate, sono riscossi direttamente dagli organi comunitari, sicché a
quel livello — ove si decidesse in tal senso — dovrebbero essere
privilegiati nella procedura esecutiva, nel concorso con gli altri crediti, allo stesso modo in cui l'art. 92 dello stesso trattato CECA li
privilegia nel procedimento di riscossione (22). Jn mancanza di un'esplicita previsione a livello comunitario, istituti
va della causa di prelazione, la corte non può provvedere in via
giurisprudenziale a colmare tale lacuna. Né a risultati diversi si perverrebbe, qualora dall'ordinamento
comunitario, in particolare dai principi di eguaglianza e di non
discriminazione formulati dalla giurisprudenza della corte, si deducesse
in dottrina Cori, Sul concetto di decisione nel trattato della CECA, in Riv. società, 1960, 1177 ss.; Sacchi Morsiani, Il potere amministra tivo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati, Mi
lano, 1965, I, 134 ss.; Tizzano, I procedimenti urgenti nel processo comunitario, in I procedimenti speciali, Napoli, 1979, 376 ss.
(16) Vedi col. 410. (17) Vedi Corte giust. 27 marzo 1980, cause riunite 66, 127 e 128/79,
Foro it., 1981, IV, 118. (18) V. Corte giust. 27 marzo 1980, cit. (19) A sostegno della propria tesi la Commissione ha richiamato
anche Corte giust. 5 marzo 1980, causa 265/78, Foro it., 1981, IV, 120. In essa però l'operatività del principio di uguaglianza nel sistema delle disposizioni finanziarie del trattato CEE è richiamata al fine di
garantire l'esercizio dei diritti individuali derivanti da normative co munitarie.
(20) V., in questo senso, iPocar, Lezioni di diritto delle Comunità europee, cit., 34 ss.; Zaccaria, Finanziamento e bilancio, in Manuale di diritto comunitario, cit., 348.
(21) V. Romoli Venturi, Imposte e tasse (diritto comunitario), voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1982, III, 1289 ss.; Carli, Politica fiscale nella Comunità, europea. La cooperazione delle amministrazioni doganali dei paesi membri, in Fisco, 1981, 4433.
(22) V. a riguardo Emerson, Scott, The Financial Mechanism in the Budget of the European Communities, in Common Market Law Review, 1977, 209 ss. Per il particolare procedimento di esecuzione di cui all'art. 92 del trattato CECA, v. Tizzano, op. cit., 377; Testa, Disposizioni generali, in Commentario, diretto da Monaco, Quadri, Trabucchi, Milano, 1970, II, 1293 ss.; Monaco, Comunità europea carbone e acciaio, voce. dell'Enciclopedia del diritto, 1961, III, 338 ss.
ta alla società Ferriere Sant'Anna s.p.a. L'art. 2 di tale decisione stabilisce che i crediti di cui trattasi « sono crediti privilegiati di
rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato ». A richiesta della Commissione, la decisione è stata munita della formula esecutiva da parte del ministro italiano competente.
7. - All'udienza del 4 aprile 1982, dinanzi al Tribunale di
Milano, la Commissione ha concluso chiedendo, in base alla
suddetta decisione, che il suo credito fosse ammesso in via
un obbligo, per i singoli Stati membri, di privilegiare, con le loro
disposizioni di diritto interno, i diritti di prelievo comunitari negli stessi modi e termini dei crediti dello Stato. Nemmeno tale lacuna, infatti, potrebbe essere colmata dalla giurisprudenza della corte, il cui intervento potrebbe al massimo individuare un obbligo relativo per gli Stati membri della Comunità, non già determinare modi e termini di operatività di una causa di prelazione, per giunta cosi' particolaristica come i privilegi.
5. - Le considerazioni da ultimo svolte richiedono che si prenda in considerazione l'altro profilo esaminato dalla sentenza in esame: quello dei principi generali comuni agli ordinamenti nazionali, operanti nella materia delle procedure esecutive e delle singole cause di prelazio ne (23).
A riguardo è opportuno precisare preliminarmente che un privilegio, in quanto causa legittima di prelazione, può operare all'interno di un
singolo diritto nazionale, anche se è direttamente istituito e disciplina to a livello comunitario.
Contrariamente a ciò che emerge da alcune posizioni prese dal
rappresentante del Regno Unito, il diritto delle cause di prelazione non è prerogativa esclusiva dei singoli diritti nazionali.
L'ordinamento comunitario, come ha istituito prelievi fiscali ed ha previsto specifici procedimenti di realizzazione degli stessi, avrebbe allo stesso modo potuto prevedere alcuni privilegi di esecuzione a tutela di quei crediti, stabilendo anche il relativo grado di priorità. Le eventuali disposizioni in tal senso avrebbero avuto inevitabilmente diretta efficacia nei procedimenti esecutivi, individuali o concorsuali, di diritto interno. E ciò per la generale operatività dell'ordinamento comunitario nei confronti dei singoli diritti nazionali (24).
In mancanza dell'ipotizzata disciplina comunitaria, lo « studio com
parativo dei diritti nazionali », al quale opportunamente si riferisce la corte nella sua motivazione, porta a ritenere che i privilegi, all'interno
degli ordinamenti statali, possono risultare solo da disposizioni spe cifiche e prestabilite, a tutela di determinati crediti fiscali e non del fisco tout court (25).
Come si è in altra sede precisato, la vicenda dei privilegi si
inserisce, nei singoli ordinamenti nazionali, in una storia legislativa
differenziata, spiegabile con le scelte operate dai singoli codici nazio
nali e con l'evoluzione propria degli ordinamenti di common law (26).
Malgrado, però, le differenti storie, i privilegi operano funzionalmente,
nei singoli ordinamenti nazionali, come deroghe al principio generale
dell'eguaglianza dei creditori e quindi richiedono particolari disposizio ni normative che le istituiscano e ne limitino l'efficacia, anche in
termini quantitativi, rispetto alle altre cause di prelazione <27). iPer supplire alla sopra rilevata carenza, l'organo esecutivo comunita
rio ha seguito nel caso di specie la strada dell'assimilazione dei diritti
di prelievo comunitari alle pretese dello Stato, tutelate in via privile
giata dagli art. 2752 e 2759 c.c., che peraltro prevedono un
particolare criterio di determinazione del credito privilegiato, non
applicabile ai prelievi comunitari (28). La scelta sopra indicata richiede necessariamente, in contrasto
con i singoli ordinamenti statali, per i quali le norme istitutive dei
privilegi costituiscono disposizioni eccezionali, l'applicazione analogi
ca delle norme in questione. Si tratta, infatti, di estendere privilegi
previsti per crediti dello Stato a crediti che sono espressione di una
(23) Si è giustamente rilevato che la corte, grazie al riferimento ai
principi generali comuni agli ordinamenti nazionali, integra il corpus del diritto comunitario, ma esercita sugli stessi una fondamentale influenza. V. sul punto Bazoli, Liserre, La Corte comunitaria: un nuovo giudice o una nuova giustizia?, in Dir. scambi internaz., 1981, 740.
(24) Sul problema del c.d. inserimento delle fonti comunitarie nell'ordinamento giuridico italiano, si rinvia a Sperduti, L'ordinamen to italiano e il diritto comunitario, Padova, 1981, 36 ss., 74 ss., nonché a iPizzetti, Efficacia delle norme comunitarie nell'ordinamento italiano, in L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano, cit., 5 ss.
(25) V. la motivazione della sentenza, particolarmente col. 410. È
questo del resto un chiaro esempio del ruolo che può assumere il
giudice comunitario non solo per il confronto tra le esperienze giuridiche dei singoli Stati nazionali, ma per lo sviluppo di un diritto comune europeo. V. Brown, General Principles of Law and the English Legal System, in New Perspectives for a Common Law of Europe, a cura di Cappelletti, Firenze, Bruxelles, Lejden, 1978, 171 ss.
(26) Non a caso il progetto di convenzione sul fallimento, elaborato in sede comunitaria, in deroga al principio dell'unità del fallimento, ha adottato un principio di territorialità, una volta constatata l'impossi bilità di uniformare le norme dei vari Stati in materia di garanzia. V. a riguardo, Gallesio-Piuma, Aspetti sostanziali del progetto di con venzione sul fallimento e sulle altre procedure concorsuali, in L'in fluenza del diritto europeo sul diritto italiano, cit., 361 ss.
(27) V., a riguardo, Tucci, Riforma dei privilegi e finanziamento dell'impresa, in Legisl. economica, 1978-79, 207 ss.
(28) V., in particolare, col. 410.
This content downloaded from 185.2.32.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:14:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
privilegiata e in subordine — in caso di reiezione della domanda
principale — che la causa fosse rimessa alla corte affinché essa, ai sensi dell'art. 41 del trattato CECA, statuisse sulla validità
della decisione stessa.
8. - 11 Tribunale di Milano, a norma del suddetto articolo, ha
proposto alla corte la seguente questione pregiudiziale: « Se la
decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre
1981 n. C (81) 1887 def., sia valida nella parte in cui (art. 2) stabilisce che i crediti della CECA verso la società Ferriere
Sant'Anna s.p.a. (per prelievi CECA e relativi interessi) debbono
essere considerati crediti privilegiati di rango eguale a quello dei
simili crediti dello Stato ».
9. - Invitata dalla corte a precisare, prima dell'udienza, « lo
scopo e la portata della sua decisione 10 dicembre 1981, ed in
particolare dell'art. 2 della stessa, riguardo al procedimento princi
pale », la Commissione ha risposto che « la qualificazione del
credito come privilegiato ha valore dichiarativo e non costitutivo, in quanto il carattere privilegiato deriva dai principi e dalle
norme di diritto comunitario evocati nella memoria della Com
missione ».
10. - Vista tale risposta e le circostanze in cui la decisione di
cui è causa è stata adottata dalla Commissione, il governo del
Regno Unito e la curatela della società Ferriere Sant'Anna s.p.a. hanno messo in dubbio la sussistenza stessa dei requisiti di
applicazione dell'art. 41 del trattato CECA.
Essi hanno osservato in particolare ohe, se lo scopo dell'atto di
cui è causa è solo, come sostiene la Commissione, quello di
dichiarare qual è il diritto comunitario in vigore, tale atto deve
essere considerato come semplice parere della Commissione e non
come vera e propria decisione, ciò che comporta l'incompetenza della corte nel procedimento pregiudiziale previsto dall'art. 41.
11. - Tale tesi non può essere accettata. L'art. 41 del trattato
CECA prevede, infatti, che « soltanto la corte è competente a
giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni
dell'alta autorità e del Consiglio, qualora una controversia pro
posta avanti a un tribunale nazionale metta in causa tale validi tà ». Benché non sia contestato che, a norma dell'art. 92 del
trattato CECA, non può venir eccepita la validità della decisio
ne di cui è causa, per quanto riguarda la entità delle obbligazioni
pecuniarie che essa comporta, ciononostante, con l'art. 2, essa è
diretta a produrre, nell'ambito del procedimento fallimentare
pendente dinanzi al giudice nazionale, effetti giuridici nei con
fronti di terzi e, in particolare, degli altri creditori dell'impresa. Poiché detto giudice ha ritenuto necessario, per poter decidere la
potestà fiscale appartenente ad un soggetto sovranazionale ed operante in un ordinamento di tale natura (29).
La ricostruzione storica può forse correggere i nostri atteggiamenti mentali di giuristi educati per troppo tempo ad un rigido esclusivismo del diritto nazionale, frutto di una storia tutta particolare degli ordinamenti nazionali europei '(30).
Quando la potestà fiscale non era prerogativa assoluta degli Stati, ma era riconosciuta anche nell'ambito di ordinamenti universali come la Chiesa, sorgevano egualmente problemi di conflitto tra i privilegi dello Stato e privilegi della Chiesa con conseguenti diverse soluzioni di priorità tra le cause di prelazione in conflitto (31).
L'esistenza di una potestà fiscale sovranazionale, da un lato, e di una potestà fiscale dei singoli Stati nei termini in cui attualmente
sussiste, dall'altro, richiede, se si vogliono tutelare i diversi crediti in via privilegiata, che si stabilisca anche la regola di priorità tra i rispettivi privilegi. Tale regola può risolvere il relativo conflitto in termini di equiparazione o in termini di subordinazione del credito dello Stato a quello del soggetto sovranazionale.
In mancanza però di disposizioni, che istituiscano il privilegio a tutela dei prelievi comunitari e ne prevedano il rispettivo grado, non è possibile supplire a tale lacuna attraverso l'interpretazione giurispru denziale.
Nella sopra indicata prospettiva non può non accogliersi la deci sione della corte e la relativa motivazione.
Giuseppe Tucci
(29) Non a caso i diritti di prelievo di cui all'art. 49 del trattato CECA sono considerati come « prima imposta europea ». A riguardo v. Tesauro, Sulla natura giuridica del prelievo CECA, cit.; Mon nary, Disposizioni finanziarie, in Commentario, diretto da Mona co, Quadri, Trabucchi, cit., 11. 656 ss. Sui rapporti tra prelievi comunitari e sovranità fiscale degli Stati nazionali, v. Pescatore, Diritto comunitario e diritto nazionale secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Foro it., 1970, V, 40 ss.
i(30) Tale esclusivismo nazionale viene chiaramente espresso nelle più rigide configurazioni del concetto di ordine pubblico, di cui agli art. 31 disp. prel. c.c. e 797 c.p.c. Sul punto v., da ultimo, Mengozzi, Le disposizioni sulla legge in generale, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescicno, Torino, 1982, I, 342 ss.
(31) V. a riguardo la ricostruzione storica di Clamerò, Hispanus Fiscus, Persona Fida, in Quaderni fiorentini, 1982-83, Itinerari moderni della persona giuridica, nn. 11-12, Milano, 1983, 1, 118 ss.
Il Foro Italiano — 1983 — Parte IV-31.
causa, di sottoporre alla corte una questione pregiudiziale verten
te sulla validità dell'art. 2 della decisione, sussistono le condi
zioni stabilite dall'art. 41 del trattato CECA.
12. - La Commissione sostiene che la decisione di cui è causa
va considerata valida alla luce delle norme e dei principi generali del diritto comunitario, in forza dei quali ciascuno Stato membro
è tenuto a concedere ai prelievi CECA gli stessi privilegi rico
nosciuti ai simili crediti dello Stato.
13. - Essa sottolinea, da un lato, che il trattato CECA, agli art.
49 e 50, legittima l'alta autorità ad esercitare poteri fiscali, nei
quali rientra la possibilità di istituire, di determinare entro certi
limiti e di percepire direttamente dalle imprese un'imposta di cui, ai sensi dell'art. 92, può ottenere il pagamento anche con esecu
zione forzata. Da ciò deriverebbe che i prelievi CECA vanno
sottoposti ad una regolamentazione che ne garantisca l'effettiva
riscossione in qualsiasi circostanza e che essi devono pertanto fruire degli stessi -privilegi delle imposte statali simili.
14. - Non può certo negare l'importanza dei poteri fiscali
riconosciuta all'alta autorità (ora alla Commissione) dagli art. 49
e 50 del trattato CECA al fine di consentirle di adempiere, nelle
migliori condizioni possibili, la missione affidatale dal trattato.
Non risulta tuttavia necessariamente dalla natura e dagli scopi conferiti ai prelievi dai suddetti articoli che, in caso di fallimento
dell'impresa debitrice, essi debbano automaticamente fruire degli stessi privilegi che le legislazioni degli Stati membri riconoscono
alle imposte nazionali simili.
15. - Da uno studio comparativo dei diritti nazionali risulta
infatti che, nella misura in cui, nella liquidazione di fallimenti, sono riconosciuti dei privilegi a determinati crediti, questi posso no risultare solo da disposizioni di legge specifiche e prestabilite, in quanto essi pregiudicano il principio generale dell'eguaglianza dei creditori. In mancanza di disposizioni particolari relative, nella liquidazione dei fallimenti, all'esistenza di un privilegio a
favore della Commissione per i crediti derivanti dai prelievi, un
privilegio del genere non può essere ammesso.
16. - La Commissione sostiene, inoltre, che dal principio generale di uguaglianza si desume che la CECA non deve essere
svantaggiata nel recupero dei prelievi rispetto a crediti d'imposta analoghi ai quali gli Stati membri riconoscono un rango privile giato.
17. - A sostegno della sua tesi, la Commissione invoca la
giurisprudenza della corte, specialmente la sentenza 27 marzo
1980 (Meridionale Industria Salumi, cause 66, 127 e 128/79, Racc. 1980, pag. 1237; Foro it., 1981, IV, 118), secondo la quale
gli Stati membri non possono rendere il sistema di riscossione
delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo.
18. - Se è vero che uno Stato membro non può sottoporre la
riscossione degli oneri comunitari del debitore a condizioni o a
modalità diverse da quelle previste per oneri nazionali analoghi, il principio di uguaglianza di trattamento non implica, tuttavia, di per se stesso, che, in mancanza di una norma comunitaria
chiara e precisa che stabilisca, fra l'altro, il rango del prelievo e
l'imposta nazionale a cui esso dev'essere equiparato, gli Stati
membri sono tenuti, in caso di fallimento del debitore, a conce
dere ai prelievi della CECA gli stessi privilegi riconosciuti ai
crediti simili dello Stato.
19. - Si deve concludere che, in mancanza di una norma come
quella sopra descritta, adottata dal legislatore comunitario nel
l'ambito di quanto previsto dal trattato, la Corte di giustizia non
può per mezzo della sua giurisprudenza introdurre un criterio
volto a stabilire un privilegio del tipo di quello rivendicato dalla
Commissione. Come la corte ha avuto occasione di affermare
nella sentenza 5 marzo 1980 (Ferwerda. causa 265/78, Racc.
1980, pag. 617; Foro it., 1981, IV, 120) non è possibile supplire, in via giurisprudenziale, alla mancanza di una normativa che ha
necessariamente carattere tecnico e particolareggiato.
20. - Stando cosi le cose, la questione proposta deve essere
risolta nel senso che la decisione della Commissione del 10
dicembre 1981 non è valida nella parte in cui dispone, all'art. 2,
che i crediti privilegiati CECA nei confronti della società fallita
sono crediti privilegiati di rango uguale a quello dei simili crediti
dello Stato. (Omissis)
Per questi motivi, pronunciandosi sulla questione sottoposta le dal Tribunale di Milano con ordinanza 22 aprile 1982, di
chiara:
La decisione della Commissione 10 dicembre 1981 è inva
lida nella parte in cui dispone, all'art. 2, che i crediti per
prelievi CECA nei confronti della società fallita sono crediti
privilegiati di rango uguale a quello dei simili crediti dello
Stato.
This content downloaded from 185.2.32.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:14:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions