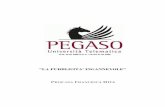"Io, benzinaio onesto vorrei abbassare i prezzi ma me lo impediscono"
S IIC COOLLOOGG IA A EEE DD E EDUUCAAZZIIOONNEE...
Transcript of S IIC COOLLOOGG IA A EEE DD E EDUUCAAZZIIOONNEE...

““PPSSIICCOOLLOOGGIIAA EEDD EEDDUUCCAAZZIIOONNEE MMUUSSIICCAALLEE PPAARRTTEE TTEERRZZAA””
PPRROOFF.. MMAAUURRIIZZIIOO PPIISSCCIITTEELLLLII

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
2 di 12
Indice
1 INTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2 L’EDUCAZIONE MUSICALE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3 L’APPRENDIMENTO MUSICALE AUTOREGOLATO ------------------------------------------------------------- 8
4 L’ACQUISIZIONE DEGLI AUTOMATISMI -------------------------------------------------------------------------- 10

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
3 di 12
1 Introduzione
L’apprendimento delle abilità musicali si differenzia, per certi aspetti, dagli altri tipi di
apprendimento come quello della matematica, del linguaggio o dell’imparare una nuova lingua. Per
quanto riguarda la musica l’acquisizione delle abilità è più complessa perché durante l’esperienza
musicale entrano in gioco più fattori, sia emotivi, mentali che corporei. Prendendo come esempio la
tecnica pianistica, nel suonare il pianoforte l’uomo utilizza contemporaneamente le dita, il piede
(per abbassare e alzare il pedale) e nello stesso tempo legge lo spartito, a meno che non conosca il
brano a memoria. La memoria non rende l’esecuzione più semplice ma, al contrario, la mente del
musicista (mentre suona uno spartito) procede nell’elaborare le informazioni costruite attraverso
rappresentazioni mentali1.
Un’altra specificità che si incontra durante l’apprendimento della tecnica pianistica riguarda il modo
in cui il musicista suona le note, ponendo le mani sui tasti in maniera appropriata, senza pensarci.
Un pianista difatti, quando suona un brano che già ha studiato, non ha bisogno di prendere decisioni
sulla posizione delle dita da assumere per ogni nota, perché la sua mano adotterà automaticamente
la configurazione corretta. La difficoltà consiste proprio nella lettura dello spartito durante
l’esecuzione. La lettura musicale può essere vista come «un continuo passaggio da un processo
controllato a uno automatico, dove le unità d’informazione musicale aumentano progressivamente.
Lo studente si focalizza inizialmente sull’associazione di note individuali scritte sullo spartito, con
la posizione della mano sullo strumento, attraverso un processo controllato. Con la pratica, le
associazioni fra le note e la mano diventano automatiche e l’attenzione può essere focalizzata su
pattern musicali più complessi come gli accordi, le battute e, infine, le frasi musicali. In questo
modo le unità più complesse possono essere eseguite in modo automatico con un singolo sguardo
allo spartito»2.
Le parole su un testo possono essere lette direttamente con uno sguardo che segue linearmente la
sequenza dei lemmi; per i musicisti, invece, suonare un brano visto per la prima volta non è cosa
facile. A tal riguardo è stato svolto uno studio sui movimenti oculari compiuti dai musicisti durante
la lettura dello spartito. La ricerca era incentrata sul comportamento dei pianisti, poiché la musica
per pianoforte è scritta su due righi, o meglio su due pentagrammi, ed è di conseguenza impossibile
1Sloboda J. ( 2002). La mente musicale, op. cit.

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
4 di 12
vedere tutte le note che vanno suonate con un unico sguardo, ma si dovrà fissare prima un rigo e poi
l’altro. Dallo studio è emerso che una strategia adottata per leggere gli spartiti per pianoforte era
quella di compiere uno spostamento oculare verticale dall’alto verso il basso, con un movimento
verso destra. Questo metodo rendeva possibile ‘vedere in anticipo’ la struttura del testo per
organizzare l’esecuzione successiva in modo continuo e rapido3.
Un altro fattore che entra in gioco nell’esecuzione musicale, oltre all’impiego degli occhi per
leggere lo spartito, è lo sguardo rivolto alle mani per verificare se queste sono nella posizione
corretta. Una delle difficoltà che si incontrano agli inizi dell’apprendimento di uno strumento
musicale è proprio questa: utilizzare la vista sia per leggere lo spartito sia per guardare dove
posizionare le dita sulla tastiera. Per quanto riguarda gli spartiti per pianoforte, le note scritte su i
due pentagrammi si leggono diversamente l’uno dall’altro: la mano sinistra suona le note scritte in
‘chiave di basso’ presenti sul secondo rigo e la mano destra suona le note scritte sul primo rigo,
ossia in ‘chiave di violino’. Soltanto dopo molte ore di esercizio e con anni di studio questo
coordinamento risulterà semplice e automatico. È importante rilevare che la configurazione delle
dita4 ovviamente cambia in base al brano da suonare, anche se spesso ci sono configurazioni e
strutture simili che possono essere utilizzate in diversi spartiti. Per esempio un tipo di struttura può
essere un accordo che è possibile suonare con una stessa posizione in diversi brani musicali.
Lo sviluppo delle competenze musicali «porta a un aumento del numero di ripetizioni, all’utilizzo di
strategie di verbalizzazione, all’indipendenza tra le due mani e alla capacità di proseguire l’esercizio
per periodi più lunghi. I soggetti più esperti sono in grado di rappresentarsi mentalmente il proprio
comportamento nell’esercizio in modo più vario e complesso. In altri termini, un determinato brano
viene associato contemporaneamente alla sequenza di movimenti necessari per eseguirlo, a
particolari aspetti dello spartito e alle variazioni di tempo e di dinamica che si sono verificati
nell’intero brano»5.
2 Schon D., Akiva-Kabiri L., Vecchi T. (2007). Psicologia della musica. Roma: Carocci, pp. 76-77
3 Sloboda J. ( 2002). La mente musicale, op. cit.
4 Per configurazione delle dita si vuole fare riferimento alla posizione della mani sulla tastiera, ossia l’attribuzione delle
dita a specifiche note o accordi musicali. 5Schon D., Akiva-Kabiri L., Vecchi T. (2007). Psicologia della musica. . Op. cit., pp. 52, 53

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
5 di 12
2 L’educazione musicale
L’educazione musicale è una disciplina presente da molti anni all’interno dei programmi
scolastici, soprattutto nelle scuole primarie. Essa tuttavia, prima che potesse essere considerata una
disciplina vera e propria, ha registrato notevoli cambiamenti di statuto all’interno dei passati
programmi ministeriali ma anche tenaci resistenze corrispondenti alla concezione che si aveva
allora della musica, considerata prevalentemente come una forma di svago e non come una
disciplina che potesse formare musicalmente gli allievi. Alla sua pratica venivano associati caratteri
educativi secondari e inoltre veniva identificata esclusivamente con il canto6.
Osservando la situazione dell’insegnamento musicale del nostro Paese, troviamo che nella Legge
Casati7 del 1859, dove ampie indicazioni didattiche e altri consigli vengono dati nelle “Istruzioni ai
maestri”, pur avendo un forte taglio culturale, i programmi non contengono il benché minimo
accenno a una qualche forma di cultura o pratica musicale. La prima forma di educazione musicale
in Italia nasce con un programma ministeriale del 1888 (programma Gabelli) per la scuola
elementare. Esso prevedeva esercizi di canto corale e l’apprendimento di alcune teorie musicali
basate sullo studio mnemonico, mentre l’educazione musicale era affidata esclusivamente ai
Conservatori e alle Accademie ed era riservata a coloro che erano interessati a farne una scelta di
livello professionale. Nell’ambito del canto corale, uno spazio importante ha lungamente occupato
il «canto popolare» riferito ai canti patriottici e religiosi. La Riforma Gentile del 1923 prevedeva un
programma di educazione teorica e pratica per le scuole elementari tra cui veniva riconosciuta alla
musica il diritto di essere una disciplina didattica obbligatoria e fondamentale, anche se ancora
etichettata con i termini di ‘canto’ e ‘canto corale’. Negli anni successivi venne sostituito
l’insegnamento di ‘canto corale’ con ‘Elementi di musica e canto corale’ ed inoltre introdotto lo
studio facoltativo di uno strumento musicale. Per quanto riguarda l’istruzione media e superiore non
vi furono molti cambiamenti e l’educazione musicale fu prevista soltanto per alcuni istituti. Mentre
per la musica intesa come tecnica venivano individuate nei Conservatori e nelle Accademie le sue
6 L’educazione musicale fu introdotta nella scuola dell’obbligo nel 1963 e fino a questa data essa era definita «canto» o
«canto corale». Nei Conservatori, invece, le cattedre di didattica musicale incominciarono a essere istruite a partire dal
1965. Cfr. Grazioso G. (1994). L’educazione musicale tra passato, presente e futuro. Milano: Ricordi. 7 La Legge Casati prese il nome dal Ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati. La legge conferiva un assetto
organico all’intero sistema scolastico definendone cicli, curricula, materie di insegnamento, programmi, personale,
apparato amministrativo.

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 12
sedi naturali di formazione, come canto era invece considerata un’attività riservabile
prevalentemente ai bambini e alle ragazze. Ciò contribuì a lungo a bloccare l’educazione musicale
nell’ambito scuole primarie8. I primi cambiamenti verso un’educazione musicale più efficiente
risalgono intorno agli anni sessanta con la nascita della SIEM9, una società per l’educazione
musicale che si occupò di diffondere la cultura musicale in tutto il Paese. Essa riuscì a far
riconoscere alla musica un ruolo formativo praticabile da tutti. Si giunse finalmente a considerate
l’educazione musicale come «una vera e propria disciplina che consente agli studenti di acquisire le
competenze necessarie per lo sviluppo delle proprie potenzialità musicali e per la scoperta e
l’affermazione della propria identità musicale»10
. Nel tempo la musica, o meglio l’educazione
musicale, ha ottenuto una posizione di rilievo quasi al pari delle altre discipline scolastiche, anche
se le metodologie di insegnamento utilizzate hanno tardato ad aggiornarsi e a rinnovarsi. A tal
proposito, Riccardo Nardozzi11
afferma che «se gli studi di psicologia musicale più recenti hanno
fatto passi da gigante, proprio a partire dal riconoscimento di tale importanza e nella direzione,
dunque, di una maggiore conoscenza e comprensione in tema di modalità, potenzialità e capacità
degli individui all’interno del processo di apprendimento musicale, non sempre sono stati affiancati
da pratiche o metodologie di insegnamento adeguate»12
. Nonostante i cambiamenti che hanno
interessato le modalità e i contenuti che l’insegnamento della musica doveva proporre per
consentire ai bambini di poter essere formati ed istruiti musicalmente nel miglior modo possibile,
domina tutt’oggi nella maggioranza degli insegnanti l’atteggiamento orientato a insegnare a suonare
lo strumento e a comporre musica ma non a “pensare” e a “teorizzare” sulla musica13
.
8 Per comprendere meglio la situazione dal punto di vista legislativo si legga il Testo Unico: «l’istruzione elementare
(r.d. 577/5 febbraio 1928) prevedeva l’insegnamento di canto e audizione musicale in tutte le classi della scuola
elementare. In conseguenza, musica e canto furono inseriti nei programmi dell’istituto magistrale che provvedono alla
formazione rispettivamente degli insegnanti elementari e di quelli di scuola materna. A partire dal 1963 l’educazione
musicale è entrata a far parte del piano di studi della scuola media (l. 1859/31 dicembre 1962) quale insegnamento
obbligatorio nella prima classe e facoltativo nelle due classi successive; in seguito (l. 348/16 giugno 1977), tale
insegnamento è diventato obbligatorio nell’intero corso di scuola media. Attualmente i contenuti dell’educazione
musicale sono confluiti in uno specifico percorso formativo che si sviluppa secondo le indicazioni nazionali allegate al
d. legisl. 59/2004, partendo dalla scuola dell’infanzia e giungendo fino alla secondaria di primo grado. La disciplina,
peraltro, assume una propria connotazione distinta solo dalla scuola primaria, ove viene indicata come ‘Musica’ e viene
insegnata in questa veste fino alla scuola secondaria di I grado […]» 9 Società Italiana per l’Educazione Musicale (SIEM) fondata da Carlo Delfrati nel 1969.
10 Grazioso G. (1994). L’educazione musicale tra passato, presente e futuro. Op. cit., p. 11
11 Musicista e insegnante AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento musicale).
12 Nardozzi R. (2010). L’apprendimento della musica nel bambino da 0 a 6 anni. Music Learning Theory: teoria e
prassi secondo Edwin E. Gordon. Roma: Albatros, p. 12. 13
Ibidem.

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 12
Le innovazioni e i successi didattici degli ultimi anni sono arrivati in Italia in ritardo rispetto a molti
altri Paesi dove era presente già da tempo una forte tradizione pedagogico-musicale. Da circa dieci
anni i metodi di Jaques-Dalcroze14
, di Carl Orff15
, di Kodaly16
, di Edgar Willems17
e di Edwin E.
Gordon18
sono stati diffusi anche nel nostro Paese, soprattutto attraverso l’AIGAM19
. In Italia, tra i
metodi di insegnamento musicale, è soprattutto noto quello di Laura Bassi, nato negli anni trenta,
ispirato alla Ritmica di Dalcroze: un modo innovativo di educazione musicale basato sulla
partecipazione del corpo, definita dalla Bassi con l’espressione “Ritmica Integrale”. Nel suo metodo
l’autrice pone attenzione al ritmo, ossia all’elemento unificatore di musica, movimento, espressione
verbale e grafica.
Anche Maria Montessori pose particolare attenzione all’educazione dei sensi, nello specifico
all’educazione dell’orecchio condotta attraverso attività ritmiche, ritmico-motorie, di ascolto e di
esecuzione strumentale.
Dalcroze occupandosi dell’educazione ritmica del corpo e della musica, definisce la ritmica
un’educazione musicale che mette in relazione i movimenti naturali del corpo con i ritmi artistici
della musica (tempo, durata, misure, dinamica, altezze, frasi). Un’educazione attiva, che con
l’attenzione rivolta allo sviluppo della percezione uditiva, mira a tradurre l’informazione musicale
attraverso il movimento e l’uso dello spazio20
. Dalcroze era guidato dalla preoccupazione di
facilitare nei suoi alunni l’apprendimento delle strutture musicali; egli intuì il valore del corpo come
mezzo privilegiato per vivere la dimensione temporale della musica e fonda la sua ritmica come un
modo di vivere con il corpo le strutture musicali (dinamiche, profili melodici, fraseggio) ma anche i
significati e le emozioni21
.
14
E. J. Dalcroze (1865-1950). È stato un pedagogo svizzero. La sua importanza risiede in particolare nello sviluppo
dell'euritmica, un metodo per insegnare e percepire la musica attraverso il movimento. 15
C. Orff (1895-1982). È stato un compositore tedesco. Essendosi occupato intensamente anche di pedagogia e
didattica, ha influenzato profondamente, attraverso lo Orff-Schulwerk, l'educazione musicale. 16
Zoltàn Kodàly (1882-1967), compositore ed etnomusicologo ungherese. Nel suo metodo l’allievo viene guidato non
all’apprendimento dei suoni ma alla scoperta dei rapporti sonori. 17
(1890-1978) Pedagogista svizzero. Sostiene che musicalità e senso sonoro sono doti innate e la percezione sonora
coinvolge vari livelli percettivi. L’intelligenza uditiva è la sintesi delle esperienze sensoriali e affettive. 18
Autore della Music Learning Theory, secondo cui la musica può essere appresa attraverso gli stessi meccanismi di
apprendimento della lingua materna. 19
AIGAM: Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale, fondata da Andrea Postoli e il cui presidente
è Edwin E. Gordon. 20
Fonte: www.edt.it 21
Grazioso G. (1994). L’educazione musicale tra passato, presente e futuro. Op. cit., p. 20.

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 12
3 L’apprendimento musicale autoregolato
In psicologia l’apprendimento è considerato «un processo psichico che consente una
modificazione durevole del comportamento per effetto dell’esperienza. Con questa definizione si
escludono tutte le modificazioni di breve durata dovute a condizioni temporanee, episodi isolati,
eventi occasionali, fatti traumatici, mentre il riferimento all’esperienza esclude tutte quelle
modificazioni determinate da fattori innati o dal processo biologico di maturazione»22
.
Come si può notare il termine apprendimento è talmente generale da poter essere attribuito a
situazioni fra loro molto diverse. Per esempio, un topo che percorre velocemente un labirinto, il
cane che va a riprendere un bastone lanciato dal padrone, andare in bicicletta, guidare l’automobile,
parlare la propria lingua o una straniera, leggere, suonare uno strumento musicale, scrivere e così
via. L’apprendimento della musica è un processo di interiorizzazione di regole e strutture musicali
che ha luogo principalmente nelle scuole e nei Conservatori.
Tuttavia la musica può essere appresa anche attraverso un percorso auto-didattico, che si sviluppa
lontano dai sistemi tradizionali. Il percorso musicale da autodidatta è attualmente incoraggiato dallo
sviluppo delle nuove tecnologie che, offrendo molti materiali didattici, permettono all’utente di
intraprendere uno studio di uno strumento musicale autoregolato. Inoltre, l’apprendimento
autoregolato può migliorare la performance artistica e creativa dell’allievo. Dunque, parlare
dell’apprendimento autoregolato è importante anche per comprendere le motivazioni, i
comportamenti e le capacità cognitive e musicali dell’allievo di autoregolare il personale processo
di formazione e perfezionamento.
L’individuo che intende iniziare un processo di autoregolazione dell’apprendimento (SRL, Self-
Regulated Learning), in altre parole, che desidera formarsi da solo, deve possedere la capacità di
saper pianificare, motivare e valutare il proprio processo di apprendimento: è necessario che sappia
scegliere gli obiettivi didattici, i contenuti da trattare e i modi di utilizzo delle strategie di
apprendimento, così da poter affrontare le sfide cognitive, meta-cognitive, motivazionali ed
emotive23
. Inoltre è fondamentale ricordare che apprendere in maniera autoregolata vuol dire non
22
Galibmerti U. (2006). Dizionario di psicologia. Torino: Utet, p.79. 23
Giannetti T. (2006). Autoregolazione dell’apprendimento e tecnologie didattiche, Tecnologie Didattiche.
http://www.tdjournal.itd.cnr.it

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 12
solo saper controllare il processo di apprendimento cognitivo ma anche saper gestire le emozioni e
le motivazioni24
.
La gestione della meta-cognizione comporta una continua attenzione ad analizzare le attività e i
risultati cognitivi ottenuti. Inoltre, essa produce un feedback interno che lo studente utilizza per
migliorare l’apprendimento. Regolare la motivazione implica essere consapevoli dei propri obiettivi
e dell’importanza che l’individuo gli attribuisce. L’apprendimento autoregolato necessita: di saper
gestire il comportamento individuale, ovvero, effettuare scelte e controlli personali nel corso
dell’attività di apprendimento ed esserne responsabili e di essere consapevoli che sono fonti di
apprendimento anche le relazioni interpersonali25
.
24
Ibidem. 25
Ibidem.

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 12
4 L’acquisizione degli automatismi
Per automatismo si intende «l’attività non classificabile nell’ambito dei movimenti riflessi
compiuta senza intenzione e consapevolezza»26
. In altre parole, le attività e le azioni compiute
vengono effettuate senza la necessità di sforzarsi, di fare controlli continui o di avere una particolare
attenzione nelle varie fasi dell’esecuzione, ossia tali comportamenti consistono in ‘processi di
automatizzazione’.
Vi sono situazioni in cui l’automatismo si forma prima e indipendentemente da ogni atto di
comprensione. Infatti, riguardo gli automatismi cognitivi, i bambini sono capaci di produrre certe
strutture sintattiche senza conoscere la grammatica. In secondo luogo, vi sono situazioni in cui
l’automatismo si forma dopo che la comprensione si è verificata e in seguito a una continua
ripetizione di un’azione. Un esempio in cui la comprensione avviene prima dell’automatismo può
essere quello della collocazione delle dita della mano sinistra sulle corde di un violino: occorre
sapere come e dove trovare le note, su una certa corda, prima che il ritrovamento divenga
automatico27
. Un altro esempio è quello della persona alla guida di un auto: quando prendiamo le
prime lezioni di guida teniamo sotto controllo tutte le informazioni necessarie per mettere un moto
la macchina, ossia pensiamo a ciò che stiamo facendo. Dopo anni di guida, invece tutte le procedure
diventano automatiche28
.
Per Johnson e Hasber, un processo è automatico se possiede alcune caratteristiche: «deve essere non
intenzionale, ossia un atto di volontà non è necessario perché il processo abbia luogo; deve
realizzarsi al di fuori della consapevolezza; non deve essere controllabile, ossia una volta iniziato
l’individuo non può interromperlo; essere efficiente, ossia consumare una quantità minima di
risorse cognitive e potersi realizzare in maniera parallela a un’altra attività di elaborazione»29
.
26
Galibmerti U. (2006). Dizionario di psicologia. Op. cit., p. 121. 27
Petter G. (2002). La mente efficiente. Firenze: Giunti. 28
Ibidem. 29
Arcuri L., Castelli L. (2010). La cognizione sociale. Strutture e processi di rappresentazione. Roma: Laterza, p. 135.

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
11 di 12
Berry e Dienes ritengono che le informazioni apprese senza consapevolezza sarebbero in realtà
mancanti di processi metacognitivi coscienti. In particolare sarebbero implicite quelle informazioni
che si trovano fra la soglia soggettiva e quella oggettiva di consapevolezza30
.
I processi di automatizzazione descritti da Shiffrin e Schneider sono distinguibili dai processi di
apprendimento impliciti perché i legami associativi automatizzati sono inizialmente consapevoli e
solo con la pratica diventano meno visibili. La differenza principale esistente tra i processi
consapevoli e inconsapevoli è data «dal rapporto tra “automaticità versus intenzionalità selettiva”.
Mentre i processi automatici inconsapevoli non sono condizionati dalla capacità, quelli associati
alla coscienza lo sono»31
.
Lo sviluppo degli automatismi a seguito di una pratica continuativa di apprendimento produce
padronanza o expertise nell’allievo. L’esperto è «colui che, in seguito a una lunga pratica in un
settore, ha acquisito capacità e strategie che gli consentono di svolgere i compiti con maggiore
precisione, velocità e soddisfazione. Spesso l’esperto è anche molto motivato per l’attività che
svolge, anche se è difficile distinguere quando la motivazione possa essere considerata causa o
effetto dell’expertise. L’expertise può quindi essere definita come un insieme di abilità sviluppate in
ambiti specifici attraverso una lunga pratica nel compito, in genere accompagnata da un buon uso di
strategie e da alti livelli motivazionali»32
.
Secondo Arcuri e Castelli, quindi, una persona esperta in un particolare dominio «è in grado di
impiegare con efficienza lo schema corrispondente e riesce a trattare in maniera integrata
informazioni complesse e interconnesse. Questo significa, allora, che anche in presenza di un
numero rilevante di informazioni da gestire in fase di giudizio, la persona esperta fa ricorso alla
struttura schematica e riesce a trovare le più efficienti strategie di combinazioni delle informazioni e
giungere rapidamente a emettere il giudizio»33
.
Le prime ricerche sull’expertise si sono focalizzate sulle differenze nella capacità di memoria. Una
ricerca importante da ricordare è quella svolta sui giocatori di scacchi. Con questa ricerca è stato
dimostrato che i giocatori esperti riescono a ricordare l’immagine di una scacchiera e a prevedere i
movimenti successivi più semplicemente rispetto ai non esperti. La capacità dimostrata da questi
30
Dentale F., Accursio G. (2003). Processi mentali impliciti. Teorie, metodi ed orientamenti di ricerca. Milano: Franco
Angeli. 31
Conte M., Accursio G. (1989). Inconscio e processi cognitivi. Bologna: Il Mulino, p. 220 32
De Beni R., Moè A. (2000). Motivazione ed apprendimento. Bologna: Il Mulino, p.16 33
Arcuri L., Castelli L. (2010). La cognizione sociale. Strutture e processi di rappresentazione. Op. cit., pp. 39, 40

Università Telematica Pegaso Psicologia ed Educazione Musicale
terza parte
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
12 di 12
soggetti veniva rilevata anche quando venivano posizionati i pezzi della scacchiera in modo casuale
e illogico rispetto alle regole del gioco. Il vantaggio degli esperti risulta dal prodotto della capacità
di associare alla scacchiera schemi passati, conoscenze personali e altro, che rendono semplice la
memorizzazione34
.
Schön e i suoi collaboratori hanno dimostrato che il principio alla base di questo effetto è il
raggruppamento: «gli esperti riescono a codificare le informazioni sulla base di configurazioni
predefinite con maggiore facilità, ciò determina di fatto una riduzione delle informazioni da
memorizzare e quindi il miglioramento della prestazione. L’accumulo di esperienza in uno specifico
dominio permette l’organizzazione delle informazioni sotto forma di configurazioni complesse
gerarchicamente organizzate, sfruttando al massimo le capacità di memoria»35
. Pertanto, è possibile
affermare che la migliore prestazione degli esperti è legata all’esercizio e non a un fattore generale
di sviluppo. A tal proposito, alcuni ricercatori hanno dimostrato che anche in ambito musicale i
musicisti utilizzano l’effetto del raggruppamento. L’esperimento realizzato dimostrò che i musicisti
professionisti leggevano le note creando delle configurazioni musicali più complesse, mentre i
principianti leggevano le note una per volta36
.
Tuttavia gli esperti, avendo sviluppato una specifica competenza, difficilmente riescono ad
aggiornarla o a modificarla radicalmente, a causa di una rigidità dovuta al consolidamento e
all’automatizzazione derivanti da numeroso anni di pratica, ma rispetto agli inesperti dimostrano
maggiori potenzialità di apprendimento e di analisi dei nuovi problemi per effetto degli automatismi
e della possibilità di sfruttare strutture di conoscenze preesistenti37
.
Arcuri e Castelli sottolineano che l’insieme delle conoscenze depositate in memoria non si presenta
soltanto come un archivio pronto per essere consultato, ma diventa una mappa di riferimento che in
modo rapido ed efficace indirizza verso comportamenti presumibilmente più appropriati alla
situazione data38
.
34
Schön D., Akiva-Kabiri L., Vecchi T. (2007). Psicologia della musica. Op. cit. 35
Ivi, p. 50 36
Ibidem. 37
Arcuri L., Castelli L. (2010). La cognizione sociale. Strutture e processi di rappresentazione. Op. cit. 38
Ibidem.





![GUITAR COMBO GTX30/GTX60 Guida rapida · {9} Il regolatore BASS della sezione EQ consente di alzare o abbassare le basse frequenze. [10] Il regolatore CONTOUR consente di influenzare](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/614394cd6b2ee0265c022347/guitar-combo-gtx30gtx60-guida-rapida-9-il-regolatore-bass-della-sezione-eq-consente.jpg)