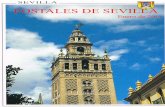postale - 70% CNS TV analisi e commenti · Anno 12 n. 6-2010 periodico bimestrale - Poste Italiane...
Transcript of postale - 70% CNS TV analisi e commenti · Anno 12 n. 6-2010 periodico bimestrale - Poste Italiane...
analisi e commenti
Fondazione Nord EstPresidenteAndrea Tomat Direttore scientificoDaniele Marini
NEDirettore responsabileAuro Palomba
Redazione:Carlo Bergamasco, Davide Girardi, Daniele Marini, Fabio Marzella, Silvia Oliva, Giuliano Pasini, Gianluca Toschi
Hanno collaborato: Aris Accornero, Alberto Bombassei, Maurizio Castro, Innocenzo Cipolletta, Enzo Rullani, Giorgio Santini, Tiziano Treu, Emilio VioforaAnno 12 n. 6-2010 periodico bimestrale - Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale - 70% CNS TV
EditorialeC’è un extraterrestre che si aggira per l’Italia. Viene dal Canada, è atterrato a Torino, e potrebbe tornarsene a Detroit. Questa è almeno (o forse) la speranza di molti che non accettano l’evidente insofferenza di un uomo che per portare la Fiat a primeggiare nel difficile mondo dell’automotive sta cercando di spaccare le consorterie e le abitudini di un Paese che precipita sempre di più nelle classifiche mondiali di competitività.Quando si entra come un elefante in cristalleria a volte si rompono anche i vasi sbagliati. Ma è indubbio che oggi la difficoltà di Marchionne sia quella di farsi comprendere, anche perché l’im-pressione è che molti si appiglino ai particolari invece che guardare al generale del suo pensiero.Lui parla di salari maggiori legati alla produttività e il messaggio che passa è che vuole lasciare il Paese.Certo è che nessuno può dubitare sul fatto che le relazioni sindacali in Italia vadano cambiate se si vuole riportare la nostra industria sul terreno della competitività nazionale. Molti lo pensano, pochi lo dicono. Fra questi vi è Marchionne, che ha avuto il coraggio (aiutato da John Elkann) di caricarsi sulle spalle il destino del maggior gruppo industriale del paese nel momento più difficile per l’economia mondiale.La partita è cominciata, e in gioco non c’è solo la Fiat bensì la possibilità di fare ancora impresa in questo paese e, soprattutto, di diventare attrattivi per multinazionali che avessero il desiderio di venire in Italia.Marchionne chiede un nuovo modo di fare relazioni sindacali, un nuovo patto sociale. Confin-dustria lo appoggia, alcuni sindacati accettano il confronto, altri lo rifiutano. La politica sembra imbarazzata: capisce alcune ragioni ma sembra soffrire il personaggio. Come finirà?
Auro Palomba
Testo della lettera dell’Amministratore De-legato della Fiat Sergio Marchionne a tutti i dipendenti dell’azienda in Italia pag. 2
Le relazioni industriali e la competizione pag. 4
Un patto sociale per rispondere alle nuove sfide nell’economia e nel lavoro pag. 7
La necessità di politiche di sviluppo pag. 10
Le relazioni industriali come vettore di coesio-ne sociale pag. 13
Quale mutamento per le relazioni industriali? pag. 15
Debolezza del lavoro e deroghe ai contratti pag. 18
Il ritorno delle tensioni sindacali pag. 21
Marchionne e la crisi. Le relazioni industriali stanno cambiando, an-che se la cronaca ripete vecchie sceneggiature pag. 24
2Testo della lettera dell’Amministratore Delegato della Fiat Sergio Marchionne a tutti i dipendenti dell’azienda in Italia
Scrivere una lettera è una di quelle cose che si fa raramente e solo con le persone alle quali si tiene veramente. Se ho deciso di farlo è perché la cosa che mi sta più a cuore in questo momento è potervi parlare apertamente. Non è la Fiat a scrivere questa lettera, non è quell’entità astratta che chiamiamo «azienda» e non è, come direbbe qualcuno, il «padrone». Vi scrivo da uomo che crede fortemente che abbiamo la possibilità di costruire insieme, in Italia, qualcosa di grande, di migliore e di duraturo. Ci troviamo in una situa-zione molto delicata, in cui dobbiamo decidere il nostro futuro. Si tratta di un futuro che riguarda noi tutti e che riguarda il nostro Paese, per il ruolo che vuole occupare a livello internazionale. Basta pensare a quanto è basso il livello degli investimenti stranieri in Ita-lia, a quante imprese hanno chiuso negli ultimi anni e a quante altre hanno abbandonato il Paese per capire la gravità della situazione. La cosa peggiore di un sistema industriale, quando non è in grado di competere, è che alla fine sono i lavoratori a pagarne diretta-mente — e senza colpa — le conseguenze. Quello che noi stiamo cercando di fare con il progetto «Fabbrica Italia» è invertire questa tendenza. Il vero obiettivo del piano è colmare il divario competitivo che ci separa dagli altri Paesi e garantire all’Italia una grande indu-stria dell’auto e a tutti i nostri lavoratori un futuro più sicuro. Le regole della competizione internazionale non le abbiamo scelte noi e nessuno ha la possibilità di cambiarle. L’unica cosa che possiamo scegliere è se stare dentro o fuori dal gioco. Non c’è nulla di eccezionale nelle richieste che stanno alla base della realizzazione di «Fabbrica Italia». Abbiamo solo la necessità di garantire normali livelli di competitività ai nostri stabilimenti, creare normali condizioni operative per aumentare il loro utilizzo, avere la certezza di rispondere in tempi normali ai cambiamenti della domanda. Non c’è niente di straordinario nel voler aggiorna-re il sistema di gestione, per adeguarlo a quello che succede a livello mondiale. Eccezionale semmai— per un’azienda — è la scelta di compiere questo sforzo in Italia, rinunciando ai vantaggi sicuri che altri Paesi potrebbero offrire.
Anche la proposta studiata per Pomigliano non ha nulla di rivoluzionario, se non l’idea di trasferire la produzione della futura Panda dalla Polonia in Italia. L’accordo che abbiamo raggiunto ha l’unico obiettivo di assicurare alla fabbrica di funzionare al meglio, eliminan-do una serie interminabile di anomalie che per anni hanno impedito una regolare attività lavorativa. Proprio oggi abbiamo annunciato che, insieme alle organizzazioni sindacali che hanno condiviso con noi il progetto, metteremo in pratica questo accordo.
Insieme ci impegneremo perché si possa applicare pienamente, assicurando le migliori condizioni di governabilità dello stabilimento. So che la maggior parte di voi ha compreso e ha apprezzato l’impegno che abbiamo deciso di prendere. Credo, inoltre, che questo non sia il momento delle polemiche e non voglio certo alimentarle. Ma di fronte alle accuse che sono state mosse e che hanno messo in dubbio la natura e la serietà del progetto “Fabbrica Italia”, sento il dovere di difenderlo. Non abbiamo intenzione di toccare nes-suno dei vostri diritti, non stiamo violando alcuna legge o tantomeno, come ho sentito dire, addirittura la Costituzione Italiana. Non mi sembra neppure vero di essere costretto a chiarire una cosa del genere. È una delle più grandi assurdità che si possa sostenere. Quello che stiamo facendo, semmai, è compiere ogni sforzo possibile per tutelare il lavoro, proprio quel lavoro su cui è fondata la Repubblica Italiana. L’altra cosa che mi ha lasciato
3incredulo è la presunta contrapposizione tra azienda e lavoratori, tra “padroni” e operai, di cui ho sentito parlare spesso in questi mesi. Chiunque si sia mai trovato a gestire un’orga-nizzazione sa bene che la forza di quell’organizzazione non arriva da nessuna altra parte se non dalle persone che ci lavorano. Voi lo avete dimostrato nel modo più evidente, grazie al lavoro fatto in tutti questi anni, trasformando la Fiat, che nel 2004 era sull’orlo del fallimento, in un’azienda che si è guadagnata il rispetto e la stima sui principali mercati internazionali. Quando, come adesso, si tratta di costruire insieme il futuro che vogliamo, non può esistere nessuna logica di contrapposizione interna. Questa è una sfida tra noi e il resto del mondo. Ed è una sfida che o si vince tutti insieme oppure tutti insieme si perde. Quello di cui ora c’è bisogno è un grande sforzo collettivo, una specie di patto so-ciale per condividere gli impegni, le responsabilità e i sacrifici in vista di un obiettivo che vada al di là della piccola visione personale. Questo è il momento di lasciare da parte gli interessi particolari e di guardare al bene comune, al Paese che vogliamo lasciare in eredità alle prossime generazioni. Questo è il momento di ritrovare una coesione sociale che ci permetta di dare spazio a chi ha il coraggio e la voglia di fare qualcosa di buono. Sono convinto che anche voi, come me, vogliate per i nostri figli e per i nostri nipoti un futuro diverso e migliore. Oggi è una di quelle occasioni che capitano una volta nella vita e che ci offre la possibilità di realizzare questa visione. Cerchiamo di non sprecarla. Grazie per aver letto questa lunga riflessione e grazie a tutti quelli, tra voi, che vorranno mettere le loro qualità e la loro passione per fare la differenza. Buon lavoro a tutti.
Sergio Marchionne (Corriere della Sera del 10.07.10, p. 42/43)
4Le relazioni industriali e la competizione
La crisi ha accelerato la consapevolezza della necessità e dell’urgenza di attivare processi di cambiamento. È per questo che nelle settimane scorse abbiamo proposto ai sindacati ed a tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese di avviare un percorso comune volto a definire alcune azioni prioritarie che, nel rispetto del vincolo della finanza pubblica, servano a rilanciare la crescita e l’occupazione. Abbiamo già rag-giunto un accordo su quattro documenti dove sono indicati i percorsi che a giudizio di tutte le parti sociali dovrebbero essere intrapresi nell’immediato in materia di ricerca e innovazione, ammortizzatori sociali per la crisi, semplificazione della Pubblica Ammini-strazione, Mezzogiorno. Mentre ci apprestiamo a portare queste proposte all’attenzione del Governo, stiamo tutti insieme continuando a lavorare per definire posizioni comuni su fisco, spesa pubblica, costi della politica e federalismo e, ultimo ma non meno impor-tante, sul nostro ruolo nello sviluppo della produttività. Non so, al momento, se tutto questo si tradurrà in un nuovo “patto sociale” ma al di là del raggiungimento di intese più o meno storiche, resto sempre più convinto che un risultato deve essere conseguito e cioè quello di dare un segno di discontinuità, prima culturale e poi di merito specie per quanto riguarda le azioni necessarie per realizzare anche un miglior funzionamento del mercato del lavoro, delle regole per il lavoro, dei rapporti fra imprese e sindacati. Negli ultimi tempi abbiamo dovuto registrare troppi segnali di ritorno al passato, ad un passato che tutti ci eravamo impegnati a dimenticare ed a far dimenticare perché fatto di conflitto, di contrapposizione sterile, di scarso rispetto delle diverse idee, fino al limite della violenza. Siamo tutti assolutamente d’accordo sul fatto che un certo livello di conflittualità è anche positivo nello sviluppo democratico delle relazioni fra le parti. Cosa del tutto diversa sono l’antagonismo e la lotta di classe specie se sfocia in atti di intolleranza proprio nel momento in cui si richiede, invece, il maggior tasso di convergenza verso obiettivi comuni. E gli obiettivi comuni nei rapporti fra gli attori delle relazioni industriali certo non mancano.
Aumentare la produttività significa anche più flessibilità organizzativa, migliore uti-lizzo degli impianti, crescenti quote di retribuzione collegate al merito ed ai risultati dell’impresa. Uno dei fattori fondamentali per vincere la sfida competitiva è la com-petenza del fattore umano. Purtroppo si deve ancora registrare una carenza di prepa-razione nelle persone che entrano nel mercato del lavoro. Sta allora alle parti sociali rafforzare la propria azione, comune e condivisa, sulla formazione continua così come sta allo Stato ed alle Regioni avere una gestione dei finanziamenti mirata alle necessità di chi deve trovare o ritrovare l’occupazione. Deve esserci un impegno comune affinché, da un lato, il sistema di istruzione e formazione professionale sia rivolto ad una mag-giore attenzione alle prospettive del mercato del lavoro e, d’altro, si realizzi l’effettivo incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Per competere le imprese devono fare affidamento su un adeguato margine di fles-sibilità organizzativa per cui devono essere riviste e semplificate le normative sul lavoro avendo come obiettivo primario l’occupazione dei giovani. E tra le forme di occupa-zione regolare e tutelata va certamente privilegiato l’ingresso al lavoro con contratto di apprendistato. Nei giorni scorsi abbiamo firmato insieme al Governo ed alle Regione un’importante intesa per favorire il rilancio dell’apprendistato quale via privilegiata per
La crisi economica ha accelerato la necessità di un segno di discontinuità per un miglior funzionamento del mercato del lavoro, delle regole per il lavoro, dei rapporti fra imprese e sindacati. Possono essere semplificate le normative avendo come obiettivo l’occupazione dei giovani, intervenendo sia sui contratti di lavoro a tempo determinato che sui contratto di somministrazione. L’accordo interconfederale del 2009 ha confermato il valore del contratto nazionale e valorizzato la contrattazione aziendale. La competizione internazionale può porre la necessità di avere discipline specifiche per singole realtà aziendali. Allargare l’applicazione dei contratti nazionali può essere un obiettivo, ma non un vincolo.
di Alberto Bombassei, vice presidente di Confindustria per le relazioni Industriali, previdenza ed affari sociali
5l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Adesso quell’intesa va ulteriormente de-clinata per cercare di semplificare ulteriormente la disciplina e a tal fine sarebbe molto efficace attribuire la responsabilità della formazione all’impresa.
L’obiettivo della semplificazione deve riguardare sia il contratto di lavoro a tem-po determinato che il contratto di somministrazione per i quali, come ho proposto al recente Convegno di Genova sul Lavoro, sono convinto che si potrebbe “scambiare” il burocratico obbligo di indicare causali generiche o specifiche, con la garanzia di una durata massima, così come avviene nella maggior parte delle legislazioni europee. Per contrastare la “fuga dei cervelli”, poi, ho anche proposto di definire una nuova procedu-ra che consenta alle imprese di assumere i giovani che si sono distinti nello studio, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con specifico trattamento economico e fiscale, e con iscrizione ad un Master universitario. Ai giovani guarda anche la nostra proposta in tema di pensioni. Chi oggi si trova all’interno di un percorso di carriera discontinua, con fasi di lavoro e di non lavoro, teme per la propria pensione. A Genova ho lanciato lo slogan “ogni giorno di lavoro deve essere utile per la pensione” proponendo così di rimuovere tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla completa totalizza-zione dei periodi assicurativi, senza aggravi di costi per lo Stato.
Sappiamo che fra le questioni che la crisi ha messo definitivamente a nudo c’è la gestione delle transizioni. Dobbiamo creare le condizioni per garantire un adeguato sostegno per i periodi di inattività che dovranno diventare il più possibile brevi grazie ad un miglior funzionamento dell’incontro domanda-offerta ed all’aumento dell’occu-pabilità favorita da formazione mirata.
Sono convinto che se si realizzassero questi interventi, magari a seguito di un avviso comune recepito dal legislatore, si metterebbe in atto una soddisfacente flessibilità organizzativa che potrebbe consentire alle imprese anche di non far ricorso ai contratti di collaborazione a progetto per l’ingresso al lavoro dei giovani.
Regole per il lavoro semplificate e relazioni industriali più costruttive e partecipative sono indispensabili per contribuire al potenziamento dell’industria del nostro Paese. Chiarito che nel sistema di Confindustria nessuna Associazione e nessuna impresa in-tende innovare violando o cancellando i diritti di chi lavora, vi è piena disponibilità a fare insieme a tutti i sindacati “un primo tagliando” all’accordo interconfederale del 2009. Quell’accordo ha riformato gli assetti della contrattazione confermando il valore del contratto nazionale e valorizzando la contrattazione aziendale. La riforma risponde proprio all’esigenza di costruire un contratto nazionale “più generale”, come chiede la Cgil, nella convinzione comunque che la contrattazione aziendale serve quando assi-cura alle imprese “normali” livelli di produttività, “normali” condizioni operative per il maggior utilizzo degli impianti, la “certezza” dell’attuazione degli accordi sottoscritti. Ed i contratti nazionali possono anche diventare “più larghi”, come propone ancora la Cgil e come, peraltro, è già stabilito negli impegni sottoscritti con l’accordo firmato con Cisl e Uil nel 2009. La competizione internazionale, comunque, può anche porre la ne-cessità di avere discipline specifiche per singole realtà aziendali o di comparto. Quindi, allargare il campo di applicazione dei contratti nazionali è un obiettivo, ma non può essere un vincolo. Razionalizzare è corretto, ma potrebbe risultare utile e necessario an-che “specializzare”. Le relazioni industriali devono essere un fattore di competitività ed occorre evitare che non producano i risultati attesi in ragione della mancanza di regole
6certe e condivise sulla rappresentanza. È per questo motivo che rimango convinto che a questo tipo di regole si debba giungere con un accordo interconfederale e non con una legge. La legge, eventualmente, interverrà dopo, per darne validità generale. Su questo, così come su tutti gli altri punti, Confindustria è pronta non solo a confrontarsi ma a concludere sollecitamente intese di immediata operatività. In altre parole, è pronta a realizzare quel confronto “serio e pacato” - sollecitato dal Presidente della Repubblica - che possa consentire alle parti sociali di semplificare le regole del lavoro. Semplificare non vuol dire ridurre le tutele, bensì renderle effettive.
7Un patto sociale per rispondere alle nuove sfide nell’economia e nel lavoro
Sono molte le “cose nuove “ del tempo attuale che rimettono in discussione in profon-dità i capisaldi su cui si è sviluppata la crescita dell’economia e della coesione sociale nelle società europee e con esse ridisegnano le prospettive future.
Sono due nello specifico le questioni più spinose che sollecitano particolarmente il sindacato.
La prima sfida è data dal fatto che si è rotto il nesso diretto tra sviluppo e lavoro, fe-nomeno già presente da alcuni anni ed accentuato ora dalla crisi economico-finanziaria ancora in corso; in secondo luogo la crisi incide pesantemente sui bilanci degli Stati de-terminando l’esplosione del debito pubblico e spingendo alla riduzione delle prestazioni del welfare con forti rischi che vengano pregiudicate anche in forma sostanziale le tutele sociali dei cittadini.
Sono entrambe tendenze ruvide ma non temporanee, si tratterà di farci i conti per un periodo almeno di medio termine. Diventa quindi necessario organizzare sul piano politico, sociale ed economico una nuova capacità di risposta per fronteggiarne gli effetti e salva-guardare anche in questo nuovo contesto, sicuramente insidioso, le condizioni che possano determinare in misura adeguata qualità dello sviluppo e qualità dell’occupazione.
Rilanciare sviluppo e lavoroSul piano dell’economia e del lavoro il compito è particolarmente arduo, dopo il pe-
sante fallimento dell’economia finanziaria alla quale soprattutto nell’area occidentale non si riesce ancora a sostituire una nuova economia “ reale “ basata sulla produzione di beni e servizi e non sulla speculazione.
Questa incertezza che attraversa in questo momento soprattutto l’Europa, unita alla velocità e all’intensità con cui lo sviluppo si consolida in altre aree del mondo (i c.d. paesi BRICS) determina le grandi difficoltà cui stiamo assistendo: tassi annui di crescita stentati oscillanti tra 0 e 1%, aumento della disoccupazione tornata a sfiorare il 10% in Europa (con una minor incidenza in Italia dovuta solamente all’estensione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), difficoltà generalizzata a promuovere nuove occasioni occupazionali, con una forte penalizzazione delle giovani generazioni .
Per vincere questa sfida, invero molto dura, sono necessarie politiche incisive e co-ordinate che ogni Stato deve approntare, ma che, in via prioritaria, sarebbe necessario fossero assunte a livello Europeo, innanzitutto sul versante delle politiche industriali e di sviluppo, con una prospettiva nuova di favorire soprattutto l’innovazione nella produzio-ne, attraverso la promozione della ricerca sulle nuove fonti di energia, su nuovi materiali, alzando la soglia della qualità per evitare la trappola del dumping sui costi che già sta im-poverendo il panorama industriale europeo, a vantaggio del nuovo baricentro produttivo orientato ormai verso le economie emergenti dell’oriente.
Sul piano nazionale, nonostante la fase acuta di instabilità politica, le parti imprendi-toriali e sindacali, hanno elaborato una serie di proposte riguardanti le politiche possibili per rilanciare lo sviluppo e la produttività complessiva del Paese che, nella loro parte sostanziale dovrebbero essere ora recepite e messe in atto dal Governo e per le loro com-petenze anche dai livelli istituzionali decentrati. Si tratta di rilanciare le infrastrutture e
Due questioni principali sollecitano il sindacato: la rottura del nesso diretto tra sviluppo e lavoro; l’esplosione del debito pubblico e la riduzione del welfare. L’incertezza in Europa, unita all’intenso sviluppo di altre aree del mondo determina grandi difficoltà. Sarebbero necessarie politiche coordinate a livello europeo per favorire l’innovazione. Sul piano nazionale, gli imprenditori e i sindacati hanno elaborato proposte per rilanciare sviluppo e produttività. È in corso una rilettura di molte conquiste del sindacato e la progressiva uscita dalla retorica dell’intoccabilità dei diritti. L’importanza della coesione sociale impone la salvaguardia dei diritti sociali e l’attenzione sulle condizioni perché essa sia possibile.
di Giorgio Santini, segretario confederale Cisl
8gli investimenti in particolare in ricerca ed innovazione, di superare la dipendenza energe-tica, di semplificare e razionalizzare gli adempimenti burocratici, di ridurre il peso fiscale su lavoro ed investimenti, di utilizzare la contrattazione collettiva riformata per favorire nuovi investimenti e maggiore occupazione, di affrontare in termini nuovi il rilancio dello sviluppo nel Sud, innanzitutto impegnando la classe dirigente nazionale e regionale ad ottimizzare, in chiave di sviluppo e lavoro, l’utilizzo dei fondi nazionali ed europei, oggi penosamente sprecati.
Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, va finalmente e compiutamente attuata la flexicurity seguendo le migliori esperienze in atto in Europa, con la capacità di rimodel-lare in modo dinamico i diritti e le tutele dei lavoratori, in un contesto di flessibilità e di variabilità destinato a rimanere tale per un tempo molto lungo.
Ciò significa rileggere in chiave nuova molte conquiste storiche del movimento sinda-cale dei lavoratori: gli ammortizzatori sociali è necessario che siano estesi a tutti coloro che ne hanno necessità, ma perché ciò sia possibile è necessaria una mutualità da parte di tutti i soggetti così come è essenziale che gli ammortizzatori sociali responsabilizzino chi li percepisce all’impegno attivo per riqualificarsi professionalmente e rendersi disponibile in vista di un rapido reimpiego.
Sul versante contrattuale è necessario uscire dalla retorica dell’intoccabilitàdi diritti astrattamente concepiti, bensì mobilitarsi e mobilitare le migliore energie di ogni territo-rio per determinare innanzitutto le condizioni di mantenimento e sviluppo delle attività economiche e produttive che rendano possibile la negoziazione dei giusti diritti e delle tutele per i lavoratori. I recenti fatti riguardanti gli investimenti Fiat a Pomiglianostanno a dimostrare come di fronte ad un mondo che cambia non si può solo star fermi a riven-dicare la giustezza delle proprie tesi, ma ci si deve metter in cammino per commisurare le imprescindibili necessità dei lavoratori alle condizioni con cui si possano in concreto realizzare ed adeguando a questo, anche con le necessarie deroghe, i propri strumenti contrattuali, come è stato fatto nel 2009 con la riforma della contrattazione collettiva in Italia, vero spartiacque nelle relazioni sindacali tra imprese e lavoratori, fondato sullo sviluppo della contrattazione decentrata, sul collegamento tra salario e produttività, su minore conflittualità e più partecipazione, su esperienze sempre più ampie di bilateralità.
Un nuovo Welfare per la coesione socialeLa sfida sul Welfare è se possibile ancora più ardua, determinata dall’intreccio delle due
tendenze che contrassegnano la grave crisi che stiamo vivendo: la lentezza dello sviluppo e al contrario la pesantezza dei bilanci statali e la necessità di ridurre il debito.
L’importanza della coesione sociale impone la salvaguardia dei diritti sociali e, con grande nettezza la necessità di focalizzare l’impegno di tutti sulle condizioni perché ciò sia possibile. Sono necessarie politiche rigorose e selettive che sappiano innanzitutto tagliare la spesa pubblica inutile, inefficiente, legata a sprechi e/o privilegi anche quando attorno ad essa si siano creati dei blocchi di rendita di natura politica ed economica che contraste-ranno questa scelta. Ma non ci sono alternative su questa discriminante si gioca il futuro dello stato sociale e non ci possono essere né ambiguità né tentennamenti.
Oltretutto, come ci ricorda magistralmente la teoria di AmartyaSen, uno stato sociale così inteso come produttore di opportunità sociali, può diventare esso stesso fattore di sviluppo economico ed occupazionale. Tra i nuovi bacini occupazionali da scoprire e da far
9emergere rapidamente dall’opacità del lavoro irregolare e clandestino che oggi li connota, ci sono i c.d. White Jobs, vale a dire i lavori legati alla cura delle persone che variano in senso molto ampio dai servizi assistenziali ed educativi dell’infanzia fino all’assistenza de-gli anziani, passando per il vasto arcipelago della sanità. In particolare il lavoro di cura per gli anziani, se si sapranno organizzare politiche coordinate che sostengano fiscalmente le famiglie che ne hanno necessità e nel contempo lo regolarizzino sul piano contrattuale e professionale, può generare realmente un valore aggiunto sul piano occupazionale, come peraltro dimostrato da esperienze positive già in atto in alcuni paesi europei. In tema di sostegno concreto alla famiglia questo è un progetto sociale da realizzare quanto prima anche in Italia.
L’economia sociale di mercato rappresenta quindi una prospettiva credibile ma al tem-po stesso è molto esigente sul piano dell’innovazione delle pratiche organizzative e della concezione stessa dei servizi che da fatto puramente assistenziale (e quindi assimilabile immediatamente a costo) diventano economicamente rilevanti e quindi possono generare valore ma dovranno rispettare le regole economiche della qualità e della concorrenza, diventando non più monopolio del settore pubblico ma potendo articolarsi all’interno di regole definite e standard qualitativi in diverse forme di privato e di privato-sociale.
La correzione delle anomalie della spesa pubblica e la sua maggiore qualificazione in senso sociale necessita anche che nel nostro Paese venga realizzata, senza ulteriori rinvii, la riforma fiscale, con l’obiettivo di preservare il gettito fiscale necessario al finanziamen-to del bilancio pubblico ma di ridistribuirne il carico sui soggetti che oggi pagano meno di quanto dovrebbero, lasciando quasi l’intero peso fiscale sulle spalle delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Non si spiega altrimenti la patologia italiana di oltre 120 miliardi di evasione fiscale, che recentemente il governatore della Banca d’Italia Draghi ha definito la vera “macelleria sociale” e che va combattuta, in modo condiviso, su tutti i fronti dal contrasto repressivo alla modifica delle norme che ne impediscano il formarsi alla fonte, alla maggiore tassazione dei consumi pregiati, dei patrimoni, delle transazione e delle rendite finanziarie per poter realizzare una riduzione del carico fiscale a partire dalla famiglia, dal lavoro e per promuovere lo sviluppo.
Il vero banco di prova del federalismo fiscale sta proprio in questo: da un lato deter-minare una maggiore efficienza nella spesa pubblica, in base alla generalizzazione dei costi standard, dall’altro di imporre una maggiore equità e giustizia fiscale per recuperare dall’area dell’evasione fiscale e dell’inefficienza risorse da destinare a sostegno dei redditi, del lavoro e dello sviluppo.
10La necessità di politiche di sviluppo
Credo che un ragionamento sulle relazioni industriali ed il ruolo della contrattazione debba prendere le mosse da una riflessione sulla crisi che ha investito vaste aree del pia-neta ed ha avuto ricadute assai pesanti sull’economia e sull’apparato produttivo italiano, portando allo scoperto le criticità del sistema.
Siamo di fronte ad un crollo che non ha precedenti nella storia repubblicana e che vede non solo l’Italia più esposta rispetto ad altri paesi dell’Eurozona, ma anche più debole nelle capacità di reazione. Le risposte finora messe in atto dal Governo si sono mantenute su misure di carattere meramente difensivo e non di prospettiva.
L’assenza di una politica di sviluppo rischia di provocare un arretramento del Paese ed una perdita di competitività anche delle aree più avanzate, quali il Nord Est, a fronte dei processi che investono con grande velocità il mondo globalizzato.
Pensare di riprodurre in Italia condizioni di paesi più arretrati è una ricetta miope e perdente. Le performance della Germania, dove i salari sono più elevati che da noi e la sfida si gioca sui segmenti alti della competitività, sta a dimostrarlo.
Siamo ad un punto critico ed è indispensabile che la politica e gli attori sociali compia-no un ripensamento sul sistema paese e sulle difficoltà della nostra economia a ripartire, con una domanda interna sostanzialmente bloccata.
La questione salariale va assunta a priorità non solo perché siamo ai livelli più bassi della classifica europea, ma anche per la presenza di distorsioni che col tempo, anziché attenuarsi, si sono andate approfondendo. Da 20 anni a questa parte abbiamo assistito ad una caduta drastica di potere d’acquisto delle retribuzioni cui è corrisposta una redi-stribuzione della ricchezza a favore delle rendite finanziarie, mentre gli investimenti sono rallentati (dal 1980 al 2008 la quota di investimenti in rapporto ai profitti è scesa del 38,7%).
La forbice si è allargata al punto che l’Italia è divenuta un paese profondamente “di-seguale”, con tutte le conseguenze negative sulle potenzialità di crescita e di sviluppo che ciò comporta. Secondo le stime della Banca d’Italia, quasi metà della ricchezza del Paese (45%) è nelle mani del 10% delle famiglie, mentre il 50% della popolazione possiede solo il 9,8% della ricchezza netta complessiva.
Non solo; nonostante la caduta di potere d’acquisto dei salari (la Cgil calcola una per-dita cumulata pari a 5.453 euro dal 2000 al 2010), aumenta il costo del lavoro per unità di prodotto: un paradosso tutto italiano che ha visto il clup salire in Italia di 5 punti a differenza degli altri paesi europei (in Germania è sceso di 4 punti).
Ciò significa che c’è una perdita di produttività ed è evidente che il nostro Paese sta pagando una politica economica che inasprisce la pressione fiscale sul lavoro dipendente, disarticola il welfare e i diritti e non punta alla ricerca, alla formazione ed all’innovazio-ne.
Pur in presenza di un quadro articolato, che vede ad esempio le medie imprese crescere più delle altre sul piano della produttività senza che tuttavia a ciò corrisponda maggio-re salario, va evidenziata una bassa propensione agli investimenti in ricerca e sviluppo (0,60% sul Pil da parte delle imprese nostrane contro il 2,01% degli Stati Uniti e l’ 1,83% della Germania) ed una maggiore incidenza del fattore lavoro rispetto al capitale nella crescita della produttività italiana (0,7 contro lo 0,4 annuo dal ’95 al 2007).
L’Italia pare trovarsi di fronte ad un crollo che non ha precedenti, con un arretramento del Paese anche nelle sue aree più avanzate. Si è registrata la caduta di potere d’acquisto delle retribuzioni cui è corrisposta una redistribuzione della ricchezza a favore delle rendite finanziarie, mentre gli investimenti sono rallentati. Pare aumentare il costo del lavoro per unità di prodotto, a indicare una perdita di produttività. Un accordo generale sulla crescita dovrebbe mettere al centro la riforma degli ammortizzatori sociali, la riforma fiscale per alleggerire il prelievo sul lavoro spostandolo verso le rendite, un piano di investimenti per l’innovazione, il potenziamento delle infrastrutture.
di Emilio Viafora, segretario generale CGIL Veneto
11È questo il nodo da sciogliere e per questo è sbagliata la ricetta della Fiat che nascon-dendosi dietro il dito dell’assenteismo (quasi che le aziende italiane non disponessero già di fior di strumenti contro comportamenti illeciti) attacca diritti indisponibili quale quello di sciopero o penalizza i lavoratori ammalati.
Dopo le ultime dichiarazioni di Marchionne sulla scarsa redditività degli stabilimen-ti italiani e la bassa remuneratività del nostro mercato, esponenti sia del Governo che dell’opposizione hanno detto che la Fiat guarda al nostro Paese con la logica di una multi-nazionale. Se così è, non possiamo pensare che quella della Fiat possa essere la sede in cui tracciare la strada maestra delle relazioni industriali.
Una competizione giocata sull’abbattimento dei costi e dei diritti non serve ed è stata la causa dell’attuale difficoltà italiana a competere nei segmenti alti della divisione inter-nazionale del lavoro.
Occorre voltar pagina e puntare ad un accordo generale sulla crescita e lo sviluppo che abbia al centro alcuni grandi temi, quali la riforma degli ammortizzatori sociali da esten-dere all’intero mondo del lavoro; la riforma fiscale per alleggerire il prelievo sul lavoro spostando il carico verso le rendite ed i grandi patrimoni e da sostenere con una efficace lotta all’evasione; un piano di investimenti per potenziare l’innovazione e la ricerca; il po-tenziamento delle infrastrutture materiali ed immateriali; l’incremento della produttività.
Tutto questo presuppone un nuovo quadro di relazioni industriali, sanando il vulnus arrecato da rotture che non hanno aiutato a guardare in avanti nel pieno della crisi.
Usciamo da una fase estremamente difficile, segnata dall’accordo separato sulla ri-forma della contrattazione del 22 gennaio, dall’accordo separato sul contratto dei me-talmeccanici, dalla vicenda di Pomigliano fino al recesso del contratto 2008 da parte di Federmeccanica.
Queste ultimi due atti sono indice di una concezione autoritaria dei rapporti sindacali. Fabbrica Italia si basa sulla disponibilità immediata all’organizzazione proposta dall’azien-da che si riserva di rendere noti ed effettuare gli investimenti solo a seguito della piena accettazione delle condizioni imposte.
In tal modo si azzera il dialogo sociale proprio in una fase in cui, a fronte della velocità delle trasformazioni, la forza soprattutto delle piccole e medie imprese risiede nella quali-tà delle risorse umane (e quindi delle buone relazioni), oltre che nella capacità di innovare e fare sistema.
L’accordo del 22 gennaio va profondamente rivisto. Dopo quella data abbiamo rinno-vato 55 contratti nazionali che non hanno fatto proprio quell’impianto e che indicano la necessità di un nuovo modello che, senza smantellare il contratto nazionale (come avver-rebbe con il sistema derogatorio previsto dall’accordo del 22 gennaio), sposti di più il peso - e renda esigibile per una platea di lavoratori più larga dell’attuale - il II livello di con-trattazione dove redistribuire la produttività. Questo implica un maggiore coinvolgimento delle Rsu (rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro) nella definizione delle strategie aziendali, degli obiettivi e nel governo degli orari e dell’organizzazione del lavoro.
Tutto ciò è possibile se si punta ad un quadro di relazioni sindacali che assuma la di-versità degli interessi come un dato fisiologico.
Trovo fuorviante la discussione sulla fine della contrapposizione capitale/lavoro, men-tre è più interessante una riflessione sull’evoluzione delle relazioni pensando, ad esempio, a forme di codeterminazione. Forme di partecipazione dei lavoratori all’azionariato delle
12imprese sono da escludere perché indurrebbero logiche distorsive ed oltretutto costringe-rebbero il lavoratore, a digiuno di finanza, ad impegnare una quota del proprio reddito in un titolo azionario esposto ai molteplici fattori che agiscono sui mercati finanziari.
Un tema che va invece assolutamente affrontato è quello relativo alle regole che le-gittimano i soggetti della contrattazione e presiedono alla validazione di piattaforme ed accordi ai vari livelli, dal luogo di lavoro, al contratto nazionale fino alle intese a carattere interconfederale.
Una legge sulla rappresentanza (magari preceduta da un accordo endosindacale e pat-tizio) è indispensabile per definire i soggetti deputati a trattare in quanto espressione dei lavoratori cui – cosa che non va mai dimenticata - resta in capo la titolarità contrattuale.
Il secondo aspetto riguarda la democrazia nel lavoro, tanto più necessaria in una fase in cui si manifestano differenze tra organizzazioni sindacali. Il pronunciamento dei de-stinatari degli accordi (sarebbe opportuno portare la validazione oltre la soglia del 51% per favorire le coalizioni e scoraggiare intese separate) deve diventare una regola e non l’eccezione di comodo a fronte di ricatti aziendali.
Sono due condizioni fondamentali perché solo partendo da qui è possibile delineare un quadro evoluto di relazioni sindacali capace di cogliere le sfide del nuovo millennio tutelando il lavoro e consentendo alle imprese di crescere ed innovarsi. Questo mi pare l’unico terreno possibile per delineare un nuovo patto sociale tra attori che insieme devo-no affrontare la sfida dell’innovazione indotta dalla globalizzazione.
13La ripresa dopo la crisi economica si sta manifestando in modo selettivo. Le imprese più preparate nei settori tradizionali evidenziano un modello che appare destinato a fondarsi sull’integrazione tra intelligenza ed esperienza delle risorse umane e su una natura comunitaria dell’impresa. Le società pubbliche dovrebbero prevedere modelli di governance dove risultino separati organismi di sorveglianza e di gestione. L’intervento in situazioni di crisi potrebbe essere demandato a task force con istituzioni locali, associazioni sindacali e datoriali. Un ruolo più ampio potrebbe avere la contrattazione di secondo livello, per regolare campi come la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria, l’accesso ai servizi.
di Maurizio Castro, parlamentare del Pdl
Le relazioni industriali come vettore di coesione sociale
Lenta, selettiva, discontinua: così si sta manifestando la ripresa, dopo l’alluvionale irruzione della Grande Crisi nelle economie dell’Occidente. Eppure, sono già nitide le tra-iettorie che saranno seguite dalle imprese migliori, imprimendo il segno e il senso al corale cammino del sistema verso una nuova stagione di solidità e di sviluppo. I “campioni” ope-reranno nei settori tradizionali delle produzioni italiane, dalla moda all’alimentare, dalla meccanica all’arredamento, là dove più autenticamente si dispiegano le nostre “compe-tenze distintive”, quasi etnicamente connotate, riposizionandosi tuttavia nei segmenti più elevati dei mercati internazionali; il focus delle loro azioni imprenditoriali si concentrerà sul “prodotto” e non già sul “processo”, in coerenza con un approccio che rivaluta i mar-gini generati dal riconoscimento e dalla remunerazione di innovazione e qualità creativa, anche a costo di sacrificare i volumi; la loro dimensione sarà prevalentemente media, a coniugare robustezza e agilità, e scandita la loro vocazione all’esportazione, soprattutto lungo le nuove “vie della seta” che conducono a Est e a Sud; e, soprattutto, il loro modello culturale e organizzativo sarà fondato sul primato del sistema integrato di intelligenza-esperienza-sapienza delle loro risorse umane e sulla ribadita natura comunitaria e par-tecipativa dell’impresa, in cui confluiscono interessi diversi nella provenienza sociale, ma identici nel télos politico.
La centralità delle relazioni industriali come vettore di una coesione sociale divenuta cruciale fattore competitivo è dunque evidente in un simile schema, soprattutto in quelle aree della Nazione le cui imprese più limpidamente incarnano i requisiti per il ritorno allo sviluppo, cominciando dal nuovo “triangolo industriale” (Milano, Bologna e Pa-Tre-Ve). Proviamo allora a stilare una sorta di agenda per le R.I. di quest’area, individuando alcuni interventi propulsivi.
Innanzitutto, va implementata esplicitamente una cultura della partecipazione ancora attardata in una dimensione pre-organizzativa. In questa direzione, propongo tre speri-mentazioni: l’adozione, in tutte le società a controllo pubblico e di adeguata consistenza, a muovere dalle multiutility, del modello duale di governance, distinguendo un Consiglio di Sorveglianza per la definizione delle strategie e per il controllo dei risultati da un Consiglio di Gestione attraverso il quale un management indipendente realizzi gli obiettivi assegnati e prevedendo la strutturale rappresentanza nel primo dei dipendenti; la diffusione in tutti i settori, per effetto di accordi aziendali coordinati e assistiti da un livello regionale di mo-nitoraggio e di garanzia, della distribuzione di una quota degli utili ai lavoratori; l’ingresso dei collaboratori nell’azionariato di aziende in sviluppo e caratterizzate dal decisivo con-tributo organizzativo di personale qualificato, attraverso aumenti di capitale loro dedicati e finanziati dal trattamento di fine rapporto e dalla premialità di risultato.
Inoltre, va rafforzata la rete di “sutura” delle lacerazioni del tessuto produttivo e socia-le, mercé la costituzione a livello territoriale, attraverso accordi triangolari della Province con le associazioni sindacali e datoriali, di task-force per il monitoraggio preventivo delle aree di crisi, per l’attivazione mirata e tempestiva di ogni opportuno strumento contrat-tuale in deroga per la salvaguardia dei livelli occupazionali e/o per la riallocazione profes-sionale dei lavoratori in eccedenza ovvero per l’implementazione di programmi collettivi di assunzione in occasione di start-up e per la predisposizione di congrui bacini di alimen-tazione delle risorse professionali critiche attraverso acconci strumenti di on the job trai-
14ning e di relativa certificazione delle competenze affidata a organismi bilaterali. Ancora, nella prospettiva di prevenire il conflitto sociale, vanno realizzati accordi per demandare la risoluzione delle controversie individuali e collettive di lavoro a rapidi, efficaci e affidabili lodi arbitrali, lungo la via tracciata dal Collegato Lavoro di recente approvazione.
Ancora, va sviluppata la virtuosa tendenza a superare la tradizionale perimetrazione della contrattazione di secondo livello al sinallagma prestazione-mercede, estendendone il campo d’interesse e di regolazione a materie di crescente rilievo: la previdenza comple-mentare, per esempio introducendo una sorta di tertium genus rappresentato dal fondo aperto “personalizzato” dagli accordi sindacali aziendali che ne prevedono l’accesso; l’as-sistenza sanitaria integrativa, almeno per la copertura dei segmenti meno presidiati dal servizio pubblico come i grandi interventi e le cure odontoiatriche, affiancata da polizze protettive dei rischi d’un invecchiamento protratto e non-autosufficiente; il mantenimento dell’”ascensore sociale”, attraverso la previsione di borse di studio e di incentivi economici a favore dei figli dei dipendenti che frequentino profittevolmente corsi d’istruzione univer-sitaria e post-universitaria d’eccellenza; l’accessibilità a servizi qualificati che garantiscano e favoriscano la conciliazione dei tempi di vita come asili e Kinderheim o come l’assistenza domiciliare ai familiari anziani, ovvero promuovano la fruizione culturale e la salute, come abbonamenti o sconti per teatri, musei, concerti, librerie, palestre; l’agevolazione al ricorso a prestiti per il consolidamento e il radicamento delle famiglie dei collaboratori.
Sul versante poi della P.A., una nuova stagione di contrattazione tra gli Enti locali e le organizzazioni sindacali deve favorire significativi recuperi di efficienza, magari attraverso la costituzione di società miste tra soggetti pubblici, che apportino i volumi, e privati, che apportino competenze e investimenti per le piattaforme tecnologiche, ove far confluire e concentrare le attività di back-office delle amministrazioni locali e delle loro aggregazioni connotate da basso tasso di efficienza e da alto tasso di competenza specialistica di ge-stione (amministrazione del personale, contabilità, tesoreria, facility management, acqui-sti, sistemi informativi, progettazioni, relazioni esterne, safety & security, etc.), applicando rigorosi modelli di price-cap.
Si tratta di un’agenda concreta, con progetti ad alta densità di cambiamento e insieme di facile e pronta esecuzione. Ma il suo successo è inesorabilmente legato ad alcune con-dizioni di fondo: sul fronte sindacale, il definitivo abbandono di ogni tentazione antagoni-stica e il compiuto riconoscimento di un modello di modernizzazione delle relazioni indu-striali italiane fondato sulla cultura della responsabilità, della collaborazione, del primato del bene comune, pena l’autoesclusione dall’arena negoziale; sul fronte imprenditoriale, la scelta senza trucchi di un high-road strategy, cioè di un modello competitivo orientato alla produzione di beni e servizi caratterizzati da originalità e distintività e dunque da machinery organizzative plurali, inclusive e partecipative; e, sul piano istituzionale, l’ac-cettazione compiuta e convinta del principio di sussidiarietà, che nella riforma federale conduce a bandire ogni inclinazione verso neo-centralismi a base regionale e a scandire invece la relazione strutturale e integrale, fiduciariamenteatteggiata, con i corpi intermedi e le rappresentanze organizzate delle categorie e delle professioni come presupposto di un’”economia sociale di mercato” coraggiosa, aperta, intensa. Così s’inverano i presupposti per riportare l’Italia a svolgere un ruolo cruciale nello scacchiere internazionale, approfit-tando di quel “salto di paradigma” che la Grande Crisi ha cagionato e che ha sconvolto le gerarchie mondiali formatesi negli Anni ‘70.
15Pomigliano e altri casi pongono alle aziende e ai sindacati il problema della competizione globale. Diviene opportuno cambiare il sistema delle relazioni industriali. L’attuale sistema normativo soffoca gli spazi per la contrattazione collettiva e non consente la ricerca di una base di diritti comune a tutti i contratti di lavoro. Una semplificazione porterebbe più flessibilità e la possibilità di deroghe per fronteggiare situazioni di crisi. L’alleggerimento del contratto nazionale lascerebbe agli accordi decentrati lo spazio per governare le diversità aziendali e ridimensionerebbe le deroghe allo stesso contratto. Il rischio è che prevalga una competizione basata sulla compressione dei costi e delle condizioni di lavoro.
di Tiziano Treu, parlamentare del Pd
Quale mutamento per le relazioni industriali?
Le Relazioni Industriali devono cambiare perché sono cambiati i fondamentali su cui sono state costruite nei decenni passati: l’impresa fordista, la classe operaia, lo Stato-nazione. Pomigliano e altri casi di difficoltà aziendali pongono alle aziende e ai sindacati il problema di come cambiare: come affrontare una competizione globale sempre più dura, con quali condizioni di lavoro, ma anche con quali innovazioni e con quale tipo di competitività.
Prima di discutere di specifiche modifiche, occorre cambiare i criteri con cui affron-tare il cambiamento, evitando due opposti atteggiamenti, entrambi pericolosi; la difesa ad oltranza dell’esistente e l’arrendevolezza a priori alle esigenze del mercato. La prima preclude la ricerca di nuove regole (giuridiche e contrattuali) rispondenti ai nuovi biso-gni e può portare a favorire una selezione perversa, cioè a una conservazione dei diritti acquisiti, anche oltre il necessario, nelle zone più forti o più protette a scapito di quelle più deboli o più esposte. Il secondo atteggiamento è rinunciatario e può comportare un arretramento generale dei diritti e delle condizioni di lavoro.
Il cambiamento deve riguardare non solo le Relazioni Industriali ma anche le regole legali, perché l’attuale giungla di norme soffoca gli spazi alla contrattazione collettiva, alle innovazioni, anche quelle virtuose, spesso non tutela i bisogni dei nuovi lavori e perpetua situazioni indifendibili.
Per questo ho proposto di sfoltire questa giungla normativa per ricercare una base di diritti comune a tutti i lavori (dipendenti, parasubordinati e autonomi); una base che comprenda i fondamentali diritti di libertà, le tutele universali del reddito in caso di inattività, accompagnate da politiche attive di formazione, un compen-so minimo per il lavoro svolto, e in prospettiva pensioni di base comuni. Questo “zoccolo sociale” fornirebbe un sostegno anche alla contrattazione collettiva (vedi più ampiamente T. Treu, Trasformazioni del lavoro e indicazioni di policy, in Italiani Europei, 2009, p 257 ss.).
Un’operazione simile di sfoltimento è necessaria anche per i contratti collettivi na-zionali. Oggi essi sono sovraccarichi di norme di dettaglio, inutilmente rigide, (il contrat-to attuale dei metalmeccanici è di oltre 250 pagine). L’inflazione normativa impedisce una gestione flessibile dei rapporti di lavoro rispondente alle esigenze del diversificato panorama delle aziende e dei lavori.
Il contratto collettivo nazionale deve diventare veramente una normativa quadro che dia le direttive per il governo delle relazioni Industriali e stabilisca trattamenti di base comuni a tutto il Paese.
Anche il numero dei contratti nazionali è pletorico (oltre 460) e va ridotto a non più di 10-15. Passi in questa direzione sono stati fatti già nell’accordo del luglio 1993, e poi in quello del 22gennaio 2009; ma con forti limiti, per le resistenze, specie della CGIL, ad abbandonare l’idea rassicurante, ma illusoria, di contratti omnibus.
Occorre procedere su questa strada in due direzioni diverse ma convergenti: una forte semplificazione contrattuale che serve in generale a dare maggiore flessibilità all’intero sistema e a valorizzare le autonomie decentrate; la possibilità di deroghe che risponde alla necessità di fronteggiare specifiche situazioni di crisi o esigenze particolari.
16L’alleggerimento del contratto nazionale lascerebbe agli accordi decentrati lo spazio per governare le diversità aziendali e territoriali e ridimensionerebbe anche la necessità di ricorrere a deroghe allo stesso contratto, limitandole a casi specifici e temporanei, riducendo quindi i rischi di destabilizzazione del sistema.
È importante che le deroghe siano controllate a livello nazionale per quanto riguar-da gli ambiti e le condizioni applicative. Così prevede l’accordo del 2009, e l’indicazione confederale dovrebbe essere specificata nella trattativa in corso fra Federmeccanica e sindacati di categoria.
Una regolazione delle deroghe è oggi particolarmente importante perché esse devo-no fronteggiare criticità aziendali causate dalla competizione globale e non solo soste-nere processi di sviluppo come era nel caso dei contratti degli anni ’90 (quando clausole di deroga furono concordate anche con la CGIL).
Tutte le condizioni definite nel contratto sono in principio negoziabili, mentre resta salvo il limite delle condizioni regolate in tutto o in parte per legge.
L’accordo di Pomigliano ha riproposto la questione dei limiti di diritto di sciopero. La tesi che lo sciopero sia un diritto non negoziabile è una costruzione dottrinale, elaborata storicamente ma non necessaria per l’ordinamento italiano (come per altri sistemi europei). Questo non significa che ogni limite allo sciopero sia ammissibile. Non sarebbero ammissibili clausole di tregua cd. assolute che obblighino ad astenersi da qualunque sciopero. Ma non è questo il senso dell’accordo di Pomigliano: esso prevede un obbligo circoscritto, quello di astenersi da scioperi che contrastino con il rispetto de-gli obiettivi produttivi concordati, in particolare astensioni dal lavoro nei sabati previsti come lavorativi. Il rispetto di tali obiettivi è essenziale per la competitività aziendale e per l’affidabilità dei sistemi di Relazioni Industriali.
Una simile valutazione di merito va fatta anche per altre modifiche contrattuali e rinunce ai trattamenti in atto. L’esperienza mostra scambi di successo, ma anche casi in cui le rinunce ai diritti sono state inutili agli stessi fini occupazionali.
L’utilità degli scambi dipende dall’equilibrio realizzato fra gli interessi e i valori in questione. A tale proposito sono importanti le condizioni di contesto in cui questi scambi si attuano. Solo politiche di impresa innovative, sostenute da coerenti politiche pubbliche di sostegno, possono permettere scambi virtuosi. In mancanza di contesti fa-vorevoli il rischio è che prevalga una competizione al ribasso basata sulla compressione dei costi e delle condizioni di lavoro, tale da costringere lavoratori e sindacati ad accordi squilibrati, ponendo l’alternativa inaccettabile fra lavoro e diritti.
La qualità dei patti dipende inoltre dal grado di consenso e di unità fra le organiz-zazioni sindacali e dal loro coinvolgimento nelle scelte dell’impresa. Ambedue le con-dizioni sono carenti in molte delle nostre vicende sindacali, non solo di Pomigliano. E il governo non si attiva per propiziarle, come dovrebbe.
La situazione è aggravata dalla mancanza di regole condivise, contrattuali o legali, per dirimere le eventuali convergenze sorte fra sindacati. In mancanza di tali regole, il dissenso, anche di minoranze, può vanificare gli effetti, non solo giuridici, degli accordi, compreso quello di Pomigliano.
In conclusione, Pomigliano è una provocazione, utile se viene raccolta, con innova-zioni condivise e partecipate dei rapporti di lavoro, in grado di promuovere una compe-titività aziendale basata sulla qualità. La divisione sindacale e lo scontro non aiutano a
17fronteggiare le sfide globali.Occorre perseguire Relazioni Industriali meno conflittuali e più partecipate, come
mostrano gli esempi stranieri di successo, a cominciare da quelli tedeschi.Anche in Italia molte aziende, fortunatamente, stanno seguendo questa strada e
dimostrando che si possono ottenere buoni risultati senza rotture sindacali anche nel difficile contesto competitivo attuale.
18È in corso un processo di indebolimento economico e sociale del lavoro. Lo testimoniano la dinamica del salario reale, il calo della quota-lavoro nella distribuzione del reddito, il divario fra i guadagni degli operai e dei manager, i tempi del lavoro. Le ricerche confermano che i lavoratori hanno oggi meno speranze nel futuro e più timori per i figli, ai quali vorrebbero offrire opportunità migliori. In Occidente pare potersi riscontrare una situazione di crisi dei sindacati, accompagnata all’arretramento elettorale delle sinistre, il cui sostegno aveva promosso e veicolato le istanze operaie. In questo scenario va collocata la questione dei contratti collettivi di lavoro, ove si delinea una strategia motivata dalla globalizzazione.
di Aris Accornero, docente presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Debolezza del lavoro e deroghe ai contratti
Si lamenta spesso l’invisibilità, la solitudine, la sparizione degli operai. (Questo in Occidente, giacché in Oriente gli operai stanno crescendo a milioni e si stanno anche facendo sentire, come mostra il caso cinese). Purtroppo, al di là di tali immagini e sensazioni, c’è la dura realtà: nessuno può negare che siamo in presenza di un netto indebolimento economico e sociale del lavoro, e del suo mondo. Lo testimoniano la dinamica piatta del salario reale, la perdita di terreno rispetto al carovita, il calo della quota-lavoro nella distribuzione del reddito, i colpi di coda del drenaggio fiscale, il di-vario abissale fra i guadagni degli operai e dei manager, i tempi stessi del lavoro: da un lato gli orari di fatto si allungano vanificando la conquista storica delle 40 ore, dall’altro la pensione viene ritardata poiché crescono le aspettative di vita.
Sui trattamenti pesa anche il ridimensionamento delle imprese, dovuto alla colos-sale trasmigrazione di lavoratori avvenuta in questi anni, da quelle più grandi a quelle più piccole. E pesa la destrutturazione dei rapporti di lavoro, concentrata nel terziario e facilitata dai troppi impieghi a tempo determinato, che abbassano le paghe e diffondo-no insicurezze. Pesa infine la crisi finanziaria, dovuta alle follie del capitalismo ameri-cano, che si è abbattuta sui lavoratori, sia dipendenti che autonomi, facendo diminuire il tasso di attività e salire ulteriormente la quota degli inattivi. In Italia gli occupati sono tornati sotto i 23 milioni, mentre i disoccupati sono risaliti oltre i 2 milioni, e non accennano a diminuire (dopo la crisi del 1992-93, sebbene fosse meno grave, ci vollero ben sei anni per riassorbirli). Ne risentono anche le forme di lotta, che diventano più disperate, più isolate, più estreme. Del resto, tutte le ricerche confermano che i lavo-ratori hanno oggi meno speranze nel futuro e più timori per i figli, ai quali vorrebbero offrire qualcosa di meglio.
In tutto l’Occidente si assiste poi all’accerchiamento dei sindacati, di cui parla Guido Baglioni. I loro iscritti tendono a invecchiare e diminuire, mentre il loro potere viene eroso da politiche imprenditoriali che intaccano i trattamenti in atto, e da politiche pubbliche che ridimensionano le provvidenze del welfare. (In Italia c‘è anche una di-sunione sindacale che minaccia di diventare incurabile.) Ma non è colpa dei sindacati se, al mutar del secolo, le condizioni economiche e sociali del lavoro hanno cominciato a peggiorare. In termini di conquiste, la parabola sembra ormai discendente, tanto più che si accompagna all’arretramento elettorale delle sinistre, il cui sostegno aveva pro-mosso e veicolato le istanze operaie.
Questo indebolimento del lavoro sconta effetti ed errori di una globalizzazione e di una competizione le cui conseguenze economiche hanno travalicato e tradito quelle sociali. Paesi evoluti come Gran Bretagna e Stati Uniti hanno “esternalizzato” così tanto lavoro manuale da dipendere ormai da lontane “fabbriche del mondo”, dove costa poco. Le imprese che hanno ingaggiato lavoro in altri paesi, lucrando una concorrenza al ri-basso a spese della propria capacità produttiva, hanno oscurato gli operai stessi e, se li hanno favoriti come consumatori, non li hanno certo favoriti come lavoratori.
È questo lo scenario in cui va collocata la questione dei contratti collettivi di lavoro, ove si delinea una strategia motivata dalla globalizzazione e compendiata nelle deroghe alle intese nazionali. Ciò che emergeva già dall’accordo separato del 2009 sul sistema contrattuale (cui manca “soltanto” la firma del sindacato più forte) è stato ribadito dal-
19le perentorie condizioni poste da Sergio Marchionne per investire nello stabilimento ex Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco, scelto appositamente come test “o la va o la spacca”. È un’iniziativa che mira formalmente a un contratto del settore auto (ma di fatto della sola Fiat), e la cui convenienza in termini di costi e di produttività viene polemicamente comparata, dal big business, alle performance dello stabilimento polacco ove l’impresa torinese, ormai globalizzata, produce da anni.
Si prospettano così delle relazioni industriali influenzate assai più di prima dal mer-cato globale. E qui bisogna essere chiari. Se il costo del lavoro dovesse assurgere a pa-rametro dirimente anche dove pesa meno di un decimo sul costo totale, come alla Fiat, ai lavoratori la globalizzazione finirebbe col costare un calo delle paghe, o la perdita del posto, o tutt’e due, né basterebbe lavorare più che negli altri paesi… Ecco perché molti lavoratori, un po’ ovunque, temono gli esiti socialmente regressivi della globalizzazione; e perché è del tutto miope chi li accusa di nazionalismo protezionista.
La strada delle deroghe ai contratti nazionali non può che dar luogo a un’artico-lazione e dispersione delle condizioni e dei trattamenti. Si deve quindi pretendere che alle deroghe si possa ricorrere - “in via sperimentale e provvisoria” - esclusivamente per contingenze eccezionali dell’impresa, sia negative che positive. Non dimentichiamo che da noi quasi metà degli occupati lavora ormai in aziende fino a 9 addetti, mentre in quelle oltre i 500 ce n’è appena il 16%, contro il 42% di trent’anni fa, e che la contrat-tazione di secondo livello interessa appena un terzo degli occupati. Questo ci impegna a non marginalizzare il contratto nazionale, pena un peggioramento di condizioni per il grosso dei lavoratori dipendenti. Basterebbe procedere ad accorpamenti e sfoltimenti in vista di un testo unico, almeno per tutta l’industria.
Bisogna poi vedere quali saranno i parametri da cui far dipendere la remunerazione della produttività: saranno elucubrati e improbabili come ieri, oppure pratici e condi-visi? A questo proposito bisognerebbe forse parlare di “partecipazione dei lavoratori”, anche se Confindustria e Federmeccanica da questo orecchio non ci sentono, mentre il ministro Maurizio Sacconi ripete che una legge non serve e basta la sussidiarietà. So-prattutto, occorre che le deroghe siano davvero finalizzate all’interesse di tutti anziché di una sola parte, il che farebbe perdere terreno ai lavoratori senza vantaggi credibili. Né basta certo esorcizzare il conflitto d’interessi fra capitale e lavoro sostenendo, come fa il ministro, che sopravvive soltanto per la Fiom e la Cgil, mentre il mondo è cambiato in meglio. No: negli ultimi decenni, per chi lavora, le cose si sono messe male.
D’altro canto la strada delle deroghe non è certo nuova, anzi: basta ricordare che lo stesso stabilimento Fiat di Melfi nacque grazie a un accordo - oneroso e coraggioso - negoziato e firmato da tutti i sindacati. Non sembrerebbe neppure indispensabile pre-vedere deroghe contrattuali, se non fosse che Marchionne vuole deroghe anche su voci finora non derogate o non derogabili; e che Federmeccanica e la stessa Confindustria si propongono di farne un largo uso, sia in caso di crisi e riorganizzazione, sia di sviluppo ed espansione. È comunque una strada che va oltre il riconoscimento imprenditoriale della contrattazione aziendale, avvenuto nel 1993 dopo ben 40 anni di recisi rifiuti. (Quando presiedeva la Confindustria, Antonio D’Amato parlava addirittura di anteporre il contratto aziendale a quello nazionale: assurdo, nel paese che in Europa ha la maggior quota di piccole imprese, con il minor numero medio di addetti.) Nel “Protocollo” del 1993 i vantaggi accordati alla parte di retribuzione destinata a remunerare la produt-
20tività erano purtroppo così ridotti da incoraggiare ben poco gli accordi in materia; la detassazione promessa oggi dal governo è meno avara e, di conseguenza, può arroton-dare maggiormente le paghe (e quindi “sventagliarle”).
Rispetto a quello statunitense, ai cui estremi stanno la contrattazione a livello azien-dale e il salario minimo per legge, il nostro modello è meno rozzo e più solidaristico, proprio perché centrato sul contratto nazionale e regolato - diciamolo - da parti “con-federali”. Ed è anche virtuoso, visto che in Italia giudici e giurisprudenza si riferiscono ai suoi contenuti anche in mancanza di un’apposita legge erga omnes. Non svalutiamolo.
21Attualmente, non sembra profilarsi una situazione di emergenza sindacale, con il caso Fiat che appare isolato. Si potranno però verificare altre situazioni in cui si dovrà decidere se mantenere in Italia le produzioni. Emerge così la necessità di un sistema di relazioni industriali caratterizzato da nuove condizioni organizzative a livello aziendale. Negli ultimi dieci anni un’evoluzione rilevante è stata la rottura dell’unità sindacale, che in passato aveva risolto il problema del peso specifico di ogni sindacato. Sono venute meno le regole della rappresentanza che garantivano l’attuazione degli accordi. Nuove regole offrirebbero modalità per l’applicazione degli accordi quando questi sono sottoscritti dalla maggioranza dei lavoratori.
di Innocenzo Cipolletta
Il ritorno delle tensioni sindacali
La controversia sindacale alla Fiat a Pomiglianoci riporta indietro nel passato: ancora una vertenza sindacale che stenta a concludersi; ancora la Fiat come terreno di lotta sin-dacale; ancora la Fiom come sindacato intransigente; ancora violenze e intolleranza delle posizioni altrui. Pare un film già visto. Ma non è così. Malgrado la crisi economica, la poli-tica di austerità, le molte ristrutturazioni e il rigonfiarsi della cassa integrazione guadagni, non ci troviamo affatto in una situazione di emergenza sindacale. Le relazioni industriali non sembrano mostrare tensioni di rilievo. La gestione delle aziende private non appare condizionata da incomprensioni tra datori di lavoro e lavoratori pur in un momento così difficile. Il costo del lavoro non appare essere la principale variabile che determina oggi la capacità competitiva delle imprese italiane, pur se c’è sempre chi ritiene che sia troppo elevato. Non si avverte un’esigenza di sovvertire il sistema delle relazioni industriali.
Il caso Fiat appare essere un caso a se, ma non per questo meno emblematico. È il caso di una grande azienda che deve aumentare rapidamente la produttività per rima-nere competitiva in un segmento del mercato di prodotti a basso valore unitario, quale è quello delle piccole auto utilitarie, che resta la principale produzione automobilistica della Fiat. Altre imprese si sono spostate, nel corso degli ultimi anni, verso segmenti di produzione a più alto valore unitario ed hanno delocalizzato gran parte della produ-zione a più basso valore unitario in paesi ove il costo del lavoro è più contenuto. Ma, poiché non tutte le aziende possono fare un vero salto di qualità e poiché non sempre conviene al Paese che ci siano delocalizzazioni di produzione, allora il caso Fiat torna ad essere emblematico per il nostro Paese. Tanto più che nel prossimo futuro ci potranno essere altri casi in cui sarà necessario decidere se mantenere nel nostro Paese specifiche produzioni o se conviene perderle.
Quello che appare evidente è che sempre più i problemi di ristrutturazione saranno aziendali e non settoriali, come erano stati nel passato. La crisi finanziaria ha colpito tutti i paesi e tutti i settori con una pesante recessione, ma ha finito per avere riflessi diversi da azienda ad azienda, pur nello stesso settore. Ormai il mercato mondiale si è allargato notevolmente e le aziende hanno di fronte a loro opportunità e rischi diffusi. Chi riesce a qualificare la propria produzione e a inserirsi in mercati in crescita può salvaguardare profitti e lavoro. Chi invece è attaccato dalla concorrenza di altri produttori e non riesce a riconvertirsi per tempo, rischia di scomparire se non adegua rapidamente la sua produtti-vità ed i suoi costi a quelli dei concorrenti. Questo significa sempre più che alcune aziende riusciranno a cogliere le opportunità, mentre altre dovranno affrontare rischi notevoli. Ne risulterà una forte selezione tra le imprese. Una selezione che, se non controllata, potreb-be portare a numerose perdite di posti di lavoro, di professionalità e di conoscenze. Ecco allora la necessità che le singole imprese possano adattarsi a percorsi di ristrutturazione che consentano loro di superare momenti di crisi. Da qui la necessità di avere un sistema di relazioni industriali che possa disegnare nuove condizioni organizzative a livello azien-dale, mentre meno importante risulta essere l’accordo di settore, se non nella misura in cui consente adattamenti a livello aziendale. Ed ecco allora che vale la pena ragionare su cosa non abbia funzionato nel caso Fiat, al di la delle specifiche questioni che hanno portato al rifiuto da parte della Fiom di sottoscrivere un accordo che invece Uilm e Fim hanno siglato con la Fiat.
22Se si riflette su quale sia stata nel tempo la novità più rilevante nel campo delle re-lazioni industriali nel nostro Paese, si finisce per forza per notare che, negli ultimi dieci anni, vi è stata una sistematica rottura dell’unità sindacale, tra CGIL, CISL e UIL, che invece nel passato era la regola. Infatti, nei quaranta anni precedenti (dal 1960 al 2000) l’unità sindacale era stata interrotta solo in pochi casi circoscritti (la vertenza sui punti di con-tingenza del 1984) e le relazioni industriali si erano basate sempre su una ricerca di unità tra le tre principali sigle sindacali. Questo costante ricorso all’unità sindacale aveva reso, a volte, più lente le relazioni industriali e più lungo il percorso per gli accordi con le con-troparti datoriali, fino a che tutte le componenti sindacali fossero convinte a sottoscrivere l’accordo. Ma aveva anche finito per stemperare le punte estreme, che non avevano il coraggio di ostacolare indefinitamente un accordo, pena la perdita di salario per tutti i lavoratori. L’unità sindacale di fatto aveva poi reso quasi inutile il problema della conta e del peso specifico relativo di ogni sindacato e, quindi, delle rappresentanze. I diritti dei sindacati erano suddivisi per tre e le rappresentanze erano paritetiche, indipendentemente dal numero degli iscritti. Gli accordi sottoscritti da CGIL, CISL e UIL erano validi per tutti. Al massimo, si ricorreva ad un referendum fra i lavoratori che finiva sempre per confermare l’accordo proposto.
A partire dal 2000 questa unità sindacale è venuta meno, anche grazie alle pressioni del governo di destra che ha giocato sulla spaccatura sindacale per isolare la CGIL con-siderata come un avversario politico. Senza più unità sindacale, il sistema delle relazioni industriali non ha più funzionato. Certo, ci sono stati molti accordi settoriali ed aziendali dove le tre sigle sindacali non si sono divise. Ma a livello nazionale non è stato più possibile firmare un accordo rilevante con tutti e tre i sindacati. E nel settore metalmeccanico, dove la CGIL è tradizionalmente più presente e dove la sua organizzazione (Fiom) è più intransi-gente, non si è più fatto un accordo unitario sul rinnovo del contratto di settore. Le cose, poi, sono precipitate quando Confindustria, CISL e UIL hanno firmato un accordo per un nuovo sistema di contrattazione salariale (a sostituzione di quello del 1993), fortemente sponsorizzato dal Ministro del Lavoro dell’attuale governo di destra e sul quale la CGIL si è rifiutata di mettere la propria firma.
Con l’abbandono dell’unità sindacale sono venute meno le regole non scritte che so-printendevano alla rappresentanza e che garantivano l’attuazione degli accordi sotto-scritti. Ed è per questo che, in questa nuova situazione, per ridare certezza al sistema delle relazioni industriali appare urgente scrivere le regole delle rappresentanze sindacali. Si potrà così avere certezza su chi è legittimato a firmare accordi contrattuali e si potranno avere modalità certe per l’applicazione degli accordi quando questi siano sottoscritti da chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori. Solo con regole certe per contare il peso specifico dei singoli sindacati a livello aziendale e a livello settoriale è possibile stabilire chi ha diritto a sottoscrivere accordi e come questi possono essere resi esigibili dalle con-troparti. Invece la prassi attuale, che di fatto non prevedeva accordi separati, rende incerta l’applicazione di accordi che non siano sottoscritti da tutti i sindacati. Da qui la difficoltà della Fiat a Pomigliano, malgrado l’accordo raggiunto sia stato sottoscritto da due sinda-cati (Fim e Uilm) e malgrado esso sia stato ratificato da un referendum che ha visto due terzi dei lavoratori votare a favore di questo accordo.
Poiché è da ritenere che, data la frattura che si è prodotta, l’unità sindacale non sarà ricomposta in fretta e poiché sempre più sarà necessario negoziare accordi in sede azien-
23dale, dove l’unità sindacale è spesso ancora più difficile da raggiungere, appare urgente fare una legge sulle rappresentanze sindacali. Certo, sarebbe meglio che i sindacati si accordassero tra di loro per trovare una formula di rappresentanza democratica che superi questi ostacoli. Ma la definizione non è agevole perché la lunga pratica della pariteticità delle rappresentanze sindacali aveva finito per favorire oltremisura i sindacati più deboli, quelli con meno iscritti, che oggi appaiono restii a perdere queste posizioni di vantaggio e a subire i rischi di una competizione sindacale. Ecco perché è necessario che intervenga una legge che definisca come si contino le rappresentanze e certifichi il numero degli iscritti, che oggi è lasciato alle autonome dichiarazioni dei sindacati stessi. Se poi un giorno i sindacati volessero accordarsi per una nuova prassi delle rappresentanze, la legge potrebbe sempre recepire l’accordo eventuale.
Con nuove regole sulle rappresentanze sindacali, dove gli iscritti possono far valere la propria voce, sarà più agevole definire accordi aziendali che si renderanno necessari per adeguare le imprese alle esigenze dei mercati e consentire ai lavoratori di partecipare meglio ai risultati economici delle aziende. Certo, rappresentanze proporzionali alle iscri-zioni possono anche far emergere sindacati più rigidi, sostenitori di richieste volte più a prendere il consenso dei lavoratori che a favorire una crescita delle imprese. Ma queste sono le regole e i rischi della democrazia, anche in campo sindacale. Spetterà poi ai lavo-ratori capire se l’intransigenza sindacale li tutela meglio con riferimento ai loro diritti e alle loro aspettative o li espone a maggiori rischi di perdita del lavoro o di bassi guadagni. E spetterà alle imprese avviare un dialogo costruttivo con i propri lavoratori per acquisire quel consenso che è comunque necessario se si vuole essere competitivi sui mercati in-ternazionali.
24Le vertenze di Pomigliano e Melfi costituiscono un’occasione per un ripensamento sul ruolo del lavoro, dell’impresa e della produzione nel nuovo secolo. Ne è emersa una domanda di collaborazione tra l’azienda, la politica e le rappresentanze sindacali per una condivisione strategica dei rischi e degli obiettivi a lungo termine. L’attuale sistema delle relazioni industriali appare obsoleto, in un contesto globale di forte concorrenza sui costi di produzione. I lavoratori e i territori rischiano di trovarsi “fuori mercato” e dovrebbero attivare un flusso di investimenti in apprendimento e in servizi, per aumentare la loro potenzialità di produrre valore. Nel lungo termine, questo potrebbe essere l’unico fattore capace di trattenere o attrarre imprese nel sistema produttivo italiano.
di Enzo Rullani, Presidente TeDIS, Venice International University
Marchionne e la crisi. Le relazioni industriali stanno cambiando, anche se la cronaca ripete vecchie sceneggiature
1. L’occasioneOgni tanto i nodi vengono al pettine: è accaduto a Pomigliano, poi a Melfi. Niente di
grave, per ora, ma è stata un’occasione di ripensamento collettivo sul ruolo del lavoro, dell’impresa e della produzione nel nuovo secolo, appena iniziato.
Un’occasione che non si presenta spesso e che dunque non va sprecata.Invece, la sensazione generale è di un accalorarsi su una trama che sa tanto di déjà
vu: stessi protagonisti (grande azienda versus il sindacato che ha più radici nel passato, la FIOM), stesse rappresentazioni (lavoro contro capitale, buoni contro cattivi), stesso pubbli-co. Stessi mediatori che richiamano al buon senso (quasi tutti gli altri).
Il racconto ripete una liturgia collaudata, come se il tempo si fosse fermato e la gente riprendesse dal punto a cui eravamo rimasti alla fine dell’ultima puntata. Ma la ripetizione sta nel racconto: non nella vita reale.
Tutti sanno – e i protagonisti prima di tutto – che la vita reale è un’altra cosa. E che, tornati alle proprie attività, ciascuno comincerà a ragionare in modo ben diverso, perché, come è ovvio, il modo di oggi non è quello di ieri. Il racconto che mette in scena infinite volte la stessa situazione va bene per far rivivere simbolicamente le emozioni di cui abbia-mo fatto esperienza, non per rispondere ai nuovi problemi che devono essere affrontati oggi: qui e ora.
2. Il patto di collaborazione: oscuro oggetto del desiderio, ma difficile da capire e realizzare
Marchionne, che è un pragmatico, nel racconto non ha ottenuto un gran punteggio. Ma, guardando al sodo, se l’è cavata abbastanza bene, perché ha evitato lo scontro senza arretrare di un ette sulla sua pressante richiesta di maggiore ed effettiva collaborazione della controparte sindacale. Di controparte come collettivo, certo, ma anche – e qui sta l’effetto deflagrante - delle singole persone coinvolte.
Se mi prendo un rischio per conto dell’azienda, ha in pratica detto, è giusto – e con-trattualmente equo - che altri lo prendano con me, collaborando attivamente al risultato da conseguire insieme, a lungo termine. Non solo facendosi trascinare dalla controparte.
Questa offerta di collaborazione resta e resterà, anche quando il polverone della cro-naca si sarà posato.
Ma, alla fine, domandiamoci: che probabilità c’è che dalla politica e dalla società – non-ché dalle rappresentanze sindacali – venga una risposta chiara, definitiva, a questa esplicita domanda di collaborazione strategica sul risultato da conseguire? E dunque che possibilità ci sono di portare tra breve il rapporto tra azienda e lavoro sul terreno della condivisione strategica dei rischi e degli obiettivi a lungo termine, come chiede Marchionne?
La risposta è: poche o punte probabilità. Prepariamoci al fatto che le cose, con qualche aggiustamento di facciata, continueranno così: la Fiat cercherà lo sganciamento morbi-do, indolore, come ha già in parte fatto (non produce più tantissime macchine in Italia, rispetto a quanto fa all’estero). E la controparte sindacale farà finta di non accorgersene, dando per scontato che la colpa è comunque dell’azienda, egoista e ir-responsabile, che non pensa agli uomini che hanno per tanto tempo lavorato per lei.
25Il fatto è che non siamo probabilmente pronti a fare il gran passo: chiudere con gli schemi fordisti, sopravvissuti nella grande azienda, nel sindacato e nello Stato, per re-inventarci altro.
Collettivamente, non abbiamo ancora presenti i termini reali con cui questa possibile collaborazione potrebbe prender corpo, in presenza di modi di ragionare tuttora così di-vergenti. D’altra parte, chi lavora per il compromesso (in nome del far pace …) spesso - per sminuire i contrasti – minimizza, dettaglia, media fino a rendere invisibile il nodo vero che – occasionalmente - la vicenda di Pomigliano e di Melfi ha portato alla luce.
Qual è questo nodo che rischia di restare ai margini dei tanti discorsi che sono nati dalla Marchionne-story di questi giorni?
È presto detto. Le analisi più intelligenti che ci sono state sulla vicenda hanno bene in-quadrato la questione: le nostre relazioni industriali sono col tempo diventate sempre più rituali e dunque obsolete. Ecco il nodo: dobbiamo scioglierlo. La Cina, l’India, l’Est Europa con la loro concorrenza di costo, non ci danno molto tempo per farlo.
Il mondo è cambiato ma molto meno sono cambiate le organizzazioni della rappre-sentanza sociale.
Intendiamoci: il fatto che in altri paesi, nei rapporti capitale-lavoro, si “faccia in un altro modo” (oggi tutti elogiano la mitica cogestione tedesca, magari qualche anno fa non l’avrebbero fatto) non è di per sé dimostrazione che ciò che avviene in Italia è ormai inappropriato rispetto ai bisogni di una moderna organizzazione produttiva. Ma certo una spia di inadeguatezza è la mancanza – in tutti questi anni – di una sperimentazione di avanguardia sul terreno delle nuove (possibili) forme di relazione tra capitale e lavoro. Forme adatte ad un capitalismo di piccola impresa e di territorio che è non solo diverso dagli altri, ma anche inedito tra le varianti di organizzazione tecnico-economica assunte dall’economia post-fordista degli ultimi quaranta anni. Ma anche la sperimentazione di un rapporto di lavoro che tenga conto del mutato ruolo del lavoratore nel processo pro-duttivo: un lavoratore che non si limita più ad “erogare” – nei tempi e modi stabiliti dal contratto e dal datore di lavoro – una prestazione pura e semplice, ma che ormai – per fornire l’intelligenza lavorativa indispensabile a reggere la concorrenza con il lavoro low cost – deve investire a proprio rischio tempo, denaro e attenzione nella formazione di competenze professionali evolute. Tali da non poter essere usate in modo soltanto esecu-tivo, ma da richiedere un grado sempre più elevato di autonomia e intelligenza nell’uso.
Se il lavoratore investe a rischio, acquista in autonomia e intelligenza lavorativa, dif-ferenzia le sue posizioni da chi questo investimento non l’ha fatto, o l’ha fatto in forma diversa, magari sbagliata. Nello stesso senso, il suo interesse di fondo è che la capacità produttiva ottenuta da questo investimento sia messa a frutto dall’impresa per cui lavora, avendo in cambio una parte del valore differenziale prodotto. È un cambiamento di fon-do, che impresa e lavoratore devono realizzare congiuntamente e nel comune interesse, prendendo impegni reciproci verso questa co-evoluzione di lungo periodo. Ma, forse pro-prio per questo, la cronaca non ne parla, preferendo altri punti di vista. Siamo, in effetti, rimasti prigionieri, un po’ tutti, delle rappresentazioni ideologiche ereditate dalla stagione fordista, nonostante che siano quaranta anni che la realtà economica ne è fuoriuscita.
Non è solo tramontata la “lotta di classe”, come ha detto Marchionne, ma è muta-to il ruolo del sindacato rispetto all’epoca d’oro del fordismo, quando il sindacato era una istituzione fondamentale della distribuzione del reddito (insieme al welfare State).
26E si comportava di conseguenza, potendo presentarsi (e pensarsi) come rappresentante non solo del lavoro, ma dell’interesse collettivo.
In effetti, nelle relazioni industriali, il sindacato faceva quello che l’organizzazione sociale del tempo gli demandava: amministrare, più o meno saggiamente, la distribuzione del reddito, in base al potere negoziale detenuto dai diversi interessi dotati di rappre-sentanza collettiva. La produttività fordista era, allora, generata dal management della grande fabbrica. Le politiche sociali (col welfare State o attraverso i tanti mitici “tavoli” della contrattazione) lo ridistribuivano. Tra chi produceva e chi assicurava la domanda necessaria per trovare sbocco alla produzione c’era complementarità, più che conflitto, nonostante le apparenze della cronaca e nonostante qualche frangia che non aveva - e forse non ha ancora - capito le (vere) regole del gioco.
Oggi questa situazione, che era dominante in tutti i paesi industrializzati mezzo secolo fa, non c’è più e non può tornare. Per tante ragioni.
In primis, la fabbrica da sola non ce la fa più a generare nuova produttività. Per farlo, le imprese hanno bisogno di investimenti importanti che altri - molti altri - devono fare in sintonia con i suoi piani di attività, per compensare lo svantaggio di costo di partenza di cui soffre rispetto a cinesi, indiani e così via.
Chi può convincere gli investitori a farlo, se non è conveniente dal loro punto di vista? Nota bene: non stiamo parlando solo degli investimenti tipici fatti dalle aziende, ma
anche di quelli che, oggi, dovrebbero essere fatti dalle persone (per alimentare la loro pro-fessionalità: istruzione, formazione, ricerca, ideazione) e dai territori (nel sistema di servizi, di competenze e di reti a cui la produzione si deve appoggiare).
In effetti, basta ragionare un poco per accorgersi che, oggi, la concorrenza vera non è tra aziende italiane e aziende cinesi (le aziende sono mobili, e possono trovare mille modi di organizzarsi in modo da diventare complementari con le fabbriche cinesi low cost), ma è – come non ricordarlo? – tra lavoratori italiani e lavoratori cinesi (indiani, turchi ecc.). E tra territori italiani e l’infinita gamma di luoghi dove Stato, ambiente, regole, energia, servizi pubblici costano meno che da noi. Talvolta molto meno.
Sono i lavoratori e i territori, insomma, che rischiano per primi di trovarsi “fuori mer-cato”. E che dunque hanno un interesse primario – molto più che le aziende – a mettere in moto un flusso di investimenti in apprendimento che sia in grado di moltiplicare per due, o per tre volte, la loro produttività potenziale. Un flusso di investimenti che, alla lunga, sarà l’unica “ragione forte” capace di trattenere o attrarre imprese nel nostro sistema. Non per ragioni di cuore o di responsabilità sociale, ma per il fatto che qui potrebbero guadagnare di più, o non meno, che altrove.
In mancanza di questa condizione gli altri non verranno da noi (già adesso ne vengono pochi), e chi invece già c’è, potendo, comincia a pensare che potrebbe trovare qualcosa di meglio da qualche altra parte. Non illudiamoci sui decantati “ritorni” di chi se n’era anda-to. Il mondo è grande, e cercando si trova sempre un angolo accogliente, anche se i primi tentativi possono andare a vuoto.
Quando si dice che la Fiat ragiona come una multinazionale globale, si dice questo: per la Fiat di Marchionne, di oggi, l’Italia è diventata una delle opzioni, non l’unica. L’origine, le radici, la storia sono una bella cosa, ma non sono tutto: e possono impallidire rispetto al peso che, nelle decisioni, possono avere differenze importanti di costo, di rischio, di produttività.
27Il che significa una cosa: se i nostri lavoratori e i nostri territori non si danno da fare per arricchire le loro competenze e aumentare la loro potenzialità di produrre valore nelle filiere globali, forse possiamo dire che per aziende tipo Fiat la localizzazione in Italia cessa gradualmente di essere un’opzione. Diventare non conveniente, sotto il profilo della pro-duttività e del rischio, in presenza di uno svantaggio strutturale di costo può rivelarsi alla lunga un disastro. Specie se rischi e produttività sono considerate in modo sfavorevole a causa di ragioni che non sono facilmente rimediabili.
Fiat che comincia a ragionare in modo globale (ricordate quando Marchionne ha an-nunciato, da un giorno all’altro, che rinunciava agli incentivi pubblici?) prepara una nuova stagione nei rapporti capitale-lavoro. Furono pochi allora a capire il senso di quell’annun-cio che tagliava il cordone ombelicale tra Fiat e politica, ossia tra l’azienda e una necessità localizzativa che nasceva da convenienze non economiche, ma da opportunità di altro genere.
Per questo Pomigliano e Melfi sono solo la punta di un iceberg: fanno affiorare un modo di ragionare che, di fronte ad una controparte che guarda al mondo, non trova più sponde a cui appoggiarsi. Il solito “tavolo”, invocato a gran voce, sarà comunque zoppo: una delle parti ha iniziato a giocare un’altra partita e invita i suoi interlocutori a cambiare la logica della relazione in essere. Non perdiamo questa occasione, quello che è accaduto non serve per recriminare, ma per rendersi conto di quanto il mondo sia irreversibilmente cambiato, negli ultimi anni.
Quello che non va nel richiamo alla “lotta di classe” o - più laicamente - alla microcon-flittualità di altri tempi è che un contesto del genere, in cui manca un impegno comune a realizzare lo stesso progetto strategico, finisce per scoraggiare gli investimenti delle azien-de che oggi possono andare altrove (al contrario di quello che accadeva in epoca fordista, quando erano parte di capitalismi nazionali ben strutturati e condizionanti).
Soprattutto non va l’idea, sottostante, che gli operai - e in genere i lavoratori - siano necessariamente soggetti passivi che possono contare qualcosa nella redistribuzione del reddito, ma che, nella produzione, si limitano a fornire la propria forza lavoro. Erogando una prestazione in merito alla quale subiscono l’iniziativa altrui, buona o cattiva che sia (da cui un certo piglio moralistico, presente nella maggior parte dei discorsi di commento).
Ma è così (chiedendo solo un atteggiamento di obbedienza passiva, mitigato da diritti riconosciuti e da salari non di fame) che possiamo difendere i nostri lavoratori dalla con-correnza di costo del lavoratore cinese che si contenta di metà o anche meno del reddito guadagnato dall’operaio di Pomigliano o di Melfi?
Bisogna cominciare a vedere le cose in altro modo, anche da parte delle aziende. I lavoratori dovrebbero infatti essere - e in certi casi già lo sono (vedi i lavoratori della conoscenza e i giovani precari che molto si danno da fare all’interno delle imprese o nell’indotto) - protagonisti della costruzione del loro futuro se trovano il modo di inve-stire sulle proprie idee e capacità. Contribuendo a progettare un sistema produttivo e di relazioni azienda-lavoratore di tipo nuovo. Un sistema fatto per valorizzare l’intelligenza differenziale che il lavoratore italiano può acquisire e mettere in campo rispetto al lavoro di massa, dequalificato, svolto in qualche paese low cost. Una intelligenza differenziale da costruire nel tempo, mediante investimenti in istruzione, formazione, sperimentazione del nuovo portati avanti nella carriera professionale del lavoratore. A questo può contribuire anche la costruzione di un circuito di apprendimento e valorizzazione professionale del
28capitale umano su cui azienda e lavoratori si impegnano nel lungo termine, puntando alla crescita della produttività mediante un arricchimento importante delle funzioni e del sapere impiegato.
Molte aziende, si dirà, non sono pronte a ragionare in questo modo, un po’ come accade per una parte del sindacato. È vero, ma da qualche parte bisogna pur cominciare: nuove aziende richiedono nuovi lavoratori, e nuovi lavoratori richiedono nuove aziende. Si cam-bia insieme, sperimentando il possibile a partire dai punti in cui questa sensibilità condivisa è più avanti. Dunque, possiamo provarci, partendo da alcuni prototipi e da alcune aziende battistrada. Poi col tempo molte altre seguiranno: non bisogna sopravvalutare le resistenze culturali, in un sistema destrutturato come il nostro. Le aziende, abituate a fronteggiare tutti i giorni la concorrenza di mercato, possono anche avere dei pregiudizi, ma sono anche capaci di metterli da parte. Se una cosa funziona, e rende, perché non farla?
Molte regole e molte pratiche dovrebbero cambiare, per creare questa possibilità, ren-dendo effettivamente conveniente l’investimento per chi lo fa. In tutto il mondo industria-lizzato la spesa delle famiglie e delle persone nella formazione di professionalità rilevanti è l’asse del sistema produttivo, e costituisce la principale difesa contro la perdita delle posizioni competitive sui mercati. Ma da noi? Una famiglia che investe i propri risparmi sull’istruzione dei figli, mandandoli all’estero e facendo loro prendere un Master o un PhD da qualche parte che non sia sotto casa, non sa se sta facendo un buon investimento e se, poi, a cose fatte, lo sforzo compiuto sarà o meno apprezzato dal mercato del lavoro. Un lavoratore che volesse accrescere la propria professionalità sacrificando parte del suo salario e del suo tempo libero non sarebbe, nel contesto attuale, considerato un investitore che va ad esplorare il futuro, nell’interesse di tutti noi (per la produttività conseguente), ma costituisce un’anomalia che non rispetta l’orario di lavoro, pensa ad altro, ha propositi che all’azienda non interessano o sono vissuti in negativo. E che succede se questo lavora-tore si trova ad essere in conflitto con la sua azienda, e se questa non capisce che la voglia di apprendere del dipendente è anche nel suo interesse? Difficile che possa imparare cose diverse dalla sua routine lavorando al nuovo la sera, la notte, la domenica e le feste co-mandate. E se poi impara qualcosa di rilevante, chi certifica quello che sa fare, rendendolo spendibile sul mercato del lavoro?
Insomma, in tutta questa partita rischia di mancare la cosa esseziale: la convenienza ad investire sul proprio futuro. Possiamo solo dire che si è davvero fatto molto poco su questo versante. Questo non deve però scoraggiare: il bicchiere mezzo vuoto, se visto da un’altra angolatura, è anche mezzo pieno. Partendo da una posizione arretrata, molte cose utili e rilevanti potrebbero essere fatte senza correre troppo con la fantasia.
Ad esempio, basterebbe incentivare, con opportune politiche e regolazioni, anche con-trattuali, le scelte di chi ha maggiore sensibilità per questo problema ed è disposto per questo ad investire, a rischio, su se stesso, per imparare nuovi mestieri e mettere a punto nuove idee. Serve per queste persone un tessuto di relazioni e dialoghi che consenta di far circolare le idee e di trovare i necessari compagni di viaggio. Si dovrebbero creare “pale-stre” di addestramento, percorsi sperimentali per il test di nuove idee, cornici consensuali per il miglioramento dell’esistente (come il kaizen giapponese), orari e permessi dal lavoro compatibili con questo disegno, certificazioni professionali credibili su quello che si sa e si sa fare, carriere interne ed esterne che premiano chi ha investito e penalizzano chi – po-tendo - ha preferito non farlo. Niente di impossibile, come si vede. Ma da fare.
29Insomma, sono tante le novità che si potrebbero diffondere nella vita quotidiana di chi lavora e di chi dà lavoro, seguendo l’esempio, magari, di qualche azienda disposta a fare da battistrada in questo campo. Per adesso le poche esperienze avanzate che ci sono – in molte delle nostre medie aziende, ad esempio – restano eccezioni. Ma i problemi di produttività, reddito, produttività del lavoro sono drammatici per tutti, anche per coloro che per adesso si sentono al riparo, ma non lo saranno a lungo. Tuttavia, quando provia-mo a rappresentare le nuove possibilità, scatta la dialettica delle identità collettive, che ripropongono prassi e simbologie consuete, scoraggiando le novità, considerate quasi per definizione un arretramento e una sconfitta, mai una scommessa sul futuro.
Il risultato è che gli investimenti in capitale umano, in Italia, non si fanno o – salvo ecce-zioni - si fanno in misura assolutamente inadeguata ai bisogni imposti dalla concorrenza.
Pensiamo ad una sola cosa: non ci si occupa abbastanza del turnover da azienda ad azienda, che in certe aree è davvero molto elevato. A prima vista, il turnover sembra una cosa buona dal punto di vista del mercato del lavoro: significa che il lavoratore non è psicologicamente inchiodato al suo posto e che le aziende cercano continuamente sul mercato del lavoro chi ritengono più adatto. Ma bisogna anche tener conto del fatto che un elevato tasso di turnover è un disincentivo formidabile per la collaborazione a lungo termine e l’investimento condiviso (azienda/lavoratore) nella costruzione delle compe-tenze professionali. Vi pare che un’azienda tipo, nei nostri distretti industriali o nelle aree comunque ad alta occupazione, possa davvero investire nella formazione di competenze professionali di punta per il suo personale dipendente, se questo se ne può andare da un momento all’altro, con un preavviso di pochi giorni?
Senza aver messo a punto con i dipendenti (o con i fornitori, consulenti, designers ecc.) un progetto condiviso di sviluppo della professionalità mirato ad accrescere nel medio lun-go periodo la produttività/competitività dell’azienda, nessuno investirà mai. È il disastro di quella che continuiamo a chiamare flessibilità, ossia reciproca indipendenza tra lavoratori e azienda nelle scelte che riguardano il rapporto di lavoro. Nelle condizioni attuali, in cui tutti badano a tenersi le mani libere per contrattare meglio e di più, le aziende si guar-dano bene dall’investire in professionalità che possono perdere in pochissimo tempo, se i lavoratori che le hanno apprese decidono di mettersi in proprio o di passare, per qualche incremento di paga, alla concorrenza.
E dunque?Non sarebbe difficile mettere a punto schemi contrattuali di co-investimento dove i
processi di apprendimento necessari sono in parte a carico dei diretti interessati e in parte finanziati dall’impresa, avendo in mente un quadro contrattuale che impegna per 3 o 4 anni a rimanere in azienda per sfruttare insieme quanto si è imparato.
Ma certo, si tratterebbe di un lavoratore diverso dall’operaio massa che delega al sin-dacato la trattativa sulla distribuzione del reddito e che non ragiona come farebbe uno che aspira ad essere “imprenditore di se stesso”.
Insomma, la sfida reale è quella che dovrebbe portare ad imprenditorializzare il lavoro, individuale e collettivo (per gruppi), nel senso che il lavoratore dovrebbe oggi essere visto come un soggetto attivo che condivide con l’impresa intelligenza e rischio, con la connessa autonomia/responsabilità legata a ciascuna mansione. Perché questo accada, è necessario aver stabilito insieme una cornice contrattuale e normativa – nonché di comportamenti pratici – che realizza questa ripartizione contrattuale e fiduciaria dei compiti. Il sindaca-
30to avrebbe un ruolo nel definire insieme alla controparte la cornice normativa (regole, contratti-tipo, tutela dell’apprendimento, certificazioni, arbitrati, sanzioni ecc.) di queste transazioni individuali o di gruppo, lasciando poi ai diretti interessati la loro specifica-zione, volta per volta. Questa possibilità oggi non è esclusa, e forse è praticata qua e là. Ma certo non è al centro di una sperimentazione sociale delle nuove relazioni industriali, come potrebbe.
È vero, non tutti i lavori di oggi si prestano a dare spazio a competenze e autonomia dei singoli lavoratori, o di gruppi qualificati di essi. Ma ormai non dimentichiamoci che – specie dove ci sono linee di produzione automatizzate - il lavoro non è più di fatica, ma di testa. Una gran parte del lavoro di oggi – e ancor più del lavoro futuro – è ormai di tipo cognitivo, anche quando è organizzato in modo da essere meramente esecutivo. Ma se al lavoro viene messa l’intelligenza, non bisogna dimenticare che la crescita della produttività richiede che essa possa svilupparsi in forme che ammettono autonomia, apprendimento, e assunzione di rischio. Fino a che il lavoro cognitivo rimane di tipo meramente esecutivo, anche se senza rischio, diventa impossibile differenziarlo dalla prestazione che, dall’altra parte del mondo, viene fornita da un lavoratore cinese dello stesso settore. Un lavoratore che magari usa la stessa macchina e produce per lo stesso committente.
La tradizionale organizzazione fordista del lavoro, che ha ancora un peso determinante nelle forme di organizzazione del lavoro delle aziende più strutturate, forse andrebbe ri-pensata alla radice, perché il suo presupposto - l’accentramento delle competenze e dunque del potere decisionale e del rischio - non regge più, in un sistema produttivo che deve fron-teggiare una domanda di varietà, flessibilità e varietà crescente. Le aziende sono sempre meno governabili dal centro e da un’unica testa. Servirebbe l’apporto di più intelligenze, in una rete di autonomie e di responsabilità basata sull’impegno alla reciproca collabora-zione, a tutela dell’interesse condiviso che è la produttività e competitività aziendale.
Insomma, se impresa e sindacati devono fare un patto per lo sviluppo, non basta im-maginare uno scambio politico basato sull’assunto: l’azienda investe, il lavoratore obbedi-sce alle regole e magari si ingegna di fare, in certi luoghi, un po’ di pause o di malattie in meno. Lo scambio deve essere un altro. Ossia: l’azienda investe e aiuta i singoli lavoratori (o gruppi di essi) ad imprenditorializzarsi e sviluppare le loro capacità professionali.
Altrimenti, se non si prende consapevolmente questa strada, come faremo a raggiun-gere le “paghe” di operai tedeschi o svedesi che pure non mandano a fondo le aziende in cui queste paghe vengono erogate? E come faremo a non precipitare, passo dopo passo, verso le paghe degli operai turchi, rumeni o vietnamiti?
Non ci sono risposte facili. Ma una buona domanda, a cui non si sa rispondere, è ciò che basta per giustificare l’inizio di un viaggio di esplorazione verso il nuovo e il possibile.
Di questo, oggi, c’è un gran bisogno. Convinciamoci.
31Aris AccorneroMarco AlfieriKhaled Fouad AllamBruno AnastasiaLuca AntoniniGiorgio Barba NavarettiTony BarberFabrizio BarcaPier Paolo BarettaJacques BarrotPaolo BastianelloAlessandro BenettonLuigi BerlinguerPier Luigi BersaniEdmondo BerselliMarina BertoncinEnrico BertossiFrancesco BillariLorenzo Bini SmaghiGiuseppe BisazzaAlberto BombasseiFabio BordignonElisa BottignoloPeter Daniel BratschiFerruccio BresolinRenato BrunettaGiorgio BrunettiMassimo CacciariMassimo CalearoCorrado CampobassoLucio CaraccioloAlessandro CastegnaroMaria CastiglioniMaurizio CastroVincenzo CesareoInnocenzo CipollettaGiovanni Cobolli GigliMassimo ColombanGianluca CominGiancarlo CoròGiovanni CostaPaolo CostaMonica D’AscenzoLuigi Dalla ViaAdriano DalpezKatia Da RosFrancesco Dal MasGianpiero Dalla ZuannaAnna Galizia DanovCarlo De BenedettiLuca De BiaseFerruccio de BortoliCesare De MichelisItalo De SandreGraziano DebelliniNadio DelaiPiero Della Valentina
Livio DestroIlvo DiamantiDario Di VicoMassimo EgidiFederico FantiniAngelo FerroMarino FinozziGiuseppe FioroniAlberto ForchielliRoberto FormigoniGiorgio FranceschiCarlo Fratta PasiniSergio FrigoGiancarlo GalanDiego GalloMaurizio GambuzzaArio GervasuttiVladimiro GiacchéGraziella GiovanniniGiovanni GocciAndrea GoldsteinMariangela Gritta GrainerRoberto GrandinettiMassimo GuagniniFederica GuidiRichard HeuzéErnesto IllyRiccardo IllyCarlo JeanFrancesco JoriPaolo LandiAlessandra LanzaGad LernerEnrico LettaArrigo LeviDanilo LonghiMatteo LunelliBruno ManghiFranco ManzatoEmma MarcegagliaRenato Raffaele MartinoAntonio MarzanoMariano MaugeriEzio MauroRoberto MigottoVincenzo MilanesiGiuseppe MorandiniMario Moretti PolegatoGilberto MuraroMichael NovakVittorio NozzaRomeo OrlandiEnzo PaceAngela PadroneCinzia PalazzettiArduino PanicciaLuca Paolazzi
Roberto PapettiAndrea PaseClaudio PasqualettoCorrado PasseraLucio PegoraroFilippo PenatiTobias PillerAndrea PininfarinaFranco PittauAlessandra PivatoFranca PortoPaolo PossamaiEmilio PucciFrancesco RamellaAndrea RanieriMaurizio RaseraLuisa RibolziAlessandro RielloLuca RomanoLuigi Rossi LucianiEnzo RullaniMaria Silvia SacchiMaurizio SacconiArduino SalatinMatteo SalinDominick SalvatoreGianluca SalvatoriFabio SalviatoGiorgio SantiniVendemiano SartorCinzia SassoGiuseppe SbalchieroSilvio ScanagattaDario ScannapiecoAntonio SciortinoAngelo ScolaPaolo SegattiCuno TarfusserNicola TognanaAndrea TomatCarlo TonuttiFlavio TosiTiziano TreuSergio TrevisanatoRoberto TunioliNorberto UrliGiorgio UsaiAlessandro VardanegaTiziano VecchiatoEmilio ViaforaGiovanni VianiMarco VincenziGiorgio VittadiniFrank Paul WeberFrancesca ZaccariottoGiuseppe Zigliotto
Regi
stra
zion
e Tr
ibun
ale
di T
revi
so n
° 23/
05 d
el 1
1/10
/200
5 -
Dire
ttor
e re
spon
sabi
le A
uro
Palo
mba
pre
sso
Fond
azio
ne N
ord
Est,
Rivi
era
Sant
a M
argh
erit
a n°
6, 3
1100
Tre
viso
- S
tam
pa M
arca
Prin
t, Q
uint
o di
Tre
viso
(Tv)
- N
/E
è un
a ne
wsl
ette
r bim
estr
ale
pubb
licat
a a
cura
del
la F
onda
zion
e N
ord
Est,
stre
ttam
ente
rise
rvat
a ai
des
tina
tari.
Ne
è vi
etat
a la
ripr
oduz
ione
anc
he p
arzi
ale.
Fon
dazi
one
Nor
d Es
t, Ri
vier
a Sa
nta
Mar
gher
ita
n° 6
, 311
00 T
revi
so
Credits – Fra gli altri, hanno collaborato con noi: