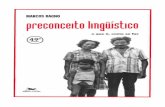Luigi Aprile (a cura di) - Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico [Thaeteve].pdf
Transcript of Luigi Aprile (a cura di) - Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico [Thaeteve].pdf
-
FIRENZEUNIVERSITY
PRESS
a cura di Luigi Aprile
FUP
Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico
Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico
Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico presenta sedici contributi originali che raccolgono studi e ricerche realizzate da autori di varie Universit italiane, tra le quali, oltre a Firenze, quelle di Padova, Roma, Trieste. Pubblicato in onore di Filippo Boschi, un lavoro che presenta alcune delle pi aggiornate acquisizioni scienti che sulla psicologia della lettura in particolare e dello sviluppo cognitivo e linguistico in generale. un volume che si rivolge non solo a specialisti e cultori del settore, ma anche a studenti universitari impegnati nello studio della psicologia dello sviluppo e delleducazione.
Luigi Aprile Professore di Psicologia dello sviluppo presso lUniversit di Firenze. Fra i suoi lavori, oltre ad articoli pubblicati su riviste specializzate, alcuni volumi editi dalle Edizioni Giuffr, Giunti, Organizzazioni Speciali OS, Piccin su tematiche concernenti lo sviluppo psicologico e del linguaggio in particolare.
Sommario: I. Filippo Boschi: una vita per la psicologia (Luigi Aprile) 2. Percorsi di ricerca in psicologia della lettura (Filippo Boschi) 3. Studi sul ruolo della memoria di lavoro nella comprensione del testo (Cesare Cornoldi, Rossana De Beni e Barbara Carretti) 4. Apprendere dal testo espositivo: interazioni tra conoscenza e interesse degli studenti e coerenza testuale (Lucia Mason e Pietro Boscolo) 5. Lo sviluppo dei sistemi simbolici: che relazione tra linguaggio e codice scritto? (Giuliana Pinto) 6. Disegnare un carattere, scrivere un ritratto. Un confronto tra le idee infantili sul disegno e sulla scrittura (Anna Silvia Bombi, Eleonora Cannoni, Maria Stella Angelucci e Chiara Cola gli) 7. Contesti di gioco e comunicazione tra pari (Elena Bortolotti e Loredana Czerwinsky Domenis) 8. Il ruolo del linguaggio nello sviluppo concettuale: analisi critica del paradigma delle classi di equivalenza (Dolores Rollo) 9. Processi di elaborazione cognitivo linguistici di stimoli verbali e visivi corrispondenti: uno studio evolutivo (Luigi Aprile) - 10. Le referenze agli stati mentali nelle produzioni narrative infantili (Elisa Faso e Caterina Primi) 11. Dai processi ai prodotti: la correttezza ortogra ca (Lucia Bigozzi) 12. Leffetto frequenza duso dei fonemi della lingua italiana in soggetti afasici con de cit di lessico fonologico di output e/o di buffer (Sonia Calvani) 13. Livello socio-economico e sviluppo linguistico in et prescolare (Beatrice Accorti Gamannossi) 14. Modelli didattici per lo svilupo del pensiero critico: unanalisi descrittiva (Stefano Malvagia e Saverio Fontani) 15. Le prove di veri ca: nuove prospettive di intervento didattico nellarea cognitiva (Annamaria Di Fabio) 16. Lo studio delle modalit di sviluppo delle competenze cognitivo-linguistiche e delle competenze di de nizione lessicale (Emanuela Bavazzano, Andrea Fornari e Giacomo Grifoni)
20,00
Tra teoria e intervento
9 7 8 8 8 8 4 5 3 0 7 6 9
ISBN 88 -8453 -076 -8
-
studi e saggi
9
-
Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico
tra teoria e intervento
a cura diluigi aprile
Pubblicazione in onore di Filippo Boschi
firenze university press2003
-
2003 Firenze university Press
universit degli studi di FirenzeFirenze university PressBorgo albizi, 28, 50122 Firenze, italyhttp://www.fupress.com/
Printed in Italy
Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico : tra teoria e intervento : pubblicazione in onore di Filippo Boschi / a cura di Luigi aprile. Firenze : Firenze university Press, 2003.(studi e saggi ; 9)
http://digital.casalini.it/8884530652
isBN 88-8453-065-2 (online)isBN 88-8453-076-8 (paper)418.4019 (ed. 20)
Lettura-Psicologia
-
Indice
Introduzione 1Luigi Aprile
1. Filippo Boschi: una vita per la psicologia 5Intervista, in due parti, a cura di Luigi Aprile
2. Percorsi di ricerca in psicologia della lettura 21Filippo Boschi
3. Studi sul ruolo della memoria di lavoro nella comprensione del testo 39Cesare Cornoldi, Rossana De Beni e Barbara Carretti
4. Apprendere dal testo espositivo: interazioni tra conoscenza e interesse deglistudenti e coerenza testuale 47Lucia Mason e Pietro Boscolo
5. Lo sviluppo dei sistemi simbolici: che relazione tra linguaggio e codice scritto? 55Giuliana Pinto
6. Disegnare un carattere, scrivere un ritratto. Un confronto tra le idee infantili sul disegno e sulla scrittura 67Anna Silvia Bombi, Eleonora Cannoni, Maria Stella Angelucci e ChiaraColafigli
7. Contesti di gioco e comunicazione tra pari 75Elena Bortolotti e Loredana Czerwinsky Domenis
8. Il ruolo del linguaggio nello sviluppo concettuale: analisi critica del paradig-ma delle classi di equivalenza 89Dolores Rollo
9. Processi di elaborazione cognitivo linguistici di stimoli verbali e visivi corri-spondenti: uno studio evolutivo 97Luigi Aprile
10. Le referenze agli stati mentali nelle produzioni narrative infantili 105Elisa Faso e Caterina Primi
11. Dai processi ai prodotti: la correttezza ortografica 115Lucia Bigozzi
-
12. Leffetto frequenza duso dei fonemi della lingua italiana in soggetti afasici con deficit di lessico fonologico di output e/o di buffer 125Sonia Calvani
13. Livello socio-economico e sviluppo linguistico in et prescolare 137Beatrice Accorti Gamannossi
14. Modelli didattici per lo svilupo del pensiero critico: unanalisi descrittiva 147Stefano Malvagia e Saverio Fontani
15. Le prove di verifica: nuove prospettive di intervento didattico nellarea cognitiva 161Annamaria Di Fabio
16. Lo studio delle modalit di sviluppo delle competenze cognitivo-linguistiche e delle competenze di definizione lessicale 175Emanuela Bavazzano, Andrea Fornari e Giacomo Grifoni
-
Introduzione
Luigi AprileUniversit di Firenze
Qual il contributo che Filippo Boschi ha dato allo studio della psicologia dello svi-luppo cognitivo-linguistico, sia sul piano teorico che su quello operativo, dellintervento?
Credo che i lavori raccolti in questo volume pubblicato in onore del Prof. Boschi pos-sano anche essere letti come una chiave di risposta a tale domanda, centrale in unopera chevuole rendere omaggio a uno studioso che ha dedicato la propria vita alla ricerca e allin-segnamento in queste aree di indagine. Tuttavia, mentre il lettore stesso pu costruire unasua interpretazione del significato che assumono nel loro insieme i contributi di colleghi eallievi, in questo capitolo introduttivo vorrei segnalare alcuni punti focali che mi sembra-no, in sintesi, una delle possibili risposte alla domanda che ho posto allinizio. Come si dicein questi casi, naturalmente non ho alcuna pretesa di completezza, sono anzi in dubbiosulla loro verosimiglianza, ma, per come vedo queste cose in relazione agli studi e alle espe-rienze fatte, mi sono convinto, a torto o ragione, della loro plausibilit.
Punto primo: che cos la lettura?
La ricerca scientifica attuale del parere che la lettura sia un tipo di attivit, un insie-me di prestazioni, di compiti complessi, ma nello stesso tempo specifici. La lettura vistacome un settore di studio che riguarda una serie di aspetti cognitivi (memoria, apprendi-mento, processi percettivi, attentivi) e in parte emotivi e motivazionali (motivazioni, inte-ressi, stati emozionali). Ma si tratta sempre appunto di un settore, per quanto importante,di studi e ricerche. Questo punto di vista lapprodo principale di oltre un secolo di inda-gini teoriche, empiriche, operative, come il lettore pu constatare anche leggendo i varicapitoli di questo libro e le ulteriori indicazioni bibliografiche fornite in tali contributi.
La mia opinione che dopo il lavoro di Boschi, per le numerose prove empiriche basa-te su modelli logici e linguistici e per lavvio di prospettive aperte alla ricerca empirica esperimentale, le cose non stiano pi cos: la lettura non pi un settore di ricerca specifi-co, delimitato, ma qualcosa di molto pi vasto, che ha a che fare direttamente col modo incui fatta e funziona la mente umana. I modelli empiricamente fondati sulle cinque formedi linguaggio (parafrastico, inferenziale, logico, critico-valutativo ed estetico-poetico) nellacomprensione della lettura e sulle caratteristiche evolutive della competenza lessicale (cfr. ilavori di Boschi) fanno parte, a buon diritto, delle attuali teorie della mente.
In questo senso, la lettura pu essere definita come un ambito, un laboratorio doveposso capire alcuni dei principi di base, delle leggi di sviluppo della mente umana. Si trat-
-
ta di un laboratorio che si costruito attraverso la storia degli esseri umani, della loromente. Se questa ipotesi fosse almeno approssimativamente vicina a come stanno vera-mente le cose, allora vedere che cosa succede quando un umano impara a leggere, a capi-re che cosa sta leggendo, a utilizzare ci che legge, significa capire come fatto, gli aspettistrutturali, e come funziona, gli aspetti funzionali, la sua mente. Significa quindi avereinformazioni preziose non solo su come si sviluppano e funzionano aspetti specifici (adesempio la lettura decifrativa, o i processi di comprensione del testo, di memorizzazione,ecc.), ma anche su quali sono le architetture interne della mente.
Studiare la lettura allora utile non solo per capire come e che cosa fare per insegnare,far imparare a padroneggiare sempre meglio questo strumento indispensabile per lo svi-luppo formativo e culturale, ma anche per capire chi , che cosa luomo, la sua mente, lapersona specifica che abbiamo di fronte.
Punto secondo: in cosa consiste lo sviluppo cognitivo-linguistico?
Il lettore trover una intervista a Filippo Boschi nella quale, attraverso una sintesi delleprincipali tappe della sua vita di studioso, vengono parallelamente prese in considerazionele diverse aree connesse agli studi e alle ricerche sulla lettura: gli ambiti della psicolingui-stica evolutiva, della psicologia dellapprendimento, della personalit, delleducazione,dello sviluppo. Successivamente sono presentate alcune delle principali opere pubblicatesulla psicologia della lettura da parte di Filippo Boschi, seguendo un criterio di tipo tema-tico: dagli studi sui processi di comprensione nella lettura in studenti della scuola mediasuperiore, alle ricerche sulle prime fasi di acquisizione della lettura, agli studi sullo svilup-po lessicale, alle indagini sui processi di lettura in soggetti adulti, allo studio delle relazio-ni tra lettura e variabili di personalit, lettura e valutazione, fino alla elaborazione di nuovimodelli dei processi di comprensione della lettura, alle ricerche sulle metodologie di inter-vento per favorire i processi di sviluppo delle abilit e capacit di lettura nei vari periodidello sviluppo, dallinfanzia alladolescenza, fino allet adulta.
La ricerca scientifica ritiene che lo sviluppo cognitivo-linguistico riguardi aspetti comelevoluzione del linguaggio, del pensiero, dei processi di apprendimento, della scrittura,delle influenze che i contesti culturali, ambientali hanno su tali aspetti della mente umana.
Il lettore pu trovare esempi di rilievo degli orientamenti attuali della ricerca nei con-tributi presentati nel volume. Tutti questi contributi affrontano tematiche di crucialeimportanza per capire lo sviluppo cognitivo-linguistico, sia sotto il profilo delle teorie chesi confrontano e a volte scontrano, sia sul piano delle cose da fare nei processi formativi,educativi, didattici, negli interventi operativi.
Cornoldi, De Beni e Carretti, presentano al lettore una rassegna aggiornata degli studisul ruolo svolto dalla memoria di lavoro nei processi di comprensione della lettura: la capa-cit della memoria di lavoro (un sistema attivo di memoria che consente di mantenere econtemporaneamente elaborare il contenuto di un testo mentre il soggetto sta leggendo)sembra svolgere un ruolo cruciale nella comprensione del linguaggio, cos che le differen-ze tra buoni e cattivi lettori appaiono legate alla efficienza (ampiezza) di tale memoriadi lavoro. Mason e Boscolo danno modo al lettore di studiare un esempio di ricerca empi-
2 Luigi Aprile
-
rica sui processi di apprendimento legati alla lettura di testi espositivi, in particolare sonoesaminate le interazioni tra conoscenza e interesse degli studenti e il grado di coerenza diun certo tipo di testo. I risultati sembrano evidenziare relazioni complesse tra tali variabi-li: ad es., solo nel caso in cui gli studenti presentino un alto livello di conoscenza, linte-resse facilita non solo la comprensione pi semplice, pi superficiale, ma anche quella picomplessa presente in un dato testo.
Pinto presenta una rassegna dei principali filoni di ricerca che oggi si confrontano aproposito dello sviluppo dei sistemi simbolici, delle relazioni tra linguaggio e codice scrit-to. Come sono connesse le conoscenze fonologiche e quelle relative al codice scritto? Dopouna rassegna della letteratura sullargomento, viene presentato un modello evolutivo e unaserie di indicazioni specifiche sul modo in cui insegnare, educare alla consapevolezza fono-logica. Bombi, Cannoni, Angelucci, Colafigli illustrano una ricerca sul confronto tra leidee infantili sul disegno e sulla scrittura, dalla quale emerge come i bambini abbiano rap-presentazioni ben distinte di tali due strumenti, il disegno e la scrittura, e di quanto sianoquindi complesse le loro relazioni evolutive, anche sotto il profilo degli interventi educati-vi. Bortolotti e Czerwinsky Domenis presentano una indagine empirica sulle relazioni tracontesti di gioco e comunicazione tra pari, dalla quale emerge come la produzione lingui-stica dei bambini si muova ancora preferibilmente in relazione ad una prospettiva ludica,ad una dimensione immaginativa e creativa dove la comunicazione viene utilizzata prefe-ribilmente per attivit piacevoli come quelle legate al gioco. Rollo propone una ricerca sulruolo del linguaggio nello sviluppo concettuale, mediante una analisi critica del paradig-ma delle classi di equivalenza. Aprile presenta una ricerca sui processi di elaborazionecognitivo-linguistici di stimoli verbali e visivi corrispondenti. Faso e Primi illustrano unostudio empirico sulle referenze agli stati mentali nelle produzioni narrative infantili.Bigozzi propone uno studio sulla correttezza ortografica, nel quadro dei concetti di pro-cesso e prodotto legati alle ricerche sulla lettura. Calvani, illustra una indagine sullef-fetto di frequenza duso di fonemi della lingua italiana in soggetti afasici con deficit di les-sico fonologico di output e/o di buffer. Accorti Gamannossi propone uno studio sulle rela-zioni tra livello socio-economico e sviluppo linguistico in et prescolare. Malvagia eFontani studiano alcuni modelli didattici finalizzati allo sviluppo del pensiero critico. DiFabio propone una riflessione sulle prove di verifica in relazione a nuove prospettive diintervento didattico che si sono aperte nellarea cognitiva. Infine, Bavazzano, Fornari eGrifoni presentano uno studio sulle modalit di sviluppo delle competenze cognitivo-lin-guistiche e di quelle di definizione lessicale.
Credo che anche in questo caso il lavoro di Boschi porti oltre questo orizzonte le fron-tiere della ricerca futura e a nuove riflessioni sui significati di quella passata e presente.
Forse lo sviluppo cognitivo-linguistico, come fondamentali figure della storia della psi-cologia hanno sostenuto, riflette in modi particolarmente specifici, mirati lorganizzazionee levoluzione delle architetture della mente umana, sia in generale che nei singoli indivi-dui.
Il paziente in analisi, adulto o bambino che sia, porta in primo piano le strutture e ilfunzionamento della sua personalit attraverso processi cognitivo-linguistici, mediante ciche dice, che fa. Corrispondentemente lanalista interviene sulla mente del paziente con
Introduzione 3
-
parole, con azioni che seguono un loro percorso simbolico nelle rappresentazioni, consa-pevoli o al di fuori del campo della coscienza dellanalizzato stesso. Le opere di SigmundFreud, di Melanie Klein cos come tutta la storia della prospettiva psicodinamica e psicoa-nalitica sono l a dimostrarlo.
Lo sviluppo della mente, come emerge fin dai lavori di Jean Piaget, ai pi recenti con-tributi di Jerome S. Bruner, sembra avere unintima connessione con levoluzione dei pro-cessi cognitivo-linguistici.
Le attuali ricerche storico-culturali e neurobiologiche, in stretta relazione con il fioriredi studi sulle opere di Lev S. Vygotskij e Aleksandr R. Lurija che sempre pi diffusamen-te compaiono nella letteratura specialistica internazionale, evidenziano il ruolo chiave svol-to dai processi cognitivo-linguistici nellaprirci nuove strade nella conoscenza della menteumana, anche a livello di singoli individui.
Il lavoro di Filippo Boschi si nutrito, secondo me, di queste ipotesi che ho sintetizza-to in tali due punti base. E credo che sia questo, ridotto in poche parole, il contributo diFilippo Boschi alla storia della psicologia contemporanea.
4 Luigi Aprile
-
1Filippo Boschi:una vita per la psicologia
Intervista di Luigi Aprile (03/02/2001)
Prima parte
Ho incontrato il Prof. Filippo Boschi il 3 febbraio del 2001 alle 11 e 30 per iniziare unaconversazione sulla sua vita di studioso: una vita dedicata alla psicologia.
Sono entrato nella sua casa, dove avevo messo piede per la prima volta alla fine di gen-naio del 1986. A differenza di allora, attualmente lingresso e lo studio compongono ununico ambiente, ugualmente sobrio ed elegante. A distanza di quindici anni, mi accorgoche il Prof. Boschi ha mantenuto lo stesso entusiasmo, la stessa capacit di lavoro, lo stes-so desiderio di scavare, di cercare, di scoprire nuovi sviluppi nelle cose di cui si occupa-to fin da quando era studente universitario e poi, dopo la laurea, come allievo del primoCorso biennale di Specializzazione per Collaboratori psicologi (1955) presso lIstituto diPsicologia dellUniversit di Firenze, diretto da Alberto Marzi. Era il periodo a cavallo frala fine degli anni Quaranta e la met degli anni Cinquanta. Fasi di grandi cambiamenticaratterizzavano la psicologia internazionale del ventesimo secolo: nordamericana, da unlato, con lemergere degli studi di matematica e ingegneria computazionale che avrebberoportato alla costruzione dei primi computer, scoperte che avrebbero segnato il nascere dinuovi modi di fare e concepire la psicologia scientifica, cos come fino ad allora, in misu-ra dominante, erano proposti dalla prospettiva comportamentista. Daltra parte, anche lapsicologia europea segnava nuove rotte nello studio dello sviluppo, della struttura e dellefunzioni dellintelligenza e della personalit, con i relativi strumenti di misurazione, di cuidette ampia documentazione Maria Luisa Falorni in due famosi volumi dei primi anniCinquanta.
In Italia, la psicologia scientifica era in piena fase di ricostruzione. Nel 1945 sopravvive-va in Italia ununica cattedra di psicologia presso lUniversit Cattolica di Milano, gli altriinsegnamenti erano stati soppressi in seguito allimpostazione della riforma gentiliana.
Il prof. Boschi ha proposto di sederci in salotto, disponendo una specie di area di lavo-ro con un tavolino, dove appoggiare fogli documenti e registratore, e due sedie poste unadi fronte allaltra, ai lati maggiori del tavolo. Il Professore aveva le spalle che davano versola finestra, mentre io stavo sullaltra sedia. La giornata era grigia e la scarsa luce mi rende-va difficile mettere pienamente a fuoco i lineamenti del suo volto e cogliere cos nitida-mente le sue espressioni.
-
Mi sembrato di percepire, appena seduti e acceso il registratore, un certo imbarazzodi entrambi. Dun tratto, ho avvertito come un passaggio di clima: dallinformalit degliscambi iniziali del nostro incontro, a una certa ufficialit, un andare al cuore del proble-ma.
Il Professore ha tuttavia sentito il bisogno di sdrammatizzare e, sorridendo, ha detto:
Appunto, ti chiedevo: di cosa vuoi che ti parli?
Ecco, io pensavo di chiederle questo: prima di tutto, che cosa lha indotta a occuparsidi studi sulla psicologia del linguaggio, dellapprendimento, sulla psicologia cognitiva, nelmomento in cui ha cominciato a fare ricerca. Qual era il panorama, qual era il clima cul-turale, storico della psicologia nel periodo in cui ha iniziato, sia a livello nazionale cheinternazionale? Perch immagino che allepoca fossero tuttaltro che scontati questi svilup-pi che oggi sembrano cos ovvi; mi riferisco, ad es., alla notevole espansione delle ricerchesui rapporti tra cervello, mente e processi di apprendimento. In particolare, che cosa lhaindotta a occuparsi per tutti questi anni dei processi di comprensione? Che cosa ha vistonegli studi di Frederick B. Davis di cos interessante da meritare un approfondimentointensivo e continuativo per diversi decenni?
Comincio a rispondere cos, a braccio. Non posso infatti avere una memoria immediata diquesti cinquantanni!
Il primo approccio con limpostazione di Davis risale alla prima met degli anni Cinquantaed avvenuta tramite lo studio delle basi teoriche del suo test (il Davis Reading Test) che miport in seguito a collegarmi con gli studi sulle teorie della mente. Il responsabile delleOrganizzazioni Speciali, Edoardo Abbele, mi pass questo test di Davis sui fattori fondamen-tali di comprensione della lettura, con lo scopo, poco impegnativo inizialmente, di tradurre iltest e di farne un adattamento italiano. Cominciando a lavorare, con laiuto di esperti in lin-gua inglese, mi accorsi che una traduzione e un adattamento italiano di un test di comprensio-ne del linguaggio nato in lingua straniera non era un compito che avrebbe potuto risolversi inmodo soddisfacente. Allora proposi, sulla scorta della tassonomia di Davis, di fare un test ita-liano. E cos avvenne, con la pubblicazione del mio primo test: il TCL-Test di Comprensionedella Lettura per le scuole superiori.
Nel momento in cui lei inizi, mi risulta che la psicologia della lettura, in Italia, prati-camente non esistesse.
In realt, in Italia, non mi sembrava che ci fosse molto in psicologia della lettura. Fammi,tuttavia, confrontare le date. Alla fine degli anni Sessanta avevo preso la Libera Docenza. Inquelloccasione, avevo tenuto una lezione sul tema della lettura attraverso gli studi psicologici,poi pubblicata in forma di articolo sulla rivista Cultura e Scuola, ed effettivamente la biblio-grafia riportata conferma la tua osservazione.
Perch proprio questo argomento?
6 Intervista di Luigi Aprile
-
Era quello sul quale avevo lavorato maggiormente nei dieci anni precedenti. Ma torniamotra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta.
In quel periodo mi ero messo a lavorare, sia dal punto di vista teorico che psicometrico, allacostruzione del TCL - Test di Comprensione della Lettura. Ma ero interessato anche a questio-ni metodologiche pi generali, in particolare quelle connesse alla psicometria, stimolato dagliinteressi e dalle competenze di Saulo Sirigatti, che conobbi al Corso di Specializzazione. Mi erogi occupato di test fin dal 1954-1955, quando svolgevo funzioni, poi ratificate da nominaufficiale, di Assistente Volontario di Psicologia presso lUniversit di Pisa. Tale incarico era com-pletamente gratuito, per nellambito dellUniversit facevano capo anche attivit di tipo remu-nerativo. A questo proposito, fui nominato Psicologo presso la Casa di rieducazione, doveappunto svolsi, secondo limpostazione del tempo, un intenso lavoro psicodiagnostico mediantelapplicazione di test.
In queste esperienze, che impressione ebbe di quelli che erano i problemi dellappren-dimento in questi ragazzi della Casa di rieducazione: fin da allora vide nel problema del-lapprendimento una problematica centrale?
Con questi soggetti i problemi della lettura, devo dire, erano tangenziali, ma non menoimportanti. Ad esempio nella scala Wechsler-Bellevue, nelle prove verbali, cerano appunto provedi vocabolario e di comprensione ed io non mi limitavo a dare il solo risultato quantitativo,numerico, ma, sulla scorta delle teorie piagetiane, formulavo anche un giudizio scandito cro-nologicamente, per tappe evolutive. Nelle definizioni delle parole, avevo gi individuato proce-dimenti che poi avrei chiamato, piagetianamente, tendenze assimilative e accomodative nellemodalit definitorie che si manifestano nel corso dello sviluppo. Nel fare la relazione sui singo-li soggetti, fornivo quindi sia una valutazione quantitativa, i risultati ottenuti nei test, che qua-litativa, il livello di sviluppo del soggetto, con le relative connotazioni di egocentrismo del pen-siero. Cos gli insegnanti delle scuole interne avevano indicazioni per orientare le rispettive scel-te didattiche.
Le sembr, a questo proposito, che le caratteristiche dei processi di comprensione, o deiprocessi di elaborazione lessicale di questi ragazzi con difficolt incidessero in qualchemodo sulla loro condizione? Le faccio questa domanda perch oggi, ad es., nel disegno delCorso di laurea triennale per Educatore professionale in ambito socio-sanitario, laPsicologia delleducazione non stata inserita. Questo perch si ritiene, probabilmente,che siano prevalenti le problematiche cliniche, di personalit, rispetto ai problemi, ad es.,connessi ai processi di comprensione, di elaborazione lessicale e linguistica. Ecco, questeesperienze che fece allepoca, che cosa le permisero di capire, di toccare con mano a que-sto riguardo?
Mi fai venire in mente proprio un aspetto che avevo approfondito e di cui avevo preso con-sapevolezza, forse in maniera, per certi aspetti, originale per il tempo. Nel discutere le interpre-tazioni dei subtest della Scala dintelligenza Wechsler-Bellevue, lautore aveva richiamato lat-tenzione sul possibile rapporto fra due test di intelligenza sociale: il test di Comprensione della
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 7
-
seconda prova della Scala verbale, in cui il soggetto invitato a descrivere come ci si deve com-portare in certe situazioni sociali (e che indicativa della maturit sociale e del retroterra for-mativo e culturale dei soggetti) e, nella scala performance, il test di Riordinamento di figure,che indica come il soggetto riesce a muoversi nelle situazioni pratiche di comportamento socia-le. Sulla base dei risultati ottenuti, lautore aveva suggerito che gli antisociali, coloro che pre-sentano difficolt e problemi di accettazione delle norme sociali, di aggressivit nei riguardidella societ mostravano una differenza, una eterocronia significativa nello sviluppo delle duecapacit. Nellintelligenza sociale pratica, che risultava nel Riordinamento di figure otteneva-no punteggi molto elevati, mentre nellintelligenza sociale misurati con laltro subtest, presenta-vano punteggi molto bassi. Appariva dunque che questi giovani erano molto bravi nel realiz-zare una sequenza di azioni, per pianificare ed eseguire ad esempio un furto, uno scippo e cosvia, mentre non erano in grado di esprimere un giudizio di adeguatezza o di non adeguatezzasociale dei loro atti. Erano quindi soggetti capaci di muoversi a un livello pratico nella societ,ma non lo erano altrettanto nel valutare le conseguenze delle loro azioni e di operare sceltesocialmente positive.
Avevo raccolto unampia documentazione negli anni della mia attivit di psicologo cliniconegli Istituti di Osservazione, nelle Case di rieducazione e nella Prigione scuola, ove,secondo lorientamento del tempo, sottoponevamo tutti i minori ai test psicologici dintelligenzae di personalit, oltre, naturalmente, a colloqui clinici.
In questi colloqui emergevano in maniera significativa le caratteristiche di questa disarmo-nia nello sviluppo delle competenze sociali e noi eravamo molto attenti a tener conto di taliaspetti. Ad es. ad un giovane che era risultato particolarmente abile nel mettere in moto unamacchina senza chiavi, connettendo fili ecc., lo psicologo fece presente il disappunto di un pro-prio amico quando una mattina era uscito e non aveva pi trovato la propria automobile. Inseguito a tale osservazione il ragazzo ebbe come una sorta di intuizione, di insight, sulle conse-guenze dei suoi atti alle quali non aveva pensato.
Hai ragione quindi a sottolineare limportanza della riflessione e delle competenze cogniti-ve e linguistiche accanto ai fattori emotivo affettivi.
Queste osservazioni che lei fece lo indussero dunque a riflettere sullimpatto che puavere, per es., nello sviluppo psicosociale di un soggetto, ma pi in generale nello svilup-po psicologico, levoluzione dei processi di comprensione e produzione linguistica. Fu por-tato a riflettere in generale sul peso che pu avere lo sviluppo linguistico e cognitivo nellosviluppo della mente, del cervello di un soggetto, ma queste esperienze furono anche piestesamente uno stimolo a interessarsi dei problemi della lettura e pi in generale del fun-zionamento della mente?
Inizialmente, questi due interessi sono andati avanti in modo parallelo: come psicologo pro-fessionale operavo in varie istituzioni e organismi, anche quindi con compiti di diagnosi e trat-tamento di minori devianti o a rischio, o con compiti di orientamento scolastico, mentre comestudioso ero sempre pi coinvolto nellanalisi dei fattori fondamentali che sottostanno ai proces-si di comprensione della lettura. Ma se torniamo al punto di partenza di questa conversazione,devo dire che il mio interesse per limportanza che riveste lo studio della lettura nello sviluppo
8 Intervista di Luigi Aprile
-
dellindividuo maturato soprattutto in connessione con gli studi nel campo della psicologia sco-lastica e pi in generale della psicologia delleducazione. In questo senso: successivamente allapubblicazione del TCL - Test di Comprensione della Lettura (1965), ricevetti linvito da partedi Luigi Meschieri a partecipare al progetto IEA-CNR. Fui coinvolto in uno dei pi grandi pro-getti internazionali di psicopedagogia comparata promosso dallInternational Association forthe Evaluation of Educational Achievement con lo scopo di confrontare il rendimento scolasti-co (e quindi la qualit della scuola) nei vari paesi e nelle varie discipline scolastiche, compresala comprensione della lettura. Fui pescato attraverso quella mia pubblicazione, in quantoMeschieri stava organizzando per lItalia il pacchetto delle prove e gli occorreva una batteria ditest di comprensione della lettura. Nel gruppo di lavoro trovai Domenico Parisi, OrnellaAndreani Dentici, Tullio De Mauro, Aldo Visalbeghi, Maria Corda Costa e Lydia Tornatore.Eravamo agli inizi degli anni Sessanta.
Quindi erano passati quasi una diecina di anni dal momento in cui aveva iniziato aoccuparsi di teorie e tecniche dei test applicati alle situazioni curricolari, forse cera un veroe proprio vuoto di studi e ricerche nel campo della psicologia della lettura in Italia.
Questo vero solo in parte, anche se le presenze importanti (Gabriele Calvi e la stessaAndreani coi loro studi sullintelligenza e sulla creativit) erano al momento esigue. Questi col-leghi furono fra i primi in quel periodo a occuparsi di psicologia scolastica e delleducazione. Sitrattava di un lavoro da pionieri, dato il lungo periodo di silenzio della cultura psicologicanel nostro paese. Basti pensare che il 1923, anno dellattuazione della riforma Gentile, con lagraduale soppressione degli insegnamenti di psicologia, coincideva invece negli Stati Uniti conla fondazione dellAssociazione di psicologia dellEducazione ad opera di Edward L. Thorndike.E fu proprio alle iniziative ed alle pubblicazioni di lingua inglese che facevamo ricorso per recu-perare il tempo perduto; cosa non facile perch bisogna tener presente che a quellepoca non eraagevole reperire materiali bibliografici. Per avere un articolo o un libro straniero a volte si dove-va aspettare mesi e non erano disponibili neppure banche dati per una rapida ricerca biblio-grafica.
Se torniamo per al nocciolo della domanda precedente, cio limportanza di cogliere il pesoche ha la comprensione nei processi cognitivi dellindividuo, fui subito colpito dalla rilevanzateorica e operativa delle ricerche di Frederick B. Davis. Questo mi indusse a prendere contattocon lo stesso autore, con il quale intercorsa una corrispondenza fruttuosa, soprattutto in rife-rimento al lavoro sui fattori fondamentali che guidano la comprensione nella lettura: lormaicelebre Fundamental Factors of Comprehension in Reading, pubblicato sulla rivistaPsychometrika alla met degli anni Quaranta. Iniziai da quel momento a confrontarmi conuna serie di aporie metodologiche, che soltanto col tempo siamo riusciti a sbrogliare. Nel dibat-tito che ne seguito, il fulcro centrale di interesse sia teorico che applicativo era costituito dal-lintuizione cruciale di Davis: certi fattori di comprensione sono fondamentali e quindi da sti-molare specificamente, cio le varie competenze non sono soggette a un transfer assicurato.Tuttavia le verifiche empiriche stentavano a dimostrare lindipendenza dei fattori: la varianzaemersa dalle analisi di Davis era cos piccola che in realt la comprensione della lettura potevaessere interpretata come un fattore unico. Questo dibattito riportato nel mio libro Psicologia
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 9
-
della lettura, dove sono documentati e illustrati i riferimenti bibliografici delle varie analisifattoriali, dibattito che copriva oltre un ventennio al 1977, data di pubblicazione del volume.Finch appunto si scoperto (ed anche noi abbiamo contribuito ad evidenziare questo fatto)come i risultati che rendevano difficile lindividuazione di fattori separati fondamentali nellacomprensione della lettura erano dovuti a procedure metodologiche. Nel Davis Reading Test enei primi test del genere, si presentava un brano con domande aggiuntive che facevano capo avari fattori e ci provocava appunto problemi di inibizioni proattive e retroattive, per cui nonera possibile stabilire se la risposta del soggetto a una data domanda fosse influenzata dalladomanda precedente, che attivava un altro processo. Tale effetto disturbante si rifletteva suirisultati delle analisi fattoriali.
Il nostro contributo alla soluzione del problema stato evidenziato con la costruzione delleProve di Comprensione dei Linguaggi, le 5 V-M (1996 e 2000) e con le sperimentazioni rela-tive. Seguendo le indicazioni della letteratura specialistica, abbiamo previsto cinque differentiforme di linguaggio (Parafrastico, Inferenziale, Logico, Critico-Valutativo ed Estetico-Poetico) eper ciascuna forma abbiamo scelto dei brani, avendo cura di farli seguire da domande accura-tamente riferibili alla specifica forma che si doveva misurare. Questa scelta metodologica statapremiata, per cui i risultati statistici ci hanno permesso di dimostrare che i cinque Fattori sonoveramente delle capacit da considerare separatamente. Altre evidenze sono state ottenute dalgruppo di ricerca che fa capo a Cesare Cornoldi dellUniversit di Padova, che si distintoanche per pregevoli iniziative a livello di una adeguata applicazione delle impostazioni teori-che.
Il nostro Modello di comprensione della lettura entrato cos a far parte degli studi condot-ti nellambito del dibattito sulle teorie della mente, che oppongono concezioni modulariste aconcezioni connessioniste. I nostri risultati, dai quali si trae sia lindicazione che i cinque fat-tori partecipano di un processo cognitivo-linguistico unitario, sia la dimostrazione empiricadella consistenza di cinque fattori, si collocano in una posizione intermedia.
Ecco, tutto questo ci riporta agli aspetti pi strettamente scientifici. Torniamo agli inizidel suo lavoro di ricerca. Oggi si tende a trattare le problematiche dei soggetti svantaggia-ti a vari livelli nei processi di apprendimento come problematiche di tipo clinico, perso-nologico o di tipo evolutivo generico, ad es. legate ai processi di sviluppo sociale. Mentremi ha colpito il fatto che ancora oggi, a distanza di quasi un cinquantennio da quando leiha iniziato queste ricerche, si tende ad avere difficolt a capire il peso che possono avereproblemi legati allo sviluppo dei differenti processi di comprensione nello sviluppo men-tale del soggetto. Non le sembra che si tenga poco conto che il rapporto tra intelligenza,cognizione e processi di sviluppo sociale ed emotivi sia, come dire, pi propriamente, bila-terale? Quindi se i fattori di personalit, per cos dire, colpiscono e condizionano lo svi-luppo dellintelligenza, della cognizione, presumibilmente se ci sono questi fattori distintinon altamente probabile anche un discorso allopposto: cio presumibile che questi fat-tori di comprensione che evolvono a ritmi distinti possano incidere pesantemente sullo svi-luppo anche emotivo, affettivo e sullo sviluppo delle capacit sociali? Quando si occup diqueste ricerche sui fattori distinti arriv a conclusioni, a una qualche ipotesi riguardo a taliproblematiche? La domanda in sintesi questa: il fatto che Davis avesse intuito la presen-
10 Intervista di Luigi Aprile
-
za di fattori distinti nei processi di comprensione e che abbiate ottenuto evidenze empiri-che di tale distinzione, a che riflessioni la port riguardo pi in generale al modo di fun-zionamento della mente e al modo di intervenire sul loro sviluppo?
Siamo stati portati a collegare le carenze nella formazione scolastica con la scarsa conoscen-za e consapevolezza di queste acquisizioni della ricerca psicologica. Non ci siamo stancati di sot-tolineare (ottenendo frequenti consensi) come di solito gli insegnanti come gli stessi autori dilibri di lettura stimolano prevalentemente la comprensione in maniera non mirata. Le ricercheinternazionali, ad esempio lindagine IEA di cui ho parlato prima, hanno messo in rilievo comegli allievi italiani mostrassero modalit di comprensione della lettura di tipo assimilativo-ricet-tivo, evidenziando carenze nella comprensione approfondita. Anche le nostre ricerche sul con-cetto di maturit in lettura, che ho sviluppato con Giuliana Pinto, studiando le abilit e lecapacit di lettura degli studenti liceali, avevano evidenziato che i nostri giovani scolastica-mente maturi mostravano di essere ampiamente alfabetizzati per quanto riguarda la quantitdi lettura, mentre apparivano ancora analfabeti nelle capacit di lettura critica e creativa, dicollegare con lazione innovativa le informazioni assunte leggendo e di prendere spunto dalle let-ture per migliorare la comunicazione interpersonale.
Ci significa che occorre intervenire, a livello di formazione e di sviluppo sia sugli aspetticognitivi che sulle componenti affettive e di personalit. A livello applicativo abbiamo tenutoconto di tale esigenza nellintepretazione dei profili che derivano dallapplicazione delle nostreProve, considerando il fenomeno delleterocronia nello sviluppo delle cinque competenze.Proprio leterocronia era oggetto di unanalisi che permetteva di evidenziare, anche medianteconfronti con altri tipi di rilevazioni, interferenze emotivo affettive sullapprendimento. Nelsenso che se un individuo ha bisogno di sicurezza mostra ad es. un picco elevato nello sviluppodelle competenze di tipo logico formale, dove la risposta alle domande una e unica e dunquerassicurante. In altre competenze, ad es. quelle critico-valutative, o anche per certi aspetti quel-le inferenziali, che richiedono di dover scegliere una risposta prevalente ma non sicuramenteunivoca, tali soggetti insicuri presentavano un abbassamento nei punteggi ottenuti. Allora checosa determina tale abbassamento intellettivo nelle abilit critico valutative o inferenziali in unsoggetto che mostrava una emergenza cognitiva in forme di ragionamento complesso come quel-le richieste dal fattore logico? Approfondendo lanalisi si scopre che si tratta di fattori di perso-nalit che incidono sullintelligenza e viceversa.
Pi recentemente ha svolto un approfondimento teorico ed unarticolata sperimenta-zione che le ha permesso, sempre nellambito delle teorie della mente, di fornire le proveempiriche per lindividuazione di due distinti fattori di competenza lessicale: il fattoresemantico ed il fattore pragmatico, con riferimento alla definizione delle parole.
Quando abbiamo cominciato ad occuparci dello sviluppo lessicale non pensavamo che cisaremmo imbattuti in un campo cos vasto e cos ricco di zone ancora inesplorate. Ad avventu-rarci in questo ambito siamo stati spinti da una fondamentale intuizione di Vygotskij per ilquale la coscienza si riflette nella parola come il sole in una piccola goccia dacqua: La parolasta alla coscienza come un piccolo mondo ad uno grande, come una cellula vivente ad un orga-
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 11
-
nismo, come un atomo al cosmo. Lapprofondimento teorico e sperimentale che ho effettuato instretta collaborazione con i membri del gruppo di ricerca del nostro Dipartimento di Psicologia,nel quale tu stesso hai ricoperto un ruolo fondamentale, ha permesso di individuare e di evi-denziare nella ricchezza del linguaggio lessicale gli organizzatori cognitivo-linguistici dellaconoscenza. Come ho indicato nel contributo presente in questo volume abbiamo presentato dueModelli di rappresentazione lessicale, empiricamente dimostrati e riferibili alle Grammaticheinfantili e alle Grammatiche delladulto.
E sulla base di questi modelli ha sviluppato un efficace metodo di educazione lessicalee linguistica centrato sulle parole, ma strutturato in modo tale da permettere, allinternodi items lessicali, la stimolazione dei processi fondamentali costitutivi del pi ampio svi-luppo cognitivo-linguistico.
Desidero ripetere quanto mi stato di aiuto e di stimolo il contributo tuo, di mia moglie edi Lucia Bigozzi, per elaborare un programma che prevede stimolazioni gradualizzate in otti-ca evolutiva, mediante un analitico ed articolato riferimento alle tappe e alle crisi di sviluppoche caratterizzano lapprendimento delle parole. Si tratta di una realizzazione nella quale teo-ria e conseguente applicazione sono oggetto di un reciproco monitoraggio.
Da tempo, per fortuna, tali contributi non sono pi isolati. Disponiamo di pregevoli pub-blicazioni anche nel settore della psicologia delleducazione costituite da manuali come quelli diPietro Boscolo, di Clotilde Pontecorvo, di Guido Petter e, pi recentemente, di Felice Carugatie sono pure disponibili materiali applicativi ancorati a precise teorie dellapprendimento, cura-ti dallo stesso Petter e dal citato gruppo di Cesare Cornoldi.
Anche il settore che affronta i problemi del disagio e del rischio sociale ha espresso nuovi epi produttivi approcci, che si estendono ad una casistica pi ampia di quella da me visitatanelle mie lontane esperienze di psicologa clinica. Basti ricordare gli studi sul bullismo di AdaFonzi e del suo gruppo e le proposte di intervento che ne conseguono.
Seconda parte
Passando ad altro nucleo di argomenti, vorrei chiederle qualche notizia sul panoramaorganizzativo riferibile allo sviluppo della psicologia a Firenze, in particolare allistituzionedel Corso di laurea di psicologia, ove anche lei ha avuto un ruolo di rilievo.
Nella seconda met degli anni Cinquanta ci fu unapertura verso la psicologia nella Facoltdi Magistero, ad opera di un pedagogista molto vicino alla psicologia, Lamberto Borghi, mortorecentemente. Alberto Marzi, insieme a Borghi, aveva richiesto che nella Facolt di Magisterofossero introdotte altre discipline psicologiche. Cos, nella prima met degli anni Sessanta, ce-rano a Magistero: Psicologia dellEt Evolutiva, Psicologia Sociale, Psicologia Pedagogica,Psicologia Dinamica, Psicologia Generale, Storia della Psicologia. Psicologia era insegnata daAlberto Marzi, che frattanto era passato alla Facolt di Magistero.
Perch era passato?
12 Intervista di Luigi Aprile
-
Perch precedentemente insegnava alla Facolt di Lettere e Filosofia. Il mio primo esame dipsicologia lo sostenni con Marzi, a Lettere.
LIstituto di Psicologia allepoca dovera?
Era in via Battisti, dove tuttora compare uninsegna che indica la propriet dellUniversitdi Firenze.
Lei frequent lIstituto in via Battisti?
Ci avvenne dopo la laurea, per frequentare il Corso di specializzazione.
Lei con chi si laure?
Mi laureai in Lettere con una tesi in Pedagogia, con Giovanni Cal.
Su quale argomento?
Su Scoutismo e scuole attive, con una commissione di rilievo presieduta da GaetanoSalvemini, e composta, oltre al relatore, da Eugenio Garin, Gaetano Chiavacci, PaoloLamanna. Cera gi in me un orientamento verso laspetto psico-pedagogico, con riferimentialla psicologia dello sviluppo. Poi, avendo cominciato ad insegnare nella scuola media, ebbinotizia del Corso di specializzazione per Collaboratori psicologi, organizzato da Marzi. Nelcorso conobbi Maria Luisa Falorni, che aveva bisogno di un assistente a Pisa e fui segnalato daMarzi. Cos cominci questa doppia gestione tra linsegnamento di materie letterarie nella scuo-la media, di psicologia alluniversit e di attivit psicologica nelle sedi applicative, ove iniziaianche le mie ricerche.
Che significato aveva un corso per Collaboratori psicologi?
Alla met degli anni Cinquanta per chiamarsi psicologi bisognava avere almeno la Liberadocenza, per cui fu adottata per questo corso una terminologia cos blanda, pur essendo i par-tecipanti tutti laureati. Fra i docenti cerano per cattedratici di rilievo: cera Ugo Teodori, ceraLamberto Borghi, Walter Battacchi, Renzo Canestrari, Maria Luisa Falorni, Sergio Levi.
A quel tempo quali attivit svolgeva?
Ai primi del 1960 lasciai la scuola media e mi dedicai soltanto allo studio e al lavoro di psi-cologia. Dato che lincarico di Assistente volontario era gratuito, svolgevo attivit di consulen-za presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Istituto di Osservazione, Case di rieducazionemaschili e femminili, Prigione scuola) e, dal 1962 al 64, consulenza presso il Centro di orien-tamento scolastico e professionale della Camera di commercio di Pistoia e, successivamente, finoal 1974, presso una Comunit giovanile di Arezzo. Nel 1968 avevo preso la libera docenza ed
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 13
-
avevo cominciato ad insegnare Storia della Psicologia a Magistero.
E allepoca come si prendeva la Libera docenza?
Si prendeva facendo domanda, quando venivano aperti i bandi. A quel tempo avere laLibera docenza non significava avere un lavoro, ma avere un titolo. Serviva tuttavia perch gliincarichi universitari venivano dati solo ai liberi docenti, quando si rendeva disponibile unposto. Cos ebbi lincarico (gratuito) di Storia della psicologia, a Magistero. Il primo incaricouniversitario retribuito fu quello di Psicologia Generale alla Facolt di Lettere e Filosofia.
In contemporanea?
Inizialmente s, ma poi lasciai Storia della Psicologia.
Perch la lasci?
Perch tutte e due gli insegnamenti assorbivano molto tempo: erano gli anni della liberaliz-zazione degli accessi, per cui sia a Magistero che a Lettere cerano molti studenti.
In che anni siamo?
Era il 1971-72 Nel 1981 vinsi il concorso e diventai professore ordinario di PsicologiadellEt Evolutiva a Magistero.
Quindi nell81 tornato a Magistero. Per quale motivo, a Lettere non fu creato un inse-gnamento di professore di prima fascia?
Erano anni in cui la filosofia nella Facolt di Lettere, come a livello nazionale, presentavaun forte sviluppo con nomi prestigiosi come, a Firenze, Eugenio Garin e Cesare Luporini, men-tre i docenti di psicologia e delle altre scienze umane erano ancora alle fasi iniziali della loroformazione, per cui non era facile rimpiazzarli quando i docenti di queste discipline si trasfe-rivano altrove. Negli anni Settanta presso lIstituto di filosofia cerano tre insegnamenti di psi-cologia e tre di pedagogia, attualmente rimasto solo un insegnamento di psicologia.
Perch si crearono queste opportunit nella Facolt di Magistero?
Con la liberalizzazione degli accessi il numero degli studenti era molto cresciuto. Ada Fonziaveva chiesto lo sdoppiamento della cattedra di Psicologia dellEt Evolutiva ed era stato ban-dito anche un concorso per Psicologia sociale, che fu vinto da Francesca Morino Abbele.
Quindi inizi il suo insegnamento a Magistero come ordinario dellinsegnamento diPsicologia dellEt Evolutiva. E lIstituto allora era gi in via della Pergola?
14 Intervista di Luigi Aprile
-
S.
Quali furono i problemi di ordine organizzativo? Mi sembra che fosse centrale linte-resse per istituire anche a Firenze il Corso di laurea in psicologia.
Nonostante le disponibilit concorsuali sopra ricordate non erano prevedibili significativisviluppi. Daltra parte molti studenti della regione si orientavano verso i corsi di laurea di psi-cologia di Padova e di Roma, ai quali (ci che attirava la nostra attenzione) il Ministero avevaassegnato un numero consistente di nuove cattedre (addirittura alcune diecine). Il problema eraquello di promuovere nella Facolt di Magistero, accanto al Corso di laurea in Pedagogia unCorso di laurea in Psicologia. Fu agli inizi del 1980 che cominciammo a stabilire dei collega-menti a livello nazionale con le altre Facolt interessate allo stesso progetto.
Lazione congiunta delle diverse sedi si realizz attraverso il coordinamento, a livello nazio-nale, di una Consulta dei Direttori degli Istituti e dei Dipartimenti di psicologia. Io ne facevoparte per delega di Francesca Morino, che dirigeva lIstituto e poi il Dipartimento di Firenze eche curava la regia del progetto. Attraverso la Consulta venivano vagliate le proposte delle variesedi. A Firenze, ottenuto lassenso della Facolt di Magistero, il progetto di apertura del Corsodi Laurea in psicologia fu inserito nel piano di sviluppo universitario 1986-90 (reiterando larichiesta gi avanzata fin dal 1980). La richiesta veniva motivata dal fatto che da oltre 15 annisi iscrivevano dalla Toscana ogni anno ai corsi di laurea in psicologia di Padova e di Roma oltre800 studenti, subendo i disagi di un dispendioso pendolarismo. Come responsabili deiDipartimenti di psicologia ci impegnammo a mettere a punto una strategia che si caratterizzasseper un salto qualitativo in quanto la precedente impostazione aveva gi espresso tutte le suepotenzialit. Tale impostazione, che puntava soprattutto a sottolineare gli aspetti quantitativi enumerici e le esigenze di preparazione professionale degli psicologi, si rivel ben presto insuffi-ciente in quanto fu recepita dal Ministero, ma fu letta alla luce dei dati statistici relativi alleiscrizioni dei Corsi di Padova e di Roma. Il numero di iscritti e di laureati in questi ultimi 15anni era risultato largamente eccedente le richieste del mercato del lavoro e le esigenze previstedai piani di programmazione nazionale. Le conseguenze furono quelle di vedere la psicologiacollocata tra le discipline universitarie a sviluppo bloccato. Ma dietro a questa impostazione pro-grammatoria cera lesigenza di economizzare sulle risorse, perch a quel tempo i nuovi corsi dilaurea ricevevano fondi per la creazione di nuovi insegnamenti. I piani pluriennali di svilupporichiesti dal Ministero erano dunque finalizzati a razionalizzare le richieste delle varie univer-sit, economizzando sulle risorse. Mentre eravamo in attesa della risposta ministeriale, avemmounindiretta anticipazione dellorientamento restrittivo del Ministero al riguardo, durante il dis-corso che il Ministro della Pubblica istruzione tenne a Firenze per linaugurazione dellannoaccademico. Doveva essere il 1987-88. Ero seduto accanto ad Ada Fonzi. Ad un certo punto ilMinistro, parlando dei criteri della programmazione universitaria afferm esplicitamente che ilMinistero era contrario alla parcellizzazione dei corsi di laurea. Ada ed io ci voltammo di scat-to luno verso laltra, sgranando gli occhi con espressione di accorato disappunto.
La risposta ufficiale del Ministero alle richieste della Consulta (fra cui la nostra) fu esami-nata nella riunione tenuta a Milano, l8 aprile 1988, presieduta da Enzo Funari e verbaliz-zata da Walter Gerbino. La risposta ministeriale si limitava ad accogliere linserimento nel
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 15
-
piano quadriennale 86-90 di tre atenei (Bologna, Trieste, Napoli) quali sedi in cui aprirenuovi corsi di laurea in psicologia. Nella stessa riunione la Consulta manifest la propria preoc-cupazione per lesclusione degli atenei di Torino e di Firenze dal novero delle sedi in cui si pre-vedeva lapertura di nuovi corsi di laurea in psicologia. A tale riguardo fu istituita una com-missione (Amerio, Andreani, Boschi, Cornoldi, Gerbino) col compito di elaborare al pi prestoun documento nel quale si sottolineasse lesigenza di delineare opportunamente le caratteristi-che dei corsi di laurea in psicologia come finalizzati non tanto e non solo a fornire una laureaa base professionalizzante, ma soprattutto a favorire lo sviluppo della cultura psicologica. Tenutoconto che il Ministero non era disposto a prevedere aumenti di risorse, venne presentata la pro-posta di un piano di coordinamento fra sedi territorialmente vicine, in modo da presentare solu-zioni economiche. Per quanto riguarda la nostra sede venne previsto un piano di coordinamen-to in pieno accordo con la sede di Bologna, per la creazione di un polo complementare con lat-tivazione del biennio propedeutico in ambedue le sedi, seguito da indirizzi triennali differenti.
Il documento della commissione, redatto in tempi rapidi, venne illustrato l11 maggio 1988al vice presidente del CUN Frati ed al sottosegretario allistruzione Covatta e guadagn lap-provazione della commissione in merito alle richieste delle sedi di Torino e di Firenze a condi-zione che lapertura di tali corsi non implicasse il reperimento di nuove risorse. Venne cos supe-rata la difficolt di aprire un corso di laurea in psicologia nella sede di Firenze, nonostante lavicinanza con la sede di Bologna. Dopo il biennio propedeutico Firenze avrebbe aperto sololIndirizzo di psicologia dello sviluppo e delleducazione, mentre Bologna avrebbe aperto indi-rizzi differenti (Psicologia generale e Clinica). Tuttavia rimaneva un orientamento tiepido neinostri riguardi da parte del Ministero, come ebbero modo di constatare il preside della nostraFacolt, Leonardo Savoia che, con Ada Fonzi, fu successivamente ricevuto dal sottosegretarioCovatta.
Comunque la strada era aperta per inserire e prevedere laccoglienza della nostra propostanel piano triennale 1991-93, che fu inviato con lapprovazione della Facolt di Magistero edel Senato Accademico dellUniversit. In tale proposta vennero rafforzate le ragioni per laper-tura dellIndirizzo Psicologia dello sviluppo e delleducazione, lunica formula che al momentoci permetteva di ottenere lapprovazione ministeriale per lapertura del Corso di laurea.
Nella motivazione della proposta mettemmo in luce tutte le argomentazioni che ci qualifi-cavano al riguardo. Oltre che per la competenza e interessi del corpo docente anche per le preoc-cupanti risultanze delle ricerche nazionali ed internazionali sulle carenze formative della nostrascuola, specialmente a livello medio e superiore. Listituzione di un corso di laurea col suddettoindirizzo avrebbe quindi rappresentato un significativo contributo per colmare il divario anco-ra esistente fra Universit e le esigenze formative del mondo della scuola e delleducazione.Venivano poi sottolineate le ampie risorse delle iniziative editoriali, presenti in loco, con volu-mi e collane riguardanti larea psicologica, compresi i settori di Psicologia dello sviluppo e del-leducazione e come in tali settori avessero sede in Firenze le redazioni di importanti rivistescientificamente qualificate. Attivi anche i collegamenti per la ricerca bibliografica presso la sededellUniversit europea e altri centri universitari. Il prestito interbibliotecario, attivo presso laFacolt di Magistero, permetteva di reperire le pubblicazioni necessarie ai lavori di ricerca. Danon trascurare il fatto che nellattuale progetto, dati gli accordi con lUniversit di Bologna, lin-dirizzo a noi assegnato veniva a coprire, per la formazione universitaria, un arco territoriale
16 Intervista di Luigi Aprile
-
molto vasto, che si estendeva da Roma a Padova.Da settembre 1988 il consiglio di Ateneo aveva assegnato al Dipartimento di Psicologia (che
frattanto era stato istituito, anche per il fattivo impegno di Francesca Morino) una nuova e piampia sede nel centro di Firenze (Palazzo Vegni), con aule utilizzabili anche per la didattica.Sulla base di tali disponibilit: sede, qualificazione dei docenti e servizi di ricerca, il Corso dilaurea in psicologia ed il successivo indirizzo di Psicologia dello sviluppo e delleducazione, con-cludevamo nella nostra relazione, presentava un elevato grado di fattibilit e, oltre ad attenua-re i disagi del pendolarismo studentesco, rispondeva ad aspettative di qualificazione culturalenellarea della psicologia cognitiva e socio-educativa, particolarmente sentite anche nel mondodella scuola.
Frattanto il gruppo di docenti e ricercatori, specialmente coloro che facevano capo al settoreSviluppo e educazione, frequentavano regolarmente congressi ed incontri nazionali ed interna-zionali, accrescendo la visibilit della qualit della ricerca nel nostro Dipartimento. Larea dellapsicologia generale, il cui insegnamento era rimasto vacante, fu coperta, anche se per un breveperiodo, dalla significativa presenza di Bruno Bara e poi, stabilmente, da Piero Salzarulo, assi-stiti validamente in modo continuativo da Giuliana Mazzoni.
Si trattato quindi di una lunga battaglia, durata quasi 10 anni, per superare gli osta-coli di una programmazione ministeriale che andava riducendo sempre pi lassegnazionedi risorse, ma alla fine ci siete riusciti ed avete inaugurato il Corso di laurea nellanno 1992-93. E ci siete riusciti superando le limitazioni della programmazione nazionale delMinistero attraverso questa formula economica, rivelatasi vincente, che aveva previsto unpiano coordinato con Bologna. Ma cosa sarebbe successo se fosse venuto a mancare que-sto vostro attivo e sagace interessamento? Cera il pericolo che questo corso di laurea nonsarebbe stato concesso?
In assoluto certamente no, anche perch negli anni successivi venne a cadere il rigoroso diri-gismo ministeriale che era ancora attivo, come abbiamo visto, alla fine degli anni Ottanta e agliinizi degli anni Novanta. Certo che un ritardo si sarebbe verificato, di quanto tempo non pos-sibile precisare, forse di due-tre-quattro anni, con negative conseguenze per lacquisizione dinuovi docenti, della nuova sede per la didattica, del progetto per la trasformazione in Facolt.Oggi saremmo forse a met percorso.
Queste precisazioni accrescono limportanza del vostro lavoro, di cui risentono positi-vamente gli attuali componenti del corso di laurea. Ma, nella fase iniziale, qual stato ilruolo del Dipartimento di Psicologia?
I Dipartimenti sono stati in questo caso listituzione che ha significativamente contribuitoa creare le basi organizzative e strutturali per la costituzione dei corsi di laurea e il nostro non stato da meno.
Dopo Leonardo Savoia divent Preside della Facolt il Prof. Orefice?
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 17
-
No, dopo Savoia c stato Sergio Givone ed sotto la sua presidenza che partito il corso dilaurea, iniziando con la formula a sviluppo bloccato, con le iscrizioni limitate a 150 studen-ti.
Lei quando divent Direttore di Dipartimento?
In corrispondenza dellapertura del Corso di laurea.
E in questa fase che problemi si posero?
Il Corso di Laurea, essendosi aperto a sviluppo bloccato, quindi praticamente senza nuoverisorse, grav per gran parte della propria organizzazione sul Dipartimento. Il primo anno tuttii corsi si svolsero nella sede del Dipartimento. E sempre come Dipartimento, con le nuove esi-genze di spazi per i corsi del secondo anno, collaboravamo per la ricerca di locali allesterno.Ricordo che eravamo spesso in contatto con gli incaricati dellAteneo per cercare spazi; anche neiteatri, specie quando, sotto le pressanti richieste degli studenti, aumentammo la leva annuale da150 a 250 (gli aspiranti erano fin dallinizio un migliaio). C voluto molto a sganciare ilDipartimento dai problemi della didattica per recuperare le sue caratteristiche di strutturadevoluta alla ricerca. Daltro lato quando, sotto le pressione ed il ricorso degli studenti, fu toltoil numero chiuso il problema degli spazi divent un problema cruciale per lAteneo.
Che impressione ebbe quando fu attivato il Corso di Laurea in Psicologia? Che dire-zioni avrebbe preso la psicologia fiorentina? Perch era inevitabile che ci sarebbero statiapporti di nuovi docenti, di nuovi indirizzi, di nuovi progetti.
C stata la comparsa di altri indirizzi di ricerca, che hanno arricchito il panorama scien-tifico del Dipartimento: con Piero Salzarulo e gli studi sul sonno, la psicologia della salute conSaulo Sirigatti, la metodologia con Riccardo Luccio e la storia della psicologia con LucianoMecacci. C poi una prospettiva di sviluppo per la Psicologia del lavoro e soprattutto il proget-to di trasformare il Corso di laurea in Facolt. Ci sono state poi delle modifiche anche per ilfatto che nel frattempo si verificato il passaggio del Dipartimento nellarea bio-medica.
Perch ora il Dipartimento nellarea bio-medica?
S. Ma questo non avvenuto perch ci fosse un interesse esclusivo per il settore bio-medicopi che per il settore umanistico. La spinta fu anche di tipo economico, perch nel passato perlassegnazione dei fondi di ricerca, il settore bio-medico aveva degli accreditamenti molto pielevati. Quindi non stata solo una questione culturale, ha influito anche un aspetto di tipopecuniario.
Limpressione che ho avuto che larea delleducazione sia andata progressivamente ero-dendosi nellambito della Psicologia, avendo preminenza una visione di tipo clinico nelleapplicazioni della psicologia o di tipo diagnostico, o di tipo clinico-diagnostico di orienta-
18 Intervista di Luigi Aprile
-
mento, ossia ambiti di psicologia del lavoro, che non squisitamente di psicologia delledu-cazione. Ecco perch le ho fatto quelle domande allinizio, proprio sullinterpretazionedella psicologia. Ho notato che questa tendenza ha avuto anche delle ripercussioni neglistessi corsi di laurea che si stanno progettando a Scienze dellEducazione, in quella che sarla Facolt di Scienze della Formazione anche nel caso in cui si costituisca la Facolt diPsicologia1, cio una visione dellarea della psicologia delleducazione come strettamenteconnessa soprattutto al momento scolastico, al momento educativo nel senso pi ristretto.Mentre, per esempio agli educatori professionali, sia in ambito socio-culturale che socio-sanitario, quindi a coloro che dovranno andare ad operare con giovani come quelli con cuilei ha lavorato allinizio della sua carriera, ragazzi con difficolt o devianti, non verrannofornite le basi per una cultura di psicologia delleducazione. Cio saranno soggetti cheandranno ad operare con questi ragazzi con una cultura di tipo clinico o tuttal pi evolu-tivo ma in senso lato e non in senso cos specifico. Mi sembrato che linsegnamento chederiva dalla sua vita di studioso sia che lo studio dei processi di apprendimento nel sensopi profondo del termine, cio dei processi della psicologia delleducazione, vada ad inci-dere sui processi di sviluppo, proprio su come si struttura la mente del soggetto e quindiin senso pi ampio sugli aspetti che riguardano lo sviluppo emotivo, le relazioni affettive,le relazioni sociali. Mentre oggi c una tendenza ad accentuare gli aspetti clinici, pi stret-tamente bio-medici, meno quelli formativi, educativi, che forse sarebbero il vero asse por-tante di una psicologia che non voglia declinare nelle neuroscienze.
Questa bandiera dovrebbe essere impugnata soprattutto nellambito della Facolt di Scienzedella Formazione. Ma anche il Corso e domani la Facolt di Psicologia dovrebbero tener contodi questi aspetti.
Se in un domani verr attivata la Facolt di Psicologia, sar un organismo autonomo osi appogger alla Facolt di Medicina?
La Facolt di psicologia sar autonoma, come tutte le altre Facolt. E certo questa realizza-zione, alla quale sta lavorando Luciano Mecacci, anche nella sua qualit di Pro-Rettore, per-metter di acquisire nuove e pi consistenti risorse.
In questi ultimi anni prima del suo pensionamento ha ricoperto a livello di Ateneo unruolo di Coordinatore della SSIS (Scuola di Specializzazione per lInsegnamento delleScuole superiori). Si tratta dellOrganismo che, mediante un corso biennale, permette aineo laureati di ottenere labilitazione allinsegnamento. Come mai si dedicato a questainiziativa?
Innanzitutto il Corso di laurea, con la presidenza Sirigatti e il Dipartimento con la dire-zione Luccio non avevano pi bisogno di me, ma soprattutto perch ho visto in questa proposta
Filippo Boschi: una vita per la psicologia 19
1 La Facolt di Psicologia stata istituita nellanno accademico 2002-2003.
-
legislativa un progetto che favoriva un salto di qualit nella formazione degli insegnanti: nonsolo nei metodi didattici per linsegnamento della propria disciplina, ma anche nellopportuni-t di offrire una conoscenza teorico-pratica delle competenze nei vari settori delle scienze delle-ducazione. Si trattato di un incarico nel quale ho dovuto interessarmi anche di aspetti orga-nizzativi, in ci sostenuto dalla costante collaborazione sia del Preside Paolo Orefice che delRettore Paolo Blasi, ma anche dalla simpatia di Paolo Marrassini e Roberto Casalbuoni, Presididelle Facolt di Lettere e Filosofia e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Soprattutto perho posto attenzione affinch lorganizzazione e la conduzione degli insegnamenti si svolgessesecondo i criteri innovativi della legge. In ci aiutato dai docenti universitari e dai bravi docen-ti delle scuole secondarie che avevano vinto il concorso per il ruolo di supervisori della attivitdidattiche e dei tirocini.
Se dovesse fare una sintesi di tutta la sua esperienza sia scientifica sia di studioso che halottato anche sul piano organizzativo per far emergere un Corso di Laurea e per organiz-zare la SSIS che visione dinsieme ha oggi di questa sua vicenda? Qual leredit che lascia,lapporto che pensa di aver dato sia sul piano scientifico sia sul piano istituzionale?
una domanda bella ma difficile. difficile racchiudere la risposta in una formula o inpoche parole. C stata sempre questa propensione a far cose fra loro coerenti sul piano organiz-zativo e sul piano della ricerca. Mi sembra che questo collegamento, questa corrispondenza traattivit di ricerca ed organizzativa sia stata una delle caratteristiche di questa mia vicenda.
20 Intervista di Luigi Aprile
-
2Percorsi di ricerca in psicologia della lettura
Filippo BoschiUniversit di Firenze
I Lo sviluppo degli interessi dagli anni Sessanta al Duemila
Linizio degli interessi di ricerca in questo settore si manifestato, fra laltro, attraversola pubblicazione, di un test di lettura per studenti di scuola superiore:
T.C.L. Test di Comprensione della Lettura (1965)
Lo stimolo che ci ha spinti a sviluppare questi precedenti interessi sulla psicologia dellalettura stata la pubblicazione, allinizio degli ani Settanta, dei risultati della grande ricer-ca internazionale di psicopedagogia comparata IEA-CNR.
I risultati erano stati piuttosto negativi per i nostri studenti alle soglie della maturitclassica e scientifica:
Tracciamo un sintetico riassunto dei risultati: 1967-73 Ricerca internazionale IEA-CNR patrocinata dallUNESCO
- Campione internazionale: 258.000 studenti / 50.000 insegnanti / 9700 scuole.- Campione italiano: 35.000 studenti.- Capacit esaminate: Lingua materna (vocabolario, velocit e comprensione di lettu-
ra, letteratura), Scienze, Matematica, Lingua straniera, Educazione civica, Scale di atteg-giamento
(verso la scuola, la famiglia, la societ).- Livelli scolastici esaminati: 10-11 anni / 14-15 / ultimo anno di scuola superiore.
* Risultati per lItalia: viene posta in rilievo dai coordinatori nazionali (A. Visalberghi eL. Meschieri), nei confronti delle altre nazioni, una generalizzata e netta inferiorit del pro-dotto culturale del nostro paese. Questi risultati si collocano molto al di sotto di quelli deglialtri paesi sviluppati.
Il nostro paese si colloca, a livello di maturit, fra i paesi sviluppati e quelli `in via disviluppo (Cile, India, Iran e Tailandia) che hanno partecipato alla rilevazione e ci in quasi
-
tutte le materie in cui il confronto possibile. inoltre il paese in cui si realizza il progresso minimo fra la fine della scuola media e
quella secondaria superiore sia nelle Scienze, sia in Letteratura, sia in Comprensione dellalettura, cio in tutte le materie in cui stato possibile effettuare tale comparazione (...)nonostante che la scuola secondaria italiana duri in genere un anno di pi rispetto agli altriPaesi ( Misurazione del rendimento scolastico - Indagine IEA e situazione italianaAnnali della Pubblica Istruzione, 5, pag. 1-369, 1977).
I suddetti interessi sono stati sviluppati sia a livello della lettura iniziale che della lettu-ra avanzata.
Mi limiter a citare quasi esclusivamente i libri, omettendo i numerosi articoli.
(A) Livello della lettura iniziale
Dopo un saggio su La lettura attraverso gli studi psicologici (1972), allinizio deinostri percorsi di ricerca si colloca il volume La lettura e linsegnante (1977) scritto conAndrea Smorti e Franca Tani. il contributo nel quale si trova la prima rassegna italiana einternazionale riferibile alle principali dimensioni della lettura iniziale: Reading-readiness,lettura decifrativa, comprensione. La ricerca da noi condotta riguarda 899 alunni di scuo-la elementare e mette in luce alcuni aspetti preoccupanti emersi anche a questo livello: limpreparazione degli insegnanti nel cogliere i disturbi di lettura; la tendenza ad evidenziare i disturbi verbali, trascurando le funzioni non verbali, che
assumono unimportanza geneticamente rilevante per lo sviluppo del pensiero la dimostrazione dei vantaggi di un intervento mirato dopo unaccurata diagnosi del
disturbo.Nel volume Imparare a leggere (1986) curato con Giuliana Pinto, ma comprendente
contributi di Giuliana Mazzoni e di Ida Scibetta, la ricerca svolta tende ad analizzare la fon-datezza delle tesi dibattute per contributi di Ferreiro Teberosky e di Crowder. Il successo,o eventualmente, linsuccesso in lettura, pu essere pi adeguatamente stabilito con pre-dittori specifici o con prove di tipo cognitivo-personologico pi generali?
Lipotesi economica dei predittori Reading like si basa sulla concezione che la letturapossa essere analizzata di per s. Crowder distingue cos lo studio degli aspetti che hannounimportanza centrale per la lettura da quelli che implicano importati connessioni fra lalettura e altre attivit mentali. Su tale orientamento metodologico sembra fondarsi la con-cezione dei pre-requisiti vicini al compito: reading like.
Dalla nostra ricerca longitudinale emerge che le prove reading like presentano correla-zioni positive solo col criterio correttezza decifrativa, cio con gli aspetti pi automatici esuperficiali della lettura. Non si evidenziano rapporti significativi con la comprensione delsignificato, cio con i processi che presuppongono lattivazione dei meccanismi profondidelle regole trasformazionali. I risultati ottenuti in queste ricerche autorizzano a ridimen-sionare linteresse troppo marcatamente rivolto agli aspetti linguistici del leggere a favoredi una pi ampia, anche se non esclusiva, considerazione delle funzioni cognitivo simbo-liche. Tali risultati sono inquadrabili in una problematica teorica pi generale sui rapporti
22 Filippo Boschi
-
fra pensiero e linguaggio nella prospettiva concettuale che, a partire dagli anni Settanta staprocedendo al superamento di una visione astratta dei suddetti rapporti, ponendo invecelaccento sullanalisi delle strutture semantiche e cognitive sottostanti lacquisizione del lin-guaggio. I suddetti risultati sulle relazioni fra pensiero-lettura iniziale sembrano confer-mare pi la posizione piagetiana sulle relazioni pensiero-linguaggio che una posizioneesclusivamente linguistica.
Ricerche di questo tipo sono decisive anche per gli orientamenti applicativi a livellodelle prime fasi dellapprendimento della lettura.
Studi sullo sviluppo lessicale
Linteresse per lo studio dello sviluppo lessicale si sviluppato con lintento di con-frontarsi con i termini del dibattito svolto allo scopo di conferire al concetto di sviluppouno statuto epistemologico valido sia dal punto di vista teorico che sperimentale.
La sperimentazione sui modelli di sviluppo presenta particolare interesse in quanto per-mette di chiarire, nellarea presa in esame, leventuale emergenza di differenze stadiali oscansioni caratterizzate da fenomeni di priorit temporali (decalages).
Le concezioni neostrutturali e interattivo-cognitiviste (Case, Mounoud) tendono aintegrare lidea secondo cui lo sviluppo cognitivo si realizzerebbe secondo stadi caratteriz-zati da operazioni molto generali, con una concezione che implica una fondamentale par-tecipazione di componenti operazionali specifiche ai vari campi di conoscenza. In tal senso,la maggior importanza attribuita allinterazione dei fattori ambientali (in particolare del-lambiente umano) con gli schemi organizzativi interni, agli effetti dellapprendimento,permette di superare una concezione dello sviluppo come sequenza normativa di opera-zioni molto generali, in cui lordine delle acquisizioni sia prefissato ed immutabile edammette che una variazione nel ritmo di sviluppo dipenda anche dalle disponibilit di sti-moli ambientali appropriati. Si tratta di un processo interindividuale nel quale il fanciullofa la sua parte, fornendo il contributo della propria organizzazione interna.
Quando abbiamo iniziato ad occuparci dello sviluppo lessicale non pensavamo che cisaremmo imbattuti in un campo cos vasto e ricco di zone ancora inesplorate.
Per molti anni alcuni linguisti avevano escluso lo studio del lessico, perch mancante diquelle regolarit richieste per un inquadramento rigoroso. Per Bloomfield, ad esempio,il lessico rappresentava una somma di irregolarit. Ma anche dopo la rivoluzione linguisti-ca verificatasi ad opera del paradigma chomskiano, lo studio del lessico rimase a lungo tra-scurato.
Alinei (1974) afferma per la mancanza di una teoria e di un metodo adeguati, il lessi-co rimasto finora come una sconfinata foresta di cui, al massimo, conosciamo alcunialberi.
Seguendo una prospettiva pi generale, nelle nostre ricerche abbiamo lavorato per cer-care o meno conferma alla tesi secondo cui lo sviluppo del linguaggio si realizzerebbe adopera di un apprendimento controllato da regole. Un appoggio a questa ipotesi sarebbe
Percorsi di ricerca in psicologia della lettura 23
-
indicato dalla documentazione di un vertiginoso aumento di parole conosciuto che si veri-fica negli anni di scuola.
stato stabilito, con sempre maggiore precisione che a partire da due anni il bambinoaccresce il suo patrimonio lessicale con una media di circa 10-13 parole al giorno. A cin-que sei anni conosce circa 3-4 mila vocaboli, con un aumento annuo che varia, secondo lestime, da 2 a 3500 termini (appunto circa 10 al giorno). Alla fine delle scuole medie supe-riori pu raggiungere 40.000 vocaboli se si escludono le molteplici derivazioni legate allevarie modificazioni di un termine (es.: coniugazioni verbali, suffissi, ecc.), altrimenti puconseguire la cifra di 80.000 parole fino anche a 100.000 in soggetti con cultura a livellouniversitario. Non sarebbe possibile che un bambino acquisisse 10 parole al giorno se lodovesse fare imparando le parole separatamente. quindi plausibile un apprendimentoguidato da regole. A conferma di tale posizione sono da citare anche i fenomeni di iper-correttismo.
Nella nostra ricerca abbiamo esplorato questa ipotesi nel caso delle Grammatiche infan-tili, nel quadro della prospettiva, in gran parte condivisa, che lo sviluppo lessicale sia carat-terizzato da cambiamenti progressivi nelle concezioni che il fanciullo si forma riguardo alleparole e alle regole per cui queste diventano comprensibili. Le diverse spiegazioni espressedalla mente del fanciullo nelle varie fasi dello sviluppo cambiano in funzione dellarricchi-mento delle conoscenze esperienziali e linguistiche, cos le teorie esplicative dei fanciullitendono ad abbandonare le spiegazioni inadeguate per avvicinarsi a quelle degli adulti picomplesse e culturalmente mediate. Siamo partiti dalla definizione delle Grammaticheinfantili, con un inquadramento che le distingue dalle Grammatiche delladulto, elabo-rando due differenti modelli multidimensonali di competenza lessicale (Tabella 1 e 2).
Abbiamo appositamente elaborato una prova analitica di definizione lessicale (Proveanalitiche di vocabolario) con 4 alternative a scelta multipla. Fra le 3 risposte errate solouna riguardava le grammatiche infantili (distrattore critico distinto dai distrattori comuni).
Come si vede dalla tabella 3 il distrattore critico, fra le risposte errate, scelto inmaniera significativamente superiore rispetto ai distrattori comuni.
La sperimentazione ci ha permesso dunque di confermare la validit della posizione chegiustifica lipotesi delle grammatiche infantili, cio di un apprendimento controllato daregole e che appare rivelato da una serie di tentativi che mostrano lintenzione del bambi-no di scoprire ed applicare delle regole.
24 Filippo Boschi
Competenza lessicale
CO - LE
Tautologie Vincoli grafofonemici
Effetti consecutivi Valore di immagine Significatodominante
Frequenza duso
Tabella 1. Modello Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale (MMRL). Grammatiche infantili
-
Tale fenomeno si verifica anche nelladulto non culturalizzato. Cfr. definizioni del tipoboccaccesco: uno che fa le boccacce, encefalo: un pesce, ecc.
La sperimentazione sulla competenza lessicale ci ha permesso inoltre di mostrare, alivello dellet evolutiva, la distinzione cognitiva fra fattore semantico e fattore pragma-tico, cio fra la capacit di cogliere il significato delle parole quando il contesto criticoe quando non lo .
Abbiamo pure mostrato che lo sviluppo lessicale avviene in maniera discontinua per fasicritiche, fra gli 8 e gli 11 anni.
Questi studi sul lessico sono stati riportati nel libro Le parole e la mente (1992).Gli interessi per lo studio del linguaggio sono stati ulteriormente sviluppati autonoma-
mente da Luigi Aprile nel libro Linguaggio lessicale e conoscenza sociale del bambino (1993)e da Giuliana Pinto nel libro Dal linguaggio orale alla lingua scritta (1993).
(B) Livello avanzato di lettura
il settore di ricerca che pi direttamente stato influenzato dai risultati del progettoIEA-CNR, ma gi allinizio degli anni Sessanta avevamo cominciato a lavorare su un pro-blema teorico: lindividuazione dei fattori fondamentali nella comprensione della lettura,che si era concluso con la pubblicazione del citato test per studenti di scuole superiori.
Percorsi di ricerca in psicologia della lettura 25
Competenza lessicale
CO - LE
CO LE in contesto saliente CO - LE in contesto non saliente
Sin. Ant. Categ. Funz. Sin. Ant. Categ. Funz.
Tabella 3. Confronto fra distrattori.
distrattore
critico comuneclasse n Media Ds Media Ds t p
III 472 3.10 1.67 1.19 1.14 19.17 .00IV 495 2.36 1.57 1.00 .99 15.53 .00V 521 1.61 1.45 .90 .94 9.50 .00
Tabella 2. Modello Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale (MMRL). Grammatiche delladulto
-
Il dibattito sulla validit metodologica delle ricerche volte ad individuare i suddetti fat-tori si sviluppato per quasi 30 anni, dagli inizi degli anni Quaranta fino allinizio deglianni Settanta. Agli inizi degli anni Settanta la situazione vedeva i sostenitori delle differenticoncezioni riportati in tabella 4.
Non eravamo inizialmente attrezzati per portare un contributo alla ricerca sui fattorifondamentali della lettura. Nel volume Psicologia della lettura (1977) avevamo portato
Fattori isolati Metodo di analisi
Davis F.B. (1944) Fattori separati:Conoscenza delle paroleRagionamento verbaleSignificato letteraleSeguire la struttura
del branoCapacit di individuare le tecniche let-
terarie
Metodo ad assi principali di Kelley
Thurstone L.L. (1946) Livello generale di lettura(Rianalisi dei dati del Davis 1944)
Unidimensionale di Spearman
Davis F.B. (1968) 1971
(Tests appositi)
Conoscenza del significato delle paroleCapacit di trarre inferenze circa il
significato di una parola in riferi-mento al contesto
Capacit di rispondere a domande lacui risposta esplicita o espressa inparafrasi e collegare le idee del testo
Trarre inferenze dal contenuto di unbrano
Identificare le tecniche letterarie eseguire la struttura di un passaggio(1 matrice)
Riconoscere gli scopi, latteggiamento,il tono e lo stato danimo di unoscrittore (2 matrice)
Analisi delle componenti principali doporotazione varimax su due matrici indi-pendenti
Thorndike R.L. (1971)Rifattorizzazione deidati di Davis 71
Conoscenza delle paroleRagionamento in lettura
Rotazione dei fattori
Spearritt D. (1972)
Rifattorizzazione deidati di Davis 71
Riconoscere il significato delle paroleCapacit di trarre inferenze dal testo di
un branoRiconoscere gli scopi, latteggiamento,
il tono e lo stato danimo di unoscrittore
Capacit di seguire la struttura di unbrano
Analisi dei fattori al massimo di probabi-lit (likelihood)
26 Filippo Boschi
Tabella 4. Risultati delle analisi fattoriali sulle capacit di lettura. [Quadro sintetico tratto da Boschi, 1977]
-
invece un contributo sui modelli di lettura dando supporto empirico allidea della letturacome compito complesso ed abbiamo analizzato con metodologie statistiche le varie moda-lit di lettura, evidenziando tre tipologie: Il Modello del power (lettura lenta, approfon-dita e corretta), dello speed ( lettura molto rapida e poco corretta), del rate (lettura suf-ficientemente rapida e corretta ). Per ogni tipologia stato indicato il differente peso deifattori di pensiero convergente, divergente e di personalit, precisando il contributo per-centuale delle variabili di pensiero convergente, divergente e di personalit, rispetto allavarianza spiegata nei modelli del Power, Speed e Rate di lettura (Tabella 5).
Come abbiamo visto dalle analisi statistiche sopra riportate, agli inizi degli anniSettanta si era giunti ad una situazione di stasi un punto (luogo) aporetico che non sem-brava permettere ulteriori sviluppi.
Le caratteristiche di questo dibattito contraddittorio e inconcludente possono cos rias-sumersi: disaccordo sul metodo di analisi statistica. La pluralit dei fattori evidenziata da
metodi che mostrano livelli di varianza significativi ma bassi; insufficiente specializzazione delle domande (che non escludono altri fattori); bias di procedura: pi domande riferibili a funzioni differenti, presentate dopo uno
stesso brano, non permettono, per linterferenza di elementi spuri, di ottenere un sod-disfacente accertamento delle differenti abilit di comprensione;
limitazioni dovute al ricorso al modello teorico neobehaviorista del tempo.
Dagli anni Settanta in poi le cose sono andate cambiando nel settore in esame. E ciper le influenze della psicolinguistica chomskiana e post chomskiana, della psicologiacognitivista nelle sue varie correnti e delle teorie costruttiviste.
Nuovi termini indicano le nuove acquisizioni. Si ipotizzato che la conoscenza vienestoccata in strutture schematiche e la comprensione costituita dallinsieme dei processicoinvolti nel formare, elaborare, modificare o integrare queste strutture di conoscenza(Anderson, Spiro, Rumelhart, Ortony, 1977). Altre teorie hanno proposto distinzioni fraconoscenza strategica, di contenuto, e metacognitiva.
Secondo Kitsch e Van Dijk la nozione di macrostruttura spiega la rappresentazione delsignificato in memoria e quindi pu rendere espliciti termini quali tema, trama, idea, sche-ma, usati in altri lavori.
Per verificare se strutture linguistiche o logiche inerenti al brano facilitano la compren-sione sono state formulate numerose grammatiche che hanno trovato larga applicazionenello studio dei brani descrittivi e delle storie.
Percorsi di ricerca in psicologia della lettura 27
Tabella 5. Contributo percentuale delle variabili nei modelli di lettura.
Modelli di Lettura Power Speed Rate% % %
Pensiero critico 48,4 32,6 54,4Pensiero divergente 4,7 14,9 17,3Funzioni di personalit 46,9 52,5 28,5
-
Queste nuove acquisizioni, quando hanno guidato accortamente i nuovi costruttori ditest, hanno permesso di superare le aporie che avevano bloccato lo sviluppo degli studi inquesto settore.
Mi limiter qui a ricordare limpresa dei colleghi di Padova (Prove avanzate di com-prensione della lettura) e le nostre Prove di comprensione dei linguaggi nella lettura.
Il gruppo di Padova ha progettato prove per la rilevazione di fattori molto analitici,riuscendo a differenziarli con accuratezza.
Le nostre 5 V.M. Prove di comprensione dei linguaggi di comprensione nella lettura(1996) e le Prove avanzate (2000) sono basate sulle indicazioni della letteratura specialisti-ca che distingue forme di linguaggio differenti: parafrastico, inferenziale, logico, critico-valutativo ed estetico poetico.
Anche noi abbiamo proposto uno stesso tipo di domande in riferimento allo stessobrano.
Utilizzando la lezione dei precedenti insuccessi abbiamo tenuto conto che i fenomeniprocedurali adottati provocavano interferenze retroattive e proattive e che era quindi neces-sario predisporre un materiale per la sperimentazione formato da numerose domande,dello stesso tipo allinterno di ogni brano, esclusivamente rivolte ad esplorare singolar-mente le abilit considerate. Il risultato ha premiato la nostra impostazione ed abbiamoottenuto sia lindicazione che i cinque fattori partecipano di un processo cognitivo lingui-stico unitario, sia la dimostrazione empirica della consistenza di cinque fattori operantinella comprensione dei linguaggi, come indicato dai risultati delle seguenti matrici di ana-lisi fattoriale (Tabella 6 e 7).
Tabella 6. Analisi fattoriale per 5 forme di Linguaggio su alunni di III Media (N. 443). Metodo Varimax.
Variabili Fattore 1
Parafrastico .69397Inferenziale .67606Logico .77803Critico valutativo .69738Estetico poetico .65767Varianza spiegata: 49%
Tabella 7. Risultati di analisi fattoriale dopo rotazione degli assi (Metodo Varimax). III Media.
Linguaggio Fatt. 1 Fatt. 2 Fatt. 3 Fatt. 4 Fatt. 5
Paraf .19011 .18841 .31059 .23477 .88135Infer. .97535 .04622 .03274 .15685 .14453Logic. .05000 .94455 .20466 .19380 .16087
Crit.Val. .03389 .22281 .91349 .18974 .28060Est.Poet .18712 .21030 .19016 .91578 .21435
Var. spieg. 53% 19% 12% 9% 7%
28 Filippo Boschi
-
Lo schema sopra riportato costituisce la rappresentazione grafica dei risultati di analisifattoriale configurandosi come un modello gerarchico dei fattori di comprensione dei lin-guaggi nella lettura (Tabella 8).
Si tratta di studi condotti nellambito del dibattito generale sulle teorie della mente, cheoppongono concezioni modulariste a concezioni connessioniste. I nostri risultati si collo-cano in una posizione intermedia.
Il concetto di maturit in lettura
Alle ricerche sui fattori fondamentali in lettura si sono intrecciate le analisi sul concettodi maturit in lettura, seguendo il modello delineato da Gray e Rogers (1956).
Il modello prende in considerazione sia aspetti quantitativi che aspetti qualitativi. Perquanto riguarda questi ultimi vengono considerati aspetti positivi della lettura, quali: il valore del materiale letto (cronaca, svago, letture impegnate, interessi operativi, ecc.); gli aspetti metacognitivi, quali la consapevolezza della variet e della pluralit delluti-
lizzazione della lettura; gli scopi per cui si legge (accrescimento di conoscenze, sviluppo del pensiero critico,
piacere, orientamento per lagire, contributo alla conoscenza di s, facilitatore dellacomunicazione, ausilio tecnico, ecc.).
Il modello esplora anche la consapevolezza di eventuali svantaggi, quali: assimilazione acritica, ostacolando la formazione di idee personali; veicolo di cond