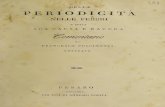La chimica del prof. Olmi€¦ · Web viewLa comprensione del concetto di periodicità è stato...
Transcript of La chimica del prof. Olmi€¦ · Web viewLa comprensione del concetto di periodicità è stato...

Un solitario con le “tessere” di Mendeleev...Una esperienza didattica di (ri) costruzione della tavola periodica mendeleviana FABIO OLMI
La periodicità delle proprietà degli elementi rappresenta un concetto-chiave per qualsiasi corso di chimica di base. Troppo spesso questo concetto viene trattato sbrigativamente sui libri di testo, quasi fosse autoevidente o peggio banale. Non solo, ma dall’esame dellamaggior parte dei testi in commercio, si ha l’impressione che il concetto di periodicità possa essere trattato solo dopo aver introdotto la struttura atomica, quasi fosse un “indiretto fisico” scaturito quarant’anni dopo la sua effettiva scoperta. Se prendere coscienza del carattere evolutivo della scienza è uno degli obiettivi educativi importanti dell’apprendimento delle scienze sperimentali, se riteniamo che alla base del successo di un intervento educativo debba esserci la partecipazione attiva dell’allievo alla costruzione del proprio sapere, diventa determinante far ripercorrere almeno in parte il cammino compiuto nella costruzione di concetti-base quale quello di periodicità: ciò èpossibile attraverso una serie di compiti di vario genere e di riflessioni e discussioni opportune. Da qui è scaturita la motivazione di progettare, realizzare e valutare un percorso didattico per allievi di fine biennio (15-16 anni) che consentisse di ricreare il contesto di scoperta della legge periodica e portasse alla ricostruzione di una parte almeno della tavola mendeleviana sulla base della conoscenza, acquisita con vari metodi, di alcune proprietà fisiche e chimiche degli elementi noti a quel tempo.
Il contesto della scoperta della legge periodica L’insegnante che si accinge ad un lavoro del tipo suddetto deve avere chiaro il quadro storico-epistemologico in cui è venuto strutturandosi il concetto in esame e deve cercare di fare ricostruire nella mente dell’allievo il contesto di scoperta proponendo brani di letture, schede, ... e discutendo con la classe (1, 2, 3). In breve, il contesto che precede la scoperta della tavola periodica è caratterizzato da alcuni eventi fondamentali che si possono così riassumere:- fino al tempo di Lavoisier la concezione della materia si fondava sulla teoria dei 4 elementi, aria, acqua, terra e fuoco; con il lavoro di Lavoisier si giunse ad una nuova concezione di elemento come “corpo semplice”, ultima porzione di materia a cui si può pervenire mediante la scomposizione delle sostanze.

Ai tempi di Lavoisier erano noti una ventina di elementi (fig.1), ma alla fine del XVIII secolo erano circa il doppio e poco dopo la metà del XIX secolo, ai tempi di Mendeleev, erano noti già 63 elementi (fig.2).All’aumentare delle conoscenze sugli elementi si faceva strada l’esigenza di una simbologia che permettesse la comunicazione univoca degli elementi e dei composti (fuBerzelius che propose di nominare gli elementi con le iniziali del loro nome latino) e la necessità di ordinare le conoscenze sulle caratteristiche degli elementi stessi;- fu J. W. Dobereiner che tra il 1817 il 1829 lavorò sulle analogie di comportamento degli elementi raccogliendo in triadi quelli con proprietà simili, ad esempio Ca, Sr, Ba e Cl, Br, I; egli osservò che il peso atomico (p.a.) dell’elemento centrale della triade era all’incirca medio di quello degli altri due. Il lavoro di Dobereiner si applicava solo a pochi degli elementi noti e non

era ancora emersa l’importanza di una grandezza ordinatrice degli elementi che consentisse di costruirne una successione logica e ordinata rispetto alla quale studiare analogie e differenze nelle loro proprietà;- la svolta decisiva nella direzione suddetta si realizzò dopo l’importante Congresso internazionale di Chimica di Karlsruhe del 1860 a cui parteciparono circa 120 scienziati, prevalentemente chimici. In questa sede, senza che fosse un chiaro obiettivo del Congresso, venne affrontata da Cannizzaro la questione della corretta determinazione dei pesi atomici. Fu J. L. Meyer che dopo il Congresso, resosi conto della validità delle ideedi Cannizzaro, ne diventò un convinto sostenitore attraverso il suo Trattato di chimica (Die Modernen Theorien der Chemie, 1864) , impiegandole successivamente per la sua classificazione degli elementi (1870): il peso atomico relativo diventava la grandezza ordinatrice degli elementi;- fu J. Newlands che pubblicò, in una prima edizione del 1864 e successivamente con una seconda nel ‘65, la prima, effettiva tavola periodica disponendo i 63 elementi noti secondo il loro peso atomico crescente e raccogliendoli in 8 colonne di 7 caselle ciascuna ( si parlò di “legge delle ottave”). La tabella di Newlands (fig.3) non incontrò molti favori poiché non prevedeva posti per nuovi elementi, alcuni non sembravano collocati al giusto posto per le loro caratteristiche e infine perché in alcuni casi nella stessa casella dovevano forzatamente trovarsi 2 elementi;- la ricerca di una sistemazione completa di tutti gli elementi in funzione del loro peso atomico proseguì lungo due direzioni: quella tracciata da Meyer che studiò essenzialmente il volume occupato da quantità fisse di diversi elementi che, secondo il principio di Avogadro, rappresenta il volume atomico dei diversi atomi degli elementi, e quella seguita da Mendeleev. Anche lui era a conoscenza delle idee di Avogadro e Cannizzaro, ma si orientò invece verso lo studio delle proprietà chimiche degli elementi, in primo luogo della valenza, sempre in funzione del peso atomico crescente. Dice A. M. Maggio in un recente lavoro (4) .L’attenzione di Mendeleev si concentrò sulle tessere riassuntive delle caratteristiche degli elementi. Cominciò così quel gioco di spostamento delle tessere che A. E. Fersman in un suo saggio dedicato alla scoperta del sistema periodico ha efficacemente paragonato ad un “solitario”.Nelle file orizzontali Mendeleev dispose le tessere relative agli elementi affini appartenenti ad uno stesso gruppo ( e quindi, proseguendo nella metafora, le tessere dello stesso “seme” chimico, ma di diverso “valore”); nelle colonne verticali collocò le tessere degli elementi aventi pesi atomici vicini e quindi appartenenti ad uno stesso periodo (dunque le tessere più o meno dello stesso “valore” ma di diverso “seme”).....Quando Mendeleev trovò contraddizioni tra la successione dei pesi atomici e le proprietà chimiche di alcuni elementi, convinto della validità del suo metodo, pur non potendosi ancora spiegare le ragioni di queste anomalie, dette priorità alle proprietà chimiche degli elementi riuscendo a collocare correttamente tutti gli elementi noti, lasciando liberi i posti che dovevano a suo giudizio spettare ad elementi non ancora noti. La prima tavola di Mendeleeev fu pubblicata nel 1869. Solo un anno piùtardi, nel 1870, anche J. L. Meyer pubblicò la sua tavola degli elementi; la seconda edizione della Tavola mendeleviana riveduta nel 1871 riporta i gruppi in verticale e i periodi in orizzontale, come nelle odierne Tavole. La legge periodica formulata da Mendeleev è stata riassunta nel seguente modo: “le

proprietà degli elementi (corpi semplici) variano con cadenza periodica all’aumentare del peso atomico”.A partire da questi anni la scienza chimica trova una sua prima solida sistematizzazione teorica fondata su un piccolo numero di enunciati di base e su alcune leggi generali: da qui ebbe inizio uno sviluppo sempre più rapido delle ricerche e delle tecnologie chimiche che verrà ulteriormente accelerato e razionalizzato con le scoperte connesse alla struttura atomica e con le successive teorie atomiche. Non c’è dubbio quindi che la legge periodica rappresenti un caposaldo nella sistematizzazione concettuale della scienza chimica e come tale va affrontata.
Fig. 4

Fig. 5
Un possibile itinerario didatticoLa pluriennale esperienza condotta in classi sperimentali di biennio di s.s.s. ha mostrato che facendo, per così dire, immergere gli allievi di 15-16 anni nel contesto teorico-sperimentale in cui è maturato il concetto di periodicità (e questo vale anche per altri concetti chiave),facendoli lavorare e soprattutto riflettere e discutere su alcuni problemi ed esempi particolarmente significativi, si è ottenuto un apprendimento non solo esteso ad un numero di allievi maggiore che in passato, ma anche più significativo e duraturo nel tempo. In precedenti lavori abbiamo riportato diversi percorsi didattici realizzati con analoghe metodologie e con risultati di apprendimento del tutto simili a quello preso ora in considerazione (5, 6). Un itinerario didattico centrato sull’acquisizione del concetto di periodicità e sulla costruzione della tavola periodica era stato messo a punto nel 1989 e realizzato nei corsi sperimentali tenuti presso il Liceo L. da Vinci di Firenze a partire dal 1990/91. Questo modulo era stato progettato per essere proposto al III anno, dopo la trattazione della struttura atomica e poneva in relazione gli elementi ordinati secondo il N. A. con alcune proprietà come l’energia di ionizzazione e il numero di ossidazione massimo: non nasceva alcun problema nella costruzione della Tavola (per i primi 21 elementi), ma si avvertiva l’estraneità della presentazione delle ideedel tempo di Mendeleev poiché non erano necessarie al lavoro di concettualizzazione impostato nel modo suddetto.Nel 1993 è stato progettato allora un itinerario didattico per il biennio centrato sull’acquisizione dellaperiodicità in modo epistemologicamente corretto. Questo lavoro presenta il secondo itinerario che viene realizzato dal 1994/95.

La prima domanda a cui ho cercato di rispondere è stata: quali sono i concetti correlati con quelli diperiodicità e legge periodica che permettono di costruire un telaio concettuale epistemologicamente corretto e adeguato al livello di sviluppo intellettuale e psicologico di allievi di 15-16 anni?L’analisi disciplinare effettuata tenendo conto di questi punti di riferimento è stata rappresentata mediante la mappa concettuale (MC) riportata in fig. 4. Il centro della mappa riporta il concetto-chiave; la parte centrale e sinistra di essa riporta i concetti satelliti proposti al biennio, la parte destra quelli che porteranno ad una successiva razionalizzazione del concetto in funzione della conoscenza dei primi modelli della struttura atomica (quest’ultima parte viene sviluppata al III anno).La parte sinistra della mappa contiene tra parentesi (poteva essere collocato a parte) l’insieme delle necessarie precondizioni per affrontare adeguatamente il concetto in esame: soffermiamoci brevemente su queste. Gli allievi devono aver acquisito precedentemente i concetti di elemento e composto, sia a livello operativo che concettuale in termini di teoria atomica della materia (Dalton-Cannizzaro); devono conoscere il significato di grandezza caratteristica e conoscere le principali proprietà fisiche e chimiche di elementi e composti (densità, temperatura di fusione, ... carattere acido/alcalino, valenza...).Per progettare concretamente l’itinerario didattico tenendo conto delle idee degli allievi, è stato effettuato un colloquio con la classe teso ad accertare, oltre il reale possesso delle precondizioni necessarie ad affrontare il concetto, le idee di classificazione e i problemi che si presentano quando si tenta di classificare gli elementi: per brevità questa fase del lavoro didattico non viene riportata. Dall’esame delle idee degli allievi e dalla MC costruita inizialmente è stata impostata la rete concettuale(RC) da cui poi è stato sviluppato un itinerario didattico che tenesse conto di ciò che ritenevamofondato far apprendere a quella classe (Fig. 5). Il Blocco 0, da cui è iniziato il lavoro, è stato rivolto aproporre condizioni di esperienza e di riflessione essenzialmente sui concetti di grandezza caratteristica,in primo luogo la valenza, di determinazione delle formule dei composti (Fig. 6) e di classificazione(Attività 2). Poichè era stato già introdotto il concetto di massa atomica relativa e di .particella minima di un composto. (concetto di molecola Dalton-Cannizzaro), note le masse atomiche del rame e dell’ossigeno, si sono avanzate ipotesi di diversi tipi di combinazione Cu/O e, a partire da diverse quantità di rame, è stato calcolato con quanto ossigeno queste si sarebbero dovute combinare a seconda dei rapporti di combinazione atomica scelti (7). Paragonando i dati sperimentali ottenuti con quelli ricavati teoricamente per i diversi rapporti ipotizzati, è stato trovato che il rapporto di combinazione Cu/O era in questo caso di 1/1 (Fig. 7); essendo l’ossigeno bivalente, anche il rame risultava bivalente. In modo del tutto analogo è stata impiegata la sintesi del cloruro di zinco (8).

Al termine del Blocco si proponeva anche la lettura e la successiva discussione di alcune schede che riportavano i primi tentativi di classificare gli elementi fino a Newlands (1864) allo scopo di ricreare il contesto teorico-sperimentale della scoperta della legge periodica (Attività 3)Da osservare che il concetto qui considerato si intreccia profondamente con molti altri che furono sviluppati nello stesso periodo, ad esempio, in un famoso saggio del 1814 J. Berzelius, discutendo l’ipotesi atomica daltoniana, propone i simboli chimici degli elementi e le formule dei composti, elementi fondamentali del linguaggio della chimica moderna. È chiaro che, pur essendo d’accordo con quanto afferma C.Fiorentini in un suo articolo (9) e cioè che ... i simboli chimici, le formule, i pesi atomici costituiscono tre aspetti centrali del pensiero chimico .. è un grave errore il loro utilizzo soltanto di tipo strumentale, senza averli sottoposti ad un’analisi capace di farne cogliere la

profonda valenza conoscitiva...., tuttavia non è pensabile che un itinerario didattico di chimica di base possa ripercorreretutte le tappe significative dell’intero percorso di sviluppo del pensiero chimico ( non solo per motivi di tempo, ma anche di opportunità, perché la genesi di alcuni concetti è complessa e talvolta di difficile comprensione per allievi di biennio). Nel ricostruire allora il concetto di periodicità e di legge periodica mi è sembrato necessario operare delle scelte e adottare dei metodi didattici particolarmente efficaci e semplici laddove ho ritenuto opportuno non seguire lo sviluppo storico dei concetti.È quanto è stato fatto nel modo di pervenire alle formule chimiche e alla valenza degli elementi.Siamo passati successivamente al Blocco 1 dando agli allievi una tabella (Fig. 8) contenente, in ordine alfabetico, una quarantina di elementi noti al tempo di Mendeleev con alcune loro caratteristiche (massa atomica, stato fisico, ossidi e cloruri delle diverse valenze, densità, ecc.) invitando gli allievi a costruirsi delle tessere di ciascun elemento secondo il modello riportato in fig. 9 impiegando piccole finestre rettangolari preparate in precedenza usando foglietti di post-it (Fig. 10).Da osservare che nella fig. 8 manca l’elemento Fluoro (F), che pure Mendeleev riporta nella sua Tavola. Ciò è dovuto al fatto che il Fluoro è stato isolato come elemento solo nel 1886 da Moissan (per elettrolisi dell’HF anidro reso conduttore per aggiunta di KF...), non era noto al tempo di Mendeleev come tale, ma era conosciuto attraverso alcuni suoi composti come il minerale CaF2 e l’acido fluoridrico HF scoperto da C. W. Scheele nel 1771. Non ho ritenuto utile fornire una tabella completa di tutti e 63 gli elementi noti a Mendeleev poiché risulta agevole a questo livello la collocazione di poco più di 20 di essi. È stata avviata una discussione su come potevano essere ordinati logicamente gli elementi e se si poteva trovare tra le grandezze date una particolarmente adatta all’ordinamento degli elementi stessi. Avendo già affrontato in precedenza con la discussione delle schede storiche il problema della grandezza ordinatrice, gli allievi hanno pensato a questo punto di cercare di riordinarli secondo l’unica grandezza che varia in modo graduale dall’uno all’altro: la massa atomica. È stata successivamente consegnata una apposita tabella che riportava in alto 40 finestre adatte come supporto delle tessere degli elementi predisposte in precedenza (Fig. 11) e gli allievi hanno disposto secondo la massa atomica crescente i primi 40 elementi, controllando eventuali errori. Gli allievi sono stati invitati, infine, aricercare una possibile disposizione razionale degli elementi che, interrompendo la sequenza ordinata e andando a capo, portasse ad incolonnare tra loro quelli con proprietà simili (densità, stato fisico, comportamenti chimici...) od uguali (valenza massima) (Fig. 12). Sono stati numerosi i problemie le questioni affrontate prima e dopo le varie Attività.

Problemi incontrati, discussioni e verifiche.Dal colloquio preliminare con la classe (che per brevità non viene riportato), è emerso chiaramente che il concetto di classificazione acquisito in Biologia riusciva a suggerire la ricerca di analogie e differenze tra gli elementi, e quindi la costruzione di gruppi di elementi con proprietà simili, ma non riusciva a innescare l’esigenza di ordinare gli elementi mediante una grandezza ordinatrice prima di ricercare analogie e differenze; ancora più lontana è apparsa l’idea che questa grandezza potesse essere la massa atomica. Nel Blocco O del percorso da noi realizzato abbiamo ripreso il concetto di massa atomica relativa e sottolineato l’importanza di disporre di m.a. sufficientemente precise, essendo queste caratteristiche univoche di ciascun tipo di atomo. La necessità di considerare prioritario

l’ordinamento degli elementi secondo le m.a. crescenti è stata introdotta attraverso la discussione seguita alla lettura di alcune schede (Attività 3) relative ai lavori che hanno preceduto quelli di Mendeleev (soprattutto quelli di Newlands del 1865).
L’altro concetto importante che gli allievi devono possedere con sicurezza per sviluppare il lavoro sullatavola periodica è quello di valenza: costituisce una proprietà essenziale per caratterizzare chimicamente gli elementi. Non si tratta di un concetto formale, come appare su molti libri di testo, ma di un concetto operativo che può essere facilmente appreso a livello di biennio: si tratta del rapporto tra la massa atomica e la massa di combinazione (detta anche equivalente) dell’elemento considerato.Se prendiamo a riferimento l’idrogeno cui si assegna valenza 1, dallo studio di vari composti formaticon altri elementi è possibile risalire alla valenza di un qualsiasi altro elemento (Attività 1); furono le formule degli ossidi e dei cloruri a fornire la valenza dei vari elementi, e sono appunto questi composti che entrano nelle tessere costruite dagli allievi. Fra le proprietà fisiche Mendeleev considerò soprattutto la densità e la temperatura di fusione. Passando al Blocco 1 dell’itinerario didattico, c’è da osservare che una prima esperienza con l’ordinamento degli elementi secondo la m.a. crescente senza introdurreil Fluoro è stata piuttosto complicata per cui è stato successivamente aggiunto alla tabella in fig. 8facendo notare che Mendeleev stesso lo conosceva anche se era noto solo attraverso alcuni suoi composti. Si è presentato poi un altro problema: la collocazione corretta dell’Idrogeno. Quando si passa a riordinare gli elementi nelle file di 10 finestre, poiché mancano i gas nobili (non erano noti e non sono stati messi tra gli elementi della tabella in fig. 8), la maggior parte degli allievi poneva il Li dopo l’H e

proseguiva con gli altri elementi. Arrivati al Na sono stati incerti se collocarlo sotto l’H o sotto il Li ... solo pochi hanno scelto di lasciare l’H da solo nella prima riga e portare sotto a questo il Li (e di seguito gli altri elementi fino al F), collocando poi il Na sotto il Li e così via.Un altro punto di discussione è stato quello della collocazione degli elementi dopo il Ca: questo viene ad avere un numero d’ordine pari a 18 (mancano 2 gas nobili rispetto alla tabella moderna) e l’elemento successivo, il Titanio (n 19), per la sua valenza massima, non si accorda a stare sotto l’Al ma sotto il Si. A questo punto si doveva scegliere: nel costruire le colonne, dovevamo mantenere costante la valenza oppure no? Alla maggior parte degli allievi è sembrato logico rispettare la valenza ... magari lasciando anche un posto vuoto ... ma il significato profondo che la scelta comportava non è apparso per niente chiaro. I successivi elementi, poi, V,Cr e Mn, pur avendo valenze uguali a quelle del P, S e Cl sotto ai

quali possono essere rispettivamente collocati, hanno proprietà assai diverse e quindi sembrava che il criterio seguito fin qui per costruire la Tabella non rispondesse più al nostro scopo..: conviene quindi sospendere la costruzione della Tavola al problema Ca/Ti. Si può magari chiedere agli allievi di cercare di trovare una collocazione logica (giustificando le scelte) agli elementi che sono rimasti fuori allineamento: Rb, Cs, Sr, Ba, As, Se, Te, Br, I. Se si riesce a trovare loro una collocazione emerge unaltro problema importante: poiché la m.a. del Te = 127,6 e quella dello I = 126,9, si deve porre prima loI e poi il Te o viceversa per rispettare l’analogia delle proprietà degli elementi di uno stesso gruppo? Anche qui si confrontano tra loro due diverse logiche: è bene che gli allievi discutano prima nel gruppo, giustifichino le loro scelte e si passi poi a una discussione generale.L’inversione Co/Ni non può essere rilevata nella nostra tabella.A questo punto, prima di proseguire il discorso, è stata consegnata ad ogni gruppo di allievi una copia della tavola mendeleviana del 1871 (Fig. 13) dicendo di fare tutti i possibili confronti fra la tavola costruita e quella di Mendeleev e di discutere nel gruppo e scrivere tutte le osservazioni possibili sulla tabella data. I punti toccati dalla discussione generale che ne è seguita sono stati i seguenti:a) il problema del posto vuoto sottolineato con un .?. lasciato da Mendeleev tra il Ca e il Ti e quindi la priorità data alle proprietà chimiche degli elementi nella loro sistemazione nella Tavola;b) la previsione fatta da Mendeleev sulle proprietà di questo elemento mancante (chiamato Ekaboro) e quelle dello Scandio scoperto nel 1879 da Nilsen;c) la creazione da parte di M. di un supergruppo di elementi con proprietà assai simili (Fe, Co, Ni, Cu);d) le due altre caselle vuote corrispondenti ad altri elementi ancora sconosciuti (Ekaalluminio, Ekasilicio) di cui Mendeleev fornì le ipotetiche caratteristiche, sorprendentemente vicine a quelle dei due elementi più tardi riconosciuti come il Gallio (1875) e il Germanio (1886);

e) la posizione data da M. agli elementi della coppia Te/I in cui si consideravano prioritarie, ancora unavolta, le proprietà chimiche rispetto alla successione delle m.a..Si è sottolineata la armonica struttura e sistematicità data da M. alla Tavola periodica in cui trovavano un posto razionale tutti gli elementi noti al tempo e, contemporaneamente, la straordinaria capacità predittiva di elementi ancora sconosciuti. Sono stati messi in luce anche i limiti del lavoro di M., primo fra tutti l’impossibilità di dare spiegazione di inversioni nella successione delle m.a. di alcune coppie di elementi (più tardi, la scoperta degli isotopi chiarirà questo mistero). La comprensione del concetto di periodicità è stato sottoposto a due verifiche: una quasi interamente dedicata a legge periodica e concetti annessi (Fig. 14), una seconda in cui si richiedevano solo alcuni aspetti essenziali e la costruzione di una mappa concettuale con riferimento all’intero percorso di studio fatto sul concetto: da entrambe le prove è emersa una buona comprensione del concetto stesso.
Al termine di questo lavoro mi preme osservare come gli allievi si siano accostati al concetto di periodicità con curiosità e con buona tensione conoscitiva. Sono convinto che una intuizione teorica, una costruzione razionale del pensiero, l’invenzione di un modello scientifico... possano creare suggestioni, siano capaci di suscitare dentro di noi emozioni, riflessioni... in una parola di coinvolgerci emotivamente con la loro intrinseca bellezza: di queste cose la scienza, e quindi anche la chimica, è piena. È un grosso errore psicologico, oltre che una scorciatoia epistemologica, non tener conto degli aspetti emotivi di ciò che si insegna e si apprende: il coinvolgimento affettivo, emotivo, la ricerca lo dimostra, è in grado di facilitare molto l’apprendimento e favorisce la comprensione dei concetti.... cerchiamo di non sottovalutarlo. Come non ricordare le frasi di Primo Levi riferite allo stuporeprovato dall’amico Sandro quando questi si stava accostando alla Chimica.(10): .... Sandro fu stupito

quando cercai di spiegargli alcune delle idee che a quel tempo confusamente coltivavo... Che vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l’universo e noi stessi e... il Sistema Periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a dipanare, era una poesia, più alta e più solenne di tutte le poesie digerite al liceo: a pensarci bene aveva anche le rime.. Fabio OlmiNote(1) J. I. Solovev L’evoluzione del pensiero chimico Mondadori Ed., Milano, 1976(2) H. M. Leicester Storia della Chimica ISEDI, Mi, 1978(3) L. Paoloni .Il sistema periodico: 1869-1914., Fondamenti metodologici ed epistemologici, storia e didattica della Chimica, (Scuola estiva ), Pisa, 1996 , S2 90-104(4) A. M. Maggio .Breve storia di una grande scoperta. (in corso di pubblicazione su CnS-La chimica nella scuola)(5) F. Olmi .Tra il conoscere e l’imparare c’è di mezzo.... Didattica delle Scienze, Ed. La Scuola, Brescia, 1996, n.185, p. 6(6) F. Olmi, M. L. d.Eugenio .La didattica per concetti- Progettazione e realizzazione di una U.D. sulle trasformazioni della materia., Didattica delle Scienze, Ed. La Scuola, Brescia, 1996, n.186, p.32(7) F. Olmi, T.Pera ALCHIMIA 2000-Quaderno di lavoro, La Nuova Italia Ed., Firenze, 1989, Scheda sperimentale 2.3, p.18 (8) AA. VV. Introduzione alla Scienza Fisica I Zanichelli Ed., Bologna, 1980, p. 82(9) C. Fiorentini, V. Parrini .Dalla legge delle proporzioni multiple alle formule chimiche.. Didattica delle Scienze, Ed.La Scuola, Brescia, 1987, n. 129, p.35(10) P. Levi – Il Sistema periodico- Einaudi Ed. , 1966