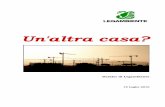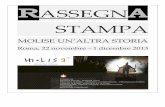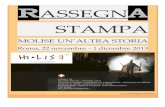Introduzione un'altra idea del mondo
-
Upload
ignazio-unoetreit-mazzoli -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Introduzione un'altra idea del mondo

Un’altra idea del mondo
Antologia di scritti di Enrico Berlinguer
1969-1984
curata da Paolo Ciofi e Guido Liguori
Introduzione di Paolo Ciofi e Guido Liguori
1. Troverete una parola, leggendo questa antologia, che Enrico Berlinguer usa spesso nello svolgersi del
suo pensiero e nei duri conflitti della lotta politica. Una parola che sembra ormai depositata nel
retrobottega della storia, decaduta com’è dal lessico di coloro che di Berlinguer hanno rovesciato il senso
della teoria e della prassi: rivoluzione.
Il segretario del Pci era un rivoluzionario, che ha lottato sul terreno democratico per trasformare questa
società capitalistica ingiusta e alienante in una civiltà più avanzata, di tipo socialista, in cui si possano
pienamente affermare liberta e uguaglianza tra gli esseri umani. E che ha dedicato a questo scopo tutta
la sua intelligenza e la sua passione, la sua riconosciuta integrità morale, la sua cristallina onesta, la sua
alta visione della politica: tutta la sua vita, fino a perderla ≪sul lavoro≫, nel tragico comizio di Padova in
vista delle elezioni europee del giugno 1984.
≪Siamo venuti per ricambiare quello che hai fatto per noi≫, stava scritto in un grande striscione portato
dagli operai della Fiat in quella enorme e insuperata manifestazione di dolore e di orgoglio, di
partecipazione e di vicinanza che attraversò Roma in occasione dei suoi funerali. ≪Un grande fatto di
popolo, che testimonia l’affetto, la stima, la fiducia per quest’uomo≫, commentò Sandro Pertini, il
presidente della Repubblica. Per lui Berlinguer era ≪un giusto, un amico fraterno, un compagno di lotta≫.
Allora furono assai vasti in Italia e all’estero, e in gran parte sinceri, i riconoscimenti per una straordinaria
personalità della politica che aveva suscitato tante speranze, per un rivoluzionario, comunista e
democratico, che voleva cambiare il mondo.
Poi e cominciata la ≪deberlinguerizzazione≫. Dimenticare Berlinguer è il titolo di un libretto molto
reclamizzato, uscito nel 1996, in cui si sostiene che la definitiva sepoltura ideale e politica del segretario
comunista era necessaria per sbloccare la sinistra, liberarla delle proprie catene e accreditarla come
affidabile forza di governo.
Sebbene non siano scomparsi coloro i quali si cimentano nel defatigante tentativo di seppellire persino la
memoria di uno dei protagonisti politici più rilevanti della seconda meta del Novecento, di recente sono
emersi giudizi meno rozzi e primitivi nel tentativo di recuperarne la figura, in questa fase di discredito
pressoché totale della politica.
Tuttavia, anche nelle ricostruzioni che vogliono essere più accurate ed equanimi, come quella di Miguel
Gotor, significativamente scompare la caratteristica principale di Berlinguer: di essere cioè un
rivoluzionario, moderno e innovatore. Come con tutta evidenza emerge da questa antologia, in cui è
Berlinguer stesso che ci guida nel percorso accidentato e appassionante dei suoi pensieri e delle sue lotte.
Emendato della passione rivoluzionaria che lo animava, Enrico Berlinguer non è più lui. La sua dimensione
si restringe al limite della banalità: un uomo onesto, un politico serio, utile per tutte le stagioni. Quando
non diventa un santino, verso il quale levare lo sguardo con un po’ di nostalgia.
2. In realtà, il suo alto profilo di dirigente comunista, che concepisce la politica come azione organizzata
di uomini e donne volta a cambiare lo stato di cose presente e a trasformare il mondo, si manifesta già
con nettezza nel 1969 nel discorso di grande respiro con il quale conclude il XII congresso del Pci che lo
elegge vicesegretario. Berlinguer osserva che in una fase nella quale ≪più pressante si fa la necessità di

una radicale trasformazione della società per soddisfare i bisogni e le aspirazioni di benessere e di liberta
di tutti gli uomini e di tutti i popoli≫, i confini della lotta per il socialismo si estendono e non si
identificano con quelli dell’Unione Sovietica e dei paesi socialisti: ≪Un movimento internazionalista,
rivoluzionario, deve interpretare e portare avanti, oggi, infinite altre esigenze affinché possa unificare
tutte le forze in un sistema differenziato, dinamico, universale≫. Dunque, è necessaria una nuova
dimensione dell’internazionalismo e, al tempo stesso, la capacità di avanzare sul terreno nazionale.
In Italia – sostiene Berlinguer – ≪come forse non mai dopo la guerra di liberazione≫ si profila sul finire
degli anni Sessanta ≪la necessità e la possibilità di realizzare un grande passo avanti sulla via della
trasformazione democratica e socialista del nostro paese≫.
Sono gli anni di ampie e combattive lotte di massa, operaie e studentesche. Una fase nella quale la
strategia di avanzata verso il socialismo nella democrazia ha bisogno di essere sostenuta da adeguate
scelte tattiche per respingere le più svariate forme di reazione autoritaria. E’ proprio ≪in questo
avvicinamento tra problemi di strategia e problemi di direzione pratica sta una delle particolarità più
appassionanti dell’attuale situazione≫.
Ciò che importa – prosegue Berlinguer – «è il processo complessivo reale, è il concepire la lotta per il
socialismo come una avanzata non lineare, ma assai complessa, aspra e articolata≫, in cui la democrazia
rappresentativa si arricchisca anche della democrazia diretta. E, in cui il Pci, rinnovandosi, sappia
guardare a ≪realtà democratiche e anche rivoluzionarie che vanno oltre il partito comunista≫, in
particolare ai giovani che scoprono il socialismo in altro modo: ≪Una via di grandi e ampie lotte di classe
e politiche e di una conseguente difesa e attuazione dei principi e del sistema politico delineato nella
Costituzione repubblicana≫. Perciò non si possono frenare i movimenti.
Ed ≪è assurdo, persino grottesco≫, rivolgere un tale invito al Pci ≪che è parte integrante, e la parte più
conseguentemente rivoluzionaria, del movimento delle classi lavoratrici. I movimenti e la mobilitazione
delle masse devono essere incoraggiati e mandati avanti≫. E’ l’indicazione di un progetto strategico, che
arricchendosi via via di diverse intuizioni teoriche, e attraversando passaggi tattici anche controversi e
contrastati, non verrà mai meno.
Nei primi anni Settanta, sul piano interno, all’impetuoso movimento del ’68-’69 si contrappose una
pesante controffensiva reazionaria, segnata dalla strage di piazza Fontana a Milano e dal tentativo
golpista del generale fascista Borghese, cui segui la formazione nel 1972 di un governo di centro-destra
Andreotti-Malagodi. Sullo scenario internazionale, all’intervento armato sovietico che stroncò la Primavera
di Praga nel 1968 fecero seguito nel 1971 la svalutazione del dollaro e nel 1973 la crisi petrolifera e il
golpe che pose fine in Cile al governo democratico di socialisti e comunisti guidato da Allende.
Avvenimenti che – insieme alla vittoria del piccolo Vietnam contro il colosso statunitense e ai processi di
liberazione del Terzo mondo – sconvolsero gli equilibri economici e politici globali.
Berlinguer parla in quegli anni di una ≪crisi di tipo nuovo≫, segnata dalla presenza dei paesi produttori di
materie prime e dalla fine, in Italia, di uno sviluppo basato sui bassi salari. Il contrasto di classe tra
capitale e lavoro non si attenua, mentre masse sempre più ampie di donne, di giovani, di anziani, di ceti
intermedi vengono coinvolte nella crisi. Ma non vi è, in Berlinguer, alcuna illusione crollista: gli è anzi ben
chiaro che il capitalismo non è vicino al crollo o senza via d’uscita, e che dalla crisi i paesi più potenti,
primo fra tutti gli Stati Uniti, potrebbero uscire anche più forti. E’ uno stato del mondo ricco di
contraddizioni e di fratture, nel quale il segretario del Pci vede sì rischi molto gravi per la condizioni di
vita di grandi masse e per la democrazia, ma anche possibilità nuove per avviare trasformazioni profonde
di tipo socialista. In tale contesto, la specificità e la particolare gravità della crisi italiana richiedono,
secondo Berlinguer, ≪una nuova tappa della rivoluzione democratica e antifascista≫, che unisca la
grande maggioranza degli italiani in uno sforzo eccezionale di lotta e di lavoro, di cultura e di creatività:
per uscire da uno stato delle cose che spinge al declino, è indispensabile introdurre ≪nell’assetto e nel
funzionamento generale della società alcuni elementi propri del socialismo≫.
Enrico Berlinguer è stato un grande innovatore. La questione del socialismo non era per lui un’astrazione
o la predicazione del ≪sol dell’avvenir≫. In un mondo segnato dalla crisi del capitalismo a Ovest e dal
contemporaneo declino del sistema degli Stati socialisti a Est, e nel quale una guerra tra le due

superpotenze avrebbe avuto conseguenze incalcolabili, la questione della trasformazione socialista in
Italia e in Europa occidentale si poneva in termini di lotta politica e sociale: per spostare
progressivamente i rapporti di forza sul piano interno e per fare avanzare il processo di distensione su
quello internazionale.
Questo tentativo messo in atto dal segretario comunista spiega l’acutezza dello scontro, particolarmente
duro in Italia, un paese a sovranità limitata dove alle lotte operaie e studentesche e alla avanzata del Pci
si sono contrapposti tentativi di golpe e ingerenze degli Stati Uniti, strategia della tensione e terrorismo,
fino a giungere all’assassinio di Aldo Moro.
Già nella Conferenza dei partiti comunisti e operai svoltasi a Mosca nel giugno del 1969 Berlinguer
emerge come un leader di livello internazionale dotato di una visione strategica a tutto campo, con la
quale i suoi interlocutori devono confrontarsi. Ci voleva molto coraggio e altrettanta determinazione per
affermare in quella sede: ≪Noi respingiamo il concetto che possa esservi un modello di società socialista
unico e valido per tutte le situazioni≫. E non si tratta neanche ≪solo di particolarità nazionali≫ –
aggiunge con una significativa sottolineatura –, giacché i processi rivoluzionari ≪non esistono mai allo
stato puro, ma solo e sempre in realtà particolari, storicamente determinate e irripetibili≫. Per quanto
riguarda l’Italia, ≪pensiamo che si possa non solo avanzare al socialismo, ma anche costruire la società
socialista, col contributo di forze politiche, di organizzazioni, di partiti diversi; pensiamo che, nelle nostre
condizioni, l’egemonia della classe operaia debba realizzarsi in uno schieramento di lotta, in un blocco di
potere, in un sistema politico pluralistico e democratico≫. Dunque, un modello di socialismo ≪diverso da
ogni altro modello esistente≫.
Berlinguer non propone una rottura con Mosca, ma un cambiamento dei comportamenti dell’Urss,
affinché si possano consolidare i movimenti antimperialisti in tutto il mondo e tra i partiti comunisti non
cresca la diaspora. L’autonomia, l’indipendenza, la libertà di ogni partito e di ogni paese debbono essere
totali e garantite, per quanto riguarda sia le scelte nazionali, sia le posizioni all’interno del movimento
internazionale. Ciò significa che non possono esserci né un partito-guida né uno Stato-guida. E neanche
un centro ideologico che dia una ≪linea≫ alla quale tutti gli altri debbano uniformarsi. Da una parte, dal
punto di vista del metodo, le guerre ideologiche tra partiti e le scomuniche vanno bandite, in particolare
nei confronti dei comunisti cinesi, le cui posizioni peraltro non sono certo vicine a quelle dei comunisti
italiani. D’altra parte – sottolinea Berlinguer – i fatti di Cecoslovacchia ≪sollevano questioni di principio
[…] che non riguardano solo i paesi interessati ma tutto il nostro movimento. Tali sono le questioni
dell’indipendenza e della sovranità, e tali sono anche quelle della democrazia socialista e della libertà
della cultura≫. In altre parole, emergono questioni cruciali, che attengono alla natura stessa del
socialismo come sistema sociale e di relazioni internazionali.
Tematiche complesse e controverse, sulle quali il segretario del Pci si mostrerà sempre molto
determinato, e che troveranno forse il punto più alto di elaborazione e di diffusione tra l’opinione pubblica
nella stagione dell’≪eurocomunismo≫, a partire dal 1975. Una stagione molto intensa ma breve, che per
iniziativa di Berlinguer coinvolse su una piattaforma comune principalmente i partiti comunisti francese e
spagnolo, ma che ben presto si esaurì come ipotesi politica a causa delle titubanze e contraddizioni degli
altri due partiti. Nel segretario del Pci si rafforzò invece il convincimento non solo che l’avanzata verso il
socialismo debba avvenire per via democratica, ma anche che il socialismo non possa essere scisso dalla
democrazia.
In altre parole, la democrazia non e solo la via del socialismo, è un suo imprescindibile fattore costitutivo.
Si tratta di un passaggio cruciale nella visione del segretario del più grande e influente partito comunista
dell’Occidente, che egli espone a Mosca il 2 novembre del 1977 in occasione del sessantesimo
anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, di fronte ai più alti dirigenti del Pcus. Considerare la democrazia
come valore universale del socialismo è un evidente salto di qualità rispetto all’impostazione originaria di
Togliatti, che teorizzava la peculiarità delle diverse vie al socialismo, e quindi la particolarità della via
italiana. Qui, nell’impostazione di Berlinguer, si sostiene che il socialismo è connaturato alla democrazia:
un principio generale, che peraltro trova un significativo punto di riferimento nella Costituzione italiana.
Sapendo, egli aggiunge, che esistono forme diverse di democrazia, ma che resta sempre essenziale il
rispetto di alcuni principi democratici fondamentali.

Intanto cresce la conflittualità nel mondo diviso in blocchi contrapposti. Dopo che il 24 dicembre 1979 le
truppe sovietiche occupano l’Afghanistan e il 13 dicembre 1981 il generale Jaruzelski proclama lo stato
d’assedio in Polonia per evitare l’invasione degli eserciti del Patto di Varsavia, il Pci non si limita a una
condanna netta nell’uno e nell’altro caso: ne trae le conseguenze politiche e si adopera per contrastarne
le conseguenze negative.
Il 15 dicembre 1981 Berlinguer dichiara che è venuta esaurendosi ≪la spinta propulsiva di
rinnovamento≫ delle società dell’Est scaturite dalla rivoluzione socialista del 1917. Più precisamente, che
≪è superata tutta una fase del movimento per il socialismo scaturita dalla Rivoluzione d’Ottobre≫. Per cui
≪si tratta di aprirne un’altra e di aprirla, prima di tutto, nell’occidente capitalistico≫, anche per aiutare gli
stessi paesi dell’Est a riconvertirsi sul terreno democratico. Ma la presa di distanza ormai irreversibile dai
paesi del ≪socialismo realizzato≫ non significa cercare un approdo socialdemocratico o identificarsi con la
socialdemocrazia. Anche la fase socialdemocratica del movimento operaio, secondo il segretario del Pci, si
è esaurita. Quindi c’è bisogno di una ≪terza via≫: ≪la terza via appunto rispetto alle vie tradizionali della
socialdemocrazia e rispetto ai modelli dell’Est europeo≫.
Se lo ≪schema, messo in giro non a caso da certi nostri avversari, secondo il quale il comunismo è e
rimarrà uguale dappertutto, è una delle più grandi castronerie che siano state dette≫, sottolinea
Berlinguer, per altro verso occorre prendere atto che nessuno degli ≪esperimenti socialdemocratici ha
portato a un effettivo superamento del capitalismo≫: ≪tanto e vero che anche in alcuni paesi dove i
partiti socialdemocratici sono al potere da decenni vi sono tutti i segni tipici della crisi di fondo delle
società “neocapitalistiche”≫. Ma proprio da qui, dalla crisi nei punti più alti del sistema, e non da schemi
ideologici prefabbricati, scaturisce ≪la necessita di uscire dal capitalismo e di andare verso una società
superiore≫. Giacché proprio da questa crisi ≪nascono non solo crescenti disagi materiali per le grandi
masse della popolazione lavoratrice≫, ma ≪anche il malessere, le ansie, le angosce, le frustrazioni, le
spinte alla disperazione, le chiusure individualistiche, le illusorie evasioni≫, ≪in conclusione quella che si
potrebbe definire […] l’infelicità dell’uomo di oggi≫.
3. La discussa questione del ≪compromesso storico≫ sta tutta dentro questa visione generale della lotta
per il socialismo, da cui Berlinguer non si allontana mai. Nella sua elaborazione – al di la dalle valutazioni
che sul piano storico se ne possono dare –, il compromesso storico è la versione nazionale della strategia
di avanzata al socialismo nei paesi sviluppati, nel contesto di determinati rapporti di forza internazionali e
nella condizione dell’Italia dei primi anni Settanta, quando è cominciata la reazione al grande movimento
di massa del ’68-’69. Adottata all’indomani del colpo di Stato in Cile dell’11 settembre 1973, la formula
del ≪compromesso storico≫ sta a indicare la prospettiva politica di ≪una collaborazione e di una intesa
delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con le forze di ispirazione cattolica, oltre che con
le forze di altro orientamento democratico≫, avendo l’obiettivo di portare l’Italia fuori dalla crisi
cambiandone le basi dello sviluppo in piena liberta e autonomia.
La domanda che Berlinguer rende esplicita a ridosso del golpe cileno, predisposto con il concorso degli
Stati Uniti, è la seguente: in quale direzione bisogna agire per garantire una libera pratica politica,
respingendo le ingerenze esterne e isolando la violenza reazionaria e fascistica? Mentre ribadisce che ≪la
via democratica al socialismo è una trasformazione progressiva – che in Italia si può realizzare
nell’ambito della Costituzione antifascista – dell’intera struttura economica e sociale, dei valori e delle
idee guida della nazione, del sistema di potere e del blocco di forze sociali in cui esso si esprime≫, il
segretario del Pci sostiene che la chiave di volta del problema consiste nel cementare l’unita delle masse
popolari e delle forze politiche democratiche, spostando i rapporti di forza nella società e nello Stato. Le
alleanze sociali, seppure assai vaste, non bastano. E’ anche necessario un determinato sistema di
rapporti politici, giacché nel tornante degli anni Settanta ≪il problema decisivo≫, secondo Berlinguer, è
quello di ≪evitare che si giunga a una saldatura organica tra il centro e la destra≫, e quindi di ≪spostare
le forze politiche e sociali che si situano al centro su posizioni coerentemente democratiche≫, avendo
presente che ≪una politica di rinnovamento democratico può realizzarsi solo se è sostenuta dalla grande
maggioranza della popolazione≫, oltre il confine statistico del 51% dei voti. In definitiva, si tratta di
evitare lo spostamento a destra della Dc, isolando coloro che puntano sulla ≪spaccatura del paese≫ e
sulla ≪pregiudiziale anticomunista≫. Tra le forze politiche che hanno fatto la Costituzione non si

realizzerà però un’intesa per ≪l’alternativa democratica≫, ≪il nuovo grande compromesso storico≫, in
funzione del rinnovamento dell’Italia e di una fase più avanzata nella vita degli italiani.
Il Pci, fino a quel momento, aveva svolto dall’opposizione un ruolo fondamentale per l’incivilimento e il
progresso democratico del paese nel campo dei diritti sociali, civili e politici, mantenendosi sempre
rigorosamente sul terreno costituzionale. Ma quando, dopo le strepitose avanzate elettorali del 1975-
1976, ottenute sulla base della strategia di Berlinguer e del costante impegno del Pci nella società, viene
all’ordine del giorno la questione del governo e del cambiamento del modello di sviluppo, la
controffensiva diventa pesante e si manifesta su tutti i terreni: sociale, politico, culturale. Nonché sul
piano del terrorismo e della ≪strategia della tensione≫.
Sul versante internazionale vi e il secco veto degli Stati Uniti all’ingresso dei comunisti al governo, reso
esplicito nel vertice di Puerto Rico del 1976 con minacce di ritorsioni economiche e di sospensione dei
prestiti, e accettato dai governanti delle maggiori potenze occidentali, tra cui in particolare il cancelliere
socialdemocratico tedesco Schmidt. Sul versante interno, segnato dalle manifestazioni violente degli
autonomi, dagli attentati del terrorismo nero, dai sequestri e dagli omicidi della Brigate rosse, si punta
allo sradicamento del Pci dalla società e dalla sua base operaia e popolare.
Il partito di Berlinguer è stretto in una morsa e attaccato da più parti, pur non avendo responsabilità
dirette di governo, mentre nel paese, scosso dalla violenza, montano il disagio e la protesta, soprattutto
degli operai e dei giovani, per il diffondersi della crisi economica e finanziaria.
Prima del rapimento di Aldo Moro Berlinguer aveva deciso di porre fine al governo della “non sfiducia”.
L’assassinio del leader democristiano che aveva aperto un dialogo con i comunisti chiude definitivamente
la stagione della ≪solidarietà nazionale≫, identificata con la strategia del compromesso storico non solo,
strumentalmente, dagli avversari interessati all’isolamento del Pci. Non è possibile dire quale strada
avrebbe potuto prendere l’Italia se Moro fosse rimasto in vita. Né se il leader democristiano sarebbe
riuscito a indirizzare il suo partito verso quella che definiva una ≪terza fase≫, nella quale avrebbero
potuto convivere una Dc aperta ai cambiamenti sociali e un Pci portatore di un ≪socialismo nuovo≫, alla
guida di schieramenti politici alternativi in una ≪democrazia compiuta≫.
4. Quel che sappiamo con certezza è che Berlinguer, sulla base di quella esperienza, introdusse
cambiamenti radicali nei programmi, nel modo di essere e nella tattica del partito, ma non cambiò la
strategia di fondo, rivolta a costruire un ≪socialismo nuovo≫ per via democratica e attraverso una
profonda trasformazione dell’economia, della società e dello Stato. Egli vedeva con chiarezza che tra il
Patto Atlantico e il Patto di Varsavia la posizione del Pci era tutt’altro che facile e conteneva ≪un certo
azzardo a perseguire una via che non sempre piace né di qua né di la≫. Perché se è vero che di la,
all’Est, ≪forse vorrebbero che noi costruissimo il socialismo come piace a loro≫, e quindi si è più sicuri
stando ≪di qua≫; ≪di qua≫, all’Ovest, ≪alcuni non vorrebbero neppure lasciarci cominciare a farlo≫.
Il Pci, afferma Berlinguer, aveva puntato ≪sulla possibilità che la Dc potesse rinnovarsi e modificarsi,
cambiare metodi e politica, decidersi a porsi all’altezza dei problemi veri del paese. Non ho difficoltà a
dire che su questo punto abbiamo sbagliato, o meglio che i mezzi non conseguivano lo scopo≫. Sono
stati commessi ≪errori di verticismo, di burocratismo e di opportunismo≫ che hanno indebolito ≪il nostro
rapporto con le masse […]. Un’esperienza del genere noi non la ripeteremo mai più≫. Sono affermazioni
che segnalano la capacità e la forza morale di un leader, in grado di cambiare la linea del proprio partito
abbandonando la politica della solidarietà nazionale e l’area di governo, proprio per mantenere aperta
una prospettiva di cambiamento indispensabile per dare soluzione alle grandi questioni del Paese, a
cominciare da quella del Mezzogiorno. La sua ≪correzione≫ è stata netta – tanto da far parlare alcuni di
un ≪secondo Berlinguer≫ –, e fu da molti contrastata.
Il rapporto con le masse: questa per Berlinguer è la questione decisiva. Perché se si perde il rapporto con
le masse si smarrisce la prospettiva e la politica diventa politicantismo. Al contrario, una caratteristica
saliente di Berlinguer è la capacita di tenere insieme, nell’azione politica, i grandi scenari strategici e la
vita delle donne e degli uomini che dentro tali scenari si muovono, agiscono e fanno la storia. L’idea di
austerità, che propone a una platea di intellettuali al teatro Eliseo di Roma e subito dopo in una

assemblea di operai comunisti a Milano, nel gennaio del 1977, non è l’annuncio di una politica lacrime e
sangue o di un stagione di generalizzato livellamento verso l’indigenza da parte di un ≪frate zoccolante≫,
come con scherno veniva apostrofato Berlinguer da avversari interessati a consolidare lo statu quo. E’
invece un’altra visione della società e della vita rispetto al consumismo sfrenato ed egoistico, che produce
disuguaglianze e malessere. ≪Per noi – precisa il segretario comunista – l’austerità è il mezzo per
contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale
e di fondo≫, dunque ≪un’occasione per uno sviluppo economico e sociale nuovo≫, ≪una scelta […]
attraverso cui il movimento operaio si fa portatore di un modo diverso del vivere sociale≫. L’austerità,
nella sua visione, significa giustizia, efficienza e anche una moralità nuova.
Berlinguer avverte che nello sviluppo del capitalismo si sta raggiungendo un crinale oltre il quale si
mettono in moto le forze dell’involuzione e del declino. O si avvia ≪una trasformazione rivoluzionaria
della società≫ o si può andare incontro ≪alla rovina comune delle classi in lotta≫ e ≪alla decadenza di
una civiltà≫. Ma una trasformazione rivoluzionaria sarà possibile solo se si tiene conto dei problemi posti
dal moto di liberazione dei popoli del Terzo mondo. E ciò comporta due conseguenze: aprirsi alle ragioni
di sviluppo e di giustizia di questi popoli con una politica di cooperazione su basi di uguaglianza;
abbandonare l’illusione che sia possibile perpetuare uno sviluppo fondato sulla artificiosa e continua
espansione dei consumi individuali, fonte di sprechi, di parassitismi, di privilegi, di dissipazione di risorse,
di dissesto finanziario.
L’analisi di Berlinguer, come sempre, si muove su due piani. Vede la portata e la qualità della crisi, ma
anche il rovescio della medaglia. Infatti, se la fase attuale della nostra vita nazionale ≪è gravida di
rischi≫, essa al tempo stesso ≪offre a tutti noi la grande occasione di un rinnovamento≫. L’Italia è la
nazione nella quale la crisi è più grave che in altre aree del mondo capitalistico e ≪nella quale, però, sono
anche maggiori che in molti altri paesi le possibilità per lavorare dentro la crisi stessa, per farla diventare
mezzo per un cambiamento generale della società≫. Il progetto per il cambiamento al quale vuole
lavorare il Pci sulla base di una nuova idea di austerità, nota Berlinguer, oggettivamente esce ≪dal
quadro e dalla logica del capitalismo≫. E uscire da questa logica, nelle condizioni dell’Italia, è interesse
non solo della classe operaia, dei comunisti e dei socialisti, bensì di strati ben più vasti di popolo, in
definitiva è interesse della nazione.
Viene al pettine il nodo della qualità dello sviluppo, del perché e per chi produrre. Dunque, del senso,
dello scopo del produrre e del consumare, e quindi dell’uso delle risorse, umane e naturali. Ciò vuol dire
che non basta distribuire più equamente la ricchezza, e che non si può restare imprigionati nel recinto
della distribuzione senza toccare i rapporti di produzione e il processo di accumulazione. In altri termini, è
necessario ≪un intervento innovatore nell’assetto proprietario, tale da spingere materialmente la
struttura economica≫ verso il soddisfacimento dei grandi bisogni dell’uomo e della collettività nazionale.
In definitiva, ≪un nuovo socialismo≫, ≪una soluzione socialista≫ che in campo economico assicuri un
alto sviluppo produttivo, una pianificazione che faccia leva sulla coesistenza di varie forme di iniziativa e
di gestione pubblica e privata. A Scalfari che chiede chiarimenti, Berlinguer risponde che non è necessaria
una pianificazione rigida dell’economia, né l’abolizione del mercato e della iniziativa privata. Ma aggiunge
che ≪dentro le forme capitalistiche ≫ queste realtà vengono distorte e soffocate, e il capitalismo ≪inteso
come meccanismo, come sistema≫ va superato ≪giacché esso, oggi, sta creando masse crescenti di
disoccupati, di inoccupati, di emarginati, di sfruttati≫.
E possibile che Berlinguer, nell’impegno totale volto a delineare un inesplorato percorso rivoluzionario
nell’Occidente avanzato, abbia sottostimato la portata delle modernizzazioni già in atto nelle società
capitalistiche investite dalla globalizzazione finanziaria e tecnologica. E quindi la capacita di ripresa e di
ridislocazione dei gruppi dominanti sotto la spinta del neoliberismo vincente. In ogni caso, nel Pci era
prevalente una lettura tradizionale del capitalismo italiano in termini di arretratezza e di squilibri, poco
adatta a mettere a fuoco i fattori di dinamismo e di modernizzazione. Adalberto Minucci ha ricordato che
Berlinguer, avvertendo l’esigenza di un generale aggiornamento delle analisi e dell’impianto progettuale
del partito, aveva proposto nel discorso sull’austerità la stesura di un ≪Progetto di trasformazione della
società≫, mai venuto alla luce e poi declassato al livello di un mediocre documento di politica economica.
Resta il fatto che, chiusa la negativa esperienza della solidarietà nazionale, il recupero delle radici sociali
del partito e il rinnovamento della politica, da un lato, e l’elaborazione delle grandi questioni emergenti –

da quella ambientale a quella della rivoluzione femminile –, dall’altro, sono i temi fondamentali che
caratterizzano ≪la svolta≫ di Berlinguer, e ne orientano la ricerca e la pratica politica fino alla
conclusione della vita. Sono temi che si incardinano tutti intorno a un’idea-forza: la trasformabilità del
sistema, la necessita di trasformare la società italiana. E su questa discriminante politica e culturale
matura il contrasto con Bettino Craxi, che a ogni ipotesi di trasformazione oppone la governabilità e
ripristina l’asse con la Dc, agitando anche il pretesto di un Pci portatore di una cultura totalitaria, a cui
dovrebbe rinunciare tagliando le proprie radici.
5. La lotta politica e sociale si inasprisce, e Berlinguer non rinuncia a mettere in rilievo ≪la diversità≫, o
meglio ≪le diversità≫ dei comunisti, che cosi sintetizza: non «occupare» lo Stato, combattere i privilegi
ovunque annidati, lottare per il superamento ≪del meccanismo capitalistico≫. E’ in questo contesto che
solleva ≪la questione morale≫. Non si tratta di un’impennata di orgoglioso moralismo, bensì di una
questione politica centrale nella realtà italiana, che riguarda il rinnovamento dei partiti e lo
smantellamento del sistema di potere imperniato sulla Dc. Una ≪pregiudiziale≫ vera e propria dalla cui
soluzione secondo Berlinguer dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni e la tenuta stessa del regime
democratico.
Il segretario del Pci è coerente, e compie due atti significativi nei quali si riassume simbolicamente il
senso della ≪svolta≫. Va ai cancelli della Fiat durante la vertenza ≪dei 35 giorni≫ contro licenziamenti e
cassa integrazione per dire agli operai che i comunisti stanno dalla loro parte; visita l’Irpinia distrutta dal
terremoto, e avendo constatato la sconcertate prova di inefficienza e incapacità dimostrata dai governanti
democristiani chiede un governo non più imperniato sulla Dc, ma sul Pci, il maggior partito di
opposizione: l’abbandono della pregiudiziale anticomunista e necessaria per affrontare efficacemente i
grandi problemi del Mezzogiorno e del paese. ≪La principale diversità del nostro partito rispetto agli altri
partiti italiani≫ – precisa il segretario comunista – sta nel fatto che i comunisti non rinunciano a lavorare
≪nella direzione indicata da due antiche e sempre vere espressioni di Marx: non rinunciamo a costruire
una “società di liberi e uguali”, non rinunciamo a guidare la lotta degli uomini e delle donne per la
“produzione delle condizioni della loro vita”≫. Questo non significa ≪voler imporre alla storia una
destinazione≫. Vuol dire, invece, impegnarsi per ≪rendere concreto e attuale ciò che è maturo dentro la
storia≫. Nei confronti della socialdemocrazia ≪la diversità≫ è sostanziale, giacché la politica dei partiti
socialdemocratici, ≪illudendosi di essere “realistica e concreta”, nei fatti è diventata spesso adeguamento
alla realtà cosi come essa è, e ha portato alla messa in parentesi dell’impegno al cambiamento
dell’assetto dato≫. Noi invece – sottolinea Berlinguer – all’impegno trasformatore e all’autonomia ideale e
politica ≪non rinunceremo mai≫.
Siamo agli inizi degli anni Ottanta, e Berlinguer vede con grande lucidità il senso dell’attacco portato dalla
Confindustria alle conquiste del movimento operaio e democratico: è un passaggio di fase che sta dentro
la più generale offensiva condotta da Reagan su scala globale sotto le bandiere del neoliberismo. In un
paese con più di due milioni di disoccupati, la finanza pubblica in dissesto e l’inflazione al 21%, lo scontro
sociale ≪ha una nettezza e una asprezza che non si conoscevano da decenni≫, e si svolge sul terreno
sociale come su quello politico. ≪L’attacco della Confindustria alla scala mobile – dichiara Berlinguer – è
un aspetto di un’offensiva che tende a scaricare sulla classe operaia tutto il peso della crisi, non solo
riducendo la sua quota di reddito ma colpendo il suo potere contrattuale, quindi sociale, e perciò, in
definitiva, la possibilità di esercitare la sua funzione dirigente nazionale≫.
Nei ≪meravigliosi≫ anni Ottanta (la definizione è dell’avvocato Agnelli), l’obiettivo è liberare finalmente il
capitale da ≪lacci e lacciuoli ≫ per sfrenarne gli ≪spiriti animali≫, e quindi bloccare i salari per
aumentare profitti e rendite. Il salario viene indicato come causa dell’inflazione, del dissesto dei conti
pubblici, delle difficolta dell’economia. Di conseguenza il movimento operaio e le persone che vivono del
proprio lavoro devono essere ricondotti a ragione, piegati e sottomessi al comando del capitale, nella
società e nell’impresa. Sul piano politico, scrive l’editorialista della Repubblica Fausto De Luca, ≪s’intende
aprire nel paese uno scontro di dimensioni nuove e forse sconosciute≫ il cui fine è l’isolamento della Cgil
e dei comunisti, ≪la liquidazione e il ridimensionamento drastico del Pci≫. L’attacco della Confindustria
alla scala mobile ha dunque una portata strategica senza precedenti. Perché si propone non solo di
ridurre salari e potere d’acquisto con conseguenze nefaste sull’insieme della società, ma perché punta

anche a sconfiggere sindacalmente e politicamente i lavoratori, tagliandoli fuori da ogni possibile controllo
sui processi di ristrutturazione in atto. Come rispondere?
Secondo Berlinguer bisogna lottare senza abbassare la guardia ≪per salvaguardare le conquiste fin qui
realizzate≫, anche perché contenendo salari e consumi tutto il ≪sistema Italia≫ sarebbe andato in crisi.
Questo va fatto non arroccandosi in vecchie trincee del passato, bensì guardando alle tendenze nuove e
alle contraddizioni del presente per poterle orientare e costruire il futuro. E senza ripiegamenti settari,
bensì allargando il fronte e identificando insieme alla classe operaia le possibili forze motrici della
trasformazione: le lavoratrici e i lavoratori intellettuali, prima di tutto, un ceto che ha ormai assunto
dimensioni di massa, e che è indispensabile per costruire una civiltà più avanzata; le donne, la cui
rivoluzione di genere è imprescindibile per rivoluzionare la società; gli emarginati vecchi e nuovi, che il
capitalismo finanziario moltiplica nelle periferie del mondo come nelle metropoli postindustriali; e i
giovani e gli anziani, della cui opera non si può fare a meno nell’impianto di una società che voglia essere
accogliente per tutte le età. C’è una sua frase che riassume efficacemente il pensiero di Berlinguer nella
tempesta della controrivoluzione liberista: ≪Per noi comunisti […] essere moderni, avanzati,
industrialmente colti non vuol dire dare ragione ai grandi finanzieri e ai grandi capitalisti, ma essergli
culturalmente superiori≫. Nessuna boria personale o di partito, non era questo il suo stile. Ma la
consapevolezza che sul fronte culturale si combatte una battaglia decisiva. Anche per questo Berlinguer
aveva proposto ≪un convegno di futurologia che affrontasse […] tutto intero l’arco delle questioni del
nostro futuro≫. Per lui è un tema affascinante di ricerca intellettuale, ma anche denso di ricadute sulle
prospettive politiche. E infatti, nell’intervista rilasciata all’≪Unita≫ il 18 dicembre 1983, un documento di
straordinario interesse che oggi andrebbe attentamente meditato, egli scruta il futuro con sguardo
attento e con profondità di analisi.
Interrogato in particolare sulla portata e sugli effetti della ≪rivoluzione elettronica≫, risponde che questi,
rivoluzionando il modo di lavorare e di vivere, pongono problemi del tutto inediti per chi lotta per
trasformare il mondo: sia sul versante sociale e culturale, sia su quello della conformazione dei sistemi
politici, dove la democrazia elettronica apre nuovi spazi di partecipazione, ma in pari tempo accresce i
rischi di autoritarismo plebiscitario. Tutto dipende, secondo Berlinguer, da chi e come i processi di
innovazione tecnologica sono orientati. Sul punto decisivo, che riguarda la possibilità di trasformare la
società attuale in una civiltà superiore, il segretario del Pci ritiene che si debba ≪considerare come un
dato ineluttabile la progressiva diminuzione del peso specifico della classe operaia tradizionale≫. Sarebbe
però un errore trarre da questo dato la conclusione che la classe operaia è ≪morta≫ e che con essa
muore ≪la spinta principale alla trasformazione≫. Non sarà cosi se si sapranno individuare e conquistare
alla lotta per la trasformazione socialista anche ≪altri strati della popolazione che assumono, anch’essi, in
forme nuove, la figura di lavoratori sfruttati». In ogni modo, tutto ciò – sottolinea Berlinguer – non
costituisce «una confutazione del marxismo e del pensiero di Marx in particolare. Il carattere sociale della
produzione (e anche della informazione come fattore di produzione) è sempre ancora in contrasto con il
carattere ristretto della conduzione economica. Questo assunto di Marx non è smentito neanche dalla
rivoluzione elettronica≫. Anzi, si può dire che e stato pienamente confermato, giacche all’enorme
socializzazione della produzione dei beni materiali e immateriali non ha per nulla corrisposto la
socializzazione dei mezzi con cui si producono. Al contrario, la loro proprietà si è massimamente
concentrata.
Se dunque il problema della ≪direzione consapevole e democratica, quindi non autoritaria, non
repressiva, dei processi economici e sociali con il fine di uno sviluppo equilibrato, della giustizia sociale e
di una crescita del livello culturale di tutta l’umanità≫ rimane aperto, Berlinguer guarda avanti e crede
che, in definitiva, i mezzi informatici, accrescendo enormemente la massa delle informazioni disponibili,
diano maggiori possibilità ≪di arrivare a una dimensione onnilaterale dell’uomo≫. Con ≪l’obiettivo del
superamento di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell’uomo sull’uomo, di una classe sulle
altre, di una razza sull’altra, del sesso maschile su quello femminile, di una nazione su altre nazioni≫.
Naturalmente, perché questo obiettivo si possa avvicinare, determinante è il fattore soggettivo, la
presenza di un soggetto politico che intenda trasformare il mondo; che abbia la volontà e la forza di
lottare, e la capacità di rinnovarsi interpretando con spirito rivoluzionario i tempi nuovi. Non si supera il
sistema se non c’è una maturazione soggettiva. Perciò la politica non può chiudersi nella torre d’avorio
delle istituzioni, non può essere ridotta ai rapporti, ai giochi, alle schermaglie fra i partiti, fra maggioranza
e opposizione. Deve essere reinsediata nel profondo della società, e in tutte le sue diverse articolazioni.

E’ un tema generale, che pero riguarda immediatamente anche il Pci. Il partito deve guardare con
attenzione alle espressioni, alle tendenze, ai movimenti e ai conflitti che attraversano la società, e che
≪portano non solo esigenze, ma anche intuizioni, indicazioni, proposte che esigono soluzioni generali
nuove perché […] interessano tutti i cittadini≫. In definitiva, c’è bisogno di ≪una rivoluzione copernicana
nella concezione della politica, tale da rovesciare il rapporto tra contenuti e schieramenti≫.
6. La morte ha colto all’improvviso Enrico Berlinguer mentre nel pieno dell’offensiva liberista, tra Est e
Ovest, stava pilotando il suo partito su una rotta non segnata nelle mappe della storia, alla ricerca di un
approdo che significasse una società diversa, più giusta, in cui il socialismo si coniughi con la democrazia
e l’uguaglianza con la liberta.
Ora viviamo in un’altra epoca. Il Pci e stato affondato ≪in mezzo al guado≫, un guado diverso da quello
degli anni Settanta, l’Urss è crollata, il ≪socialismo realizzato≫ non c’è più, o quasi, e il capitalismo ha
trionfato globalmente. Ma i problemi di quel mondo che Berlinguer con la sua lotta voleva cambiare
restano. Anzi, per molti versi si sono aggravati. La fame e le disuguaglianze che crescono, le ricchezze
che si concentrano e l’occupazione che crolla, le guerre che si moltiplicano e l’incombente rischio
ambientale sempre più grave, un sistema economico governato da un’oligarchia che produce
emarginazione e esclude dal lavoro intere generazioni. Una crisi non solo economica e sociale, ma anche
morale e democratica, in cui la stragrande maggioranza viene estromessa dalle decisioni, persino dalla
rappresentanza.
E l’Italia che declina, in bilico sul crinale di un baratro. Questo è il mondo in cui oggi viviamo: un assetto
dell’economia e della società che dal crollo dell’Unione Sovietica e del ≪socialismo realizzato≫ non è stato
emendato dalle sue interne contraddizioni, diventate al contrario più acute e drammatiche. E che però
l’ideologia dominante ha dichiarato immodificabile, come se fosse l’approdo finale della storia umana,
oltre il quale c’è il salto nel buio.
La verità e che non viviamo in una specie di fermo-immagine della storia, ma in una condizione nella
quale a una profonda e pervasiva rivoluzione scientifica e tecnologica che cambia i modi di lavorare e di
vivere, e a significativi cambiamenti nella vita individuale e collettiva, non corrisponde il rivoluzionamento
dei rapporti di proprietà, la diffusione della democrazia e della partecipazione nell’economia, nella società,
nei sistemi politici. La contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive (che sempre più hanno una
connotazione sociale) e l’arretratezza dei rapporti di produzione (sempre più connotati dalla
privatizzazione della proprietà) è diventata esplosiva. Come pure quella tra capitale e lavoro, tra Nord e
Sud del mondo, tra l’aspirazione alla liberta dell’individuo e le condizioni che lo opprimono nel
perseguimento del massimo profitto. Ma in assenza di un soggetto politico rivoluzionario e trasformatore,
la necessità di superare l’attuale ordinamento economico-sociale non trova sbocchi.
Enrico Berlinguer torna d’attualità, oggi, proprio perché voleva cambiare il mondo. E il valore della sua
ricerca e della sua azione è tanto più rilevante perché, unico autorevole dirigente politico europeo della
seconda meta del Novecento, ha posto, in termini concreti, la questione della costruzione di una società
nuova, di tipo socialista, nel cuore dell’Occidente capitalistico. Una novità di straordinaria portata che si
vorrebbe in ogni modo cancellare.
Muovendo da Gramsci, e dalla sua elaborazione della teoria della rivoluzione come processo, che si
esplica nell’esercizio della funzione egemonica da conquistare prima nella società e poi a livello statuale;
e passando per Togliatti, che con il progetto della ≪democrazia progressiva≫ incentrata sulla Costituzione
antifascista supera la contrapposizione storica tra rivoluzione e riforme e delinea la ≪via italiana≫ al
socialismo; Berlinguer compie un decisivo passo avanti, di cui bisognerebbe saper cogliere tutta la
portata innovativa.
Se Togliatti, nel mondo diviso in due dalla ≪guerra fredda≫, cerca di mantenere un varco aperto a
Occidente, con Berlinguer l’orizzonte si allarga, e dal particolare si sale al generale. La questione che egli
pone, non cancellando il valore della Rivoluzione d’Ottobre, è quella di un’altra prospettiva, di un altro
modello di società, di un altro socialismo, che acquista una connotazione alternativa rispetto alle società

dell’Ovest e anche dell’Est, e assume un significato universale proprio perché vuole investire i gangli vitali
del capitalismo maturo, il luogo più alto dello sviluppo economico e civile.
Questo è il senso della ≪terza via≫, è in questa impostazione inedita e modernamente rivoluzionaria, il
baricentro dell’iniziativa tende a spostarsi da Oriente a Occidente. Si tratta di un disegno assai ardito e
senza precedenti, che si spinge fino ad assumere una dimensione planetaria avendo come termine di
confronto, seguendo Marx, il capitalismo sviluppato (in campo economico e politico, sociale e civile) e non
le forme della sua arretratezza.
Il comunismo di Berlinguer assume il significato concreto della trasformabilità della società in cui viviamo
secondo i principi di uguaglianza e di liberta, di solidarietà e di democrazia, inscritti peraltro nella
Costituzione italiana. Un’idea che si sostanzia in un percorso credibile e praticabile, comprensibile a
grandi masse, e che in lui diventa stile di vita e azione politica, iniziativa e lotta quotidiana. Si può dire
che Berlinguer abbia intrapreso un tentativo concreto di trasformare lo stato di cose presente non
derogando mai nei suoi personali comportamenti da questa regola. Perciò esercitava un grande fascino,
sui giovani e su masse vaste di popolo, e godeva di un indiscusso prestigio internazionale.
Ripercorrendo il suo non facile cammino alla guida del Pci in un periodo tra i più drammatici della nostra
storia nazionale, una conclusione appare certa: chiunque voglia misurarsi in Italia e in Europa con il
compito, impervio ma necessario, di cambiare la società mettendola sulla via di una trasformazione
socialista verso una civiltà più avanzata, da Berlinguer non può prescindere. E da lui dovrà riprendere il
cammino.
Era un rivoluzionario, un combattente che non ha mai detto: ≪Arrendiamoci, non c’è nulla da fare, non
ha senso parlare di rivoluzione≫.