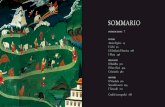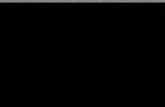Di Febo M. - Gli Edifici Sacri
-
Upload
mario-di-febo -
Category
Documents
-
view
15 -
download
1
Transcript of Di Febo M. - Gli Edifici Sacri

GLI EDIFICI SACRI AVANTI LA PACE
ECCLESIA: riunione, assemblea comunità di credenti nella stessa fede
luogo nel quale si raccoglie la comunità per celebrarvi la liturgia
ARCHEOLOGIA
Scienza che studia le arti e i monumenti dell'antichità
Arch. Pura: ha come sole fonti i resti lasciati dall'attività umana
Non può determinare una conoscenza che va al di là del suo ambito
Ambito temporale: 150 – VI sec.
Ambito spaziale: Isole britanniche, area a sud del Reno e a ovest del Danubio, Mar Nero,
Balcani, Asia Minore, area tra Eufrate e Palestina, Magreb
AUTORI
Antonio Bosio (1575-1629), Cristoforo Colombo della Roma Sotterranea
esplora, non scava, Villa Ada, catacombe di Priscilla
autore: Roma Sotterranea 1632, dedicata alle catacombe
Giovanni Marangoni (1673-1753), scoperta e scavata male la catacomba dei Giordani (Villa Ada)
Giuseppe Settele, abate (1770-1840)
Giuseppe Marchi, gesuita (1795-1870)
Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), allievo di Marchi
autore: Roma Sotterranea Cristiana 3 voll. 1864-1877
fondò: Bollettino d'Archeologia Cristiana 1894
Papa Pio IX fondò: Pontificia Commissione d'Archeologia Sacra 1852
Teorie sull'origine degli edifici sacri
1. DERIVAZIONE MATERIALE
2. LITURGICA
3. PRATICA (compromesso tra le prime due)
L'architettura paleocristiana (primi secoli del Cristianesimo) ha una data spartiacque: l'editto di
Milano del 313 da parte di Costantino, che permise:
� libertà di culto per i cristiani
� costruzione di edifici pubblici per la liturgia.
Fino ad allora infatti il culto cristiano era considerato religione illecita nell'Impero Romano e quindi le
riunioni di fedeli avvenivano specialmente in case private, chiamate domus ecclesiae, ma anche altri
locali come magazzini e negozi.
Con la liberalizzazione del culto in epoca costantiniana si pose il problema di quale forma dare agli
edifici della nuova religione. Le domus ecclesiae erano insufficienti per il numero dei nuovi adepti e i
templi classici, oltre che vestigia di religione aborrita dai cristiani, erano strutturati per funzioni
all'aperto e con spazi interni insufficienti per le funzioni del nuovo culto, essendo le naos destinate ad
ospitare solo la statua del Dio e semmai i sacerdoti.
La messa, definitivamente codificata nel IV secolo, richiedeva edifici monumentali, costruiti usando il
modello della basilica romana, cioè un edificio polifunzionale non legato alla religione e strutturato in
modo semplice.

La basilica cristiana mantiene la planimetria rettangolare e la suddivisione in tre navate, (quelle laterali
larghe metà di quella centrale) spostando però l'accesso su un lato corto (a differenza di quella romana
che lo aveva spesso sul lato più lungo) e mantenendo l'abside solo sul lato opposto. Tale rotazione crea
uno spazio inedito, fortemente direzionato e prospettico, che indirizza a dirigersi e rivolgersi verso
l'abside, solitamente orientata, dove venne posizionato l'altare, ripreso dalle are pagane, che divenne il
centro focale dell'architettura. Un testo attribuito a Clemente I, ma forse del IV secolo, recita:
« [Preghiamo Dio] che ascese sopra il cielo dei cieli verso oriente, ricordando l'antica passione per il
Paradiso, posto a oriente, da dove il primo uomo, disobbedendo a Dio, persuaso dal consiglio del
serpente, fu cacciato. » L'oriente è quindi il luogo dove si trova il Paradiso e dove si trova anche Cristo,
che tornando sulla terra da lì proverrà.
Nota: S. Pietro è orientata a rovescio con l'abside a ovest perché la tomba di Pietro deve
guardare a est.
Lo stesso testo indica che il seggio del vescovo debba stare al centro, affiancato dai sacerdoti, e che i
diaconi abbiano la cura di disporre in zone separate i laici, divisi tra uomini e donne; nel mezzo, in un
luogo rialzato, deve stare il lettore dei testi sacri.
La basilica paleocristiana presentava anche elementi nuovi come il transetto (adottato solo in un
secondo momento e piuttosto raro nei primi secoli), presente nella primitiva basilica di San Pietro in
Vaticano, quale navata trasversale disposta davanti al presbiterio, che dà alla basilica una planimetria
simbolica a croce.
La prima basilica cristiana fu probabilmente San Giovanni in Laterano costruita a cinque navate, su un
terreno di Costantino, dopo l'editto di Milano; cinque anni dopo fu iniziata San Pietro in Vaticano. Uno
degli elementi tipici delle prime basiliche era l'atrium, esterno alla basilica, o di un quadriportico o
nartece usato dai catecumeni, cioè i non battezzati, che potevano assistere solo alla prima parte della
messa, durante la quale si leggevano i testi sacri, per poi dover uscire. Non esistendo il sacramento
della confessione, il battesimo veniva normalmente dato solo agli adulti, e spesso in un'età avanzata
che "lavasse" tutti i peccati fino ad allora commessi. Antiche basiliche con quadriportico erano San
Pietro in Vaticano o quella del Santo Sepolcro a Gerusalemme (fatta costruire da Sant'Elena).
La navata centrale era più alta di quelle laterali ed era in genere coperta da un soffitto ligneo a
capriate, talvolta coperte da cassettoni, come nella basilica di Santa Maria Maggiore. Le navate laterali
avevano soffitti più bassi, per questo la facciata aveva in genere un profilo a capanna con lati spioventi,
detti salienti. La copiosa illuminazione era dovuta alle finestre che si aprivano nella parte superiore
della navata centrale, proprio nella porzione che svettava sulle navate laterali, detta cleristorio, o sulle
navate laterali stesse. I colonnati che dividevano le navate erano più spesso achitravati (Santa Maria
Maggiore) piuttosto che composti da sequenze di archi.
Tra le basiliche più importanti del IV secolo vi sono quelle promosse dall'imperatore stesso o dalla sua
famiglia, come le quattro basiliche patriarcali di Roma e di Gerusalemme, e quelle più tarde di Milano e
di Ravenna.
Ci sono giunti pochi esempi di basiliche paleocristiane il cui aspetto odierno, per via dei continui
rifacimenti e manomissioni nei secoli è spesso legato a restauri. Tra le più importanti e significative ci
sono Santa Sabina a Roma e Sant'Apollinare in Classe a Ravenna, come edifici a pianta centrale.
Contemporaneamente alle basiliche l'architettura paleocristiana vide l'erezione di edifici a pianta
centrale, circolare o ottagonale, quasi sempre coperti a cupola. Tra tali edifici troviamo battisteri,
mausolei, martyrion, costruiti sopra i luoghi di sepoltura di martiri e ospitanti famose reliquie, le

basiliche palatine, destinate all'imperatore e la sua corte, come la basilica di San Lorenzo a Milano, che
era provvista di un matroneo usato dalla corte e correlata da sacelli lungo gli assi laterali.
Anche in queste tipologie sono stati rintracciati nell'architettura romana ed in particolare nei mausolei,
nel Pantheon, nei templi monopteri e nei ninfei tardo romani. Inoltre negli edifici a pianta centrale,
sono maggiormente riscontrabili i caratteri dell'architettura tardo antica nella valorizzazione costruttiva
e visiva delle masse murarie e delle volte e negli spazi dinamici ed illuminati in modo contrastato. Tra
gli esempi: il mausoleo di Santa Costanza, il battistero lateranense e Santo Stefano Rotondo.
ELEMENTI STORICO-ARCHITETTONICI
ABSIDE – (lat. apsis, greco hapsis, "arco" o "volta") struttura architettonica a pianta semicircolare o
poligonale, parte di un edificio, spesso di una chiesa; l'abside è coperta da una volta, detta conca o
catino absidale, che ha generalmente la forma di una semicupola (quarto di sfera). L'abside è circolare
perché è dedicata a Dio mentre la navata, dove sta il popolo dei fedeli, è rettangolare.
AMBONE - [greco ambon, convesso] Tribuna in marmo, pietra o legno, da cui vengono proclamate le
letture. L'ambone è chiuso da tre lati da un parapetto e aperto su una scala nel quarto lato. Nelle
chiese paleocristiane e romaniche vi erano due amboni ai lati dell'altare:
� ambone di destra per la lettura dell'Epistola
� ambone di sinistra per la lettura del Vangelo
Sinonimo di ambone è pergamo (dal greco pergamon, "luogo elevato").
ARCO ABSIDALE – Arco che introducel'abside
ARCO TRIONFALE – Arco che conclude la parete di testa della navata in cui si apriva l’abside. In tal
modo distingueva la spazio dell’aula dal presbiterio o dal coro. Nelle chiese romaniche era usuale,
anche se posto in posizione più avanzata verso la navata, per separare la zona del coro monastico,
riparato da volta in muratura, dall’aula con tetto a capriate a vista. Sul lato dell’arco trionfale,verso
l’aula, vi erano scolpite o dipinte figure importanti per ricordare i fatti di Gesù o di santi. In San Paolo
fuori le mura l'arco trionfale, che separa il transetto dalla navata centrale, è detto di Galla Placidia che
fece realizzare la decorazione musiva che ancora lo ricopre, durante il pontificato di Leone I.
ATRIO - (dal latino atrium ) Ampio spazio aperto circondato su tre o tutti i lati da portici all'interno
della domus. Nell'architettura cristiana l'atrium o cortile dei catecumeni era uno spazio della basilica, un
quadriportico con al centro il fonte battesimale, dove sostavano i catecumeni (non battezzati).
Stilisticamente il chiostro delle architetture monacali riprende l'atrium delle ville romane.
BALDACCHINO - Grande pezza di stoffa quadrata o rettangolare, sostenuta da quattro o più aste con
drappelloni o fregi per rendere onore a cose sacre o a grandi personaggi. Baldacchino deriva da Baldac
o Baldacco cioè Baghdad, città in cui si producevano stoffe preziose. In architettura è una struttura,
retta da colonne, situata sopra un monumento o un sito fondamentale da un punto di vista rituale.
BASILICHE CIMITERIALI COSTANTINIANE - [ad corpus o ad corpora] costruite accanto alla tomba
di uno o più martiri. Delle sei basiliche cimiteriali costantiniane, quattro erano circiformi (vedi).Le altre
due basiliche cimiteriali costantiniane, ad aula absidata e navate, sono: S. Pietro in Vaticano e di S.
Paolo fuori le mura, ambedue supra corpus, cioè costruite sulla tomba di un martire.
Le basiliche ad aula absidata derivano dalle basiliche forensi, come la basilica Ulpia, dotate di un ampio
spazio suddiviso in navate. A differenza delle basiliche forensi che hanno due esedre sui lati corti e gli

ingressi sui lati lunghi, le basiliche cristiane hanno un percorso longitudinale cioè sono suddivise in tre o
cinque navate e si concludono con l’abside, vano a pianta semicircolare coperto da una semicalotta
sferica detta tazza o catino absidale.
BASILICHE CIRCIFORMI - basiliche cimiteriali costruite nella stessa forma dei circhi per le corse dei
cavalli. Il corpo basilicale era suddiviso in tre navate; le due laterali si congiungevano nell’emiciclo
posteriore. Delle sei basiliche cimiteriali costantiniane, quattro erano circiformi:
Pianta di una basilica circiforme:
BASILICHE CIVILI - (greco stoà basileiós, portico del re, portico regio dell'Agorà di Atene) edifici
pubblici, spesso in comunicazione con il foro, utilizzati a Roma dalla seconda guerra punica come luogo
coperto soprattutto per trattare affari, sanare le controversie ed amministrare la giustizia. La basilica
non era solo borsa e tribunale: in generale la basilica assolveva alle funzioni che nella bella stagione si
svolgevano nel foro all'aperto e che in caso di pioggia avvenivano al coperto nella basilica.
L'edificio copriva una superficie abbastanza grande da assolvere alla sua funzione, ed era in genere
composta come un edificio a pianta rettangolare suddiviso da 2 o 4 file di colonne in navate e campate.
L'ingresso poteva trovarsi sul lato maggiore e dava accesso ad un'ampia sala priva di pareti divisorie.
Su uno dei lati minori si trovava l'abside dove venivano dibattuti i processi; era uno spazio
semicircolare dotato di cattedra murata per il magistrato che presiedeva l'udienza. L'illuminazione
interna era garantita da finestre nel cleristorio. Quando i cristiani dovettero scegliere un luogo adatto al
culto, in seguito all'Editto di Milano, più che ai tradizionali templi greci si guardò ad edifici più generici
atti al contenimento di un gran numero di fedeli: la scelta non poté che cadere sulle basiliche.
BASILICHE COSTANTINIANE – A Roma sono sette:
Sei basiliche Cimiteriali
Quattro Circiformi
S. Sebastiano (Basilica Apostolorum)
S. Agnese sulla via Nomentana,
S. Lorenzo al Verano
Ss. Marcellino e Pietro
Due Absidate
San Pietro in Vaticano

San Paolo fuori le mura
Una basilica cultuale
San Giovanni in Laterano (fam Laterani)
Fuori Roma:
Santo Sepolcro, absidata con Martyrium (Basilica Martyrium)
Basilica della Natività (Basilica Martyrium), Elena ma dietro finanziamento di Costantino.
Santa Sofia
BASILICHE PAPALI – sono le quattro chiese principali di Roma che hanno il rango liturgico più alto e
fanno parte delle sette Basilicae Maiores. Derivano dalle precedenti basiliche patriarcali quando
Benedetto XVI rinunciò al titolo di Patriarca d'Occidente. Le basiliche papali sono:
1. San Giovanni in Laterano, Cattedrale di Roma, chiamata anche Arcibasilica Lateranense
(l'unica con la cattedra papale)
2. San Pietro in Vaticano, chiamata anche Basilica Vaticana
3. San Paolo fuori le mura, chiamata anche Basilica Ostiense
4. Santa Maria Maggiore, chiamata anche Basilica Liberiana
Queste quattro basiliche papali hanno una Porta santa e un Altare papale (San Lorenzo fuori le mura fu
patriarcale fino alla metà del XIX secolo e non ha mai avuto altare papale né porta santa). Le sette
Basilicae maiores di Roma rappresentano anche simbolicamente la Pentarchia (i cinque patriarchi
della Chiesa unita prima dello scisma che ha separato Occidente da Oriente). L'attribuzione è:
1. San Giovanni in Laterano - Patriarca di Roma (il Papa)
2. San Pietro in Vaticano - Patriarca di Costantinopoli
3. San Paolo fuori le Mura - Patriarca di Alessandria d'Egitto
4. Santa Maria Maggiore - Patriarca di Antiochia
5. San Lorenzo fuori le mura - Patriarca di Gerusalemme (abolito)
6. Santa Croce in Gerusalemme

7. San Sebastiano fuori le mura
Basilicae maiores fuori Roma
Basilica di San Francesco ad Assisi dal 1756
Basilica di Santa Maria degli Angeli (Porziuncola) ad Assisi
Santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei, dal 1901
Basilica di Sant'Antonio a Padova
Basilica della Santa Casa a Loreto
Tali chiese sono state elevate ufficialmente dal papa dell'epoca al rango di basilica papale e possiedono
un altare papale. Esistono poi le basiliche minori, titolo che è stato concesso negli ultimi cento anni a
numerose chiese nel mondo. Anche chiese episcopali, che sono o sono state rette da un Patriarca, sono
indicate con il titolo di basilica patriarcale: le basiliche di Lisbona, Venezia, Aquileia, Goa.
CAPPELLE LATERALI - In uso dal XIII sec. Fungono da luoghi privati di sepoltura e/o di culto.
CATACOMBE – Antiche aree cimiteriali sotterranee cristiane, ma anche ebraiche e pagane. I cristiani
adottarono la sepoltura abbandonando, per la fede nella resurrezione dei corpi, l'uso della cremazione
pagana. Le catacombe sono solitamente scavate nel tufo, roccia facilmente lavorabile, e possono avere
più livelli ed essere profonde fino a trenta metri. All'inizio si mantennero principalmente le usanze
funerarie pagane, come è provato dal cimitero precristiano di Anzio. Il sepolcro si trova quasi sempre
all'esterno della città, poiché le Leggi delle XII tavole prescrivevano che hominem mortuum in urbe
neve sepelito neve urito (Non si seppellisca né si cremi nessun cadavere in città). Cimitero deriva dal
greco κοιμητήριον, quindi dal verbo κοιμάω, ossia "dormire", "riposare", oppure dal latino accubitorium,
dal verbo accumbere per "giacere", quindi luogo dell'attesa della resurrezione. Catacomba si pensa che
derivi dal greco "κατά κύμβας " (direttamente o dal lat. "cumba") traducibile come "presso/sotto la
cavità/le grotte". Il nome "locus ad catacumbas" ossia “presso l’avvallamento” indicava un sito (forse
S. Sebastiano o il Complesso di Massenzio) in cui erano presenti cave di pozzolana, e passò poi a
indicare genericamente tutti i cimiteri sotterranei cristiani. Nei dintorni di Roma vi sono più
di 60 catacombe e migliaia di tombe. Esistevano inoltre sei catacombe ebraiche: quattro sono
scomparse, e le altre 2 sono chiuse. Le catacombe cristiane furono costruite lungo le vie consolari:
Appia, Ostiense, Labicana, Tiburtina e Nomentana. Cinque catacombe cristiane sono aperte al pubblico:
1. San Callisto,
2. San Sebastiano
3. Santa Domitilla
4. Priscilla
5. S.Agnese
CENOTAFIO – [greco κενός, "kenos", vuoto e τάφος, "taphos", tomba] monumento sepolcrale eretto
per ricordare una persona o un gruppo di persone sepolte in altro luogo.
CIBORIO - Struttura architettonica stabile che sovrasta l’altare costituita da elementi verticali (in
genere quattro colonne) che sostengono una copertura piana o a volta. La collocazione del ciborio
sull’altare è documentata dal 4° sec.; era inizialmente fornito di tende (vela ) che ne chiudevano gli
intercolumni.
CIRCO - [latino circus, "cerchio"] luogo nel quale si disputavano le gare di corsa dei cavalli su un
percorso ad anello con fondo in sabbia (in latino arena) ed era costituito da due rettilinei paralleli,
separati da una balaustra (chiamata "spina") che correva nel mezzo e raccordati da due strette curve a

180 gradi. All'interno di ciascuna curva, all'estremità della spina, vi era una colonna, la meta, intorno
alla quale i corridori dovevano girare. La tipica distanza tra le due mete era di uno stadio (circa 200
metri). La pista aveva la forma di un rettangolo molto allungato: uno dei due lati corti era arrotondato,
mentre lungo l'altro si allineavano i carceres, ovvero i box dai quali prendevano il via i carri.
CLERISTORIO - livello più alto della navata in una basilica romana o in una chiesa romanica o gotica.
Il suo nome si deve al fatto che la sua traforazione di finestre permette alla luce di illuminare l'interno.
Era già stato usato dai Romani, in ciò probabilmente influenzati dall'architettura ellenistica, nelle
basiliche, nelle terme o nei palazzi. A volte le finestre sono piccole, semplici tondi, quadrilobi o triangoli
sferici. Nei grandi edifici, tuttavia, il cleristorio è una struttura importante. Le volte a crociera
dell'architettura gotica concentrano il peso e la spinta del tetto, liberando spazio sui muri per una
finestrazione più ampia del cleristorio. Nelle chiese gotiche, il cleristorio è generalmente diviso in vani
dai piloni della volta che continuano le stesse alte colonne che formano le arcate che separano le
navate laterali da quella centrale.
COSMATESCO - I Cosmati erano marmorari romani di varie botteghe vissuti tra il XII e il XIII secolo,
famosi per i loro lavori architettonici, per le loro sculture e per i loro mosaici e le loro decorazioni
realizzate prevalentemente in luoghi ecclesiastici. Il termine "Cosmati" è dovuto al nome di un certo
"Cosma" che ricorreva spesso nelle iscrizioni epigrafiche dei marmorari romani. Tali nomi si riferivano a
due artisti appartenenti a due famiglie parallele, ma indipendenti. Camillo Boito, in un articolo dal titolo
Architettura Cosmatesca del 1860, utilizzò per la prima volta l'aggettivo "cosmatesca".
CRIPTA - (greco κρύπτη, kryptē, latino crypta: nascosto) è, nell'architettura medievale, una camera o
un vano ricavato con la pietra, di solito sito al di sotto del pavimento di una chiesa, spesso contenente
le tombe di importanti personalità come santi (o le loro reliquie) o alte cariche del clero.
CUBICOLO – (lat. cubiculum "stanza da letto", dal verbo cubare "giacere, stare distesi") è nella casa
romana un piccolo ambiente destinato a camera da letto, generalmente affiancato da altri simili e
dislocato intorno all'atrio. Cubicolo indica anche sepolture a camera riservate ad una sola famiglia.
DIACONIA - (greco διὰκονια = diaconia, letteralmente "servizio") definisce l'azione sociale in accordo
ai principi dell'etica cristiana fondata sul precetto dell'amore e del servizio verso il prossimo secondo
l'esempio di Gesù Cristo. Fin dai primi secoli del cristianesimo esisteva la funzione di diacono che
collaborava all'assistenza dei poveri, al conferimento del battesimo e ad altre cerimonie liturgiche. Nel
tempo tale attività assunse sempre maggiore importanza dando luogo, nella seconda metà del IV
secolo ad istituzioni dette "diaconie" che si diffusero in Egitto, in Palestina a Costantinopoli e in Italia,
sia come istituzioni monastiche, sia come istituzioni diocesane. Assunsero poi lo status di enti morali,

entrando in possesso di beni immobili, ricevendo contributi e attuando anche operazioni commerciali al
fine di fornire assistenza e amministrare ospedali, centri di accoglienza e di formazione.
DOMUS ECCLESIAE – (lat. "casa dell'assemblea") edificio privato, utilizzato per il culto, prima
dell'editto costantiniano. Nelle lettere di san Paolo si citano: casa di Narcisso, casa di Aquila e Prisca
sull'Aventino (chiesa di Santa Prisca). Nel III secolo alcune domus ecclesiae donate alla Chiesa dai
proprietari divennero i cosiddetti tituli. Nel IV secolo Roma ne contava 25, con altri luoghi di culto
privati. L'architettura dei luoghi di culto cristiani non differiva dalle normali abitazioni, sebbene sia
possibile che già prima del 312 semplici sale fossero state costruite appositamente per il culto. Le
domus ecclesiae e i tituli prendevano il nome del proprietario dell'edificio e lo conservarono anche in
seguito: per esempio il titulus Clementis, di proprietà di un certo Clemens, divenne poi l'ecclesiae
Clementis (chiesa di Clemente), e quindi l'attuale Basilica di San Clemente al Laterano. Alcune
abitazioni private adibite a culto sono state rinvenute sotto le chiese successive (Santi Giovanni e Paolo
o titulus Pammachii, Santa Cecilia in Trastevere o titulus Caeciliae, San Martino ai Monti o titulus
Equitii). L'identificazione è in genere difficile per la mancanza di specifiche caratteristiche
architettoniche e dall'uso di eventuali decorazioni pagane, ma alle quali potrebbe essere stato dato un
nuovo significato simbolico cristiano.
DURA EUROPOS - città siriana rasa al suolo dai Persiani nel 256 d.C., mai più ricostruita e riscoperta
dagli archeologi nel 1920. La domus ecclesiae, rinvenuta vicino alla Porta di Palmira, grazie a un
graffito databile all'anno 232 può essere definita una delle chiese più antiche del mondo. L'edificio,
parte di una casa affacciata su una strada lastricata, ha due piani, quello superiore probabilmente
utilizzato come abitazione, articolata su una serie di sale intorno ad un cortile centrale. Al piano terra, a
fianco all'atrio centrale, c'è una sala più piccola, che immette in un ambiente ancora più angusto. La
stanza più grande era la sala della comunità; la sala piccola era un ambiente intermedio che serviva per
l'agape; l'ambiente angusto era un battistero decorato con scene dell'Antico e del Nuovo Testamento in
quanto cuore dell'edificio. La chiesa si è conservata nei millenni poiché fu coperta da un bastione
realizzato per difendere la città dall'attacco dei Persiani.
FANUM - (latino, plurale fana) luogo sacro generico, o piccolo edificio di culto quasi sinonimo di
sacellum. Cicerone con fanum indica santuari estranei alla tradizione classica; Svetonio riferisce che
Cesare nella guerra gallica distrusse fana templaque (fana e templi). Nell'archeologia moderna, fanum
indica un edificio templare tipico della tradizione celtica, costituito da un'altissima cella a pianta
centrale (circolare, quadrata o poligonale), circondata da una galleria coperta, diverso dal modello del
tempio romano.
LACUNARI - [anche cassettoni] cavità ricavate in un soffitto e disposte in maniera regolare
(solitamente a scacchiera). Le forme geometriche più comuni della base delle cavità sono il quadrato, il
rettangolo e l'ottagono, ma vi sono esempi di impiego di diverse forme nello stesso soffitto. Sono
elementi già presenti nell'architettura antica: un esempio è costituito dai lacunari ricavati nella cupola
del Pantheon con funzione strutturale ed estetica, mentre nelle volte della Basilica di Massenzio vi è la
compresenza di lacunari di diversa forma.
LESENA - elemento di un ordine architettonico addossato a parete che consiste in un fusto, a pianta
rettangolare, appena sporgente dalla parete stessa, con i relativi capitello e base. La lesena ha una
funzione decorativa e non portante: si differenzia dalla parasta, che, sebbene di aspetto simile, è un
vero elemento di sostegno, inglobato nella parete e non semplicemente addossato ad essa.

LOCULO - vano, nicchia interrata in cui si adagiavano le urne cinerarie nelle necropoli romane, i corpi
avvolti da lenzuola o i sarcofagi nelle catacombe cristiane o le bare nei camposanti, fino all'adozione dei
colombari nei moderni cimiteri con file di loculi sovrapposte ricavate nelle pareti in muratura.
MARTYRION - chiesa tipica dell'arte bizantina, costruita sulla tomba di un martire o sul luogo della
sua morte. Prende lo stesso nome una particolare tipologia di cella memoriae, gli edifici funerari tipici
dell'epoca paleocristiana. In genere era un edificio a cupola, a pianta centrale e/o a croce greca.
MATRONEO - Luogo riservato alle matrone nelle antiche basiliche cristiane dove la divisione dei sessi
era rigorosamente mantenuta: a sinistra gli uomini, a destra la parte per le donne. Generalmente la
separazione dei sessi avveniva lungo le navatelle ed era resa più rigorosa da tramezzi in legno o da veli
che venivano appesi a chiodi fissati nelle colonne o nei pilastri di cui si vedono ancora i fori in alcune
antiche basiliche. Qualche volta venivano adibite come locus mulierum le gallerie superiori (p. es. S.
Agnese, S. Lorenzo fuori le mura a Roma) o una galleria posteriore all'abside (Ss. Cosma e Damiano).
MUSIVO - [lat. musivus, gr. μουσεῖος] Proprio del mosaico; che si riferisce al mosaico.
NAÒS - Cella (in greco) parte interna di un tempio che ospitava l'immagine della divinità (di solito una
statua) e simbolicamente era la casa del dio stesso; per questo era proibito entrarvi se non durante
particolari festività, mentre vi accedevano regolarmente soltanto alcuni tipi di sacerdoti. Le dimensioni
della cella nei templi classici erano perciò molto ridotte, le pareti interne erano decisamente secondarie
rispetto alla decorazione esterna, visibile dalla comunità riunita fuori dagli edifici per le funzioni e i riti.
La cella, che ha come antecedenti forse il megaron minoico e miceneo, poteva essere preceduta da un
portico colonnato (prònaos), dove potevano trovarsi le stanze dei tesori, le raccolte di offerte dei fedeli.
Talvolta questa funzione spettava invece a una stanza posteriore, detta opistodomo. La zona riservata
ai sacerdoti era detta invece adyton. La cella era spesso coperta da cancellate, per impedire il
saccheggio delle offerte. La disposizione delle colonne in relazione alla cella, definisce le varie tipologie
templari (in antis, prostilo, anfiprostilo, periptero, pseudoperiptero, diptero, pseudodiptero).
NARTECE - Parte della basilica paleocristiana e bizantina riservata ai catecumeni e ai penitenti,
costituita da un vestibolo addossato all’esterno della facciata (esonartece ), o più raramente ricavato
all’interno di essa (endonartece ); consiste in un vano trasversale, posto a contatto con la facciata.
OPUS LATERICIUM - Tecnica edilizia romana che riguarda il modo in cui viene realizzato un muro in
opera cementizia, mediante lateres, o mattoni. Vitruvio descrive un muro (opus latericium) realizzato
con mattoni rettangolari (circa 45x30 cm) cotti al sole e sovrapposti alternando i giunti. Lo spessore del
muro, limitato dalle dimensioni dei mattoni, non consentiva la costruzione di edifici a più piani.
PARASTA - Elemento architettonico strutturale verticale (pilastro) inglobato in una parete, dalla
quale sporge solo leggermente. Si differenzia dalla lesena, che pur avendo apparentemente lo stesso
aspetto esterno, ha invece funzioni solo decorative.
PASTOFORI - (παστοφόριον, "appartamento del sacerdote" o "camera per il tesoro") sono degli
ambienti gemelli, presenti in chiese paleocristiane e altomedievali, introdotti in epoca
costantinopolitana. Si tratta di due stanze a base quadrata o rettangolare, spesso absidate, disposte
simmetricamente ai lati all'abside principale, in fondo alle navate laterali (o al deambulatorio, se la
chiesa è circolare, come nel caso di San Vitale a Ravenna):
prothesis a sinistra dove si conservavano le offerte dei fedeli,
diaconicon a destra dove si custodivano i vasi e i paramenti sacri, come nelle odierne sacresti

PERISTÀSI - Porticato colonnato, spesso quadrangolare (ad eccezione del tempio a tholos e di quello
monòptero, nei quali è circolare), che circonda, particolarmente nei templi greci, ma anche in quelli
romani, il naos. Le file e il numero delle colonne che lo compongono differenziano i vari tipi di templi
greci, Perìptero: 1 (quadrangolare), Dìptero: 2 (quadrangolare), Monòptero: 1 (circolare), Tholos: 1
(circolare). Il tempio pseudoperìptero ("pseudès" significa falso, quindi "falso-periptero") sembra che
sia circondato da una peristàsi, ma in realtà le colonne sono solo metà, in quanto addossate alle pareti.
Il tempio pseudodìptero, con lo stesso significato del precedente, è un tempio circondato da una sola
fila di colonne, ma lo spazio tra la peristàsi e la cella potrebbe ospitare una seconda fila di colonne,
come il tempio dìptero. Invece il numero delle colonne presente sul fronte definisce altri templi:
tetràstilo/4, esàstilo/6, eptàstilo/7, octàstilo/8, ennàstilo/9, decàstilo/10, dodecàstilo/12.
PERSECUZIONI -
Nerone 64
66-67 martirio di Pietro e Paolo
Domiziano 81-96
Antonino Pio 155
Commodo 180
Filippo l'Arabo 249, primo imperatore cristiano
Decio 250
Valeriano 257, confisca ma il figlio restituisce
Diocleziano 303
PILASTRO - Piedritto, ovvero elemento architettonico verticale portante, che trasferisce i carichi della
sovrastruttura alle strutture sottostanti preposte a riceverlo. Un pilastro a sezione tonda è una colonna.
PLUTEI – cancelli paleocristiani a lastra piena.
PULPITO - struttura sopraelevata destinata solo alla predicazione (che a partire dal Medioevo non era
più considerata un momento organico della celebrazione liturgica, bensì un momento di istruzione al
popolo), non si trovava nel presbiterio, bensì nella navata o addirittura all'esterno della chiesa.
STADIO – Dedicato ai Giochi ginnici
TABERNACOLO - (in latino Tabernaculum - diminutivo di Taberna dal significato di Dimora), nella
tradizione ebraica e cristiana è il luogo della dimora di Dio presso gli uomini. E' una struttura a forma di
scatola presente in tutte le chiese cattoliche nella quale sono conservate le ostie consacrate dopo la
Celebrazione Eucaristica. Il termine è utilizzato anche per le edicole sacre o edicole votive che
proteggono un'immagine sacra oggetto di culto, all'interno delle chiese o all'esterno. Tabernaculum e
taberna derivano da tabula, tavola di legno e significavano capanna, accampamento mobile per i
soldati, specialmente in campagna. Avrebbe allora il senso di dimora provvisoria. La parola
tabernaculum fu utilizzata nella Vulgata per tradurre l'ebraico: מִשְׁכָּן mishkhan (dimora).
TEGURIO – Edicola o tempietto sorretto da pilastrini o colonne.
TITOLO – [lat. Titulus: tabella di legno posta sul fronte di un edificio e recante il nome del suo
proprietario]. Nei primi tempi del cristianesimo, i ricchi convertiti posero a disposizione della comunità
qualche aula dei loro palazzi dove, protetti dal diritto della proprietà privata cioè sub titulo d'un nome
potente e dello ius domiciliare, i fedeli si radunavano per il culto. Più tardi, essendo stato attribuito
culto a parecchi tra i fondatori dei primitivi titoli, anche le altre chiese, denominate già da persone
private, vennero col tempo dedicate a martiri omonimi, le cui reliquie, a cagione appunto di questa

omonimia, furono trasferite in quegli edifici. Così il titulus Sabinae, titulus Balbinae, titulus Anastasiae,
divennero ben presto tit. Sanctae Sabinae, ecc., senza che queste sante abbiano avuto alcuna relazione
con le rispettive fondatrici di quelle chiese. Titoli famosi e pervenuti:
Titulus Aequitii (San Martino ai Monti)
Titulus Byzantis (Santi Giovanni e Paolo)
Titulus Clementis (San Clemente)
L'aumento dei fedeli indusse i papi a concedere il fonte battesimale e la facoltà di amministrare altri
sacramenti anche ad altre chiese, oltre alla principale o cattedrale, che avevano clero, patrimonio e
cimitero distinti; e il primo ecclesiastico del loro clero era chiamato cardinalis. Questi, con i diaconi
regionarî, formavano il consiglio del vescovo di Roma, e da essi ebbe origine il collegio cardinalizio. I
titoli principali, inizialmente 25, salirono più tardi a 28 e ad essi fu riservato per antonomasia il nome di
"titoli". Con il crescere del numero dei cardinali, si accrebbe anche il numero dei primitivi titoli, fino
all'attuale di 50 fissati da Sisto V con la costituzione del 1587.
TOMBA A CAPPUCCINA - tombe con copertura e/o con rivestimento di tegole, utilizzate sia per la
sepoltura di inumati che di incinerati.
TRANSENNE – cancelli paleocristiani a lastra traforata a giorno.
TRANSETTO - (fr.: transept, croisée) Designa quella specie di nave trasversale, che s'inserisce tra le
navi longitudinali e l'abside o presbitero, conferendo alla pianta delle chiese la forma di croce. Deriva
da trans septa e significa di là dalla chiusura. Anticamente il culto si svolgeva nell'abside e nel
transetto, nel cui mezzo sorgeva l'altare, con tegurio ornato di cortinaggi. Al centro dell'abside era
situata la cattedra del vescovo o abate, che discendeva, attorniato dal clero, ad officiare sull'altare
posto nel transetto. Spesso alcune transenne (septa) separavano il transetto, destinato come l'abside al
clero, dalle navate longitudinali destinate ai fedeli.
VESTIBOLO – [vestibulum] Nell'architettura romana era uno spazio sontuosamente costruito fra la
strada e la porta d'ingresso delle case dei ricchi. Nel periodo tardo-romano il termine prese a indicare lo
spazio fra la porta d'ingresso della casa e l'atrio, via di mezzo fra una moderna sala d'ingresso e un
porticato. Per entrare nella casa romana (domus) bisognava attraversare il vestibolo prima di entrare
nell'atrio. Secondo J. E. Kuntze, lo scopo originario del vestibolo era quello di scuderia e luogo di
stazionamento di cavalli in una fattoria.