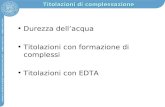CORSO LICEO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE · Progetto di Bioetica Corso per utilizzo del DAE con...
Transcript of CORSO LICEO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE · Progetto di Bioetica Corso per utilizzo del DAE con...
1
all'ALBO
CORSO LICEO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CLASSE 5^ BSA
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE finalizzato all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi
CONTENUTI DEL DOCUMENTO: - Relazione sulla classe e sull'azione del Consiglio di Classe - Preparazione alle prove di Esame - Percorso formativo della classe - Schede per materia - Griglie di valutazione adottate nelle simulazioni delle prove di esame - Testi proposti nelle simulazioni di terza prova Il presente documento è stato approvato nella riunione del Consiglio di Classe del maggio 2018.
Il Coordinatore del Consiglio di Classe Prof.ssa Lucia Sechi
Il Dirigente Scolastico Prof. Pierluigi Mario Robino
2
RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso: indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano dell'Offerta Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola.
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA DOCENTE/I
Lingua e Letteratura italiana Lucia Sechi
Lingua e Cultura Inglese Carlo Cianelli
Storia Lucia Luperini
Filosofia Orazio Caruso
Matematica Angela Castellacci
Informatica * Susanna Andronico
Fisica * Stefano Ranfone
Scienze naturali * Paola Greco
Disegno e storia dell'arte Sergio Tognarelli
Scienze motorie e sportive Carlo Pellegrini
Religione cattolica o Attività alternative Marzio Paoli
Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di genitori e studenti.
Andamento generale della classe:
La classe è costituita da 18 alunni di cui 15 costituiscono il nucleo storico. Ad essi si si sono uniti, nel corso del Triennio, quattro alunni provenienti da altri licei della provincia, dei quali uno all’inizio di questo anno scolastico, ritiratosi nel corso del I trimestre.
iscritti provenienti
da altra classe o istituto
ammessi valutazione rinviata
ritirati non ammessi
2015-16 18 1 17 8 1
trasferita
31/08/2016
1
2016-17 19 3
( due provenienti da altri istituti)
18 10 1
2017-18 19 1
proveniente da altro istituto
1
3
La classe 5 BSA, dal punto di vista socio-affettivo, risulta affiatata e solidale. I ragazzi hanno stabilito tra di loro buoni rapporti interpersonali, improntati al rispetto, alla solidarietà, all’ascolto reciproco.
La classe, dal punto di vista disciplinare, manifesta un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole scolastiche. Si evidenzia, tuttavia, una certa propensione a distrarsi, da parte di alcuni alunni, che, però, se opportunamente richiamati, non insistono nel loro atteggiamento e una generalizzata tendenza a non confidare nelle proprie capacità, a deprimersi e a rifugiarsi in atteggiamenti svalutanti.
La classe, dal punto di vista didattico, partecipa al dialogo educativo con qualche difficoltà, come testimonia l’alto numero di alunni con valutazione rinviata nel corso dei due anni precedenti, nonostante si sia operato, al termine del biennio propedeutico, ad una energica azione di riorientamento, che ha interessato un terzo degli alunni frequentanti. Buona parte degli studenti, ha manifestato, una certa fatica a concentrarsi e ad applicarsi con successo soprattutto nelle materie, che richiedono un maggior grado di astrazione concettuale: in particolare in Matematica e Fisica, dove i Docenti hanno puntato ad un consolidamento dei saperi essenziali. Più efficace è stato il dialogo nell’aria umanistica e, seppure legato ad uno studio spesso mnemonico, in quella della Lingua straniera. La preparazione, nel suo complesso , non è organica, e si presenta più incerta là dove il recupero non è stato approfondito.
In termini più analitici la classe risulta divisa in tre gruppi.
Il primo, numericamente esiguo, comprende alunni la cui preparazione è ben strutturata, organica e critica. Curiosi e diligenti hanno partecipato in maniera costruttiva, creativa, intelligente al dialogo scolastico, sfruttando tutte le possibilità di arricchimento culturale che la scuola offriva e, al tempo stesso, incoraggiando e sostenendo i compagni più in difficoltà.
Nel secondo gruppo, numericamente più esteso, si colloca la maggior parte degli studenti della classe, la cui preparazione è complessivamente sufficiente, anche se un po’ mnemonica e non particolarmente critica. Anche loro hanno partecipato con interesse e generosità alle varie attività (soprattutto laboratoriali) che la scuola offriva, traendone benefici in termini di autostima e di acquisizione di competenze trasversali.
Nel terzo gruppo troviamo alunni più insicuri, la cui preparazione è più tentennante, ai limiti della sufficienza, portati a scoraggiarsi, invece di investire in una decisa e coraggiosa azione di recupero e valorizzazione delle proprie capacità. Anche questo gruppo ha aderito con interesse alle iniziative di alternanza scuola-lavoro che l’Istituto promuoveva, rivelandosi affidabile e responsabile, mettendo a frutto, in un contesto meno teorico, competenze, non sempre evidenziate in aula.
Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti:
La classe ha sviluppato un forte senso di coesione, collaborazione e accoglienza.
Gli alunni si sono rivelati disponibili e generosi nel dialogare con i nuovi compagni e farli sentire inseriti in un gruppo unito.
Ottimo è il livello di rispetto delle regole maturato sia durante le ore di lezione, sia nel corso delle attività extra curricolari programmate (viaggi di istruzione, Happy Hour della Scienza e della Tecnica, visit guidate ,convegni ).
Riguardo al potenziamento dell’autostima, si è lavorato intensamente nel corso di tutto il Triennio, attraverso uno specifico ciclo di incontri (per un totale di dieci ore) con lo psicologo scolastico, dottor Giovanni Cioli, nel corso della Terza, per poi proseguire in Quarta e in Quinta, in maniera meno sistematica, attraverso esercizi, letture , discussioni guidate, esperienze laboratoriali. Significativo è stato, a tal proposito, il lavoro di gruppo guidato dalla docente di Informatica Prof.ssa Andronico lo scorso anno, in occasione dell’Happy Hour della Scienza e della Tecnica, in cui i ragazzi, fortemente insicuri rispetto alle proprie capacità in area scientifica, hanno acquisito consapevolezza e fiducia in se stessi, attraverso la progettazione e creazione di un piccolo robot.
4
Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti:
Rispetto agli obiettivi programmati, la classe ha risposto in maniera diversa. Mentre alcuni alunni hanno dimostrato capacità di lavorare in piena autonomia, sviluppando collegamenti tra le varie discipline, altri si sono fermati ad uno studio nozionistico e mnemonico.
Tutti hanno rivelato buone capacità di lavorare in gruppo, nel rispetto dei vari stili di apprendimento, delle diverse opinioni e personalità.
Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati:
Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e metodi riportati nel PTOF, che costituiscono motivazione dei voti assegnati.
Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate nella seconda parte di questo documento.
Attività di alternanza scuola-lavoro e/o di orientamento:
Nel corso del triennio la classe ha partecipato con interesse al progetto di “Alternanza scuola-lavoro”,
intervenendo a:
- moduli didattici relativi al mondo del lavoro o della ricerca;
- incontri con aziende, associazioni, enti culturali del territorio;
- stages in azienda o enti di studio o ricerca
Tali attività sono state valutate dalla scuola all’inizio di ogni anno scolastico con apposita griglia
attribuendo valutazioni nelle materie affini.
Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno effettuato:
- colloqui di orientamento universitario all’interno della scuola;
- percorsi di orientamento proposti dalle Università di Pisa e di Firenze;
Attività extracurricolari più significative:
Nel corso del Triennio
Attività che hanno coinvolto la quasi totalità degli alunni
Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica per tutti e tre gli anni (in V un alunno ha
partecipato anche alla fase provinciale),
Partecipazione all’Happy Hour della Scienza e della Tecnica per tutti e tre gli anni
con attività di
- accoglienza (III IV V )
- laboratorio di Lettere in collaborazione con la biblioteca Gronchi di Pontedera (IV)
- laboratorio di Chimica (III e IV)
- progetto Sbabi, "Robot programmato con Arduino" (IV V)
- conferenze (III IV V )
Attività di Cineforum presso il Cineplex con la collaborazione del comune di Pontedera su vari
temi ( lavoro, tecnologia ,memoria) per tutti e tre gli anni,
Viaggi di istruzione a Vienna (III), Monaco (IV), Lisbona (V)
5
Attività che hanno coinvolto un numero limitato di alunni
Corso pomeridiano di teatro conclusosi con una performance teatrale aperta alla scuola
Certificazioni linguistiche FCE
Corso di preparazione ai test di accesso alle facoltà universitarie
Progetto di Bioetica
Corso per utilizzo del DAE con Misericordia di La Scala
Tre giorni di studio su La applicazione delle tecniche di biotecnologie presso il Dipartimento di
Biologia di Pisa
Nel corso del corrente anno scolastico
25/11 Partecipazione a Giornata contro la violenza sulle donne
25/01 Incontro informativo sulle donazioni di sangue e di midollo osseo con medici del Centro Trasfusionale di Pontedera e con volontari delle associazioni AVIS e FRATRES di Pontedera. Una buona parte della classe ha, quindi, donato il sangue
27/01 Conferenza su Ebrei a Pisa
23/03 Conferenza su L'articolo 48 della Costituzione
26/03 Conferenza con il Rotary club sul tema Il lavoro e i giovani
20/04 Conferenza su Il progetto Virgo
24/04 Spettacolo teatrale: Ragion di stato
Attività CLIL:
Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua , il modulo è stato solo parzialmente svolto dal Docente di Fisica.
6
PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME Simulazioni della prima prova e della seconda scritta: Sono state effettuate n. 1 simulazione della prima prova scritta (Italiano), basate su testi ministeriali. Sono state effettuate n.2 simulazioni della seconda prova scritta ( Matematica), basate su testi forniti dalla Zanichelli
Le prove sono state valutate utilizzando le griglie riportate in coda al presente documento.
Simulazioni della terza prova scritta: Sono state effettuate n. 2 simulazioni di terza prova scritta, di seguito schematicamente riportate:
tipologia durata materie coinvolte n. quesiti per disciplina
B(06/02/18) 120’ INGLESE-MATEMATICA-INFORMATICA-STORIA-SCIENZE
2
B(10/05/18) 120’ INGLESE- STORIA-DISEGNO E ST.ARTE-FISICA-SCIENZE
2
In coda al presente documento sono riportati i testi proposti nelle simulazioni di terza prova nonché le griglie di valutazione adottate.
Simulazioni del colloquio: Non sono state effettuate alcune simulazioni di colloquio
7
PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di studi:
LICEO SCIENTIFICO
Opzione Scienze Applicate I II III IV V
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica * 2 2 2 2 2
Fisica * 2 2 3 3 3
Scienze naturali * 3 4 5 5 5
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative
1 1 1 1 1
ore settimanali totali 27 27 30 30 30
Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo articolato per:
contenuti;
mezzi e metodi adottati;
spazi e tempistica;
strumenti e criteri di valutazione;
obiettivi raggiunti. Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame.
8
SCHEDA MATERIA:
Lingua e letteratura italiana DOCENTE:
Lucia Sechi
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
Modulo propedeutico: Sono stati ripresi i seguenti argomenti:
La parafrasi
Elementi di retorica ( figure retoriche e nozioni di metrica)
3
Modulo I - La letteratura realista – Questa sezione è stata svolta utilizzando appunti e il libro di testo. Lo studio si è sviluppato secondo la seguente articolazione.
Panorama filosofico :il Positivismo.
Panorama letterario: il Naturalismo francese e il Verismo, la Scapigliatura
I protagonisti di cui si è affrontato lo studio attraverso il seguente schema: vita, opere ,ideologia, poetica. Lo studio della biografia di Verga e Carducci è stato condotto attraverso la lettura ragionata del libro di L. Di Giovanni e T. Guaita Vite segrete dei grandi scrittori italiani.
Gli autori presi in esame sono :
G. Verga
I. U.Tarchetti
G. Carducci
Per quanto concerne i testi ,è stata curata in classe la lettura ragionata, la parafrasi ( qualora in versi ) e il commento dei seguenti testi: Giovanni Verga: Da Eva Prefazione Da Vita dei campi La Lupa Rosso Malpelo Da Novelle rusticane La Roba Da I Malavoglia Prefazione Il ritorno e l’addio di di ‘Ntoni Giosuè Carducci: Da Rime nuove Pianto antico
San Martin
settembre /novembre
9
Da Giambi ed Epodi A Proposito del processo Fadda
( lettura ragionata) Da Odi barbare Nevicata Da Inno a Satana Un bello e orribile ( da appunti ) versi 169-200 ( lettura ragionata)
Iginio Ugo Tarchetti: Da Poesie Memento ( da appunti ) ( lettura ragionata) Da Fosca La grazia e orribilità di Fosca ( da appunti )
Modulo II – La letteratura decadente – Questa sezione è stata svolta utilizzando appunti e il libro di testo. Lo studio si è sviluppato secondo la seguente articolazione.
La crisi del Positivismo e sue testimonianze
Nuova concezione della poesia ( poeta vate e veggente),
I protagonisti di cui si è affrontato lo studio attraverso il seguente schema: vita, opere ,ideologia, poetica.
Gli autori presi in esame sono :
C. Baudelaire
G.Pascoli
G.D’Annunzio La conoscenza delle vicende biografiche di G.Pascoli è stata approfondita attraverso la discussione in classe delle riflessioni fatte da Vittorino Andreoli nel libro I segreti di casa Pascoli BUR 2006. È stata curata in classe la lettura ragionata, la parafrasi ( qualora in versi ) e il commento dei seguenti testi: . Charles Baudelaire:
Da Poesie e prose Perdita d’aureola )
Gabriele D'Annunzio: Da La Tribuna Dateci il sogno (da appunti) Da Alcyone La sera fiesolana La pioggia nel pineto ( lettura ragionata) Da Le novelle Il tesoro dei poveri ( da appunti )
novembre /gennaio
10
Da Il piacere Ritratto di Andrea Sperelli
Giovanni Pascoli: Da Pensieri e Discorsi La scienza ha perfezionato Da Myricae Il lampo Il tuono Temporale Novembre Da Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno Da Poemetti Digitale purpurea Da Il fanciullino E’ dentro di noi un fanciullino Italio Svevo: Da La coscienza di Zeno Ci sarà un’ esplosione enorme
Modulo III – Il nuovo panorama culturale e artistico del primo Novecento- Panorama filosofico –culturale -
il contributo della scienza:
le geometrie non euclidee
il principio di Indeterminazione
la relatività
la psicanalisi e Freud . il contributo della filosofia:
il tempo in Henri Berson,
l’irrazionalismo di Nietzsche.
Le principali novità formali e tematiche che il romanzo novecentesco introduce. .
gennaio
Modulo IV - Il teatro novecentesco italiano Luigi Pirandello: vita, opere ,ideologia ,poetica. Questa sezione è stata svolta utilizzando il libro di testo e appunti. È stata curata in classe la lettura ragionata e il commento dei seguenti testi:
aprile
11
Luigi Pirandello: Da L’umorismo Umorismo e comicità
Da Novelle per un anno La patente ( da appunti) La carriola (appunti) Da L’uomo dal fiore in bocca Lettura integrale( da appunti)
Modulo V – La poesia italiana del Novecento- I movimenti:
I Futuristi
i Crepuscolari
I Vociani
Gli Ermetici
Gli interpreti:
Filippo Tommaso Marinetti
Guido Gozzano
C.Sbarbaro
D.Campana
Giuseppe Ungaretti *
Eugenio Montale* Questa sezione è stata svolta utilizzando appunti e il libro di testo. È stata curata in classe la lettura ragionata e il commento dei seguenti testi: F.T.Marinetti: Da Le Figaro 20 febbraio 1909 Manifesto del Futurismo Da I nuovi poeti futuristi L'automobile da corsa (da appunti ) Guido Gozzano: Da I colloqui La signorina Felicita (versi.42-53) Le golose (da appunti lettura ragionata) Cocotte ( da appunti lettura ragionata)
febbraio/marzo/aprile
12
Camillo Sbarbaro Da Pianissimo Taci ,anima stanca di godere Dino Campana Da Canti orfici In un momento Barche amorrate L’invetriata Giuseppe Ungaretti* da L'Allegria Veglia Fratelli Commiato Il porto sepolto I fiumi Soldati San Martino del Carso Da Il sentimento del tempo La madre Eugenio Montale:* Da Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto Spesso il male di vivere ho incontrato Da Xenia Ho sceso, dandoti il braccio
Modulo VI : Alla ricerca di un senso Martin Buber Da Il cammino dell’uomo Adamo dove sei? ( appunti) Victor Frankl Da Uno psicologo nei lager Gli fu sottratta ogni cosa tranne la nuda esistenza (appunti)
maggio
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. Libro di testo adottato:
Luperini, Cataldi, Marchiani,Marchese LE PAROLE LE COSE Voll. 3A Palumbo E APPUNTI
_________________________________________________________________________________
Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Il metodo di lavoro utilizzato ha privilegiato la lezione frontale, tesa a evidenziare i caratteri principali di un autore o di un movimento, seguita dall’analisi dei testi, alcuni dei quali solo letti ( lettura
13
ragionata), altri oggetto di un più accurato studio ( parafrasi e commento). Per completare e rinforzare e la spiegazione ho fornito appunti e sintesi e questionari di ripasso.
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Gli elementi su cui ho fondato il mio giudizio, oltre al risultato delle prove scritte ed orali, a cui ho dato uno spazio e significato maggiore rispetto agli anni passati, sono stati l’assiduità della frequenza, il grado di attenzione, partecipazione e interesse dimostrati in classe e la diligenza dimostrata nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. Ho tenuto anche conto dello scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza, sia nelle verifiche scritte che orali per valorizzare i progressi fatti.
Obiettivi raggiunti: Il mio lavoro in questa classe si è inserito in un percorso, iniziato in Prima . Con gli alunni si è instaurato, nel corso degli anni, un clima sereno, improntato al dialogo e all’ascolto reciproco, congiunto ad una buona collaborazione, su un piano più strettamente didattico. Tutti gli alunni hanno maturato una preparazione sufficiente per quanto riguarda le conoscenze di Storia della Letteratura Italiana, per alcuni di loro, essa è buona e per un ristretto gruppo di studenti critica e ben articolata. Maggiori difficoltà emergono nella elaborazione scritta, dove permangono per molti di essi, incertezze a livello morfosintattico.
Docente della materia Prof.ssa Lucia Sechi
14
SCHEDA MATERIA: STORIA
DOCENTE: Lucia Luperini
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Tempi e spazi
Verso la Società di massa
Caratteristiche generali Produzione in serie: catena di montaggio, Taylorismo e Fordismo Gli eserciti di massa. Suffragio universale. Partiti di massa. La questione femminile.
Settembre - Ottobre
L’Europa nella Belle Epoque
Un quadro contraddittorio
Triplice Alleanza e Triplice Intesa. Il caso Dreyfus
Conflitti di Nazionalità in Austria-Ungheria. La Rivoluzione del 1905 in Russia ( la Duma e la nascita dei Soviet). Verso la guerra. L’Italia giolittiana. Crisi ed evoluzione del sistema liberale. Decollo industriale e progresso civile. La questione meridionale. Le riforme di Giolitti. La guerra di Libia. Crisi del sistema giolittiano.
Ottobre
La Prima Guerra Mondiale
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura. Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra. Le trincee e la nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. 1915-1916: la grande strage. Il 1917: la svolta del conflitto. L’ultimo anno di guerra. Il bilancio della guerra. Il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra, la Società delle Nazioni.
Novembre
Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin La Rivoluzione di Ottobre. Dittatura e guerra civile. Comunismo di guerra e la Nep. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo Paese. La campagna contro i Kulaki. La collettivizzazione delle campagne. L’industrializzazione forzata. I piani quinquennali. Lo Stalinismo. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Le “purghe” e l’arcipelago Gulag.
Dicembre-Gennaio
L’eredità della Grande Guerra
I problemi del dopoguerra. Difficoltà economiche e fermenti sociali. La questione di Fiume. Biennio rosso in Italia (sintesi).
Febbraio
15
I Fasci di combattimento. Lo squadrismo. I Sansepolcristi e il loro programma. La Repubblica di Weimar. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. La marcia su Roma. Verso lo «Stato autoritario». Dall’assassinio di Matteotti alle «leggi fascistissime».
L’Italia fascista
Il totalitarismo imperfetto. I Patti lateranensi. Il Regime e il Paese. Le quattro fasi della politica economica del fascismo. La politica estera di Mussolini: l’impresa etiopica. L’asse Roma-Berlino. Le leggi razziali
Marzo
La Grande crisi economica e la depressione dopo il ’29. Il crollo di Wall Street. Il dilagare della crisi. Roosevelt e il New Deal. I nuovi consumi. Le comunicazioni di massa.
Marzo-Aprile
Avvento del Nazismo
L’ascesa di Hitler al potere. Crisi economica e ascesa dei nazisti. Hitler capo del governo. Incendio del Reichstag. La notte dei lunghi coltelli. Il terzo Reich. La questione ebraica. Dalla discriminazione alla persecuzione. Propaganda e comunicazione di massa. Il contagio autoritario. Verso la II Guerra Mondiale. La guerra di Spagna (sintesi) Annessione dell’Austria e questione dei Sudeti. La Conferenza di Monaco.
Aprile
La Seconda guerra mondiale
Le origini. Lo scoppio del conflitto. Dal 39 al 42: la prima fase. Distruzione della Polonia e offensiva a Nord. La caduta della Francia. L’Italia in guerra. L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti. 1942-43: la svolta della guerra; crollo del fascismo. Repubblica sociale, occupazione tedesca, Resistenza e liberazione. La sconfitta della Germania. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.
aprile/ maggio
Guerra fredda. Le conseguenze della II Guerra Mondiale.
La nascita della Repubblica italiana: il 2 Giugno 1946, le elezioni del 1948 Il concetto di “Guerra fredda”.
Maggio (*)
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. Libro di testo adottato: Giardina A., Sabattucci G., Vidotto V. – Nuovi profili storici. Voll. 3°, 3°° Dal 1900 a oggi. Laterza Ed., Roma, Bari 2012
Mezzi e metodologie didattiche adottate: Al fine di potenziare negli studenti una coscienza storica attraverso la riflessione sui rapporti di causa-
16
effetto, sulle relazioni spaziali e temporali sulle implicazioni sociali, economiche, politiche e culturali presenti negli eventi trattati, si è privilegiato l’utilizzo delle lezioni frontali, il prendere metodicamente appunti anche come preparazione al possibile approdo universitario, la rielaborazione personale attraverso schemi o brevi riassunti. Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di comprensione essenziale sia delle spiegazioni (lezione frontale) sia di testi scritti di vario tipo e sulle conoscenze generali dell'argomento trattato. Sono stati comunque valutati anche l'impegno, la partecipazione, il lavoro autonomo di ricerca, ecc.. Sono stati utilizzati i criteri di valutazione presentati nel Piano di lavoro annuale del C. d. C. allegati al presente Documento e quelli esplicitati nel POF d’Istituto. Per la valutazione della simulazione della terza prova si sono usati i criteri specifici allegati al presente Documento finale. Infine è stata fatta una simulazione di Classe della terza prova
Obiettivi raggiunti:
Gli obiettivi prefissati sono stati in parte raggiunti e la maggior parte degli studenti si orienta con buona facilità nel percorso storico studiato, riuscendo a effettuare collegamenti fra i diversi eventi storici, a comprenderne le cause e le conseguenze nei vari ambiti (sociale, culturale economico e politico). In generale si può comunque affermare che la classe riesce a presentare le conoscenze acquisite in forme espressive semplici e a comprendere i fatti e i problemi studiati. Gli alunni hanno dimostrato poi di saper cogliere il dato cronologico sia nella sua memorizzazione più banale che nel contesto più generale. Da un punto di vista espressivo rimangono chiaramente delle diversità dovute anche alla maggiore competenza lessicale e sintattica, con i conseguenti riflessi anche sullo scritto.
Docente della materia Prof. Lucia Luperini
17
SCHEDA MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE/I: Prof. Orazio Caruso
Classe 5BSA A.S. 2017-18 Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
Kant: Scritti precritici. La fondazione del sapere. La morale del dovere. Il giudizio estetico e il giudizio teleologico. La religione.
Ore 9
Il movimento romantico e la filosofia idealista.
Ore 3
Hegel: gli scritti giovanili; i presupposti della filosofia hegeliana; l’autocoscienza e il sapere; la
Fenomenologia dello spirito; la filosofia come sistema; la filosofia della storia
Ore 13
Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione; La metafisica di Schopenhauer: la Volonta; La liberazione dalla Volontà.
Ore 6
18
Kierkegaard: L‘esistenza e il Singolo; dall’angoscia alla fede.
Ore 4
La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx: Destra e Sinistra hegeliane; Feuerbach: la filosofia come antropologia; Marx e la concezione materialistica della storia;
Ore 9
Nietzsche: la demistificazione della conoscenza e della morale; L’annuncio di Zarathustra; Il nichilismo; La volontà di potenza; Nietzsche e la cultura del Novecento.
Ore 6
Scienza e Filosofia: Russell: Logica matematica e impegno politico; Popper: una nuova definizione di scienza; l’epistemologia post-popperiana.
Ore 4
Filosofia, storia e scienze umane: Freud e la psicoanalisi.
Ore 4
Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame.
19
Libro di testo adottato:
Enzo Ruffaldi, Piero Carelli IL PENSIERO PLURALE Vol.2: L’Età Moderna Loescher - Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola IL PENSIERO PLURALE Vol.3: L’Ottocento Loescher - Enzo Ruffaldi, Gian Paolo Terravecchia, Andrea Sani IL PENSIERO PLURALE Vol.4: Il Novecento Loescher
Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Lezione frontale, partecipata; spiegazione e approfondimento degli aspetti più problematici e complessi; lettura e discussione. Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
E’ stato privilegiato l’atteggiamento costruttivo, l’impegno e la continuità nella partecipazione e nello studio. La partecipazione e l’interesse alle discussioni, la capacità di analisi, il possesso e l’uso fluente del un linguaggio tecnico della disciplina e il livello dei contributi personali offerti.
Obiettivi raggiunti: In generale gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: analizzare in maniera più o meno approfondita e pertinente le principali problematiche filosofiche ed effettuare collegamenti e raffronti.
In particolare sono in grado di: a) individuare in autori diversi la presenza di uno stesso problema cogliendo differenze e analogie; b) individuare nelle diverse opere di uno stesso autore lo sviluppo logico del suo pensiero; c) Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi che appartengono ai diversi autori e periodi storici; d) individuare ed analizzare alcuni tra i più significativi problemi della realtà contemporanea; e) confrontare e contestualizzare le diverse risposte date dai filosofi e dai più significativi approcci, alla soluzione di uno stesso problema.
Docente/i della materia
Prof. Orazio Caruso
20
SCHEDA MATERIA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: GRECO PAOLA MARIA Classe di concorso 050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
Si dedica una parte delle ore (anche nel periodo novembre-dicembre) ad un
opportuno ripasso di argomenti svolti negli anni precedenti sia di Biologia che
di Scienze della Terra. Per Biologia si torna su cellula, ciclo cellulare e
processo meiotico. Per Scienze della Terra si ripassano i minerali e le rocce
(argomenti affrontati in quarta).
Si parte, quindi, con il programma della classe quinta.
Biologia: Le basi molecolari dell’ereditarietà. Il “fattore di trasformazione” di
Griffith. L’esperimento di Avery. Gli esperimenti di Hershey e Chase. La
composizione chimica e la struttura del DNA. Il modello a doppia elica di
Watson e Crick. Gli studi di Wilkins e Franklin come importante contributo per
comprendere la struttura del DNA.
La duplicazione del DNA: il complesso proteico di duplicazione e importanza
della DNA-polimerasi. I telomeri.
AULA
SETTEMBRE
OTTOBRE
Biologia: La costruzione delle proteine. Il dogma centrale della biologia
molecolare: la trascrizione e la traduzione. Le tappe della trascrizione. Il codice
genetico. Le tappe della traduzione. Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e
genomiche. Le mutazioni come materia prima dell’evoluzione.
La regolazione genica nei virus. La struttura dei virus. Le modalità di
riproduzione dei fagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA: il virus
dell’influenza e l’HIV.
Scienze della Terra: I fenomeni vulcanici.
L’attività vulcanica e i magmi. La forma di un edificio vulcanico: vulcani “a
cono” e vulcani “a scudo”. I diversi tipi di eruzione (in funzione del tipo di
magma): eruzioni di tipo hawaiano e di tipo islandese; eruzioni di tipo
stromboliano; eruzioni di tipo vulcaniano, pliniano e pelèeano. I prodotti
dell’attività vulcanica. Gas, lave e piroclastiti. Lahar. Manifestazioni tardive.
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. La distribuzione geografica dei
AULA
NOVEMBRE
DICEMBRE
21
vulcani. Il rischio vulcanico.
Biologia: Biologia sistematica e filogenetica. Importanza delle strutture
omologhe per risalire a relazioni filogenetiche. Strutture analoghe ed
evoluzione convergente. Classificazione degli organismi in base alla filogenesi.
Sistema di nomenclatura binomia ideato da Linneo. Le categorie sistematiche.
Regni e domini.
La ricombinazione genica nei procarioti: ricombinazione per trasformazione.
Ricombinazione per trasduzione (generalizzata e specializzata). La
coniugazione e i plasmidi (fattori di fertilità, plasmidi metabolici e fattori di
resistenza). L’antibiotico-resistenza. I trasposoni.
AULA
DICEMBRE
GENNAIO
Biologia.
La regolazione genica nei procarioti: operoni ed espressione genica. Operone
lac come esempio di sistema inducibile. Operone trp come esempio di sistema
reprimibile.
La regolazione genica negli eucarioti: le caratteristiche del genoma eucariotico
a confronto con il genoma dei procarioti. Junk-DNA e suo significato evolutivo.
Epigenoma e sua importanza in relazione all'espressione genica.
Le sequenze ripetitive dei genomi eucariotici. I geni interrotti. Maturazione del
pre-mRNA. Il processo di splicing. Le famiglie geniche e la loro importanza per
l’evoluzione e per la specializzazione cellulare.
La regolazione genica prima della trascrizione: il rimodellamento della
cromatina. Eucromatina ed eterocromatina (costitutiva e facoltativa).
Regolazione pretrascrizionale agente sull’intero cromosoma: il “corpo di Barr”.
Il mosaicismo cellulare.
La regolazione genica durante la trascrizione. La trascrizione differenziale. I
fattori di trascrizione e le sequenze regolatrici. L’amplificazione genica. Lo
splicing alternativo. Un esempio di regolazione genica dopo la traduzione:
controllo dell’attività e della longevità di una proteina. Il proteasoma.
Scienze della Terra. La giacitura e le deformazioni delle rocce.
Elementi di stratigrafia. La formazione geologica e lo strato. Le facies
sedimentarie: facies continentali, marine e di transizione.
I principi della Stratigrafia: principio di orizzontalità originaria, principio di
sovrapposizione stratigrafica, principio di intersezione.
Elementi di Tettonica. Come si deformano le rocce. Limite di elasticità e carico
di rottura. Le faglie: dirette, inverse, trascorrenti; fosse tettoniche e pilastri
tettonici. Le pieghe: anticlinali e sinclinali; sovrascorrimenti e falde di
ricoprimento. Trasgressioni e regressioni del mare. Le lacune di
AULA
FEBBRAIO
MARZO
22
sedimentazione. Il ciclo geologico o di Hutton.
Biologia: Le biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di
restrizione. La reazione a catena della polimerasi (PCR). Separazione dei
frammenti di DNA mediante elettroforesi su gel. Impronta genetica (genetic
fingerprinting o DNA profiling). La clonazione. I vettori che introducono nuovo
DNA nelle cellule ospiti. Le genoteche e il DNA sintetico.
Scienze della Terra: I fenomeni sismici.
Natura e origine del terremoto. Modello del “rimbalzo elastico”. Il ciclo sismico.
Propagazione e registrazione delle onde sismiche. I diversi tipi di onde
sismiche: le onde longitudinali, le onde trasversali, le onde superficiali.
I sismografi e la lettura dei sismogrammi. Localizzazione dell’epicentro di un
terremoto.
La “forza” di un terremoto. Le scale di intensità del terremoto. La magnitudo di
un terremoto. Magnitudo e intensità a confronto.
Gli effetti del terremoto: i danni agli edifici, gli tsunami. I terremoti e l’interno
della Terra. Distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. La
previsione deterministica e la previsione statistica. La prevenzione del rischio
sismico.
AULA
APRILE
MAGGIO (*)
Scienze della Terra: Struttura interna della Terra. Il flusso termico e la
temperatura interna della Terra. La geoterma e il gradiente geotermico.
Caratteristiche del campo magnetico terrestre e cenni sulla sua origine. Il
paleomagnetismo.
La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Il fenomeno
dell’isostasia. La teoria della “deriva dei continenti” di Wegener. L’espansione
dei fondali oceanici.
Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. Espansione e subduzione. Anomalie
magnetiche sui fondali oceanici.
Un modello “globale”: la Tettonica delle placche. Le placche litosferiche.
L’orogenesi (crosta oceanica in subduzione sotto un margine continentale,
collisione continentale, accrescimento crostale, crosta oceanica sotto crosta
oceanica). Il ciclo di Wilson.
Lettura del vulcanismo e della sismicità alla luce della “teoria della tettonica
delle placche”.
Un possibile motore per la tettonica delle placche: moti convettivi e punti caldi
AULA
MAGGIO(*)
GIUGNO (*)
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
23
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.
Libri di testo adottati:
--- D. Sadava, H. C. Heller, G. H. Orians, W. K. Purves, D. M. Hillis-
Biologia-La scienza della vita - La cellula (A) – L’ereditarietà e l’evoluzione (B) - Zanichelli
--- E. Lupia Palmieri, M. Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione Edizione Blu- Zanichelli
Mezzi e metodologie didattiche adottate:
E necessario fare una breve premessa che riguarda l’insegnamento di Scienze Naturali nel Liceo
Scientifico delle Scienze Applicate nella nostra scuola. Per decisione del Collegio dei Docenti,
dall’anno scolastico 2013/2014 le classi prime, seconde e quinte sono affidate a docenti della classe
di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), mentre le classi terze e quarte sono
affidate alla classe di concorso A034 (Scienze e tecnologie chimiche). In tal modo le alunne e gli
alunni hanno la possibilità di affrontare i vari argomenti di studio avendo come riferimento diversi
approcci metodologici. Riteniamo che ciò costituisca un arricchimento per i ragazzi.
Purtroppo non ho seguito questa classe nel biennio ma solo per questo ultimo anno del corso. Ciò ha
posto gli alunni nella difficoltà di doversi adattare in quinta ad un nuovo docente con le sue proprie
metodologie. Nonostante ciò gli alunni, pur non possedendo tutti analoghe potenzialità, hanno
dimostrato una buona disponibilità e, di conseguenza, l'intesa nel dialogo culturale è apparsa
generalmente accettabile.
Devo, inoltre, fare presente che la programmazione iniziale della disciplina ha dovuto subire dei tagli,
a causa della riduzione di ore effettivamente svolte, soprattutto nell’ultima parte di Biologia dove
sarebbe stato opportuno approfondire le Biotecnologie. Ciò è stato causato da una assenza per
malattia del docente (di circa tre settimane); si aggiunge a ciò il fatto che la classe è stata coinvolta in
attività extracurricolari o in altri impegni, sempre dovuti alla normale attività didattica, che purtroppo (e
per caso) hanno spesso coinvolto la mia disciplina.
Le metodologie utilizzate nell' attività didattica sono state del tipo lezioni frontali e guidate. Inoltre le
lezioni hanno goduto di un ampia trattazione in classe, seguita da discussione con gli alunni. Per
quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale, la
chiarezza e la coerenza del discorso, nonché il possesso dei lessici della terminologia specifici .
Anche i contributi audiovisivi sono stati utili per stimolare il dibattito sulla dinamicità delle conoscenze
scientifiche e far prendere consapevolezza ai ragazzi dell’importanza dell’aggiornamento in campo
scientifico.
Gli interventi di recupero sono stati effettuati direttamente durante le ore di lezione e hanno mirato
prevalentemente all’acquisizione corretta dei contenuti ed all’uso di un lessico adeguato.
24
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Per quanto riguarda le verifiche, oltre a rapidi giri di domande per verificare la reale comprensione
degli argomenti e nello stesso tempo valutare la regolarità dell’impegno da parte degli alunni, hanno
assunto particolare rilievo anche le interrogazioni orali nelle quali è stata valutata, oltre alla
conoscenza degli argomenti, anche la correttezza dell’esposizione orale ed il possesso della
terminologia specifica della disciplina. Le verifiche scritte sono state soprattutto a risposte aperte
(trattazioni sintetiche e quesiti a risposta singola) in prospettiva della 3° prova di esame.
Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di
comprensione essenziale sia delle lezioni frontali sia di testi scritti di vario tipo e sulle conoscenze
generali dell’argomento trattato. Sono comunque stati valutati l’impegno, la partecipazione e il lavoro
svolto a casa.
Obiettivi raggiunti:
La classe da me seguita appare abbastanza affiatata e vi sono alcuni elementi dalle buone
capacità. Purtroppo, non tutti gli allievi hanno dimostrato il medesimo interesse per gli argomenti
da me trattati. Per questo motivo alcuni allievi, pur dotati di discrete capacità, hanno ottenuto dei
risultati non molto lontani dalla sufficienza, risultati che sarebbero potuti essere indubbiamente
migliori con un più intenso impegno scolastico. Di conseguenza, i risultati sono stati diversi da
allievo ad allievo, sia sul piano della qualità della elaborazione personale che su quello della
ampiezza della preparazione. Così, accanto a profitti di ottimo e buon livello, vi sono rendimenti
discreti e altri pienamente o non del tutto sufficienti.
Docente della materia
Prof.ssa Paola Maria Greco
25
SCHEDA MATERIA: Matematica
DOCENTE: Angela Castellacci
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
LIMITI E CONTINUITA’ Studiare il comportamento di una funzione nell’intorno di un punto finito o infinito e classificarla dal punto di vista della continuità. Limiti Limite finito per una funzione in un punto Limite infinito per una funzione in un punto Limite destro e sinistro di una funzione Limite finito o infinito di una funzione all’infinito Teorema della permanenza del segno.(con dimostrazione) Teorema dell’unicità del limite.(con dimostrazione) Teorema del confronto. (con dimostrazione) Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Continuità Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo Continuità delle funzioni elementari.
Calcolo dei limiti. Due limiti fondamentali :
1lim0
x
senx
x (con dimostr.) e
ex
x
x
11lim
Teorema di Weierstrass, dei valori intermedi (Darboux), dell’esistenza degli zeri (solo enunciati) Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie Asintoti : orizzontali, verticali e obliqui.
Aula
Ore 25
DERIVATE E PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO Conoscere la definizione di derivata, il suo significato geometrico e fisico. Conoscere le regole di derivazione ed i teoremi sulle funzioni derivabili. Formalizzare e risolvere semplici problemi di massimo e di minimo. Saper determinare le soluzioni di una equazione con il metodo grafico. Derivate delle funzioni di una variabile Rapporto incrementale di una funzione. Definizione della derivata di una funzione. Significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità. (con dimostrazione) Derivate delle funzioni elementari Regole di derivazione : somma, prodotto, quoziente ( con dimostrazione) Derivata della funzione inversa . ( senza dimostrazione) Derivata della funzione composta . ( senza dimostrazione)
Aula
Ore 25
26
Derivate di ordine superiore. Teoremi di: FERMAT (con dimostrazione), ROLLE ( con dimostrazione), LAGRANGE ( con dimostrazione). Teorema di DE L’HOPITAL.(senza dimostrazione). Massimi e minimi . Definizione di massimi e di minimi assoluti e relativi Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e di minimi relativi.( con dimostrazione) Studio del massimo e del minimo delle funzioni per mezzo della derivata prima . Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione. Problemi di massimo e di minimo. Concavità , convessità e punti di flesso. Studio della concavità e convessità per mezzo della derivata seconda.
STUDIO DI FUNZIONE Studiare gli elementi caratteristici di una funzione rappresentandola graficamente. Studio di una funzione. Metodo di bisezione e metodo delle tangenti per la determinazione approssimata delle soluzioni di una equazione.
Aula
Ore 25
INTEGRALE INDEFINITO E DEFINITO. IL PROBLEMA DELLA MISURA DI AREE E DI VOLUMI. INTEGRALI IMPROPRI Acquisire il concetto di primitiva di una funzione data ed il concetto di integrale indefinito di una funzione. Saper operare integrazioni immediate e saper applicare le principali regole di integrazione. Acquisire il concetto di integrale definito ed individuare il legame tra primitiva ed integrale definito di una funzione. Saper calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. Integrazione numerica . Saper integrare funzioni non continue su intervalli chiusi e su intervalli non limitati. Calcolo integrale Primitiva ed integrale indefinito. Proprietà degli integrali indefiniti. Integrali indefiniti immediati Integrazione per scomposizione . Integrazione per cambiamento di variabile. Integrazione per parti ( con dimostrazione). Integrazione delle funzioni razionali fratte Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito Primo Teorema fondamentale del calcolo integrale. ( con dimostrazione) Teorema della media ( con dimostrazione) Funzione integrale. Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale(con dimostrazione) Applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree . Applicazione dell’integrale definito al calcolo di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri.
Aula
Ore 25
27
Metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi per la determinazione approssimata del calcolo delle aree.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI Conoscere la definizione di equazione differenziali e il significato di soluzione di una equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. Le equazioni differenziali Conoscere la definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non omogenee.
maggio (*) Aula
Ore 13
ELEMENTI DI PROBABILITA’ Conoscere le variabili aleatorie e discrete. Conoscere le distribuzioni di probabilità. Elementi di probabilità Conoscere le variabili aleatorie discrete e continue. Conoscere le distribuzioni di probabilità: distribuzione di Bernoulli , di Poisson e distribuzione normale o di Gauss.
Aula
Ore 12
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. Libro di testo adottato: Nuova matematica a colori – Volume 5-Autore : Leonardo Sasso- Casa Editrice : Petrini Mezzi e metodologie didattiche adottate: Lezione frontale, lezione dialogata, discussione per problemi. Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: I criteri di valutazione adottati e le prove di verifica sono conformi a quanto stabilito nel piano di lavoro del C.d.C. Obiettivi raggiunti: Nel corso del triennio la classe ha evidenziato disomogeneità di comportamento per quanto riguarda sia l’interesse per la matematica che l’impegno nello studio. Ciò ha determinato un raggiungimento a livelli diversi degli obiettivi propri della disciplina. Un gruppo di alunni ha dimostrato discontinuità nello studio, seguito le lezioni in modo spesso passivo ed ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi della materia. Un altro gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione soddisfacente in termini di conoscenze, ma solo pochi hanno acquisito una capacità di deduzione, di rigore espositivo e di astrazione. C’è poi una fascia di studenti che si è impegnata costantemente nello studio, che conosce sufficientemente gli argomenti trattati, ma che incontra ancora alcune difficoltà nelle prove scritte, nell’esposizione orale e soprattutto nell’utilizzo autonomo e critico dei saperi acquisiti. Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti nel programma iniziale. Sono state effettuate due simulazione della prova di matematica tratte dal sito della Zanichelli.. Docente della materia
Prof. Angela Castellacci
28
SCHEDA MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE: CIANELLI CARLO
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Tempi e spazi
LETTERATURA: THE EDWARDIAN AGE. WORLD WAR 1 REMEMBRANCE DAY, THERE IS NOTHING WORSE THAN WAR (DA HEMINGUAY’S A. FAREWELL TO THE ARMY) WORLD WAR 1 IN ENGLISH PAINTING: DESCRIBING A PAINTING PAUL NASH. MODERN POETRY: TRADITION AND EXPERIMENTATION. THE NIGHTS OF SARAJEVO (SOLO RIASSUNTO). THE WAR POETS. DAL FIRST CERTIFICATE TRAINER- READING AND USE OF ENGLISH RIPASSO GRAMMATICALE
SETTEMBRE/OTTOBRE 17 ORE AULA
THE SOLDIER DI R. BROOKE DULCE ET DECORUM EST DI W. OWEN AUGUST 1914 DI ISAAC ROSENBERG E CONFRONTO CON VEGLIA DI UNGARETTI. T. ELIOT, ELIOT AND THE WASTE LAND. THE OBJECTIVE CORRELATIVE IN ELIOT. THE BURIAL OF THE DEAD PART 1, THE BURIAL OF THE DEAD PART 2. DAL FIRST CERTIFICATE TRAINER-READING AND USE OF ENGLISH. COMPOSIZIONI DI ARTICLES AND ESSAYS. RIPASSO GRAMMATICALE E LISTENING (TIPOLOGIA FIRST C.)
NOVEMBRE/DICEMBRE 24 ORE AULA
DALLA WASTE LAND: THE FIRE SERMON. FREUD AND THE PSYCHE. THE MODERNIST SPIRIT. J. JOYCE’S LIFE ACCENNI ALLA EPIPHANY AND PARALYSIS IN J. JOICE. ULYSSES AND COMPARISON WITH ULYSSES BY OMERO J. JOYCE: THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND THE INTERIOR MONOLOGUE. DALL’ULYSSES: THE FUNERAL, UN BRANO TRATTO DAL MONOLOGO DI MOLLY. LETTURA, COMPRENSIONE E RIASSUNTO DEL TESTO. STYLE AND TECHNIQUE IN J. JOYCE, PARALYSIS AN EPIPHANY: DUBLINERS : EVELINE, GABRIEL’S EPIPHANY
GENNAIO/FEBBRAIO 21 ORE AULA
29
DA (THE DEAD), LETTURE DEI TESTI, COMPRENSIONE E RIASSUNTI IN L2 JOYCE AND SVEVO SOLO LETTURA DI AMALIA E STEFANO- RIPASSO GRAMMATICALE.
WORLD WAR 2 DYSTOPIAN NOVEL VITA E OPERE DI G. ORWELL RIPASSO GRAMMATICALE
MARZO 8 ORE AULA
THE DYSTOPIAN NOVEL, G. ORWELL E 1984 PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO PRINCIPALE: WINSTON SMITH E I TEMI DEL ROMANZO. LETTURA , TRADUZIONE, SPIEGAZIONE E COMMENTI SUL BRANO TRATTO DA 1984 BIG BROTHER IS WATCHING YOU. LETTURA, SPIEGAZIONE E ASPETTI FONDAMENTALI DELLA VITA DI A. HUXLEY. DA FOTOCOPIE: LETTURA DELLE OPERE FONDAMENTALI DI HUXLEY. COMPRENSIONE E SPIEGAZIONE DA FOTOCOPIA DEL TESTO RIGUARDANTE LA DIFFERENZA TRA G. ORWELL E A. HUXLEY SULLA CRITICA AL TOTALITARISMO
APRILE 10 ORE AULA
W. GOLDING AND DYSTOPIAN ALLEGORY: LORD OF FLIES AND A VIEW TO A DEATH . THE THEATRE OF THE ABSURD AND S. BECKETT. WAITING FOR GODOT: THEMES, CHARACTERS, NOTHING TO BE DONE. RIPASSO DI TUTTO IL PROGRAMMA
maggio (*)
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. Libro di testo adottato:
PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 3 — PRACTICE TESTS PLUS 2 + FOTOCOPIE CONSEGNATE DALL’INSEGNANTE
Mezzi e metodologie didattiche adottate: LEZIONI FRONTALI E PARTECIPATE. VERIFICHE SCRITTE FORMATIVE E SOMMATIVE SU COMPOSIZIONI DI ARTICLES, REPORTS, ESSAYS O QUESTIONARI TIPOLOGIA 3^ PROVA DI ESAME VERIFICHE ORALI ESCLUSIVAMENTE IN L2, LISTENING, LETTURE DI TESTI IN CLASSE E A CASA COMMENTATI E RIASSUNTI IN L2. RIFERIMENTI A STRUTTURE GRAMMATICALI ESTRAPOLATE DALLE LETTURE
30
STESSE. Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
GLI STUDENTI, A LIVELLO ORALE SONO STATI SEMPRE VALUTATI TENENDO CONTO DELLA VELOCITA’, DELLA CORRETTEZZA GRAMMATICALE E DELL’UTILIZZO DEL LESSICO ACQUISITO NEL QUINQUENNIO. NELLE VERIFICHE SCRITTE SI E’ ANCHE TENUTO CONTO DELLA COESIONE DEI TESTI OLTRE AL CONTENUTO, AL LESSICO E ALLE STRUTTURE.
Obiettivi raggiunti:
GLI ALUNNI SIN DAL PRIMO ANNO HANNO SEMPRE EVIDENZIATO, ANCHE SE A LIVELLI DIVERSIFICATI, NOTEVOLI LACUNE SIA A LIVELLO LESSICALE CHE GRAMMATICALE, E’ STATO FATTO IL POSSIBILE PER RECUPERARE E POTER PROSEGUIRE NEL PERCORSO SCOLASTICO. SE ESCLUDIAMO DUE ALUNNI, ZANOBINI E MORELLI CHE HANNO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE PET PRIMA E IL FIRST L’ANNO SCORSO, E POCHI ALTRI ALUNNI, IL RESTO DELLA CLASSE NONOSTANTE LE DEFICIENZE STRUTTURALI E LESSICALI HA EVIDENZIATO UNO STUDIO COSTANTE ANCHE SE A VOLTE PIUTTOSTO MNEMONICO.
Docente/i della materia Prof. CIANELLI CARLO
31
SCHEDA MATERIA: DISEGNO – STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: TOGNARELLI SERGIO
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
ARTE: Caratteri generali del postimpressionismo, Cezanne, Gauguin, Van Gogh
Aula Settembre
DISEGNO: Teoria delle ombre, ombra propria e portata, linea separatrice. Le ombre nelle proiezioni ortogonali. Ombre di figure piane nelle proiezioni ortogonali
Aula Ottobre
ARTE: Belle Epoque, Art Noveau Secessione Viennese, Klimt I Fauves; Matisse L'espressionismo; Munch
Aula Novembre
DISEGNO: Ombre di figure piane nelle proiezioni ortogonali Aula Dicembre
ARTE: Cubismo Picasso Aula Gennaio
ARTE: Il Futurismo, Marinetti; Boccioni, L'architettura di Sant'Elia; Balla Aula Febbraio
DISEGNO: Ombre di solidi nelle proiezioni ortogonali ARTE: L’Aereopittura, Prampolini, Dottori
Aula Marzo
DISEGNO: Le ombre di solidi nella assonometria e nella prospettiva ARTE: Il Dadaismo, Arp, Duchamp, Ray Il Surrealismo e i suoi principali interpreti: Max Ernst, Mirò, René Magritte, Dalì
Aula Aprile
ARTE: L’astrattismo Kandiski, Klee Razionalismo in architettura, Le Bauhaus, Le Corbusier, Wright, Michelucci
Aula Maggio (*)
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. Libro di testo adottato: CRICCO DI TEODORO “Itinerario nell’arte – Dal Barocco al Postimpressionismo” versione arancione – Ed.
ZANICHELLI
32
CRICCO DI TEODORO “Itinerario nell’arte – Dall’Art Noveau ai giorni nostri” versione arancione – Ed.
ZANICHELLI
R. SECCHI – V. VALERI “Disegno 2” – Ed. LA NUOVA ITALIA
Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Lezione frontale partecipata, discussione con utilizzo di DVD
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Per la valutazione di ciascun alunno sono state utilizzate tavole grafiche di Disegno verifiche orali e scritte per storia dell’Arte. Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità di espressione mediamente corretta, sul livello di comprensione degli elementi fondamentali della materia sia per la parte grafica che quella orale. Sono stati comunque valutati anche l'impegno, la partecipazione, il lavoro autonomo.
Obiettivi raggiunti:
In generale gli studenti conoscono sufficientemente gli elementi caratterizzanti i movimenti artistici affrontati questo anno e sono in grado di ritrovare alcuni collegamenti con quelli degli anni precedenti. La maggioranza di loro è in grado di organizzare ed esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio sufficientemente adeguato alla materia,
Docente della materia Prof. Sergio Tognarelli
33
SCHEDA MATERIA: FISICA
DOCENTE: Ranfone Stefano
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
Ripasso degli argomenti di Elettrostatica svolti nell’anno precedente: Principi fondamentali: conserv. Carica elettr., teo. Gauss, conservatività di E; 1° eq. di Maxwell; il dipolo elettrico e azione di un campo elettrico su di esso; capacità e condensatori; Conduzione elettrica e circuiti elettrici in corrente continua: Leggi di Kirchhoff;
Settembre
Carica e scarica di un condensatore: circuiti RC (mathematical Box sulle eq. differenziali lineari del 1° ordine)
Ottobre
Campo Magnetico: Proprietà e Principi fondamentali: 2° eq. di Maxwell; legge di Biot-Savart e azione di un campo magnetico su una carica in movimento o una corrente elettrica: Forza di Lorentz. Teo. Ampere e legge di Laplace. Momento magnetico. Corrente di spostamento e completamento teorema di Ampere: 3° eq. di Maxwell.
Novembre
Leggi di Faraday-Lenz e Felici: Induzione elettromagnetica e 4° eq. di Maxwell; circuiti RL e RLC; circuiti in Corrente Alternata (metodo dei fasori); Set completo di Equazioni di Maxwell; Moto di conduttori in campi magnetici: esempi e applicazioni. Equazioni di Maxwell nel vuoto e loro soluzione: Onde Elettromagnetiche e loro caratteristiche
Dicembre-Gennaio-Febbraio
Teoria della Relatività Ristretta: postulati e trasformazioni di Lorentz. Lo spaziotempo di Minkowski: sua geometria pseudo-euclidea (Lorentziana) e interpretazione “grafica” delle stesse trasf. Di Lorentz; dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze. Invarianti relativistici e quadrivettori. Elementi di Dinamica relativistica. Quadrimpulso di una particella. Decadimento Radioattivo e sue leggi. Cinematica relativistica nei processi di scattering e decadimento di particelle: massa invariante; esempi e applicazioni.
Marzo-Aprile
Fisica Quantistica: Teoria dei Quanti: Teoria di Planck per la Radiazione di Corpo Nero (cenni); calore specifico dei solidi e leggedi Dulong-Petit; Modelli atomici di Thompson, Rutherford e Bohr; Righe spettrali per l’atomo di idrogeno e loro interpretazione. Effetto fotoelettrico e Compton; Meccanica Quantistica: dualismo onda-corpuscolo e onde di De-Broglie; eq. di Schroedinger (cenni): particelle in una scatola, buca e barriera di potenziale: effetto tunnel
Aprile-Maggio(*)
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. Libri di testo adottati:
D. Halliday e R. Resnick: “Fondamenti di Fisica: Elettromagnetismo” (Zanichelli, Bologna);
S. Ranfone: “Complementi di Fisica” (ETS, Pisa (2016);
Dispense del Docente: S. Ranfone: “Complementi di Analisi Matematica” (www.stefano-ranfone.it;
34
www.academia.edu).
Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Lezioni Frontali (teorico-formali), supportate da innumerevoli esercizi-esempio svolti in classe
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: Per la valutazione si sono sfruttate un certo numero di prove “sommative” (compiti scritti, contenenti un certo numero di “problemi”), completate da eventuali “Compitini” (prove “formative”, contenenti “domande teoriche aperte”). Obiettivi raggiunti: La classe, purtroppo, ha raramente mostrato un adeguato interesse per gli argomenti svolti, ed ha acquisito solo parzialmente una certa dimestichezza nell’analisi di problematiche scientifiche, anche per le difficoltà incontrate nell’utilizzo di strumenti matematici relativamente avanzati; in particolare per alcuni studenti (circa il 20%) le carenze potrebbero essere attribuite a una scarsa predisposizione verso discipline nelle quali una buona capacità di “ragionamento logico” e “formale” sono necessarie. Per un altro 20% invece, le difficoltà incontrate sono attribuibili essenzialmente ad un non sempre adeguato impegno e studio, ingredienti fondamentali per poter affrontare problemi più complessi. Solo un 15% degli studenti può considerarsi adeguatamente preparato nella presente disciplina.
Docente della materia Prof. Ranfone Stefano
35
SCHEDA MATERIA: INFORMATICA
DOCENTE: Susanna Andronico
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
Archiviazione Dati. Caratteristiche fondamentali della archiviazione dei dati e delle informazioni; importanza della conservazione e gestione dati per una organizzazione/azienda. Definizione di archivio, record, campo. Operazioni tipiche sugli archivi: inserimento, manipolazione (modifica, cancellazione), ricerche, elaborazione. Limiti dell’archivizione tradizionale, flat, senza integrazione tra archivi separati, sia su supporto cartaceo che digitale; superamento dei limiti con teoria dei database. Sistema informativo aziendale e sistema informatico. Progettazione Database (DB). Caratteristiche e proprietà DB: sicurezza, privatezza, consistenza, accessi concorrenti, viste utenti, operatori/ruoli diversi. Fasi di progettazione DB: analisi, modellazione concettuale, logica, fisica.
settembre-ottobre aula e laboratorio
Analisi e Modellazione Concettuale. Analisi del problema reale e sua rappresentazione con il modello Entity/Relantionship. Definizione di schema E/R, entità, istanza di entità, associazione e sue proprietà: cardinalità 1:1, 1:N,N:M, ricorsiva, esistenza (obbligatoria/opzionale) , grado (unaria, binaria, multipla), direzione; attributo di entità e di associazione, attributo chiave. Regole di lettura dello schema E/R.
ottobre-novembre aula
Modellazione logica. Regole di derivazione da schema E/R a schema logico relazionale di: entità, associazioni, attributi di entità e associazioni. Definizione di chiave primaria semplice, composta, chiave esterna, relazione, grado e cardinalità di una relazione, record, istanza di relazione e istanza di schema logico relazionale. Mapping tra schemi E/R e schemi logici. L’algebra relazionale: gli operatori relazionali di selezione, proiezione, prodotto cartesiano, congiunzione, esempi di join destro e sinistro. Interrogazione di database con gli operatori relazionali. Regole di integrità referenziale in inserimento, cancellazione, modifica. Definizione di normalizzazione: 1FN, 2FN,3FN.
novembre-gennaio aula
Modellazione fisica. Il software per l’implementazione di database relazionali: RDBMS OpenOffice.org Base. Creazione di tabelle con vincoli di chiave, creazione di relazioni e impostazione delle clausole di integrità referenziale, popolazione delle tabelle. Impostazione di interrogazioni su una o più tabelle tramite QBE. Il linguaggio SQL: DDL, DCL e DML. QL: il comando SELECT... FROM... WHERE...Definizione di query in SQL: proiezione, selezione, congiunzione di due /tre tabelle, ridenominazione; impostazione di semplici query sia in QBE che in SQL; esempi di query con funzioni di aggregazione, di raggruppamento e di ordinamento in QBE. Implementazione Database relazionale. Realizzazione di un progetto individuale per l’implementazione di un database relazionale, dall’analisi della situazione reale alla definizione del DB e all’impostazione di semplici query.
febbraio-aprile aula e laboratorio
36
Reti di computer. Caratteristiche e principi fondanti delle reti di calcolatori e internet: Commutazione di pacchetto, modello ISO/OSI, strati e protocolli, indirizzo fisico e logico. Classificazione di reti, modello client-server, peer to peer. I principali servizi web, web 2.0, cloud computing, internet mobile e IoT. Problematiche e soluzioni relative alla sicurezza in rete: firewall, virus/antivirus, phishing. Cenni ai BIG DATA. Intelligenza Artificiale. Cenni di robotica, bioinformatica.
aprile-maggio (*) aula, laboratorio, seminari, visite
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame.
Libro di testo adottato: A.LORENZI M.GOVONI – “INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE per il Liceo Scientifico delle Scienze applicate” – ATLAS Materiale integrativo predisposto dalla docente.
Mezzi e metodologie didattiche adottate: Nella realizzazione degli obiettivi della disciplina, quali il problem solving e la rappresentazione e l’elaborazione dei dati, abbiamo lavorato principalmente su: a) l’analisi di problemi reali; b) la conoscenza e l’uso degli strumenti e dei linguaggi specifici di rappresentazione di dati, informazioni, processi. Le metodologie più comunemente utilizzate sono state la lezione frontale partecipata, gli esercizi di analisi e soluzione di situazioni problematiche sia individualmente che in piccoli gruppi, il software di presentazione e di settore, la piattaforma moodle e internet; in alcuni casi sono stati utilizzati strumenti audiovisivi (cinema,ecc), seminari di esperti, visite a laboratori. A conclusione del percorso di progettazione del database i ragazzi hanno lavorato individualmente o in gruppo per l’implementazione di un database relazionale, dall’analisi della situazione reale alla definizione del DB e all’impostazione di semplici query.
Per quanto riguarda l’esposizione orale, scritta e pratica si è cercato di rafforzare l’utilizzo dei linguaggi tecnici e dei formalismi della disciplina, ed in special modo la coerenza tra l’analisi di situazioni problematiche e la loro rappresentazione.
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di comprensione essenziale e conoscenze generali degli argomenti trattati, sulla abilità di codifica con i linguaggi specifici studiati. Sono stati anche valutati l’impegno, la partecipazione, il lavoro svolto a casa e in laboratorio. Sono stati comunque utilizzati i criteri di valutazione accettati nel nostro istituto. Per la valutazione della simulazione della terza prova si sono usati i criteri specifici allegati al presente Documento.
Obiettivi raggiunti:
La classe ha lavorato con me in continuità didattica per tutto il triennio. Fin dai primi giorni ho potuto contare sulla volontà di migliorarsi e la serietà dell’impegno della maggioranza della classe per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ad oggi la grande maggioranza degli studenti è in grado di analizzare semplici problemi e di rappresentarli operando con discreta abilità con i linguaggi specifici della disciplina. Tra questi alcuni elementi hanno raggiunto ottimi livelli di competenza sia teorica che pratica. Rimane solo un piccolo gruppo di alunni per i quali persiste una certa fragilità.
Docente della materia Prof. ssa Susanna Andronico
37
SCHEDA MATERIA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Carlo Pellegrini
Attività svolta:
Contenuti disciplinari Tempi e spazi
Potenziamento organico e mobilità articolare
- Esercizi di mobilità articolare per il cingolo scapolo-omerale, coxo-femorale e per il rachide - Esercizi di stretching
Palazzetto dello sport. 18 ore
Rielaborazione degli schemi motori di base
-Studio del salto della funicella.
-Esercizi con scaletta di coordinazione
. Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla, rotolamenti sul piano sagittale frontale ed esercizi propedeutici alla capovolta a corpo libero implicanti un rapporto non abituale tra spazio e corpo (quadrupedie, capovolte, esercizi di tenuta-Verticali-volteggi alla cavallina-alla sbarra).
Palazzetto dello sport, Stadio Comunale. 20 ore
Conoscenza pratica dell’attività sportiva
GIOCHI SPORTIVI - Badminton: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra - Pallavolo:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra - Pallacanestro:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra - Calcetto:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra - Pallatamburello: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra ATLETICA - Resistenza: corsa continua uniforme, con cambio di ritmo,. intervallata.Metedov delle ripetute Test di Cooper. -Pattinaggio su ghiaccio: affinamento e studio dei fondamentali -Avviamento al Crossfit - Ostacoli, tecnica di valicamento degli ostacoli. - La preparazione atletica del non vedente, esercizi in assenza di campo visivo da soli e con guida.
Palazzetto dello sport, stadio comunale (pista di atletica), attività in ambiente naturale: parco dei salici
28 ore
Elementi di primo soccorso. Doping. Fondamentali e regolamenti di uno sport di squadra. Terminologia: termini tecnici delle principali attività svolte.
Palazzetto dello sport, stadio comunale
4 ore
Libro di testo adottato:
Appunti ,Fotocopie ,siti internet, film
Mezzi e metodologie didattiche adottate:
38
Lezioni frontali con difficoltà variata
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione diversi parametri sulla base degli obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative verificato tramite test motori specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è stato raggiunto per poter passare al successivo; Le competenze acquisite relative al gesto atletico e sportivo verificate attraverso esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, le conoscenze principali degli apparati cardio-circolatorio e scheletrico, nozioni di pronto soccorso. Valutazione del miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il grado di socializzazione raggiunto. Obiettivi raggiunti: : Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo in buone condizioni il sistema organico ( Cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle proprie caratteristiche fisiologiche e potenzialità.
- Presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente - Formazione di una personalità equilibrata e stabile - Hanno aumentato la fiducia in se stessi - Hanno migliorato la socializzazione e la collaborazione reciproca - Sviluppato la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri - Favorire l’acquisizione del senso della responsabilità - Hanno acquisito la cultura delle attività di moto che tendono a promuovere una pratica motoria
come attività di vita
Pontedera 7/5/2018
Docente/i della materia Prof. Carlo Pellegrini
39
SCHEDA MATERIA: RELIGIONE
DOCENTE: PAOLI MARZIO
Contenuti disciplinari Spazi e tempi
Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo
Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: introduzione Un mese e mezzo
Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: giudizio motivato su alcune questioni particolari
Due mesi e mezzo
Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la famiglia, del lavoro e dell’impegno per la promozione dell’uomo
Un mese e mezzo
Libro di testo adottato: PAJER F. “RELIGIONE” NUOVA EDIZIONE
Mezzi e metodologie didattiche adottate: Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo Libro di testo, fotocopie, audiovisivi Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: Valutazione interesse e partecipazione Valutazione appunti Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo alunno Obiettivi raggiunti: Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana.
Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla cultura e sulla
vita individuale e sociale.
Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero cattolico su
tematiche particolari della morale della vita fisica
Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo a
partire da problematiche significative per la vita del giovane e della società
Docente della materia
40
Prof. Paoli Marzio
Criteri utilizzati nella correzione e nella valutazione delle simulazioni
PRIMA PROVA SCRITTA Tipologia A
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana
L’elaborato è corretto e appropriato nell’uso della lingua.
20
L’elaborato è sostanzialmente corretto. 16
L’elaborato presenta lievi errori morfosintattici e/o lessicali
12
L’elaborato presenta errori morfosintattici e/o lessicali
8
Risposta alle richieste e alle Indicazioni della traccia
La risposta è completa ed esauriente 30
La risposta soddisfa le richieste in modo sostanzialmente adeguato
24
La risposta è superficiale, ma pertinente alle richieste
18
La risposta non è né pertinente né adeguata alle richieste
12
Capacità di analisi e possesso dei relativi strumenti tecnici
L’elaborato svolge un’analisi accurata e approfondita mediante un appropriato uso degli strumenti tecnici
30
L’elaborato svolge un’analisi coerente mediante un appropriato uso degli strumenti tecnici
24
L’elaborato svolge un’analisi superficiale ma accettabile
18
L’elaborato svolge un’analisi generica e approssimativa
12
Esame del significato fino ad arrivare ad una interpretazione contestualizzata
L’esame del significato è approfondito,ricco di opportuni collegamenti e consapevolmente contestualizzato
20
L’esame del significato del testo è ampio e adeguatamente contestualizzato
16
L’esame del significato è accettabile ma parzialmente contestualizzato
12
L’esame del significato è limitato e non contestualizzato
8
PUNTEGGIO TOTALE /100
*Per ciascun descrittore viene indicato il punteggio maggiore per ciascuna fascia
41
Tipologia B
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana
L’elaborato è corretto e appropriato nell’uso della lingua.
20
L’elaborato è sostanzialmente corretto. 16
L’elaborato presenta lievi errori morfosintattici e/o lessicali
12
L’elaborato presenta errori morfosintattici e/o lessicali
8
Capacità di avvalersi in modo esatto del materiale proposto
Il materiale proposto è rielaborato in modo approfondito e appropriato
30
Il materiale proposto è rielaborato in modo adeguato e corretto
24
Il materiale proposto è rielaborato in modo generico ma pertinente
18
Il materiale proposto è rielaborato in modo approssimativo e non pertinente
12
Capacità di organizzare il testo in modo organico e coerente
Il testo è organizzato in modo del tutto logico e coerente
30
Il testo è organizzato con soddisfacente coerenza
24
Il testo è organizzato in forma non del tutto coerente
18
Il testo è costruito in modo disorganico e confuso
12
Capacità di far emergere il proprio punto di vista
L’elaborato presenta un taglio critico e originale
20
L’elaborato sviluppa una interpretazione personale dell’argomento
16
L’elaborato sviluppa gli argomenti senza particolari approfondimenti critici
12
L’elaborato si limita a parafrasare i testi proposti
8
PUNTEGGIO TOTALE /100
*Per ciascun descrittore viene indicato il punteggio maggiore per ciascuna fascia
42
Tipologia C e D
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana
L’elaborato è corretto e appropriato nell’uso della lingua.
20
L’elaborato è sostanzialmente corretto. 16
L’elaborato presenta lievi errori morfosintattici e/o lessicali
12
L’elaborato presenta errori morfosintattici e/o lessicali
8
Pertinenza alla traccia
L’elaborato sviluppa e approfondisce tutti gli aspetti della traccia
30
L’elaborato individua e sviluppa in modo soddisfacente la traccia
24
L’elaborato individua e sviluppa in modo superficiale la traccia
18
L’elaborato non è pertinente alla traccia
12
Capacità di organizzare il testo in modo organico e coerente
Il testo è organizzato in modo del tutto logico e coerente
30
Il testo è organizzato con soddisfacente coerenza
24
Il testo è organizzato in forma non del tutto coerente
18
Il testo è costruito in modo disorganico e confuso
12
Capacità di giudizio critico
Gli argomenti sono rielaborati in modo da sviluppare idee personali e originali
20
Gli argomenti sono rielaborati in modo consapevole
16
Gli argomenti sono svolti senza particolari approfondimenti critici
12
Gli argomenti sono svolti senza alcuna rielaborazione personale
8
PUNTEGGIO TOTALE /100
*Per ciascun descrittore viene indicato il punteggio maggiore per ciascuna fascia
43
TABELLA DI MISURAZIONE PER LA PRIMA PROVA (CONVERSIONE DEI PUNTEGGI ESPRESSI IN CENTESIMI IN PUNTEGGI ESPRESSI IN QUINDICESIMI)
Punteggio in centesimi Punteggio in quindicesimi
Da 18 a 22 2
Da 23 a 27 3
Da 28 a 32 4
Da 33 a 37 5
Da 38 a 42 6
Da 43 a 47 7
Da 48 a 52 8
Da 53 a 57 9
Da 58 a 62 10
Da 63 a 67 11
Da 68 a 72 12
Da 73 a 77 13
Da 78 a 86 14
Da 87 a 100 15
Per la seconda prova è stata utilizzata la griglia ministeriale.
44
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: TIPOLOGIA B
Descrittori
Indicatori Punti
Quesito 1
Punti
Quesito 2
Conoscen
za dei
contenuti
1. Nessuna risposta o informazioni assolutamente inadeguate. 2. Sono presenti solo alcune conoscenze, superficiali,
frammentarie e lacunose fin nei concetti di base o, comunque solo parzialmente attinenti al testo.
3. Informazioni incerte e/o incomplete e non approfondite. L'analisi
delle problematiche affrontate è imprecisa, non sempre correttamente organizzata né adeguatamente motivata.
4. Sufficiente la quantità di informazioni, ma poco approfondite,
presentate in forma essenziale e non sempre adeguatamente motivate.
5. Buona lo quantità di informazioni, che risultano complete ed
argomentate adeguatamente. 6. Ottimo il livello delle informazioni che risultano approfondite, ben
argomentate e motivate.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Competen
ze
acquisite
1. Non è possibile apprezzare alcun elemento positivo. 2. Non è colto il significato delle informazioni; esse sono
inadeguatamente organizzate e non motivate. Qualche grave errore.
3. Incerta l'applicazione delle informazioni. Si esprime in modo
poco chioro. Errori diffusi. 4. Le informazioni risultano utilizzate in modo sostanzialmente
corretto ma con qualche incertezza. Si esprime in forma sufficientemente chiara pur commettendo qualche errore.
5. Corretta l'applicazione delle informazioni. Sintetizza le
informazioni in modo efficace e corretto. Si esprime in maniera efficace e sostanzialmente corretta.
6. Sicura l'applicazione delle informazioni, che dimostra di saper
utilizzare, in modo autonomo e con contributo personale, anche a casi nuovi. Si esprime in maniera fluida e senza errori ed organizza i contenuti in maniera articolata.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Punteggi totali Quesito 1 e Quesito 2
Punteggio complessivo nella Disciplina:___________________________
Punteggio massimo su un quesito 5 pt Punteggio massimo su due quesiti 10 pt Punteggio massimo su dieci quesiti 50 pt
45
TERZA PROVA SCRITTA
Tabella di conversione
PUNTEGGIO IN CINQUANTESIMI (P)
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI
0≤P≤3 1
3,5≤P≤5,5 2
6≤P≤8,5 3
9≤P≤11,5 4
12≤P≤14,5 5
15≤P≤17,5 6
18≤P≤20,5 7
21≤P≤23,5 8
24≤P≤26,5 9
27≤P≤29,5 10
30≤P≤33 11
33,5≤P≤36,5 12
37≤P≤40 13
40,5≤P≤44,5 14
45≤P≤50 15
46
Testi delle simulazioni di terza prova
A.S. 2017/2018
CANDIDATO______________________________________
CLASSE 5^ B SA
Simulazione di
TERZA PROVA
TIPOLOGIA B
6 Febbraio 2018
DISCIPLINE COINVOLTE:
LINGUA STRANIERA (INGLESE), STORIA, SCIENZE NATURALI, MATEMATICA, INFORMATICA.
La prova consiste in n. 10 quesiti a risposta aperta, 2 per ogni disciplina.
Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 120 minuti.
Domande tipologia B
Rispondere nel numero di righe indicato.
E' consentito solo l'uso della penna nera o blu; non usare il lapis.
E' consentito solo l'uso della calcolatrice non programmabile.
Non è consentito l’ uso dei correttori. Eventuali correzioni devono essere leggibili.
PUNTEGGIO ......................... / 50
47
VALUTAZIONE ........................ / 15 punti
Materia: INGLESE Candidato:_________________________
QUESITO 1
Compare “The Soldier” and “Dulce et Decorum est”, with reference to their themes and language.
QUESITO 2
How does T.S. Eliot espress the alienation of modern man in “The Waste Land”?
48
Materia: STORIA
Candidato:_________________________
1) QUESITO 1:
Elenca le riforme economiche e sociali varate dai governi giolittiani e spiega quali erano i
limiti del riformismo giolittiano.
QUESITO 2:
Spiega le varie posizioni del fronte interventista italiano nel dibattito che interessò il paese allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
49
Materia: SCIENZE NATURALI Candidato:____________________________
QUESITO 2
Descrivi le eruzioni di tipo hawaiano. (Max 10 righe)
QUESITO 1
Spiega per quali ragioni le mutazioni svolgono in biologia anche un ruolo positivo. (Max 10 righe)
50
Materia: MATEMATICA Candidato:_________________________
QUESITO 1
Dopo aver enunciato il teorema degli zeri verifica che l’equazione ammette un solo zero del quale si chiede un intervallo di appartenenza.
51
QUESITO 2
Dopo aver dato la definizione di funzione derivabile in un punto dominio della funzione,
determinare i valori di e di in modo tale che la funzione
sia derivabile in .
52
Materia: INFORMATICA Candidato:_________________________
QUESITO 1
Spiega il significato di associazione N:N nel modello E/R, soffermandoti sulla proprietà di esistenza (totale, parziale) dell’associazione e scrivendone un esempio. Deriva poi l’esempio nel corrispondente schema relazionale.
53
QUESITO 2
Dato il seguente schema logico di un database relazionale costituito dalle relazioni: ARTISTA (CodiceArtista, Cognome, Nome, DataDiNascita, DataDiMorte, Nazionalità) OPERA (CodiceOpera, Titolo, Genere, CodiceArtista*)
• descrivi le proprietà di ciascun campo (tipo, dimensioni, se chiave primaria o secondaria, etc)
• definisci l’interrogazione corretta per visualizzare il titolo, il genere e il cognome dell'autore di tutte le opere di artisti con nazionalità italiana
• indica il grado e la cardinalità della tabella risultato.
54
A.S. 2017/2018
CANDIDATO______________________________________
CLASSE 5^ B SA
Simulazione di
TERZA PROVA
TIPOLOGIA B
10 Maggio 2018
DISCIPLINE COINVOLTE:
STORIA, LINGUA STRANIERA (INGLESE), DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE, FISICA, SCIENZE
NATURALI.
La prova consiste in n. 10 quesiti a risposta aperta, 2 per ogni disciplina.
Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 120 minuti.
Domande tipologia B
Rispondere nel numero di righe indicato.
E' consentito solo l'uso della calcolatrice non programmabile.
Non è consentito l’ uso dei correttori. Eventuali correzioni devono essere leggibili.
PUNTEGGIO ......................... / 50
VALUTAZIONE ........................ / 15 punti
Materia: Storia Candidato:_________________________
55
Materia: INGLESE Candidato:_________________________
QUESITO 1:
Illustra la situazione sociale, politica, economica all'indomani del PRIMO conflitto mondiale in Italia.
QUESITO 2:
Chiarisci i punti più rilevanti del piano di Roosevelt ,noto come New Deal.
56
QUESITO 1
Describe the most relevant stylistic devices and themes used by James Joyce in “Dubliners” or “Ulysses”.
QUESITO 2
Speak about the dystopian novel in general and analyze it in details according to one of its most important representatives chosen among the writers you've studied.
57
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Candidato:_________________________
QUESITO 1 :
Illustra i caratteri della pittura futurista ed indica un opera con relativo autore appartenente a tale movimento
58
Materia: FISICA Candidato:_________________________
QUESITO 1:
Si dimostri come dalla Conservazione della Carica Elettrica derivi l’equaz. di continuità, e comesua applicazione ai conduttori, si trovi la relazione che definice il cosiddetto “tempo di rilassamento”.
QUESITO 2:
Dimostra, a partire dalle Trasformazioni di Lorentz, la legge relativistica per la composizione delle velocità (in una sola dimensione, x), e, a titolo di esempio si determini la velocità relativa tra due particelle che nel Laboratorio si muovono l’una incontro all’altra con una velocità pari ai 2/3 la velocità della luce.
59
Materia: Scienze naturali Candidato:_________________________
QUESITO 1 :
Descrivi il processo di maturazione del RNA messaggero (massimo 10 righe)
QUESITO 2 :
Qual è la differenza tra la scala Mercalli e la scala Richter (massimo 10 righe)
60
FIRME DEI COMPONENTI DEL C.d.C.
Materie Insegnanti
Lingua e Letteratura italiana Lucia Sechi
Lingua e Cultura Inglese Carlo Cianelli
Storia Lucia Luperini
Filosofia Orazio Caruso
Matematica Angela Castellacci
Informatica Susanna Andronico
Fisica Stefano Ranfone
Scienze naturali Paola Greco
Disegno e storia dell'arte Sergio Tognarelli
Scienze motorie e sportive Carlo Pellegrini
Religione cattolica o Attività alternative
Marzio Paoli
Rappresentanti dei genitori Chiara Deri Altomare Conte
Rappresentanti degli alunni Costantino Bradulet Marco Morelli
Pontedera, 15 maggio 2018








































































![AUSILI DIDATTICI BIENNIO SPECIALISTICO - COMPENDIO...[Corso di METODOLOGIA della PROGETTAZIONE] Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate A.A. 2015/2016 Titolare della Cattedra:](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/6119483ac184e328b35fb915/ausili-didattici-biennio-specialistico-compendio-corso-di-metodologia-della.jpg)