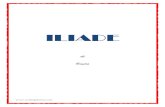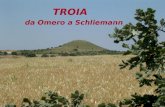01-Omero
description
Transcript of 01-Omero
-
Letteratura greca [1]
1
Omero Aedi e rapsodi Il cantore che, accompagnandosi con la cetra, celebrava le gesta di di ed eroi si chiamava (aedo): si trattava di esecutori e compositori al tempo stesso, personaggi socialmente rilevanti come mostrano le figure di Demodoco e Femio nellOdissea. Laltro termine che denotava lattivit del cantore epico era (rapsodo), attestato per la prima volta nel V secolo a.C.1 e spesso usato in riferimento a esecutori di poesia preesistente che si esibivano in occasione di festivit pubbliche. Il composto doveva essere gi noto a Pindaro che, attraverso una perifrasi (Nemea II 1-3 cantori di versi cuciti), ne propone uninterpretazione etimologica connessa al verbo cucire; e una perifrasi analoga ( avendo cucito il canto in nuovi inni) contenuta in un brano attribuito a Esiodo.2 Poich in queste due testimonianze il riferimento agli aedi, possibile che il termine rapsodo non fosse sorto per indicare dei semplici ripetitori, ma che originariamente designasse, in unaccezione pi specifica di quella di , il poeta epico, compositore-esecutore di canti secondo la tecnica formulare. Lo stesso Pindaro sembra riferirsi altrove (Istmica IV 37-39) a Omero come rapsodo allorch dice che il valore di Aiace fu da lui proclamato col bastone, alludendo a una diversa etimologia del termine, che collegava e a bastone (il bastone su cui i cantori si appoggiavano nel corso delle loro esecuzioni).3 Ancora nel VI secolo a.C. Lattivit dei rapsodi non doveva essere ridotta a pura esecuzione di canti di un repertorio gi esistente: sappiamo infatti che il rapsodo Cineto, che avrebbe per primo eseguito Omero a Siracusa nel 504/501 a.C., inseriva nella recitazione dei poemi omerici versi di sua composizione. Per altro in et arcaica i rapsodi non recitavano solo Omero, ma anche Esiodo, Senofane, Empedocle e, al di fuori della tradizione esametrica, poesia giambica ed elegiaca (Archiloco, Solone, Semonide di Amorgo4). Quando laedo iniziava la sua recitazione sceglieva (o gli era assegnato dalluditorio, come accade a Odisseo in Odissea VIII 487 ss.) un argomento tratto da uno dei grandi cicli della leggenda eroica: ad esempio lira di Achille, le avventure di Odisseo, il ritorno dei Greci, la contesa tra Odisseo e Achille (Odissea VIII 73-81), il Cavallo di legno. Il cantore epico doveva avere gi un posto fisso nei palazzi micenei, come suggerisce la figura, venuta alla luce a Pilo, di un uomo nel tipico atteggiamento del musico che, seduto su una roccia, suona una grande lira a cinque corde (laffresco del cantore di Pilo). Un leggendario cantore 1 Cfr. Erodoto V 67 (Clistene viet ai rapsodi di gareggiare con i carmi di Omero, Sofocle, Edipo Re 391 (la Sfinge come cagna cantatrice). 2 Fr. 357 Merkelbach-West. 3 Cfr. Callimaco, fr. 26,5 Pfeiffer (e il racconto intessuto sul bastone) e lo scolio a Platone, Ione 530a Greene: i rapsodi erano cos chiamati poich nel recitare i poemi omerici tenevano bastoni di alloro ( ). 4 Per Archiloco cfr. Eraclito, 22 B 42 D.-K. (Omero merita di essere cacciato dagli agoni e frustato, e lo stesso vale per Archiloco), Platone, Ione 531a-532a, Clearco, fr. 92 Wehrli (Simonide di Zacinto usava recitare [] i canti di Archiloco nei teatri, seduto sopra un seggio). Per Solone cfr. Platone, Timeo 21 b-c (molti di noi ragazzi cantammo [] i componimenti di Solone). Per Semonide di Amorgo cfr. Ateneo XIV 620c (Lisania nel I libro del suo scritto Sui poeti giambici dice che il rapsodo Mnasione nelle sue esibizioni era solito interpretare [] alcuni dei giambi di Semonide). Per Senofane cfr. la testimonianza 21 A 1 D.-K. (recitava [] le proprie opere), per Empedocle cfr. Dicearco, fr. 87 Wehrli.
-
Letteratura greca [1]
2
dellet micenea, ritenuto uno degli inventori della musica e della poesia, fu Lino: forse rappresent originariamente la personificazione di un canto di lamento fondato sulliterazione dellespressione di dolore . Altro leggendario cantore e indovino fu Filammone, di origine tracia, figlio di Apollo, che avrebbe istituito i misteri di Demetra a Lerna e i cori a Delfi e avrebbe inventato i cori femminili. Figlio di Filammone e della ninfa del Parnaso Argiope era detto il tracio Tamiri: famoso per la sua bellezza e per labilit nel suonare la cetra (arte in cui sarebbe stato istruito da Lino) e nel cantare, Tamiri si era vantato di poter vincere anche le Muse secondo una leggenda gi attestata in Iliade II 594-600:
...Dorio,5 dove le Muse Sincontrarono con il tracio Tamiri e posero fine al suo canto, 595 Tamiri che veniva da Ecalia, dalle case di Eurito, e si vantava di superare nel canto chiunque, anche le stesse Muse, figlie di Zeus signore dellegida, ed esse adirate lo mutilarono e gli tolsero il canto divino e gli fecero dimenticare la cetra. 600
[Tr. di G. Paduano]6 Veniva ricordato anche come autore di poemi cosmogonici e teologici e di una Presa di Ecalia ( ) ed era considerato linventore del modo musicale dorico. NellOdissea compaiono quattro figure di Demodoco alla corte dei Feaci, Femio in quella di Odisseo a Itaca, un aedo anonimo presso la reggia di Agamennone ad Argo (III 267 ss.) e un altro alla corte di Menelao a Sparta (IV 17-19) , e per tutti costoro riscontriamo una forma di servizio pi o meno costante presso una corte. Lerudizione antica interpret i brani dellOdissea relativi a Femio e a Demodoco come testimonianze su due aedi realmente esistiti nellet pi antica. Di conseguenza si attribu a Femio un poema intitolato Il ritorno da Troia dei compagni di Agamennone sulla base di Odissea I 325 ss., a Demodoco Le nozze di Afrodite ed Efesto e La presa di Ilio sulla base di Odissea VIII 267-366 e 499-520. Al di l di queste invenzioni erudite tuttavia significativa losservazione di Eraclide Pontico (fr. 157 Wehrli) secondo cui la poesia di Demodoco e di Femio avrebbe avuto strutture ritmiche non diverse da quelle adottate da Stesicoro e dagli antichi lirici, mentre Demetrio Falereo (fr. 192 Wehrli) accomunava Automede, Demodoco, Femio etc. come compositori di odi e canzoni per musica e cetra e e ogni altro strumento musicale. E in effetti possiamo notare che nel canto VIII dellOdissea viene approntato uno spazio per la danza () in cui alcuni giovani feaci eseguono evoluzioni orchestiche che accompagnano mimeticamente la rievocazione, da parte di Demodoco, degli amori segreti di Ares e Afrodite (vv. 256-265):
...e laraldo salz per portare dalla casa del re la cetra incavata. Tutti e nove si alzarono gli arbitri scelti del popolo, che nelle gare preparavano bene ogni cosa: spianarono un coro, allargarono bene il campo di gara. 260 Saccost laraldo recando la cetra sonora a Demodoco, ed egli avanz fino al centro. Lattorniavano giovani nel primissimo fiore, esperti di danze: scandirono coi piedi la danza divina. Odisseo guardava il balenare dei piedi e stupiva nellanimo. 265
[Tr. di G.A. Privitera]7 Analogamente, in Odissea IV 15-19, il canto dellanonimo aedo presso la corte di Menelao a Sparta associato alle figure di danza eseguite da una coppia di acrobati:8
5 Localit della Trifilia, nel Peloponneso. 6 Omero. Iliade, Torino, Einaudi-Gallimard 1997. 7 Omero.Odissea, II, testo e commento di J.B. Hainsworth, tr. di G.A. Privitera, Milano, Mondadori 1981.
-
Letteratura greca [1]
3
Essi cos banchettavano nella gran sala dallalto soffitto, i vicini e i parenti di Menelao glorioso, Lietamente: tra loro cantava laedo divino suonando la cetra; in mezzo ad essi due acrobati volteggiavano dando inizio alla danza.
[Tr. di G.A. Privitera]9 Alcuni studiosi ritengono che fra VIII e inizio del VII secolo a.C. Omero si rivolgesse esclusivamente ai nobili e fondano questa ipotesi da un lato sulla tematica generale dei poemi, sullambiente che fa da sfondo alle vicende narrate, sulla mentalit e i sentimenti sottesi alle affermazioni dei singoli personaggi, sui rapporti interpersonali che fra di essi intercorrono, dallaltro sullosservazione che i cantanti serbi di caff-concerto, i contadini, i pastori e i portatori dacqua neo-greci, i pescatori russi etc. che le odierne ricerche hanno via via assunto come termini di confronto mostrano unidentit sociologica comunque diversa da quella dei bardi greci. Ma, pur se appare innegabile il carattere aristocratico di molta parte del mondo omerico, c una serie di dati che suggeriscono per gli aedi una pluralit di possibili uditor, fino a comprendere lintera comunit. Cos, in Odissea XVII 385, laedo definito come un lavoratore per la collettivit () al pari dellindovino, del medico e del carpentiere (un indizio, altres, che gli aedi erano riuniti in corporazioni o gilde),10 Demodoco canta, oltre che nel palazzo di Alcinoo, anche di fronte a tutto il popolo dei Feaci (Odissea VIII 254 ss.), Esiodo racconta di aver vinto a Calcide in Eubea un tripode nelle gare in onore di Anfidamante (Erga 654-659), e nel Certame di Omero ed Esiodo10 si racconta che Omero recit linno ad Apollo alla festa panellenica di Delo; altrettanto chiaramente collettivo e comunitario lo scenario di pubblico presupposto nell omerico Inno ad Apollo. Anche per quanto riguarda il punto di vista sociologico presupposto dai poemi, non si pu considerare irrilevante linsistita preoccupazione, nellOdissea, perch venga garantita una giustizia capace di frenare i soprusi dei potenti (unottica che avvicina il poema alle ansie espresse negli Erga da Esiodo). Sembra perci pi corretto supporre che lepica omerica volesse e sapesse mediare, attraverso il canto, fra i valori di unaristocrazia desiderosa di autorealizzarsi nelle memorie degli avi (veri o presunti) e le prospettive di un pi vasto mondo sociale. Fonte dispirazione del canto dellaedo la Musa, come rileviamo tanto in relazione a Demodoco (Odissea VIII 44 s. / , a lui in sommo grado un dio don il canto, / a darci diletto, comunque il cuore lo spinge a cantare)11 quanto per litacese Femio. Ma lazione ispiratrice della Musa non sentita come limitazione della personale originalit del cantore, tanto che Femio dichiara a Odisseo nel momento in cui lo supplica di risparmiargli la vita che egli autodidatta anche se un dio ha impiantato () nel suo animo le vie del canto (Odissea XXII 347-49):
, . Da me solo ho imparato: a me un dio nel cuore vie
8 E sullo scudo sbalzato da Efesto si dice (Iliade XVIII 603-605) che vera molta folla intorno alla danza graziosa, / rapita; due acrobati intanto / dando inizio alla festa roteavano intorno [tr. di R. Calzecchi Onesti]. 9 Omero.Odissea, I, testo e commento di S. West, tr. di G.A. Privitera, Milano, Mondadori 1981. 10 Anche Esiodo (Erga 25 s.) pone laedo accanto a figure artigianali come il vasaio e il carpentiere. 11 Cfr. anche vv. 62 s. , / , la Musa molto lo am, ma un bene e un male gli dava: / degli occhi lo fece privo e gli don il dolce canto, e v. 73 la Musa ispirava il cantore a cantare imprese gloriose di uomini.
-
Letteratura greca [1]
4
molteplici impiant; e credo che davanti a te canterei come davanti a un dio: dunque non volermi trucidare!
Come spesso accade in Omero, azione umana e azione divina risultano complementari: qui ci che appare una manifestazione di autonomia e di originalit se osservato sul piano umano (Femio vuol dire che non ha avuto maestri nellarte e, soprattutto, che solito cantare sospinto dallimpulso del suo , cfr. il gi ricordato Odissea VIII 45 ) si prospetta come azione esterna se considerato dal punto di vista dellintervento divino. Analogamente, il carattere tradizionale dei temi e degli episodi sviluppati dagli aedi non blocca laffermarsi di unesigenza di originalit: come dice Telemaco alla madre in Odissea I 351 s.:
, . quel canto pi celebrano gli uomini che intorno giunge pi nuovo agli uditori.
Il canto epico una (Odissea VIII 481 e XXII 347), la via o traccia narrativa che il poeta pu scegliere allinterno del repertorio tradizionale e seguire per ordine ( ) partendo da un punto determinato (cfr. Iliade I 4 da quando, Odissea VIII 500 da dove). Di tanto in tanto laedo sospende la sua esecuzione (Odissea VIII 87 quando interrompeva il canto), poi riprende, eventualmente sollecitato dal pubblico (ibid. 90 s. / , , ma quando ricominciava e lo spingevano al canto / i principi dei Feaci, poich godevano dei suoi versi). Anche luditorio, come abbiamo gi detto, pu infatti richiedere la scelta di un determinato tema, come fa Odisseo quando in Odissea VIII 487 ss. chiede che Demodoco gli canti la storia del Cavallo di legno. Daltra parte la poesia orale tradizionale doveva avere un respiro limitato, circoscritto al tempo di una singola esecuzione (un pomeriggio o una sera), e non a caso Femio e Demodoco eseguono pezzi che occupano una parte limitata delle ore successive alla cena. Da questo punto di vista lautore (o gli autori) dellIliade e dellOdissea ci appare come un poeta orale estraneo alla norma, capace di esibirsi nellarco di molte ore (almeno una ventina) distribuite in diversi giorni e sedute. La leggenda di Omero Ci sono giunte sette biografie di Omero, tutte di et post-classica anche se non escluso che alcune parti e alcuni motivi narrativi risalgano fino allet arcaica (e in particolare a Teagene di Reggio, vissuto nel VI secolo a.C.). Costruita a posteriori ed esposta con ricchezza di dettagli in un racconto, anche la leggenda di un agone poetico svoltosi a Calcide in Eubea fra Omero ed Esiodo in occasione dei ludi funebri (a cui Esiodo effettivamente partecip, come sappiamo da Erga 654-659) per il principe Anfidamante: si tratta del cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi, che nella forma in cui ci pervenuto12 risale al II secolo d.C. ma si basa su modelli pi antichi (in particolare sul Museo del retore del IV secolo a.C. Alcidamante). La prova si apre con un gioco di domande e risposte fra i due poeti, poi ciascuno recita un passo delle proprie opere: il pubblico inclinerebbe a conferire il premio a Omero, ma il figlio del defunto assegna la vittoria ad Esiodo in quanto poeta della pace e dellagricoltura ( 13):
12 Cfr. Homeri opera V 218-238 Allen. Possediamo qualche resto di una versione pi antica grazie alla testimonianza di un papiro del III secolo a.C. (P. Flinders Petrie 25) pubblicato nel 1891.
-
Letteratura greca [1]
5
Anche in questa fase dellagone gli Elleni, sbalorditi, applaudivano Omero, perch i versi erano superiori ad ogni aspettativa, e chiedevano che gli assegnassero la vittoria. Il re per incoron Esiodo, dichiarando che era giusto che vincesse chi esortava allagricoltura e alla pace e non colui che narrava guerre e stragi.
[Tr. di F. De Martino]13 LOmero della leggenda biografica (ne diamo qualche cenno prendendo come base la biografia falsamente attribuita ad Erodoto)14 si sarebbe chiamato Melesigene (Nato presso il Melete) e sarebbe nato a Smirne da una certa Creteide di Cuma, resa incinta da uno sconosciuto e condotta dal padre adottivo (Cleanatte di Argo) presso un suo amico a Smirne appena fondata. Da giovane Melesigene (che non nato cieco) apprende i rudimenti dellarte epica da un certo Femio, un maestro di cui eredita la scuola, quindi simbarca sulla nave di un certo Mente di Leucade per conoscere il mondo e arriva (dopo aver visitato Etruria e Spagna) anche a Itaca, dove si ammala e, abbandonato da Mente, viene ospitato dallitacese Mentore. Ripreso il mare con Mente (tornato a Itaca a prelevarlo), a Colofone perde la vista (di qui, pi tardi, il soprannome di Omero in quanto colui che non vede, cieco).15 Fatto ritorno nella nativa Smirne, inizia il mestiere di poeta: ha successo, ma presto cade in miseria e decide di trasferirsi a Cuma, dove (dopo un soggiorno in una colonia cumana presso il cuoiaio Tichio) recita i suoi versi nei ritrovi degli anziani. La sua fama si diffonde al punto che Melesigene chiede di esser mantenuto a spese pubbliche. Di fronte al rifiuto del Consiglio cittadino maledice Cuma e si trasferisce prima a Focea, dove declama di nuovo i suoi poemi nelle sale pubbliche, poi a Eritre e a Chio, dove intende vendicarsi di un certo Testoride che a Focea gli aveva promesso cibo e alloggio in cambio del lascito ereditario dei poemi e invece era fuggito alla volta di Chio dopo averli trascritti sotto dettatura. Ma a Chio, Melesigene/Omero si smarrisce finch arriva alla masseria di un pastore di capre di nome Glauco, che lo conduce presso il suo signore a Bolisso. Qui assoldato come precettore e per i figli di costui posti sotto le sue cure compone fra laltro la Batracomiomachia. Indi si reca nella capitale dellisola, apre una scuola di versificazione, prende moglie (da cui ha due figlie) e intanto continua a lavorare a Iliade e Odissea. Riprende i viaggi approdando prima a Samo e poi a Ios, dove si ammala e giace infermo sulla spiaggia: qui alcuni giovani pescatori gli propongono lindovinello dei pidocchi (quanto prendemmo, lasciammo; ci che non prendemmo, portiamo), gi noto a Eraclito (22 B 56 D.-K.), e muore per la rabbia di non aver saputo risolverlo o per la fiacchezza (come lautore della biografia preferisce immaginare). Non sono mancati tentativi, fra cui si distingue per acume quello compiuto da Wolfgang Schadewaldt,16 di estrarre dalle Vite superstiti unimmagine di Omero almeno significativa per la comprensione del mestiere dellaedo nellVIII-VII secolo a.C.17 Senonch, come stato
13 Omero quotidiano: Vite di Omero, Venosa, Edizioni Osanna 1984. 14 Molto dibattuta la questione della data di origine della biografia pseudo-erodotea, ma il testo che possediamo rappresenta probabilmente la pi tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo a.C., verosimilmente come suppose F. Jacoby (Kleine philologische Schriften, I, Berlino 1961, 11 s.) un prodotto di cultura sofistica comparabile con il Certamen di Alcidamante. 15 Senonch parola greca e significa ostaggio, e in effetti testimonianze epigrafiche provano che in et arcaica genitori greci potevano dare al proprio figlio questo nome. 16 Homer und sein Jahrhundert, in Id., Von Homers Welt und Werk, Stoccarda 19593, 87-129. 17 Per Eratostene Omero sarebbe stato contemporaneo della guerra di Troia, da lui datata al 1194-1184; invece per Erodoto (II 53) Omero ed Esiodo sarebbero stati coetanei e sarebbero vissuti circa 400 anni prima di lui, cio alla met del IX secolo (II 53, 2 Ritengo che Esiodo e Omero mi abbiano preceduto in et di quattrocento anni, e non di pi. Sono essi ad aver composto per i Greci una teogonia, dando agli dei epiteti, dividendo gli onori e le competenze, indicando le loro forme [tr. di A. Fraschetti]. Lanonimo autore di un epigramma (A.P. XVI 298) dice che sette citt (Smirne, Chio, Colofone, Itaca, Pilo, Argo, Atene) si contendevano i suoi natali.
-
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato,18 non solo la maggior parte delle vicende di questa biografia desunta proprio dai poemi omerici, e specialmente dallOdissea, e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli, ma, soprattutto, lOmero di questa leggenda un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice, con calzolai, pescatori e vecchi nei ritrovi delle citt portuali, un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli; un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta, nellepisodio del signore di Bolisso, in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case, del resto, solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte. [...] Chi ha delineato questimmagine di poeta non importa se con intenzioni parodistiche o meno aveva davanti a s un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari, le citt e le comunit avevano raggiunto una piena fioritura, scalzando lantica struttura aristocratica della societ, quando cio gi dominava la borghesia e si richiedeva pi spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole!) che beni patrimoniali. La condizione professionale dei rapsodi era questa: artisti di declamazione, paragonabili ai nostri cantanti da concerto, che allora come oggi andavano in tourne e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte, ma solo grandi capolavori altrui. La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellet arcaica; i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedo. Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalit di Omero: ci che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale pi sopra abbiamo cercato di sintetizzare), dallaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellarte epica. Il verso dellepica Lesametro (gi Erodoto usa per lesametro dattilico espressioni come [I 47, 2] e [VII 220, 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili , di cui lultimo catalettico (con la possibilit per lultimo elemento, in virt della pausa di fine di verso, di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga: u). Le due brevi dei singoli dattili potevano essere sostituite da una lunga, costituendo uno spondeo (di qui la denominazione, per ciascun elemento in posizione pari, di biceps: y): una facolt molto ridotta nel quinto dattilo, che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono all'incirca di un caso su 18 versi). Il verso appare articolato attraverso punti di incisione, le cosiddette cesure ( tagli): le pi frequenti interessano il terzo metro, venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere: dopo il quinto mezzo piede) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica); pi rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere: dopo il settimo mezzo piede), e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere: dopo il terzo mezzo piede). Fine di parola pu ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [ divisione] bucolica, cos denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici det ellenistica). Di qui lo schema seguente:
a1 a2 m f r b y: : y /k/k : y: kk u
18 J. Latacz, Omero, il primo poeta dellOccidente (1989), Laterza, Roma-Bari 1990, 28 s.
-
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allinterno della prima met del verso le posizioni che, in alternativa reciproca, tendono a coincidere con fine di parola, m e f le posizioni della cesura principale, rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f), r la posizione della cesura eftemimere, b la posizione della dieresi bucolica. Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro, cos da escludere una bipartizione simmetrica del verso. Un punto in cui la fine di parola tendenzialmente evitata quello dopo la prima breve del quarto biceps, come fu osservato da G. Hermann (donde letichetta di ponte di Hermann). Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (prima legge di Meyer).
PER SAPERNE DI PIU Teorie sullorigine dellesametro Sul problema dellorigine dellesametro le teorie si sono succedute numerose allinterno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unit minori e chi invece, come Hoekstra (1981), ne ha proposto uninterpretazione fin dallorigine unitaria. Ad es. Th. Bergk (1854) riconduceva la genesi dellesametro a due cola lirici preesistenti, Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al piccolo epos e da questo al grande epos, A. Meillet (1923) postulava uneredit pre-greca (egea). Pi recentemente, un ritorno alla posizione di Bergk si avuto da parte di M.L. West (1973) con lipotesi di una derivazione dellesametro dallassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz, nel senso dellevoluzione di un ferecrateo espanso con linserzione centrale di tre dattili, con G. Nagy (1974); B. Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellesametro e i cola della poesia lirica det arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes, enoplio, reiziano coriambico, adonio etc.) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule pi tradizionali dellesametro omerico (per unesposizione sintetica di questa teoria cfr. B. Gentili-L. Lomiento, Metrica e ritmica. Storia delle forme poetiche nella Grecia antica, Milano, Mondadori Universit 2003, pp. 279-283).
La formularit Il fenomeno della formularit si pu definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellambito di situazioni tipiche: ad es., per quando sorse laurora troviamo usato per due volte nellIliade e in ben venti casi nellOdissea il verso:
e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso pi comune di formularit quello rappresentato dai nessi standardizzati nome/epiteto, come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi, (31 volte) e (38 volte), ambedue formule clausolari ma di diversa estensione, poich (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r, la seconda da f. Esempi:
-
Letteratura greca [1]
8
: r Iliade I 58 : f Odissea VIII 97 , Pi in particolare, se consideriamo le singole articolazioni minori del verso, riscontriamo che: a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni, pronomi e particelle connettive o avversative: ad es., fino ad a1 (): fino ad a2 (): b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda, a titolo di esempio, il verso di Iliade sopra citato, nel quale si estende, appunto, da m a r); m r Iliade I 58 c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il pi ricco serbatoio di nessi formulari: innanzi tutto, come nel caso di , le formule nome proprio/epiteto, ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto, ad es. , , , , , , . Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allestensione e alleconomicit: a) il principio dellestensione si connette alla tendenza dellepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ci che nella narrazione sia tipico, costante, ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso: ad es. per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione ( , e e una formula iniziale ( ); b) il principio, complementare al primo, delleconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che, per esprimere una medesima idea essenziale, esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unit minore del verso. Casi come e sono doppioni apparenti: hanno s la stessa misura metrica ma iniziano luno in consonante, con la connessa possibilit di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente, laltro in vocale. Non mancano tuttavia vere eccezioni come, per lhemiepes iniziale, di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto (16 volte). Luso di formule e, soprattutto, di sistemi formulari, rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando, ma nella lunga evoluzione dellepica, e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lIliade e lOdissea, la
-
Letteratura greca [1]
9
sempre pi estesa memorizzazione di ampie zone di testo, il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi, e la scoperta di inedite possibilit espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del gioco delle formule. Da un lato procedimenti come laddensamento degli epiteti, la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa), il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularit e superamento della formularit, dallaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni. La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In et moderna la riscoperta della citt di Troia, situata sullodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo, si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890), che a partire dal 1866 si dedic al disseppellimento delle rovine di Micene, di Tirinto e di altri siti micenei e, appunto, di Troia. Nel corso del tempo si venuta creando, attorno alla personalit di questo archeologo dilettante, una sorta di leggenda, a cui egli stesso contribu con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884), nel senso di un dilettantismo romantico, di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo, di un amore cieco e totale per Omero e per lEllade. E in effetti oggi sappiamo che laver percorso la Grecia e lAsia minore sulle vie di Omero non imped a Schliemann, a Micene, di attribuire allepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli pi antiche n, a Troia, di identificare con la citt omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 a.C. Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza, allepoca, di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una pi plausibile cronologia di reperti e di strati. Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la citt omerica: Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi. Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre pi in profondit, saltando gli strati del secondo millennio. Dove per il problema consisteva nellidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale, Schliemann consegu notevoli successi, in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellacropoli omerica che lopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi, situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo; e la disputa era stata viva gi nellantichit: Ellanico di Lesbo, verso il 400 a.C., aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo, sorta presso la collina di Hissarlik, e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito; invece Demetrio di Scepsi (fr. 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud, sullaltra riva dello Scamandro. La missione americana guidata nel 1932-1938 da C.W. Blegen e le pi recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto pi articolato e differenziato. Sulla base di un nuovo diagramma la citt che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa, non pi con quella che Schliemann chiamava terza citt (corrispondente a Troia II) ma nemmeno, come voleva W. Drpfeld, con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto). Gli scavi pi recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr. Korfmann 2002), che ha diretto lquipe dellUniversit di Tubinga negli scavi pi recenti, lantica Troia, intorno al 1184, cess di essere abitata, ma linsediamento continu nellarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
-
Letteratura greca [1]
10
della citt (Troia VIIb). Verso il 700 il luogo chiamato Ilio era largamente in rovine anche se in et arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto. Il problema che si dovettero porre nellVIII secolo a.C. Omero o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiarit con la geografia locale (lIliade offre indicazioni realistiche ad es. sulla navigazione dellEgeo in IX 362 s. e sulla visibilit dellisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14), che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre citt vicine o di abitanti della stessa Ilion, che nellVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale. Il santuario sorgeva allinterno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa. Omero menziona due templi, quello di Apollo e quello di Atena, e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili. I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca. Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della citt di Troia cantata da Omero? Nel bastione a nord-est della rocca stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente. La sorgente fu abbandonata al pi tardi al tempo di Troia VIIb2, prima del 1100. A partire dal 1000/950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo. Troia era molto pi larga di quanto ritenesse Schliemann. Un fossato largo 3 m e profondo 1,5 , completato durante lultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cio intorno al 1300), la circondava. Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato pi ampio e concentrico al primo completato verso il 1200. Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unarea di circa 270.000 m2. La rocca e la citt bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine. I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati. Negli scavi fatti nei quartieri della citt bassa a sud-ovest della rocca, poco fuori del muro, si scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200). La prima devastazione da ricollegarsi a un terremoto, ma la seconda sembra dovuta a unazione di guerra, come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate. Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita perch qui lantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lanello pi vulnerabile nel sistema di difesa. Gi W. Drpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s. (Andromaca a Ettore):
Piazza lesercito presso il fico selvatico, dove pi facile Laccesso alla citt e il superamento delle mura.
In questa zona solo poco pi di 80 m separavano il muro della citt bassa dal muro della rocca. Gli epiteti omerici di Troia - ben costruita, fertile, vasta, sacra, erta, ventosa, dalle belle mura, dai bel puledri - si adattano ai dati topografici: ossa di cavalli sono state trovate sul terreno, forti venti soffiano continuamente in estate. Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale, cfr. Iliade XXII 145-157:
Passarono oltre il posto di vedetta e lalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre pi dalle mura si lanciarono lungo la strada. Giunsero alle fontane dalle belle acque, dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso, una di acqua calda, da cui si leva un vapore come da fuoco ardente , laltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine, la fredda neve o il ghiaccio. Vi sono, accanto, dei lavatoi di pietra, larghi, belli , dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti , prima, in tempo di pace, prima che giungessero i figli dei Danai.
[Tr. di M.G. Ciani] In effetti gli scavi nellarea della caverna in cui situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera, con tre gallerie e altri bracci tributari, creata per fornire acqua. Lacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro depressioni o fosse circolari scavate nella roccia della
-
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto, parrebbe, i , i lavatoi di pietra ricordati da Omero). Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo a.C. Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare laccesso ai Dardanelli (lantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lantica Propontide) e al Mar Nero. In Troia VIIa stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB, che anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco. E suggestiva lidentificazione, pi volte avanzata in tempi recenti, di Troia/Ilio con Wilusa, la citt menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli Achei (). Il documento pi significativo in proposito il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 a.C. fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa, che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600: pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita, Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la citt era divenuta indipendente. Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa, la capitale dellimpero hittita, e databile al XIII secolo ricorda nellambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallhittita) di cui viene riportato il primo verso: Quando tornarono dallerta Wilusa. E a Troia negli scavi pi recenti stato trovato un sigillo con uniscrizione in luvio. Daltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio, Troo e Ilo fino a Dardano, eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade 215 ss.). I Dardani nellIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localit situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellEllesponto come Abido e Arisbe. Dalla costa europea arrivano invece i Traci, i Ciconi e i Peoni, da oriente i Paflagoni e gli Alizoni, da sud-est i Misi e i Frigi, dalla zona sud-occidentale dellAnatolia i Meoni, i Cari e i Lici. Se Dardani, Peoni, Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellAnatolia (cfr. Erodoto 7, 73 e Xanto di Lidia, FGrHist 765 F 14), i Meoni sono di stirpe lidia, mentre i Cari e i Lici appartengono allambito culturale e linguistico luvio-hittita . Comunque sia, diversamente che per Erodoto, il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2, 1), e per i poeti tragici ateniesi del V secolo a.C., in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non presentato come un contrasto fra culture diverse. I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche Danai - cio discendenti di Danao - o Argivi, in relazione al contingente proveniente dallArgolide guidato da Agamennone, il capo della spedizione), e lo stesso vale per edifici, vesti, agricoltura, cibo, suppellettili, armi. Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi di e le stesse pratiche cultuali: Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia, Apollo favorisce i Troiani ma il patrono dellindovino greco Calcante. Quanto al linguaggio, proprio la definizione dei Cari, in Iliade 867, come di lingua straniera () suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani. Infine, sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva. Lesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre, la vestizione di un guerriero, le fasi di un duello, un atto di supplica, lo svolgimento di unambasceria, la costruzione di unimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W. Arend denomin scene tipiche: situazioni, competenze, atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p. xxx). La societ omerica
-
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia innanzi tutto da sottolineare lesistenza di un duplice piano di riferimento, con talune interferenze delluno nellaltro: da un lato c lorizzonte dei fatti, collocati in un passato glorioso, dallaltro lorizzonte del poeta. Gi gli studiosi alessandrini, del resto, notavano che dati come larte di montare a cavallo, i segnali per mezzo della tromba e luso di bollire la carne compaiono nellIliade solo allinterno delle similitudini. E il testo, con una sorta di arcaismo intenzionale, mostra talora la consapevolezza dellabisso che separa passato e presente, come quando in Iliade XII 445-449 si dice:
Ettore intanto un sasso afferr e lo portava che prima stava davanti alle porte, largo di sotto, ma sopra era a punta; questo due uomini, i pi forti del popolo, difficilmente isserebbero da terra su un carro, quali son ora i mortali; egli da solo lo roteava a suo agio.
[Tr. di R. Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani: il fabbro, il vasaio, il carpentiere, il medico, lindovino, laedo) rispecchiano assai pi la situazione storica fra VIII e VII secolo a. C. che le strutture della societ micenea. Inoltre i cadaveri vengono cremati, secondo la prassi pi recente, non inumati, anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace, trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare; non ambigua comunque la testimonianza, relativa alla prassi umana in generale, fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo):
Ohim, figlio mio, il pi misero di tutti gli uomini, Persefone, la figlia di Zeus, non ti inganna, ma la legge degli uomini questa, quando si muore: i nervi non reggono pi la carne e le ossa, ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa, appena la vita abbandona le bianche ossa e lanima vagola, volata via, come un sogno.
[Tr. di G.A. Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando linventario degli oggetti: accanto ad armi, vasi, ornamenti tipici dellVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allepoca micenea, come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss. (simile a una coppa dargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellet del bronzo), lelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione d a Odisseo (Iliade X 261 ss.) e lo scudo lungo, simile a torre, di Aiace, che di un tipo inusitato dopo il XIII secolo. Un oggetto non riferibile n al mondo miceneo n allet della fissazione dei poemi bens alla prima et del ferro invece la coppia di aste da lancio, adottate verso il 900 a.C. e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellasta per colpire; e la menzione delle navi fenicie (una volta nellIliade e cinque volte nellOdissea) riflette la loro comparsa nellEgeo nel IX secolo a.C. Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche: l visto a volte come figura di autocrate assoluto, a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee sia quella dei capi () sia quella delle truppe () o insidiato dallascesa dei gruppi aristocratici, mentre il non pi il dignitario della societ micenea ma, genericamente, un principe o un capo. LIliade
19 Omero. Odissea, III, intr., testo e commento di A. Hoekstra, tr. di G.A. Privitera, Mondadori, Milano 1984.
-
Letteratura greca [1]
13
LIliade () consta di circa 15690 esametri, divisi, secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso), in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellalfabeto greco. Lunit strutturale di parecchi canti, che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lalba, e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es. Tucidide [I 10, 4] cita il Catalogo delle navi, cio il canto II), provano che non si tratt di una divisione arbitraria bens fondata, almeno in certa misura, sulle abitudini dei rapsodi. Tema dellopera non lintero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride, ma una porzione assai limitata del conflitto, una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra: lira di Achille contro lAtride Agamennone, il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze, la fine dellira, luccisione e i funerali di Ettore. Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellunit e compiutezza dellazione che gi Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b):20
... anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri: per non aver tentato di rappresentare intera la guerra, anche se essa aveva un principio e una fine; il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo, oppure, pur misurato nella grandezza, intricato per la variet. Ricavatane invece una parte, ha fatto uso di molti episodi; per esempio con il Catalogo delle navi e con altri episodi fa procedere in lungo il poema. Gli altri invece, come lautore delle Ciprie o della Piccola Iliade, compongono unazione multipla su ununica persona o un unico tempo. Di conseguenza, mentre dallIliade e dallOdissea si ricava ununica tragedia, o soltanto due, da ciascuna, dalle Ciprie parecchie...
[Tr. di D. Lanza]21
Canto I Lazione si apre sul campo degli Achei, devastato dalle frecce scagliate da Apollo: [T1] il dio ha scatenato una pestilenza perch Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide, divenuta schiava dellAtride. Ai guerrieri convocati in assemblea, lindovino Calcante rivela che la sola via di scampo la restituzione di Criseide al padre. Agamennone acconsente, ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide, la schiava che Achille tiene nella sua tenda, come premio personale () ricevuto dagli altri guerrieri. Achille non pu opporsi alla prevaricazione dellAtride, ma non disposto a subire passivamente loltraggio e insulta Agamennone, anzi gi pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia, quando viene trattenuto da Atena apparsa allimprovviso: allora si ritira nella tenda giurando che non combatter pi [T2]. Quindi invoca la madre Tetide che, dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare, intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia finch Achille non ricever soddisfazione per loffesa subita. Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era, che, ingelosita, provoca una lite nel corso del banchetto degli dei: tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lilarit dei numi e riporta la serenit. Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia. LAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda ladunata dellesercito
20 Cfr. anche 1462b: (Questi poemi sono composti come meglio non si pu, e son il pi possibile imitazione di ununica azione). 21 Aristotele. Poetica, Milano, Rizzoli 19902.
-
Letteratura greca [1]
14
con lidea stravagante di saggiare lumore delle truppe proponendo il ritorno in patria. Gli uomini, incitati da Tersite, corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore. significativo che Tersite, lanti-eroe, riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone, sottolineando gli onori di cui questi gode, e prenda le parti di Achille [T3]. Per tutta la seconda parte del libro lazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellesercito acheo dal recinto delle navi: un quadro scintillante, ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi, il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi, laspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri. Un Catalogo delle navi contiene lelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allassedio ed seguito da un catalogo, pi breve e pi arido, degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio. Canto III Latteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo: Paride/Alessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao. Iride, la messaggera degli di, spinge Elena ad accorrere alle mura, presso le porte Scee, per assistere al preannunciato duello: di l Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura. Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata pi verosimile al primo anno di guerra) Elena nomina i pi prestigiosi campioni achei [T4]. Nel duello che segue, Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao, ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze, dove, dopo aver assunto laspetto di una vecchia filatrice, ordina a Elena di giacere con lui. Elena si ribella, ma la dea non transige. Mentre Paride ed Elena si uniscono nellamplesso, Menelao, furibondo, cerca fra la folla il nemico, che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli, pur di porre fine alla guerra. Agamennone, rivendicando la vittoria di Menelao, pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze, nonch il pagamento di una forte ammenda. Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallarciere Pandaro che, sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus), ferisce con una freccia Menelao: questi viene prontamente guarito dal medico Macaone, figlio di Asclepio. Agamennone passa fra le schiere, incitandole a combattere: incontra vari capi, intenti a dare istruzioni ai propri uomini. Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte, ricevendo i rimproveri di Agamennone, ai quali Ulisse reagisce con indignazione. Gli Achei muovono contro i Troiani, con grande ordine e disciplina, mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari. Ha inizio la battaglia vera e propria, nella quale lattenzione focalizzata sui duelli individuali. Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia, mentre Atena infonde coraggio nei Greci. Il canto si chiude sullinfuriare della battaglia, la cui descrizione riprender nel canto successivo. Canto V Balza in primo piano Diomede, di cui viene presentata l: leroe glorioso e chiaro fa strage di nemici, imperversando furiosamente fra le schiere troiane. Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro, il quale mena gran vanto del colpo andato a segno; Diomede, ottenuta unimmediata guarigione grazie allintervento di Atena, muove allora contro il nemico, che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea. Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede, ma lo scudo di questi regge il colpo, Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico. Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia, ma Diomede lo colpisce con un grande masso, fratturandogli il femore. Enea viene salvato dallintervento di Afrodite, che lo avvolge nel suo manto, mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea, che fugge sullOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione. Il figlio di Tideo attacca anche Apollo, che aveva sottratto Enea alla sua furia, ma
-
Letteratura greca [1]
15
fermato dal grido di ammonimento del dio. Incitati e aiutati da Ares, ora i Troiani avanzano con impeto. Intervengono Era e Atena, e questultima assume il ruolo di auriga di Diomede. Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares, che fugge sullOlimpo. Anche le dee vi fanno ritorno. Canto VI Il canto VI una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citer come dall di Diomede un brano della prima parte del VI canto). La battaglia infuria nella pianura, ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia, quando leroe, dopo aver sfidato Glauco di Licia, scopre di avere con lavversario antichi rapporti di ospitalit. I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco, a cui Zeus Cronide lev il senno, / ch scambi con Diomede Tidide armi doro / con armi di bronzo, cento buoi con nove buoi [vv. 234-6]). Frattanto Ettore, su invito dellindovino Eleno, rientra in citt, dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena, e incontra dapprima la madre Ecuba, poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia): vorrebbe salutare anche la moglie, ma non la trova in casa, bens alle porte Scee, dove Andromaca era accorsa piena dangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice. Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio. La replica di Ettore esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellagire dei personaggi dominanti: se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria, a questa motivazione (che pure non assente) Ettore antepone l, il senso di vergogna e di responsabilit nei confronti della comunit e del nucleo familiare di cui il difensore. Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte, ma lelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo, che si rifugia in seno alla nutrice. Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5]. Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello. Il sorteggio designa Aiace come campione greco. Nello scontro Ettore lancia per primo lasta, che penetra, ma senza trapassarlo, nello scudo di Aiace, greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina, simile a una torre); Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico perch Ettore si piega di lato. Allora i due brandiscono di nuovo le aste, poi ricorrono alle pietre. Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che la notte gi viene, ed bene obbedire alla notte (v. 282). Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea, difesa da un bastione, sul margine del loro accampamento. Respingono lofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta). Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione. Canto VIII Nellassemblea degli di Zeus vieta ai numi di appoggiare luna o laltra parte in conflitto. Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia, che piega a favore dei Troiani. Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore. Lazione di Ettore travolgente finch Zeus, contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani, accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei, che organizzano la difesa delle navi. Nel corso degli scontri si segnala larciere Teucro, che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio, che lo protegge con lo scudo. Incitato da Agamennone, egli prova a colpire anche Ettore, ma soccombe, colpito con una pietra. A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei, ma vengono distolte dalle minacce di Zeus, che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani, fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione, tanto da scongiurare Achille perch ritorni. Il sopraggiungere della notte
-
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti. Ettore, galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno, si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei. Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura, esaltati dalla speranza di vittoria. Canto IX Agamennone, affranto, propone di fare ci che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lesercito: interrompere la guerra e tornare in patria. Diomede si oppone e Nestore, in un consiglio dei capi, propone di tentare la riconciliazione con Achille. Si invia alla tenda di Achille unambasceria (composta da Aiace, Odisseo e Fenice, antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi. Achille non cede, anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6]. Inutilmente Fenice, lantico precettore di Achille, cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide, richiamando la vicenda delleroe Meleagro. [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille: egli torner a combattere solo quando Ettore sar arrivato fino alle navi dei Mirmidoni. Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille), poi uccidono il re trace Reso, appena arrivato presso i Troiani, e ne rubano i magnifici cavalli. Gi gli antichi ritenevano questo canto unaggiunta post-omerica, e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare. Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarr fino al canto XVIII), che ruota intorno all di Agamennone. Quando lAtride viene ferito, gli Achei ripiegano: Diomede resta anchegli ferito, Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici. Nestore salva sul suo carro Macaone. Achille, che dalla poppa della nave osserva la battaglia, vuol sapere chi condotto via da Nestore, e manda Patroclo, che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso: egli dice di deplorare il comportamento di Achille e, con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano, si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili. Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani. Eccitato dalle parole del vecchio, Patroclo si avvia verso la nave di Achille, ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli, impietositosi, lo accompagna alla tenda e cura la ferita. Canto XII Divisi in cinque contingenti, i Troiani danno lassalto al muro eretto a difesa del campo acheo. Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio: unaquila in cielo, con un grosso serpente fra le zampe, che riesce a ferire luccello e a sfuggire. Polidamante, che interpreta il segno come un presagio funesto, consiglia di tornare indietro, ma Ettore di altro avviso. Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia. La battaglia infuria con esito incerto, finch Ettore con un macigno sfonda una delle porte, consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo, mentre i Greci fuggono verso il mare. Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia, nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire; ne approfitta invece Poseidone, favorevole ai Greci. Assunto laspetto dellindovino Calcante, il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci,
-
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento. Gli Achei riconoscono lintervento divino e riprendono fiducia. I combattimenti si susseguono violentissimi. Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo. Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allimminente intervento di Achille. Ettore non ascolta lammonimento e riprende lassalto. Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio. Canto XIV Mentre Diomede, Odisseo e Agamennone tornano feriti allaccampamento, Era, per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei, indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullIda: dopo lamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potr aiutare senza rischi gli Achei. Ettore, colpito con una pietra da Aiace, resta a lungo in stato di incoscienza, e i Troiani vengono respinti. Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo: la prima allontaner Posidone dal campo di battaglia, Apollo inciter Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni. Riprende loffensiva troiana: Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo legida atterrisce gli Achei. Patroclo corre da Achille mentre i Troiani gi sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi. Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto. [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventurer oltre la zona delle navi. Ma Patroclo, trascinato dal suo stesso impeto, oltrepassa il limite prescrittogli da Achille. Abbatte Sarpedone, figlio di Zeus, attorno al cui cadavere infuria la lotta finch Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia, sua patria. Patroclo continua lassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia, ma poco prima del tramonto, al quarto assalto, Apollo stesso, assunto laspetto di Asio, lo percuote fra le spalle: allora Euforbo lo colpisce con lasta ed Ettore lo trafigge. Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo. Vigorosamente sostenuti da Aiace, gli Achei difendono il cadavere. Una densa nebbia scende sui combattenti. Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo. [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma. In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia; Menelao manda Antiloco, figlio di Nestore, a informare Achille della morte di Patroclo, la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici. Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille alludire della morte di Patroclo provoca laccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi. La madre gli promette di procurargli nuove armi. Poich la salma di Patroclo tuttora contesa, Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici. Efesto, su preghiera di Tetide, foggia le nuove armi, fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellesistenza umana. Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione. Achille convoca unassemblea dellesercito e rinuncia alla sua collera; Agamennone lamenta di essere stato accecato da Zeus e promette doni
-
Letteratura greca [1]
18
riparatori. [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato. Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma. Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte. [T11] Canto XX Zeus consente agli di di partecipare alla nuova battaglia. Enea, scontratosi con Achille, tratto in salvo da Posidone. Achille infuria come un incendio in una selva. Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo: non risparmia neppure Licaone, figlio di Priamo, che lo supplica con accenti di grande intensit; ma altrettanto intensa, nella consapevolezza di un destino imminente, la pur spietata replica del Pelide. [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde, ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente. Gli di si azzuffano: Atena raggiunge Ares con una pietra, Era rintuzza la furia di Artemide. Infine tutti tornano sullOlimpo. Apollo, assunto laspetto di Agenore, respinge Achille perch i Troiani possano rifugiarsi allinterno delle mura. Canto XXII Il solo Ettore resta fuori, nella pianura. Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare. Mentre Achille si avvicina, Ettore decide di affrontarlo, ma quando quello gli da presso, col bronzo che gli lampeggia intorno simile al raggio / del fuoco ardente o del sole che sorge, afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura. Zeus pesa sulla bilancia i destini (le ) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso. Allora Apollo lo abbandona e Atena, apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo, gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio. Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille: Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia, ma il falso Deifobo scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullorlo dellabisso [T13]. Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma: in risposta riceve la minaccia che finir in pasto ai cani. Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro; Priamo, Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio, a cui fanno eco le donne troiane. Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo, la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo. Il mattino seguente si appresta il rogo: fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani. Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo. Seguono i ludi funebri: gare coi carri e con larco, duello in armi etc. Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellamico, ma lo spettacolo offende gli di e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide perch induca suo figlio a restituire la salma di Ettore. Iride viene inviata presso Priamo perch gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto, scortato da Ermes, alla tenda di Achille. Questi accoglie il vecchio con rispetto, riconoscendo in lui limmagine del padre lontano, e si piega alla sua supplica. [T14] Per volont degli di il cadavere non stato aggredito dalla putrefazione: composto sul pianale del carro, viene ricondotto dal padre a Troia. Qui le lamentazioni rituali sinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca, Ecuba, Elena). Si stipula una tregua di dodici giorni. Per nove giorni i Troiani raccolgono legname, poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo.
-
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti, tranne pochi episodi isolati, ruotano attorno ai due principali antagonisti: Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo), pur se non privo di pi o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellopera, lIliade lascia emergere, in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende, alcuni caratteri delineati nella loro individualit, e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore, accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare. Appunto una tale attitudine a rappresentare i caratteri () dei suoi personaggi un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11):
... dopo aver brevemente proemiato, subito introduce un uomo, una donna o un altro personaggio, nessuno privo di caratterizzazione, ma dotato di un carattere.
Fondamentale per la struttura del poema la novit della prospettiva. Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare langolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana, s che pu riuscire significativo il confronto fra lesordio della Piccola Iliade (dove, muovendo da grandi entit la citt, il paese, due popoli, la guerra , viene lanciato, secondo lespressione di J. Latacz, come uno sguardo dallesterno):
. Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri, per la quale molti dolori patirono i Danai, servitori di Ares.
con lo sguardo interno che caratterizza linizio dellIliade:
, , , , , . Canta, o dea, di Achille figlio di Peleo la collera maledetta, che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagli allAde vite possenti di eroi, e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli, e si avverava il volere di Zeus, da quando primamente si separarono, venuti a contesa, LAtride sovrano di eroi e Achille magnifico.
Argomento non dunque, come doveva avvenire nella tradizione del canto epico, un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure, come sar nellOdissea, un personaggio colto nella multiforme variet delle sue peregrinazioni: invece una reazione emotiva (lira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei). Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (da quando), ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci: Agamennone, il primo per potere (sovrano di eroi), e Achille, il primo per nobilt e forza (). E sintomatica della bipolarit del mondo epico in quanto mondo di di e di eroi la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del volere di Zeus ( ), forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata pi oltre in questo
22 V. cap. II, La tradizione omerica.
-
Letteratura greca [1]
20
stesso canto, ai vv. 518-527) di vendicare laffronto subito da Achille o, pi in generale, con il corso degli eventi in quanto tutto, come per definizione, giace sulle ginocchia di Zeus. Opera indubbiamente allinterno del poema unidea formativa, un progetto: di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza, fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto. Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone, portando doni e supplicando la restituzione della figlia, e Agamennone lo respinge aspramente, minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare; nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille, portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio: Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v. 560 con Smetti di irritarmi, vecchio!) ma poi accoglie la supplica. E al di l delle corrispondenze nelle linee dellazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali: in particolare fra XXIV 501 s.
... , ... per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei, per riscattarlo da te, e ti porto compenso infinito
e I 12 s.
... ... costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia, portando compenso infinito;
fra XXIV 555-557
, , ... restituiscimelo, perch lo possa vedere con gli occhi, e accogli il riscatto copioso che portiamo, e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria...
e I 18-20
, , , , Atridi, e voi altri, Achei dai forti schinieri, a voi concedano gli di che hanno le case in Olimpo di distruggere la citt di Priamo e tornare facilmente in patria; ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto;
fra XXIV 560 (smetti di irritarmi!) e I 32 (non mi irritare!), fra XXIV 568-570
, , . Ora perci fra i dolori non mi eccitare lanimo ancora di pi: bada, o vecchio, che non ti lasci neppure nella tenda,
-
Letteratura greca [1]
21
bench supplice, e violi gli ordini di Zeus! e I 26-28
, Mai te, o vecchio, io colga presso le concave navi ora a indugiare o pi tardi a tornare, che pi non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio!
(e infine XXIV 571 , cos diceva, e il vecchio trem e obbediva alle parole ripete esattamente I 33). In effetti lepisodio terminale del poema, col superamento dellira ad opera della piet e del senso di unesistenza invasa dal dolore, si propone come il rovesciamento consapevole dellepisodio iniziale, che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della piet e del diritto dei supplici in nome della forza. Al rifiuto iniziale del dono/riscatto si oppone laccettazione finale, in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano: Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide); Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui, ma, dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni, torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare luccisione dellamico Patroclo, e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cos smisurato e patologico che pu essere superato solo con laccettare i doni di Priamo: non tuttavia per il loro valore duso ma perch in Priamo Achille riconosce lombra del padre lontano. Cos lIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallideologia del dono e dalla conseguente centralit assegnata allonore () come prezzo che qualifica il valore del guerriero, ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lidentit universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia, la malattia, la morte...) e i legami che uniscono padre e figlio, compagno e compagno, vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca, Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore). Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra, le lotte, lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellesistenza, graditi tanto agli di che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta, eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa. Molto del fascino delle battaglie e delle dellIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di l di esse (e al di l della stessa distinzione fra Greci e Troiani, vincitori e vinti) e che pu anche, attraverso le similitudini, lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie. LOdissea LOdissea () consta di circa 12100 esametri, divisi anchessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellalfabeto greco. Largomento costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca, esposte secondo un ordine che, entrando subito nel vivo degli avvenimenti (linizio del poema mostra Odisseo nellisola di Calipso), rievoca poi i fatti gi trascorsi e li ricongiunge infine, a partire dal libro XV (con larrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo, dove gi si trova Odisseo), in unazione unitaria. La trama del poema, i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti), si articola in tre parti: la Telemachia (canti I-IV), il Ritorno di Odisseo (canti V-XIII) e la Vendetta di Odisseo (canti XIV-XXIV).
-
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case, tranne Odisseo che, pur desideroso di tornare, trattenuto dalla ninfa Calipso nellisola di Ogigia. Gli di hanno piet di lui, tranne Posidone, irato per laccecamento del figlio, il ciclope Polifemo. Ma un consiglio degli di, assente Posidone (che si recato presso gli Etiopi), delibera il ritorno delleroe: si decide che Ermes andr subito da Calipso, mentre Atena si avvia verso Itaca, sotto laspetto del signore dei Tafi Mente, per incoraggiare il figlio di Odisseo, Telemaco, a tener testa ai pretendenti della madre, i proci (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre. Canto I Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente, nellassemblea popolare, chiede una nave per andare in cerca del padre, ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lassemblea. Grazie ad Atena, che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo), Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave, con cui salpa nel corso della notte allinsaputa sia della madre che dei proci. Canto I Telemaco e Mentore/Atena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone. Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei, ma nessuna su Odisseo. Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta, dove arriva la sera del giorno successivo. Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia. Il giorno seguente Telemaco chiede del padre: Menelao gli racconta il proprio ritorno, durante il quale aveva incontrato Proteo, il vecchio nume marino, che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellisola di Calipso. Intanto a Itaca i proci preparano insidie, meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno: Penelope ne viene a conoscenza, ma Atena le appare in sogno per confortarla. Canto V Dopo un secondo concilio degli di (in effetti un doppione di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lordine di lasciar partire Odisseo. La ninfa aiuta leroe a costruirsi una zattera. Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo in vista dellisola dei Feaci, Scheria, quando Posidone, di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi, lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera. Ma la dea marina Ino Leucotea, impietositasi, gli porge il proprio velo, sostenuto dal quale leroe giunge a nuoto alla riva di Scheria, dove si abbandona esausto, addormentandosi. Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena, Nausicaa, la figlia del re dei Feaci Alcinoo, si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle. Odisseo, risvegliatosi, atterrisce le fanciulle, che fuggono tutte allinfuori di Nausicaa. Leroe supplica la giovane di porgerle aiuto, ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena, poco prima della citt, esortandolo a presentarsi a suo padre. Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto, Odisseo entra nel palazzo: abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare; poi viene accolto con onore da Alcinoo. Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa. Leroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
-
Letteratura greca [1]
23
partenza dallisola di Calipso. Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente. Canto VIII Ma lindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale laedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo. Leroe si copre il volto per nascondere le lacrime: allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia. Poi Demodoco, al margine di unarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci, canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti). La sera, al ritorno nel palazzo, Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno: Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome. Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e d inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia: distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi; sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea; arrivo allisola antistante quella dei Ciclopi, dove Odisseo si trasferisce con una sola nave: esplorazione dellisola, perdita di alcuni compagni allinterno della caverna del gigante monocolo, accecamento del mostro e fuga. Canto X Odisseo giunge allisola di Eolo, signore dei venti, che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre: ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui perch i compagni (sospettando che nellotre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si sprigionato un uragano che li ha risospinti sullisola. Ripreso il mare, Odisseo trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi, il cui attacco priva leroe di tutte le altre navi tranne la propria. Con questa fugge fino allisola (Eea) della maga Circe. Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lisola, Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allerba moly fornitagli da Ermes. Resta un anno presso Circe, che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia. Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne, sulla riva dellOceano) e scavata una fossa, Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia. Le anime accorrono: dapprima Elpenore, caduto per caso gi dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura), poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza), quindi Tiresia, che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglier dopo una lunga vita, in un paese straniero che non conosce n il sale n il remo). Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e, bevendolo, riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza: immagina invece che Odisseo sia allinterno dellAde. In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato, di Minosse, di Orione, dei grandi peccatori, di Eracle. Poi Odisseo fa ritorno a Eea e, ricevuti i consigli di Circe, si imbarca per il ritorno in patria. Canto XII Scampato alle Sirene, che invano lo attirano col canto (si fatto legare allalbero della nave; i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera), passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed costretto dai compagni ad approdare, in contrasto con le prescrizioni di Circe, allisola Trinachia, dove pascolano le greggi del Sole. I
-
Letteratura greca [1]
24
compagni, spronati da Euriloco, se ne cibano nonostante il divieto delleroe. Il Sole, sdegnato, ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine. Tutti i compagni periscono ma Odisseo, che ripassa tra Scilla e Cariddi, si salva miracolosamente da questultima aggrappandosi a un fico selvatico finch il gorgo restituisce i rottami della nave; infine arriva, remando con le mani, allisola di Ogigia. Canto XIII Terminato il racconto, leroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe. Al risveglio, per la nebbia, non riconosce la sua terra finch Atena, in veste di giovane pastore, lo rassicura e poi, rivelatasi, gli d istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico. Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo, che, pur non riconoscendolo, lo accoglie ospitalmente, rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno. Canto XV A questo punto la Telemachia si riannoda allazione principale: Telemaco, che si trova ancora a Sparta, viene indotto da Atena a tornare a Itaca; sulla via del ritorno, a Pilo, accoglie a bordo lindovino Teoclimeno e grazie allaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci, sbarca a Itaca e si reca anchegli presso Eumeo. Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio. Intanto Odisseo, rimosso lincantesimo, si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco). Eumeo torna al suo stazzo. Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in citt, seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto laspetto di mendico). Davanti al palazzo Odisseo riconosciuto dal cane Argo. Entra e va mendicando tra i proci: Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello. Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro. Penelope, scesa nella sala, prospetta ai proci leventualit di un nuovo matrimonio. Odisseo insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo. Canto XIX Insieme con Telemaco leroe allontana le armi dalla sala, poi conversa con Penelope, che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riuscir a tendere larco di Odisseo: la prova avverr il giorno seguente, al novilunio. Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e, riconosciutolo da unantica cicatrice, sta per rivelarne lidentit, ma leroe la costringe a tacere. Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto. Giungono Eumeo, Melanzio e il mandriano Filezio. Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco. Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina.
-
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce larco nella sala: dopo che parecchi fra i proci, e lo stesso Telemaco, hanno tentato invano di tenderne la corda, Odisseo chiede di partecipare alla prova, tende larco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco. Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identit. Nella lotta che segue Telemaco, Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio). Tutti i proci restano uccisi, le ancelle infedeli sono impiccate, Melanzio viene mutilato e ucciso: soltanto laedo Femio e laraldo Medonte sono risparmiati. Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope, che durante leccidio dormiva ed stata svegliata da Euriclea. Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla verit finch Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale. Canto XXIV Ermes conduce allAde le ombre dei proci. Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellemarginazione, e si fa riconoscere. Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini: leroe ha la meglio e Zeus, scagliato il fulmine, pone fine alla battaglia. Atena, sotto laspetto di Mentore, stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36.
Struttura e caratteri dellopera Gi la