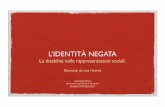Viaggio fluido Identità di genere e relazione di cura
-
Upload
alessandra-parroni -
Category
Education
-
view
104 -
download
2
Transcript of Viaggio fluido Identità di genere e relazione di cura
Alessandra Parroni
Con le narrazioni di Simona Pesciaioli
Viaggio fluido
Libero itinerario nell’identità di genere, la differenza sessuale e la relazione di cura
Introduzione
.
La vita di ognuno altro non è che una continua narrazione, un intrecciarsi di storie che raccontiamo a chi ci è vicino e in primo luogo a noi stessi.
Allo stesso modo qualsiasi tipo di psicoterapia è principalmente ascolto, analisi e attribuzione di significati, ricostruzione e amliamento dei contenuti tramite i quali ciascuno narra se stesso. E poi restituzione di un senso più ampio. Una tela sul cui ordito si lavora in due.
Dopo oltre vent’anni di lavoro come psicoterapeuta, ho sentito la necessità di una riflessone. Vent’anni di ascolto di tante storie.
Interpretare il racconto dell’altro vuol dire aggiungere a partire da sé, dalle proprie risorse, consce ed inconsce, incontrarsi in un comune processo associativo, cercare insieme nessi e risonanze. Le storie individuali sono inserite in contesti più ampi, culturali, sociali, storici, ma anche e soprattutto ancestrali. Spesso ne richiamano altre alle quali somigliano e che tutti conosciamo perché ci sono state tramandate dai miti e dalle fiabe e fanno parte della nostra memoria collettiva.
A volte sembra che il filo conduttore di una vicenda personale sia stato smarrito nei labirinti che la vita costringe ad attraversare e in cui ci si perde. Non si riesce più trovare il significato di alcuni accadimenti, quando, a volte improvvisamente, se ne coglie il senso e il possibile sviluppo in nuove direzioni, in un ampliamento della prospettiva, inaspettata apertura dell’orizzonte. Si manifesta così l’entelechia (1) che sottende ogni esistenza e la sospinge, per una sorta di “necessità”, verso la realizzazione della propria “parte” nel tutto, secondo quel “divenire ciò che si è” che Jung chiamava “principio di individuazione”.
Quelle narrate in psicoterapia sono storie di crescita e sviluppo, ma anche di perdita e minorazione, nella riduzione di sé ai minimi termini, quelli che, con il senno di poi, appaiono veramente indispensabili al proprio essere al mondo.
In questi casi il terapeuta deve esercitare la propria “arte di levare”, come la chiamava Freud. Eliminare cioè quanto è di troppo e appesantisce soggettività che sembrano smarrirsi nelle definizioni di sé date dagli altri, nell’assunzione di ruoli e obiettivi che non sentono propri.
In ogni caso quelle della terapia sono storie di trasformazione, di trasmutazione alchemica della “nigredo” ,il brutto, il “piombo”, le pesantezze, in “albedo”, chiarore, luce che rasserena, conforta, conferisce senso e indica una direzione.
Nel corso di una psicoterapia “sufficientemente buona” (2), anche gli eventi passati e la storia familiare vengono ri-narrati in una chiave diversa sino alla comprensione e all’accettazione del loro “essere stati”, in una progressiva presa di distanza. Questo processo si deve compiere qualunque sia stata la “gravitas” che origini e passato abbiano avuto, qualunque peso e condizionamento abbiano costituito per la soggettività, in un disvelarsi dell’individualità e libertà di scelta di ciascuno.
La narrazione autobiografica nel contesto terapeutico stimola processi attraverso i quali il soggetto esplora se stesso e le vicende trascorse, mentre al contempo si progetta e si rinnova. Prospettiva e nuovi orientamenti, anziché la sola “archeologia”, rispondono del resto alla domanda che nelle attuali società complesse è più frequentemente posta alla psicoterapia, a causa di un crescente disorientamento nel definire identità sempre più “liquide” ed evanescenti.
Seguendo la scia di questi temi mi è sembrato praticabile l’idea di trasferire alcune “storie” a una scrittrice affinche’ ci lavorasse con un diverso sguardo, da una diversa professionalità e che, ascoltandole da me che le ho ascoltate da “loro”, le mie “pazienti” (e di pazienza ce ne vuole e ce ne è voluta), le rinarrasse ancora, arricchendole di ulteriori significati e della propria fantasia, in una sorta di gioco delle scatole cinesi.
Entrambe convinte che le storie curino e che si debba aver cura delle storie, fra un argomento e l’altro apriremo allora delle finestre sulla vita reale e racconteremo le vicende che hanno preceduto l’ingresso in terapia.
Simona,durante una conversazione occasionale, mi comunica che, nel suo muoversi da un luogo ad un altro ,e mi pare di capire sia esterno che “interno”, sa sempre da dove parte e dove deve arrivare, ma non conosce mai le strade che attraverserà, quale sarà l’itinerario dello spostamento.
Questa sua osservazione mi è sembrata una buona duplice metafora, sia della psicoterapia che della vita stessa. Di tutte le cose che hanno un inizio e una fine.
Due punti di orientamento e transizione nella vita sono certi: la nascita e la morte. Nessuno di noi sa, quando viene al mondo, come arriverà al capolinea. Non conosce i sentieri, più o meno impervi, le strade o, se fortunato, le autostrade, che attraverserà per muoversi dalla nascita alla morte. Allo stesso modo non conosce gli itinerari e la loro percorribilità quando inizia un amore, un nuovo lavoro, una psicoterapia, una qualunque altra cosa.
Da questo assunto di base decido dunque di mettermi in cammino con Simona verso la meta finale della stesura di un testo. Sappiamo, in una sinergia di intenti, dove
intendiamo recarci, ma non conosciamo gli scenari e i “luoghi” che incontreremo durante il percorso,che ancora, in verità, ci è ignoto.
Ci mettiamo perciò in cammino con curiosità, desiderio di conoscenza, apertura ed ironia, virtù socratiche spesso dimenticate, indispensabili quando si affronta ogni nuovo viaggio.
1- L’entelechia è un principio metafisico, postulato da Aristotele, secondo il quale
ogni cosa vivente diviene secondo una propria interna necessità. Concetto poi
ripreso dal gesuita De Cassaude (vedi bibliografia) e da Ernst Bernhard,
allievo di C.G. Jung e fondatore dell’A.I.P:A. - Associazione Italiana di
Psicologia Analitica -. Secondo Bernhard, l’entelechia è il principio
organizzatore del processo di individuazione psichica, in quanto dotato di
progettualità prospettica.
2. Donald Winnicott parla di “madre sufficientemente buona” per descrivere quel
minimo di cure ed attenzioni materne necessarie ad un sano sviluppo psico-affettivo nella prima infanzia. (Non è necessario che la madre sia “perfetta”, ma “sufficientemente buona”).
Da uno a due
Mia bocca che dice le stesse parole tue
Altre cose intendendo…
Antonia Pozzi
Abbiamo scelto di raccontare storie di donne a testimonianza della più grande fatica che devono fare per strutturare la propria soggettività.
L’ottica nella quale ci siamo poste è quella della teoria della differenza
sessuale nel suo approccio decostruzionista (1) al linguaggio ed al
“neutro” universale, dietro ai quali si cela l’unilateralità del maschile.
Il linguaggio non è infatti uno strumento neutro, un semplice codice comunicativo, ma ha una genesi culturale e una valenza semantica attraverso le quali rispecchia fedelmente il modo di pensare e giudicare. Il pensiero umano è ostaggio del linguaggio poiché si può pensare soltanto ciò che esso permette di esprimere e nei limiti dei suoi confini.
Il linguaggio edifica modelli di comportamento, immagine, pensiero come categorie imposte, in tal modo diviene normativo. Ciò che si configura come distante dalla norma si definisce in negativo come mancanza e negatività: “…Il pensiero occidentale sente la nostalgia dell’uno. L’uno è il riposo del pensiero, in esso si può sostare. Si desidera l’uno come sfondo immobile che assicura la chiusura del tutto… il tutto del pensiero o il tutto del mondo. L’uno si chiude in se stesso” (2).
L’ordine simbolico della realtà, sotteso dal linguaggio e dal pensiero, si fonda sulla logica dell’esclusione e sul principio gerarchico: alla donna manca qualcosa e ciò la rende seconda di due, all’interno di logiche e gerarchie unitarie. L’altro sesso però, “per ciascuno il volto più affine allo straniero” (3), costringe a riconoscere e reintrodurre la differenza e ad escludere la gerarchia; l’umanità e le sue creazioni sono fondate su un’interna alterità.
Con il termine “identità di genere” si intendono le aspettative sociali e culturali riguardo all’essere di ciascuno biologicamente e anatomicamente maschio o femmina.
I processi di costruzione della propria identità globale nelle attuali società occidentali sono caratterizzati da modalità di elaborazione più lunghe e complesse e da una sorta di “liquidità”, per cui a una più ampia libertà di scelta si associa una maggiore incertezza. L’identità di genere è il nucleo organizzatore dell’esperienza psichica e della relazione con il mondo esterno.
Chi si occupa della psiche umana sa che le dimensioni interne del femminile e del maschile sono labili e complesse, spesso fluttuanti, e non si inscrivono nel dualismo rigido della struttura biologica e anatomica, ma non si può negare una specificità della soggettività femminile: il suo percorso di sviluppo psicologico si differenzia da quello maschile.
Gli “studi di genere” (4) sono completamente assenti dalla ricerca psicologica sino all’inizio degli anni ottanta. Per più di un secolo le teorie psicologiche si sono basate sul soggetto maschile (5).
Significativo è che Freud sia giunto a formulare una teoria dello sviluppo infantile unica per entrambi i generi, pur essendosi basato soprattutto sull’osservazione e l’ascolto di donne. Del resto fu il primo a parlare di “indicibilità” dell’esperienza femminile, soprattutto per quanto ne concerne la sessualità e l’affettività, tanto che la definì “un continente oscuro”.
Anche i contributi femminili al pensiero psicoanalitico, come quelli di Anna Freud, Marie Bonaparte, Helene Deutsch, Karen Horney , riconducono la donna a una mancanza: ella è non-uomo, definita per negazione.
Nel pensiero junghiano, e soprattutto in alcuni lavori di psicologhe analiste come ad esempio Hester Harding (6), l’ottica si modifica a partire dalla constatazione della presenza intrapsichica in ciascun individuo di aspetti femminili e maschili , chiamati“Anima” ed “Animus”, “Eros” e “Logos”. Inoltre grande spazio e amplificazione trovano nel pensiero della studiosa i miti e i simboli del femminile, che informano e costellano lo sviluppo psichico e i percorsi esistenziali della donna.
Edificare una cultura del due, considerando l’importanza dell’altro da sé nella costruzione della propria soggettività, vuol dire restituire la parola al linguaggio e all’esperienza femminile soprattutto nelle loro valenze relazionali e corporee.
La rappresentazione del proprio corpo e, di conseguenza, del proprio sé si strutturano nella relazione primaria con la madre in un dialogo che è anche e soprattutto non verbale e fatto di fisicità. Successivamente però, in molti casi, il corpo della donna diviene estraneo a se stesso: o “parlato” o “parlante”. Parlato da altri, tramite norme e prescrizioni, troppo spesso parlante attraverso il sintomo.
Dei corpi selvaggi e inaddomesticati delle isteriche di freudiana memoria, corpi ribelli e inadeguati allo “spirito” del tempo, è rimasto ben poco, ma tutti vediamo ancora i corpi
scombinati delle anoressiche, quelli omologati dalla chirurgia estetica, quelli sofferenti di malesseri in altri modi “non dicibili”.
Restituire la parola all’indicibile vuol dire allora effettuare un movimento dalla passività del corpo, che si fa manipolare e modellare dall’ordine delle rappresentazioni, a un corpo soggetto del discorso: il corpo degli affetti, del piacere e del dispiacere, delle esperienze e delle passioni.
1- Il “decostruzionismo” è una corrente filosofica contemporanea (fra i
cui esponenti ricordiamo Michel Foucault e Jacques Derrida) che si propone,
attraverso un’istanza critica di revisione e rilettura della realtà, di de-costruire le
“immagini” (linguistiche, estetiche, concettuali, comportamentali, ecc.) che si
sono progressivamente edificate lungo il percorso storico-culturale delle diverse
epoche. Quanto ci appare naturale ed oggettivo è in realtà un prodotto storico e
culturale e costituisce solo alcuni fra i diversi modi di ordinare e pensare il
mondo che ci circonda.
2- Agacinski S., La politica dei sessi, Ponte alle Grazie, Milano1998, p.24
(Politique des Sexes,Paris, Seuil, 1998, trad. it. F. Bruno).
3- Ibidem, p.11
4- Gli studi di genere (“gender studies”) si propongono di verificare le effettive
differenze fra uomo e donna in vari settori. Ad es. i campioni scelti negli studi
prevalenti nella letteratura psichiatrica sono in ampia maggioranza costituiti
da uomini. I profili psicopatologici sui quali di conseguenza si costruiscono
ipotesi di ricerca e linee guida di trattamento sono commisurati alle
caratteristiche della popolazione maschile. Spesso si riscontra anche una
assenza di correlazioni fra variabili di esito e sesso.
5- Si vedano le critiche di Carol Gilligan (op. cit. in bibliografia) alle ricerche di
Piaget e Kohlberg sullo sviluppo del senso morale nella prima infanzia.
6- Harding H., I misteri della donna (1929), Astrolabio, Roma 1973 e
Ibidem, La strada della donna (1932), Astrolabio, Roma 1974
Madri matrici dell’essere
J hide myself within my flower,
That fading from your Vase,
You unsuspecting, feel for me-
Almost a loneliness.
Emily Dickinson, Poems
Nel corso della pratica clinica ho avuto modo di osservare spesso quali diversi percorsi segua lo sviluppo individuale “in assenza di madre”.
La nostalgia è in questi casi il sentimento prevalente e a volte il “tema” centrale e portante di tutta un’esistenza.
Nei figli adottivi e in coloro che sono precocemente rimasti orfani di madre l’Io frequentemente sembra essersi costruito intorno a un vuoto e con la percezione di esso fare i conti. Questo è particolarmente vero per le donne. La ricerca di qualcosa o qualcuno che possa riempirlo contrassegna le scelte.
A mancare è l’immagine di sé, la sensazione di un’integrità psicologica e corporea. I vissuti sono frammentari, come se nel labirinto delle esperienze si fosse perduto il filo e non si riuscisse a ricomporre la trama del proprio essere al mondo. Ci si sente stranieri, privi di specchi in cui riconoscersi.
Inizia allora spesso un nomadismo volto al reperimento di una possibile origine, qualcosa o qualcuno con cui ci si possa identificare, che assicuri sicurezza, calore e integrità.
Nei sogni compaiono case sconosciute, piene di stanze chiuse, soffitte o cantine ingombre di oggetti appartenenti a un passato del tutto ignoto.
Armadi colmi di abiti propri o altrui, talvolta calzature di vario genere - che indicano come camminare nella vita-, libri sapienziali o di fiabe, giocattoli amorosamente acquistati da sconosciute mamme premurose.
Si parte insieme per un viaggio verso la propria matrice.
Nel caso dei figli adottivi capita che la partenza divenga reale. Tornano nel paese in cui sono nati con grande emozione e smisurate aspettative: di ritrovare un parente, qualcuno che li ri-conosca o gli racconti la propria storia.
In altri casi, quando si è perso un genitore, in particolare la madre, troppo presto per conservarne se non frammenti di memoria, la partenza è simbolica e l’itinerario è fatto di fotografie, narrazioni, aneddoti familiari.
L’assenza ha creato un vuoto biografico che si spera di colmare, un “buco” nella trama di una storia che niente e nessuno può del tutto riparare.
Si cerca un rifugio, un luogo dove andare.
Questo rifugio è un volto, una fisionomia che appaia familiare. Il volto perduto di una madre quasi onirica di cui si è smarrita la memoria, un corpo che la rappresenti.
Gabriella, da bambina magicamente spera che la madre morta scenda da un treno e si ricongiunga a lei. Nell’adolescenza si innamora di una giovane insegnante, in un rispecchiamento che le dà valore, nel tentativo di ritrovare la dimensione di verticalità in un modello adulto di sé che le è mancato.
Lucia cerca il suo vero nome, il nome dell’origine, quello con il quale la madre, prima di abbandonarla, l’ha nominata: la parola e il “discorso” della madre.
Si rincorre il ricordo impossibile di un calore sconosciuto, una sicurezza primaria necessaria e del tutto ignota. Nessun successivo abbraccio, nessun riconoscimento riuscirà a stemperare l’incontenibile nostalgia, il vagheggiamento, l’anelito.
La madre è morta o per sempre perduta nel corpo come nella parola ormai difficile da articolare, la sua e insieme la propria identità divengono misteri insondabili.
La soluzione, quasi obbligata, è per Gabriella l’amore per/di un’altra donna, la possibilità che l’omosessualità le offre di “ritrovare il corpo della madre”; riflettersi in un’altra per trovare se stessa e superare così anche la morte della nonna, riedizione del lutto primigenio e perdita dell’unico legame con il passato, la propria nascita, la memoria di sé.
In tale modo chiude il cerchio. Il serpente si morde la coda e l’inizio coincide, nella narrazione e costruzione di sé, con il punto di arrivo. Il suo processo di separazione-differenziazione non può avvenire se non per tramite di una donna, che rievochi la presenza della madre perduta per sempre e smarrita in un doloroso oblio.
Per Lucia è il viaggio in India, alla ricerca delle radici e di un nome. Altro sa che non troverà, ma la terra, il luogo di origine, diviene per lei un sostituto simbolico della madre, una Madre più grande, capace di accoglierla e contenerla, per poi tornare dalla “piccola madre” adottiva con gratitudine e “in pace”.
Fin da bambina ha cercato un contesto all’interno del quale collocare la propria esistenza. Si è sentita estranea all’Italia, ai nuovi genitori, ai nonni. Ferite dolorose, aperte e doloranti, hanno ripreso a sanguinare a ogni altrui domanda, ogni frase incauta riguardante il colore della pelle, la diversità, la provenienza. Nessuna spiegazione è stata quella giusta ed è iniziato un percorso insidioso, privo di ogni possibilità di lenimento.
Persino la “corte” dei ragazzi, attratti dalla sua “bellezza esotica”, è stata accolta con diffidenza e chiusura.
Lucia dice di essersi sentita assolutamente sola, straniera, “nomade” nell’impossibilità di rintracciare il principio della propria storia; addirittura “non nata”.
Nelle fiabe e nei miti è un motivo ricorrente: spesso l’eroe, il futuro re, la bella principessa, sono orfani dalle origini incerte. Per compensazione, e grazie all’assenza di vincoli, questo consente loro un destino straordinario. Sono “figli degli dei”, portatori di istanze impersonali che favoriscono grandi realizzazioni. Non a caso a volte è un fiume, metafora del fluire incessante dei casi della vita, a condurli, abbandonati in una cesta, verso il loro futuro. Figli delle acque, privi di genealogia, appartengono al tutto più che a se stessi. Nella realtà, tuttavia, la ricerca dell’ “amore perduto” contrassegna la loro esistenza e permane come un motivo di fondo, una frattura da sanare.
Lucia ricomporrà la sua frattura scegliendo in seguito di studiare le lingue orientali. Si ricongiungerà simbolicamente alla madre biologica, sua vera matrice, “per tramite” della parola, apprendendone il linguaggio come fanno tutti i bimbi piccoli. Da lei non avrà feedback, segnali di ritorno e di incoraggiamento, sorrisi, sguardi, parole, ma svolgerà per lei dentro di sè il suo “lavoro di madre”, interiorizzandone le cure mancate, in un grande e doloroso sforzo di riparazione.
Il rapporto madre-figlia è frequentemente difficile e diviene spesso marcatamente conflittuale quando la figlia giunge all’adolescenza. Il confronto si caratterizza a volte come un durissimo “corpo-a-corpo”; l’ambivalenza reciproca si fa più evidente.
Quando la madre è adottiva un meccanismo di scissione consente l’estrema idealizzazione dell’immagine fantasmatica della madre biologica, che si configura come l’altro polo, in una guerra estenuante.
La madre “sostituta” accoglie su di sé un insostenibile carico di passioni negative, invidie, gelosie, rivalità. Facilmente è investita dei ruoli di “regina cattiva”, strega, matrigna tanto rappresentati nelle fiabe di ogni tempo, luogo e cultura. La ragazza “attacca” un legame che avverte come “disperante” con fughe, aggressioni, comportamenti inadeguati ed eclatanti, sintomi di un disagio diffuso e apparentemente insanabile. Si sente incompresa e non amata. Entrambe provano un sentimento di profonda delusione reciproca. In realtà è un mettersi alla prova nella reciproca possibilità di sostenere l’una i fantasmi dell’altra, al di là dei torti e delle ragioni di ciascuna.
E’ in questo momento che, se aiutate, si riconosceranno nel legame acquisito e si daranno vicendevolmente un’identità più salda.
La gestazione di una madre acquisita avviene tutta nella mente e a volte è il dolore avvertito come viscerale che contrassegna questa fase, a far sì che la donna quasi la sperimenti nel corpo, tramite sintomi come la nausea o disturbi al basso ventre. Del resto, come afferma Luisa Muraro “il rapporto madre-figlia (e con i figli in genere)…non è riconducibile per la donna ad un semplice rapporto familiare come sono gli altri…Quel rapporto è portatore della marca simbolica che rende significativa per una donna l’appartenenza al genere femminile” (1).
1- Muraro L., La folla nel cuore, Nuove Pratiche, Il Saggiatore, Milano 2000, p.222
Cerchi concentrici ovvero: Gabry sul nascere
Se , If
Se avessi saputo, Se.
Non sarei entrata mai, lì dentro. Oppure si, Se.
Se avessi saputo, If, avrei varcato quella soglia, subito.
Ma è tardi per trovarti adesso. Se avessi potuto avrei rinunciato…
Mai, a niente.
Se avessi creduto, If, avrei fermato la corsa. Sempre.
E nell’attesa, con il fiato corto, avrei respirato.
Se, If
In ogni breve attimo.
Il giorno fatidico, maggio, più o meno, mese prima, mese dopo, Gabry era seduta sul letto. Arrivava gente in continuazione a portare regali, pacchi enormi.
Non era Natale, non era il suo compleanno, non era proprio niente.
Eppure la gente, i parenti, gli amici portavano, come i Re Magi, doni da ogni parte.
Nastri, stelle filanti e non era neppure carnevale. Scatole enormi, confezioni di prelibatezze, cioccolatini, moto a corrente, bici con le ruote smaltate, bambole di ogni tipo. Alte, magre, bionde, occhi azzurri e verdi.
Tutto per Gabry che non capiva un accidente. Sembrava la danza dell’incomprensione. Due passi avanti e uno indietro a vedere quello sguardo attonito, vestito da notte, con il viso bianco muro, come i muri imbiancati da poco.
“Come sta ora?”
Come sta chi e perché deve stare. Cosa vogliono dire queste domande sceme e che risposta devono e vogliono ottenere.
“Mah!”
Era la frase silente di Gabry che continuava a non capire un accidente.
Eppure era una bambina già sveglia. Quattro anni e mezzo, cinque da compiere presto. Nessun intoppo, nessuna ragione per essere sveglia a quest’ora del mattino. Strano a dir poco. I sorrisi che vedeva erano freddi e pericolosi. Somigliavano alla data dell’assenza, più che a una festa.
E poi che diavolo di festa era.
Dalla finestra si capiva che era primavera. Le rondini cominciavano a fare quel casino infernale che presuppone qualcosa di bello. Ma il bello dove era? Perché la nonna aveva quell’aria ferma, statica a mo’ di statua di sale? I suoi occhi le ricordavano le visciole, quelle fuori della finestra, sull’albero. Quelle che di solito in quel periodo stavano al sole e lo zucchero sopra, a coprire.
Che cosa strana quei giorni strani. Incomprensibili. C’era l’odore della strada bagnata dalla pioggia da poco, eppure non pioveva. C’era l’odore di bruciato, eppure nessuno aveva cucinato. Era tutto fermo. La gente della casa parlava piano, come si fa in chiesa. C’era anche un vago odore di incenso. Ma nessun prete a cospargerlo. Forse, pensava Gabriella, detta Gabry, la messa era finita e lei aveva dormito e non si era accorta di niente.
Sospirava perché sapeva che poi avrebbe scoperto tutto.
Certo è che non pensava di metterci tanto.
Ci vollero trent’anni a capire che giorno era quello. Che fu. Quel momento.
Pensa che bastardata la vita ti fa, se ci si mette. Brutta stronza e puttana. Ti fa credere una cosa, te la veste da festa e invece è la fine.
Gran figlia di mignotta, con tutto il rispetto per chi fa quel mestiere.
Nonna Carlotta era piccola e curva. Aveva un sacco di anni quel giorno, ma anni dopo ne avrebbe avuti di più. Parecchi. Forse era vissuta così a lungo per proteggere il mistero che mistero, ad un certo punto, non era. Più.
Gabry certo bella era, un bel po’. Aveva più che altro lo sguardo accattivante e i difetti si mischiavano ai pregi talmente bene da confondersi. Nonna Carlotta era un po’ avara di complimenti. Sembrava un generale di fronte al nuovo plotone. Criticava tutto. Il suo modo di esprimersi, le parolacce. Figuriamoci le bestemmie. Quelle non si dovevano dire, ma a Gabry sembrava giusto anche quello: perché portare tanto rispetto a chi giocava al gioco delle tre carte? Per quale motivo si doveva essere gentili con chi, di sicuro, ti aveva fatto un brutto scherzo e perfino tradito?
C’era un mistero, grande parecchio. Qui era tutto un segreto. Non si nominava più la donna bella e sfortunata.
Un giorno Gabry faceva un disegno per la scuola. Doveva partecipare al concorso “disegna la tua mamma” per la festa di tutte le mamme, anche quello un maggio.
“Ah!”
Pensava in silenzio.
“E che mi invento?”
Forse, se il titolo fosse stato “disegna tua nonna”, avrebbe vinto il primo premio. Ma qui dove si doveva mettere le mani? Come è fatta una mamma, davvero? Ha il viso da vecchia o è ancora una bambina? Quanti giri fa una boccia? Più o meno la stessa identica difficoltà. Più o meno. Qualche anno fa.
Il fatto è che Gabry mica si arrendeva facilmente. E provò. Buttò via fogli bianchi stropicciati. Accartocciò figure estemporanee. Era come inventare. Era bello inventare. Qualche sua compagna di scuola ricalcò la foto della madre. Un gioco di specchi. Bastava la luce o, meglio ancora, il controluce. Si vedeva in trasparenza e il gioco era fatto. Che boiata! Così era tutto troppo facile. Lei, invece, doveva proprio inventare, immaginare e poteva farlo in modo strano.
Provava a fare il suo stesso viso. Un po’ più lunghe le gambe, di più il seno e gli occhi più seri. Era evidente e chiaro. Chiaro che una madre avesse gli occhi seri. Mica stava al parco giochi. Aveva fatto un bambino. Aveva sofferto e gridato tanto. Aveva l’alito pesante perché, quando si sta male e si soffre, viene in bocca la puzza di metallo. Uno i denti non ha voglia di lavarseli tanto. Quando sta male. Per carità, si lascia tutto come sta. Tanto a che serve, in quel momento?
Infatti quando Gabriella era cresciuta di più, le accadeva di provare strane sensazioni, brutte pure. E allora che senso aveva cospargersi di creme e profumi come le sue amiche? Anche il sudore era più intenso e, se sniffavi, morivi di sasso. In quel momento. Quel momento era stato lungo, anche tanto. Si sdoppiava, si vedeva dall’esterno, come fosse un’altra e non si riconosceva.
Andava a lezione di flauto e non le piaceva un granchè. Era stanca di troppa concentrazione. Doveva fare qualche chilometro, forse due o tre per tornare nel giardino di casa. La strada pesava. E non erano le gambe o la schiena. Era soltanto la testa che se ne andava sempre in giro, quando avrebbe dovuto restare. Lì.
Piano piano era freddo, poi caldo, la luce troppa, intensa fino a far male. Tutto si confondeva e perdeva i contorni o era troppo netto e definito.
Si specchiava in una vetrina e vedeva il suo viso e la sagoma del corpo. Poi ripeteva il nome a voce bassa, dentro il cervello.
“Gabriella, Gabriella detta anche Gabry”.
E lì cominciavano le rogne e i problemi. Portava il gioco all’estremo e perdeva il concetto.
Gabry. Gabriella. Questa è la tua faccia. Quella che, fino a un momento fa, non ti era sconosciuta come adesso: Strana, strana, strana. Gesù mio, fammi tornare da me. Da chi? Da te?
No. Non voglio. Tanto ora mi passa e tutto torna normale e vado a studiare nell’orto. Lì c’è l’insalata, ci sono i pomodori e so che cosa sono. Sono rossi e c’hanno la fogliolina in cima e nonna li annaffia ogni giorno. E io adesso torno là e tutto finisce. Anche ‘sto modo idiota di guardarmi allo specchio. Non ripeto più il nome e torno da me, e là nell’orto.
Era un problema perché, certe volte, quando durava troppo, le veniva anche da vomitare. Le girava la testa. Si sentiva le gambe molli e le tempie gelate. Correva dietro la nuca un brivido infernale: Le sembrava di morire e invece continuava a vivere. Sopravviveva ogni volta. Di più: Perché poi, quando finiva la sensazione, aveva voglia di correre e non sentiva la fatica. Parlava con chi incontrava con una certa disinvoltura. Respirava a narici spiegate e l’aria entrava nei polmoni e tirava vento, lì dentro. Era finita, passata, conclusa.
“Uff!!! Che paura”.
Nell’orto sentiva la stanchezza della corsa e della battaglia vinta da poco.
Aspettava di vedere la nonna e raccontarle quello strano modo di sospendere l’esistenza.
La nonna non capiva. Carlotta era in gamba, ma di certe cose che cavolo ne sapeva? All’epoca sua non c’erano tanti fronzoli. C’era la guerra, la fame e la sete. Le cantine da raggiungere prima che cadessero dal cielo una miriade di banane infernali. Una volta Carlotta, ancora ragazza, stava stendendo i panni:
“Bumm!!!”
Una botta inaudita a pochi metri dall’acqua che sgocciolava l’odore di sapone di Marsiglia. Nonna Carlotta restò, quel giorno, ferma. Fu la prima volta che si bloccò. Non le vennero neanche più le mestruazioni.
Per un po’. Poi a quarant’anni cessò di avere quel disturbo fisiologico di essere donna. Non ebbe più figli e forse era meglio, perché faceva solo femmine e i maschi non volevano venire. E nonno Bruno insisteva e invece se la prendeva nel secchio, perché nascevano tutti neonati senza ciondolo.
“Ah, Ah!”
Nonna Carlotta, fra una doglia e l’altra, se la rideva perché, certe volte, era davvero spiritosa. E nonno s’incazzava. Era suo marito e voleva un maschio cui lasciare i geni e la terra. Invece doveva accontentarsi di surrogati, piccoli corpi rosa fasciati. Fra cacche e pipì. Storceva il naso e poi amava come sapeva. Bene e parecchio, fino all’ultimo istante in cui era restato.
“Ora, mia cara Gabriellina, io, se continui con questa storia che ti senti strana e male, ti porto dal dottore. Immediatamente.”
E scandiva quella parola, dottore, come fosse una minaccia, invece che una cosa da fare. Obbligatoria. Gabry da una parte voleva perché aveva paura di quelle brutte malattie del cavolo e, dall’altra, preferiva rimanere nell’orto a pensare a quello strano disturbo. Pensava, magari mi innamoro e mi concentro su altro e così guarisco e non faccio più la strada da sola.
E arrivò il tempo di tutte e due le cose. Però, a turno. Prima l’altra e poi l’una. Al contrario.
A dieci anni non andava mai in giro da sola. Si faceva accompagnare perché, se le fosse capitato di avvertire soltanto l’inizio di quell’andarsene via, avrebbe parlato forte e detto parole a raffica. E tutto sarebbe passato.
Poi, addirittura, si innamorò. Strano anche quello. Però.
Un ragazzo, compagno di scuola. Il primo giorno delle medie, sedeva dietro di lei. Era gonfio, sembrava avesse il labbro leporino. Invece, a ricreazione, Gabriella scoprì che era stato punto da un’ape.
Il giorno dopo era quasi normale e il giorno dopo ancora era splendido da morire. Un brivido e il suono scemo delle campane.
In testa, durante l’interrogazione, Gabry odiava essere in classe con Carlo.
Perché si vergognava di fare figure brutte e belle, anche.
Lui la guardava, ci avrebbe messo la mano sul fuoco.
Tornava a casa e pensava che sarebbe stato bello baciare quella bocca di gesso. Dura e compatta. Di maschio. Il primo che capitava. Carlo era anche più grande perché era stato bocciato.
“Brava, ma sì invitalo alla tua festa, fattelo amico… Almeno anche tu ripeti l’anno. Scegli sempre il meglio per te, vero Gabriella? E poi che cosa sono queste stupidaggini. Sei una bambina: Tu devi studiare. Questa non è certo l’età per pensare all’amore. Tua mad…”
E lì c’era il blocco. Un blocco barriera. Una diga poderosa sul lago artificiale. Una chiusa. Chiuso il discorso, interrotta la parola.
“Nonna cosa stai dicendo? Perché non continui?”
E non c’era risposta. C’erano solo piatti da lavare e sbattere con tutta la violenza quelle insulse ceramiche abbandonate. Regalo di un matrimonio finito.
Ambra e Felice si erano sposati negli anni sessanta e avevano pensato bene di fare in modo di ritrovarsi subito Gabriella fra i piedi.
In viaggio di nozze avevano consumato, forse dopo una cena di pesce. Gabry era entrata nella loro vita, fin da quel primo momento di intimità. Non aveva dato neanche il tempo di proseguire per tirarsi le cose a volo e tradirsi. Felice aveva capito che Ambra era particolare, ma l’aveva sposata e se la doveva tenere. Poi era arrivata la guastafeste delle feste mai vissute e lui, cretino, c’era cascato. Tornava tardi e usciva a tutte le ore. Non parlava e, se lo faceva, sputava veleno. Ambra era assillante e le dispiaceva che quell’uomo non fosse suo neanche un pezzetto.
Magari una caviglia o un polso.
Tornava e odorava di profumo di donna. Lei, invece, amava il sapone, non usava niente di diverso.
E allora erano strilli infernali. Erano urla e improperi.
Erano giorni neri.
Poi la voce si era abbassata e Ambra aveva deciso di trovare una scusa buona per mendicare un po’ di coccole. Decise di ammalarsi e ci riuscì molto bene.
Poi decise di arrivare fino in fondo e tornare da dove era venuta.
Voleva chiudere un cerchio.
Il sonno non era sufficiente per uscire di scena, durava troppo poco.
E allora si spinse oltre e se ne andò per sempre e la piansero e la ricordarono come una donna bellissima e sfortunata.
Carlotta era anche riuscita nell’intento di fare da madre a una figlia scomparsa e ne aveva guadagnato una nipote da allevare da sola.
A Gabry non parlava mai male di Felice e della sua nuova donna. Perché avrebbe dovuto spiegare troppe cose e passaggi. Avrebbe dovuto fare la storia dei geni, spiegare i DNA e i casi che la vita può offrire. Allora copriva, taceva e cucinava da Dio per farsi perdonare di quella storia mai narrata che non aveva voglia di raccontare.
Gabry cercava sempre la spiegazione. Capiva che nelle poesie c’è sempre tanto dolore, ma anche che se fai una canzone ti aiuta a vivere. Fai una canzone triste, piangi e stai bene. Stai bene perché stai male e piangi contenta.
Gabry scriveva canzoni e leggeva poesie. Amava Pascoli e se lo sentiva vicino come un orsacchiotto sul letto. Aveva visto una sua foto. Lo aveva trovato grasso e ubriacone. Lo aveva trovato un tenero contadino fra aratri, lune e misteri. Lo aveva ammirato e aveva capito che leggere le biografie aiutava la vita. La sua e quella degli altri. Sentiva che quando uno soffre, poi diventa forse famoso.
Tutte queste cose, Gabry aveva capito.
E a lei, quando sarebbe toccata la sorte di diventare famosa e per cosa?
Chiudeva il libro di poesie e si sentiva ispirata. Tornava nell’orto, guardava il cielo e aspettava un segno dall’alto.
Gabry cercava in continuazione. Lo faceva tutto il giorno. E disprezzava non sapere. Curiosava fra i pomodori nella speranza di ritrovare ciò che aveva perduto, ma non lo sapeva o non se lo diceva. E cercava.
Ormai quel gioco di perdersi anche il proprio volto e il nome era noto, facile da fare e privo di paura. Il segreto dell’inizio, ormai, lo conosceva e sapeva anche come farlo smettere. Bastava respirare lentamente. Bastava far finta di niente e scrivere o cantare. Bastava muoversi in cerchio o correre o parlare con il cane del vicino. E la realtà tornava.
Fino al giorno di quel mattino, al liceo. Ultimo sforzo prima della maturità. La classe era diversa dagli anni precedenti. Nonna Carlotta aveva optato per un’altra casa e la scuola più vicina era a qualche chilometro di distanza. L’altra era lontana un’eternità. E’ vero, aveva perso l’orto, ma guadagnato un giardino più grande e poi quello era, sicuramente, il giardino che dava sulla finestra della casa di Silvia. Da Pascoli a Leopardi, era cambiata la casa ma non l’atmosfera. La muffa era un ricordo lontano e Carlotta era più tranquilla, un generale in pensione.
Gabry odiava i comandi e le imposizioni, anche un compito sembrava una violenza, ma poi si salvava con il guizzo di un’idea e fregava tutti, tranne se stessa. Fino a quella mattina.
Quella mattina arrivò la nuova insegnante di lettere al posto della prof Tressedi, affetta da una strana malattia che non le faceva più trovare neanche la porta della classe.
Gli ultimi giorni la Tressedi, odiosa pedante, vecchia insegnante, aveva un colorito giallognolo e lo sguardo perso nel marasma di un concetto, smarrito, da esprimere.
“Secondo me la bastarda sta male. E’ fuori di testa, non lo vedete? Sembra ubriaca e non sa più neanche chi è”
Dopo aver pronunciato la frase sentiva il brivido dell’appartenenza e, allora, provava a usare un’ironia sufficiente per uscire dal cerchio dell’emulazione. La paura di fare la stessa fine. Quella che ti fa dispiacere per qualcun altro di cui poco ti frega. Poi respirava forte e ne faceva l’imitazione. Tutti ridevano e lei stava bene. La prof , ancora male. Sempre di più. Fino a che andò in ospedale e più tardi al creatore.
Quella mattina, arrivava una supplente e la classe stordita, completamente in silenzio. I ragazzi pensarono a una dea, le ragazze a una smorfiosa e a com’era vestita e Gabry alla sua vita. Da quel giorno fino all’infinito ad un pensiero che le somigliasse davvero.
Una botta, uno schianto di tuono, altro che campane, quelle di Carlo, la prima volta,e non era amore, era una cotta. Qui c’era tanto da capire. Troppo per non ascoltare. Per la prima vera grande volta.
E da quel momento fu un’immagine allo specchio. Una che volava via, come zucchero a velo sul pandoro al primo morso, l’altra che restava lì, presente in classe per la prima volta.
Nel silenzio della novità, l’imbarazzo dell’incipit, qualcosa era successo.
Era come una strana riconciliazione con il passato bianco latte, evanescente in quel volto arrossato dalla frase di presentazione, in quegli occhi puntati altezza pupille di Gabry. Perché quando fai una lezione, devi fissarti su un volto, devi concentrare lo sguardo su qualcuno, altrimenti perdi la bussola e cominci a girare a vuoto.
Quel viso era Gabry, per la novella prof di lettere.
“Io sono la vostra supplente. Per quanto tempo resterò con voi non lo so. Dovremo condividere fatiche e letture, poesia ed interrogazioni…”
Silenzio e cenni d’intesa, mentre Gabry restava a guardare ed ascoltare estasiata, come fosse la festa del Santo. Quella creatura decisa e fiera parlava con un tono di voce che lei riconosceva. Forse era il suono della voce della fata di Pinocchio. Forse la mimica di Biancaneve. Forse la mamma della casa nella prateria. Fatto sta che Gabry credeva a quella messianica manifestazione dell’amore.
La lezione scorreva come un fiume che non incontra ostacoli. L’attimo era diventato, all’improvviso, eternità.
Ma era un’eternità già nota, un vecchio refrain, il sapore dei cibi buoni che sapevano di altri, in un gioco di rimandi.
Da quel giorno Gabry andava a scuola volentieri e le ore correvano morbide sulla lavagna, sul registro ordinatamente compilato. E quando Raffaella Catalano spiegava, si apriva un mondo di vocazioni. Fra guerre ed olocausti, Hitler, Ungaretti e Montale, Gabry saliva le scale e ritrovava pure il vecchio giardino, l’orto mai dimenticato.
“Abbiamo ricevuto la grazia. Domani vado ad accendere un cero, sei riuscita a prendere nove. Non posso crederci”
“Quanto sei spiritosa e sarcastica. Non ti passa mai la voglia di denigrarmi, vero nonna?”
“Denigrarti io? Ma se ti ho tirato su a mia immagine e somiglianza! Darei dell’idiota a me stessa, non ti pare?”
“Allora vorrà dire che non sei propriamente dolce con me. Trovi sempre parole che suonano brutto…”
“Ecco, per esempio, mi dovresti spiegare se questo è il modo di esprimersi. Suonare brutto. Forse sarebbe meglio suonare male, non ti pare?”
Gli scontri e gli attacchi erano il piatto del giorno. E più il tempo passava, più le generazioni subivano lo scarto. Anzi, forse il problema era che mancava l’anello che unisse le due catene. Erano vicine, ma non si agganciavano, mai.
Catene pronte a legarsi per un destino obbligato oppure incontri di malandati ferri arrugginiti. Accadeva, era il loro limite.
Dialoghi senza uscita, monologhi privi di senso, soluzioni momentanee. Parole, incomprensioni, strade incompiute.
Certo Gabry telefonava ad ogni cabina per sapere se Carlotta respirava o meno, ma più che una telefonata di cortesia e preoccupazione, sembrava l’attacco sferrato da dentro una trincea.
Dall’altra parte Carlotta bofonchiava risposte evasive e infastidite, come se le desse noia che qualcuno, compresa sua nipote, avesse eccessivamente a cuore le sue condizioni.
In un giorno di particolare stanchezza, o forse l’aveva fatto apposta, Carlotta perse, in qualche modo, il senno. Si svegliò la mattina ed iniziò ad urtare contro la realtà preferendole l’irrazionale, l’illogico, sfiorando la follia e i suoi corollari. Gabry si stava preparando per la scuola, eccitata come un bambino la vigilia di Natale. Aspettava il regalo e ripensava a quei giorni strani di doni inaspettati. Seduta sul letto a truccarsi, e via. Faceva colazione.
Aveva letto che Proust, da una semplice cucciata di biscotti nella tazza del tè, aveva tirato fuori un capolavoro eterno. A lei sembrava di chiedere alla vita molto meno, semplici banalità: qualche ora ad osservare l’angelo della classe, la dispensatrice di benessere. Ed un segno da parte sua: la manifestazione di una speciale predilezione.
E invece Carlotta aveva deciso di rovinare tutto e regalarle di nuovo pessimismo e paura di finire sola un’altra squallida, stronza volta.
Allo specchio si guardava compiaciuta e si preparava. Simulava espressioni accattivanti e sorrisi d’incanto. Tutto per la poesia. Per la poesia o per la prosa? Domanda che, come un trapano in funzione, sfondava le tempie, ogni minuto del giorno. Che le stava succedendo?
Bò. Era puntualmente la risposta che si dava. Cercava spiegazioni, ma era una vita che lo faceva e ne aveva trovate davvero poche. Su tutto e tutti, sulla prima volta, sul primo giorno, su quel letto quella mattina e i regali, su quel viso, sul concorso per la festa della mamma, sulle foto che non c’erano. Sul perché di tante domande. Sulle domande, sulle risposte. Sulle risposte alle domande.
Carlotta, intanto, cominciava il suo show, di prima mattina. Era un debutto.
“Allora?”
“Mi sto preparando, nonna”
“Ah,si. E per che cosa?”
“Per andare a scuola. E’ tardi, non iniziare a fare l’inquisizione. E’ semplice. Per andare a scuola e comunque per uscire bisogna, come saprai, lavarsi e vestirsi. Non posso andarci nuda. Capisci nona? Nonna mi ascolti o hai avuto una visione. Soffri di incantesimo?”
Carlotta sembrava un pesce nell’acquario al quale stavano togliendo l’acqua. Gli occhi erano opachi e le pupille roteavano passando dalla concezione del sistema tolemaico a quello copernicano.
“Chi sei tu, qui nella mia camera, davanti al mio specchio? E’ ora che la facciate finita di introdurvi in casa mia. Lasciatemi stare, sono una donna anziana. Tanto i miei soldi non li toccherete. Neanche i miei ricordi riuscirete a portar via. Al massimo vi prenderete il mio dolore, quello ve lo regalo tutto. Una povera donna a cui è morta una figlia giovane, per esempio…vi può bastare?!”
Lungo la schiena di Gabry un rigagnolo di acqua gelata, brivido che scorre senza ritegno. Avrebbe voluto fermarlo, perché tanto la nonna stava di sicuro scherzando. La scema si era messa a farle paura. Che palle quando si prendono gioco di te sulle cose serie. Che palle quando tocca ricominciare a stare male e non vorresti. Che palle stratosferiche.
“Nonna, che cavolo stai dicendo? Sono io. Tu stamattina hai deciso di prendermi in giro e farmi perdere tempo. Non ti interessa se faccio tardi a scuola? Devo chiamare un neurologo? Preferisci lo psichiatra? Scomodo direttamente Freud o ti accontenti di Jung? Dimmelo, è una tua scelta”
Gabry prendeva tempo e lo faceva con le parole. Si appellava a tutta la calma che non aveva, né avrebbe mai avuto. Trovava quegli occhi un incubo vero, di quelli terrificanti, che non riesci a muoverti e svegliarti.
Poi le era anche venuto in mente di mettere le mani addosso a quella strana creatura, scuoterla fino a farle riprendere la carica. Ecco cosa ci voleva! Un cazzotto in testa, in piena fontanella. Netto e deciso. Come si faceva ai televisori quando fanno le righe. Ma le righe facevano paura, perché non ci capivi più niente. Perché interrompevano il programma che stavi guardando. Poi, se andava bene, tutto tornava normale e potevi goderti il tuo film. Se andava male, invece, arrivava il tecnico e ti faceva spendere soldi. Se andava peggio, ti diceva di buttare quella scatola vecchia. Il tubo catodico era andato.
Forse a Carlotta si era rotto proprio il tubo catodico e se non fosse tornato tutto normale, altro che tecnico! Bisognava chiamare il dottore. Ma quale? Chi? Era sempre lei a sapere di cure e terapie. A sincerarsi che Gabry avesse fatto i vaccini, le analisi e le schifezze varie. Gabry era completamente impreparata a cambiare i ruoli e le sorti.
Sarebbe stata la seconda volta e non voleva che lo fosse. Pensava di essersi appena ripresa dalle vicende strane della vita. Voleva ricrearsi un mondo. Basta tutto ‘ sto casino perché era veramente troppo. Chi avrebbe preparato i pranzi e le cene? Chi l’avrebbe aspettata al suo ritorno? Chi avrebbe rotto le scatole ad ogni passo e momento? Chi accidenti avrebbe fatto tutto questo?
Le voci sembravano strumenti scordati. Quelle di entrambe.
“Nonna, se stai scherzando va bene. Alla fine ti lancio il posacenere e la finiamo qui. Se invece è serio quello che credi di vedere, allora chiamo immediatamente l’ospedale, ti faccio ricoverare e passa la paura che mi stai mettendo. Ok?”
Le parole che uscivano erano a sorteggio. Gabry avrebbe voluto essere gentile, ma rabbia e terrore giocavano brutti scherzi e mandavano a farsi benedire dolcezza e pazienza.
Quel giorno Gabry non andò a scuola, letteralmente tremò per molte ore. Arrivò un dottore con la faccia da pirla. La barbetta precisa contorno mento, la valigetta e il fonendoscopio che spuntava dalla chiusura di metallo. Entrò nella stanza di Carlotta e bubbolarono come l’inizio di un temporale. Per non farsi sentire, forse. Poi il mago di Oz uscì mentre Gabry era appiccicata alla porta, altezza serratura, per sbirciare ed ascoltare. Non voleva farsi vedere in apprensione da quell’orribile intruso, ma pendeva dalle sue labbra. Voleva un responso certo e sicuro, possibilmente definitivo.
“Lei è la nipote, vero?”
Le gambe, a volte, non svolgono il proprio ruolo. Non sorreggono, complicano le situazioni. Si liquefanno quando non dovrebbero.
“Sua nonna ha avuto un piccolo TIA e…”
Gabry sapeva che non doveva interrompere. Era la regola d’oro, forse una delle prime acquisite. Le pareva, però, adesso, di poter fare uno strappo alla regola. Del resto, contravveniva ad una legge trasmessa da chi si permetteva di provare a morire. Figuriamoci se non esisteva il diritto di recedere dal contratto.
“Mi scusi dottore, ma non ho capito. Mi perdoni, è grave?”
“Accade, ma sta già passando. E’ un attacco ischemico transitorio. Passa, ma ci vorrà cautela e delle cure”
Intanto Gabry riprendeva fiato e vita. Un po’, una porzione.
Nei giorni seguenti il Tia rientrò e Carlotta pure. Forse si era trattato di un avviso di scadenza, la rata da pagare per il prezzo della vecchiaia e di una vita non bella. La nipote era tornata nipote, non rubava e non si introduceva nelle case altrui, soprattutto in quella sua e della nonna.
Carlotta era un po’ pallida e aveva messo da parte l’accaduto. Chiudeva il discorso che apriva Gabry, con una certa insistenza, e diceva
“Ero stanca e allora il mio cervello si è riposato senza chiedermi il permesso”
Tutto qua. L’immonda paura ridotta a pallottola di carta.
A scuola la compagna di Gabry, Valentina, l’informò subito che la supplente aveva chiesto di lei e si era preoccupata per le sue vicende. Ma Gabry perse qualche altro giorno di lezione. Andava a fare la spesa, comperava le medicine segnate a Carlotta dall’orrido puffo e tornava a casa. Contenta per il pericolo scampato. E poi iniziava a sentirsi grande, matura e quasi autonoma. Più o meno. E questo le dava anche il diritto di riflettere sul suo caso specifico. I suoi malesseri, quelli con cui ormai conviveva, erano sempre più saltuari e ora non potevano certo permettersi il lusso di aggravare la situazione.
A scuola la supplente, angelo della letteratura, le si era precipitata addosso abbracciandola forte e chiedendole lumi sulla malattia della nonna. In classe, le inenarrabili vicende si erano ingigantite, occupavano tutto lo spazio delle stronzate. Gabry era stata la regista, il deus ex machina delle corbellerie. Per sentirsi più grande, importante e protagonista. La nonna per poco non moriva. Quella era un’incipiente forma di pazzia e lei rischiava di lasciare il liceo per occuparsi dell’anziana malata, suo unico affetto.
Sguardi di commozione e troppo pieno il fiume della solidarietà.
Gabriella, in fondo, si vergognava della manipolazione, ma era fatta così. Si guardava dentro e scopriva di dover cercare un modo per farsi amare.
Ne aveva diritto. Aveva il diritto di arricchire la realtà con la fantasia.
Immaginare immagini che arrivavano da sole. Riferirle senza argini.
Arrivò l’estate ed arrivò, inevitabile, la fine.
“Il prossimo anno non sarò con voi. Torno dalle mie parti. Mi manca il mare e la famiglia”
Gabriella riassaporò tutto il marasma. Le arrivò il vecchio odore di bruciato. Pensò alle partenze e alle stazioni e le tornò uno sconosciuto bambino, che poi era femmina, che aspettava alla stazione un treno che doveva arrivare.
Per qualche tempo si sedeva sulla panchina rotta e sbiancata dal sole. E lì faceva il conto delle ore, guardava i passeggeri correre per non perdere il treno. Guardava quelli che scendevano e cercava una figura. Non c’era niente di particolare in quella ricerca. Niente. Non c’era neanche un volto specifico, una fisionomia. C’era solo il senso di smarrimento, il bisogno di trovare qualcuno che potesse assomigliare ad un fantasma, quello di una madre. E fantasticava, lei, e forzava le cose. Simulava un incontro e un abbraccio. Stretto, avvinghiante. Come quando si attacca la gomma alle scarpe o si scioglie l’asfalto sulle suole perché è caldo. Poi si alzava con la speranza delusa. Non si sentiva scema, ma sapeva che era tempo sprecato.
Quella mattina la supplente dichiarava i suoi intenti e dava inizio ad una nuova sofferenza, alla nostalgia preventiva. E il non capire perché ad ogni affetto corrispondesse una perdita.
Quel giorno a pranzo Gabriella restò in silenzio. Masticava e respirava svogliatamente.
“Non ti piace la pasta?”
“No, non è la pasta. Sono un po’ triste”
“Motivo? Un ragazzo?”
“Non dire stronzate”
“E sii più educata che non ti fa male”
E finiva lì il dialogo mozzo, iniziavano i pensieri incontrollabili.
Da quel giorno, dopo la fine della scuola, l’estate aveva assunto un tono dimesso e non si faceva sentire. Per niente.
Solo musica da ascoltare per farsi male.
Da quel momento Gabriella iniziò a riflettere su quanto la vita fosse difficile se la prendi di cuore. Sulla difficoltà di spiegarti perché ti accadono cose strane. E non capisci. Una donna al posto di un uomo. Uomo padre che non c’è. Una madre neppure. Una donna anziana che deve essere tutto a tutti e tre.
Un volto da cercare in un altrove. Per ridurre la pena. Fissarsi sull’idea che, da quel momento in poi, sarà la meta non scelta.
Ma è.
Non spiegarsi perché si sta così male e se è amore o mancanza. Se è un sentimento o un treno senza passeggeri. Se c’è soluzione accomodante o mare in tempesta.
Persa nei suoi pensieri, Gabriella continuò a cercare. Volti, corpi, abbracci, labbra e concorsi di disegno sull’ignota fisionomia di un ingresso. Su come è fatta una porta per entrare. Nomi di donna e carte di identità. Altrui.
Carlotta visse ancora tanti anni, perché lo doveva fare.
Poi anche lei decise, un bel giorno, di partire.
Quel bel giorno fu di notte. In un modo originale.
.
AAA. Cercasi
Sento che niente sono
se non l’ombra
di un volto imperscrutabile
nel buio
E per assenza esisto
Come il vuoto
Fernando Pessoa, Una sola moltitudine
Cercare dentro i secchioni non era propriamente un divertimento.
Cercare dentro i secchi dell’immondizia poteva significare essere folle o sporca dentro e fuori e affamata.
Lucia, che all’epoca aveva un altro nome, ogni giorno, a prescindere dall’ora che neanche conosceva, era costretta a dedicarsi a questa poco piacevole attività. Non erano uova di Pasqua con la sorpresa, che non sapeva cosa fossero, ma lì dentro ci trovava ogni ben di Dio o quasi.
Certe cose sapevano di schifo, a saper distinguere i sapori. Ma lei non lo sapeva, doveva solo riempire uno stomachino gonfio e scuro, con l’ombelico sporgente.
Lì dentro c’era anche da coprirsi, a volte. Un pezzo di stoffa, una scarpa, un ramo e un filo per agganciare i tesori trovati. E poi, se ti diceva culo, potevi anche trovare una base su cui sederti, per evitare gli escrementi che stavano in terra. Qualcosa dei tesori avevano in dotazione i cani randagi.
Scheletrici giravano veloci e usurpavano i suoi trofei. O Lucia usurpava i loro. Lottavano per riuscire a rosicchiare l’irriconoscibile cibo di sostentamento. E poi c’erano gli uomini. Quando Lucia trovava tesori succulenti, si metteva a correre perché nessuno li sottraesse, né uomini né bestie.
Quando calava la notte, Lucia, siccome era piccola, si infilava dentro uno di quei secchioni puzzolenti, svuotati ed ormai orizzontali. Le narici erano abituate, non si poteva andare tanto per il sottile. Non si poteva neanche parlare, bastavano i versi, come quelli degli animali, per far capire che il secchio era già occupato.
Lucia sognava, certe volte, belle situazioni. Di partire, andare lontano da quello schifo terribile, da quella solitudine. Sognava che qualcuno la aiutasse, la sfamasse ed addirittura abbracciasse la sua pelle scura, sporca e piena di buchi neri, bruciature di sigarette, più neri della pelle nera. La sua.
Chi l’abbracciava era sempre qualcuno di vero, autentico, non era soltanto un’immagine, era un corpo. Era una persona più grande di lei, alta più di lei, anche perché Lucia era bassa e sembrava più piccola di quello che, forse, era. Lei infatti non sapeva la sua età.
Chi l’abbracciava aveva la sua stessa pelle e capelli neri lunghi ai quali aggrapparsi e da lì piangere e ridere. Altro che il secchio puzzolente. Altro, che.
Chi la teneva per mano, nel sogno infinito di notte nel secchio, aveva mani lunghe e rassicuranti. Le dita si intrecciavano alle sue e formavano una trama mai provata. Chi la cullava, fra le sue braccia, nel secchio di sogno, era chi, in realtà aveva abdicato ad ogni velleità di madre. Costretta a farlo, senza possibilità di scelta.
All’alba la luce filtrava attraverso il grande, grigio coperchio del cassonetto ed ogni sogno svaniva. In un attimo, nonostante le poche energie, la scimmietta Lucia, magra come un ramo secco, si tuffava fuori con i piedi nudi in terra ed iniziava a farli camminare.
Poi vennero giorni diversi in una stanza che sembrava comoda e strana.
Al posto del secchio, un letto. Vero. E tante suore vestite di celeste. Altri bambini e colazioni con il latte e biscotti. Veri.
Un altro giorno un signore profumato di colonia arrivò con una donna, con i capelli quasi lunghi, sulle spalle, e un sorriso di quelli che si sognano la notte.
Lucia pensava di aver dormito troppo, di essere malata di avere qualcosa che non andava nella testa. Un sogno lungo un treno che non aveva mai visto. Un sogno veloce e lento come il volo di un aereo che non aveva mai preso.
Il rumore nella testa era assordante, forse era la fine di tutto. Quel qualcosa che qualcuno chiama morte. Dove la stavano portando quei due?
La donna la stringeva e lei si sentiva protetta. Ma chi era e cosa voleva?
Lucia, cagnolino bastardo in balia di mani sconosciute che afferranno e accarezzano finchè non ti scacciano di nuovo. Pussa via.
Il cagnolino veniva trasportato come chi non ha potere per decidere.
Però quella mano di donna era uguale al sogno sognato, solo bianca con lo smalto rosso. Era un paradiso o un’agonia quello che Lucia provava, e si confondevano.
I giorni di dopo avevano sempre quel sapore. I nuovi genitori avevano la casa bella, tante cose da mangiare e per lavarsi, la voce gentile, gli occhi buoni, giocattoli e vestiti rosa tutti per lei. Tanti, troppi.
Certe volte gridava e faceva i versi per far uscire il brivido dentro e tante cose che non riusciva a dire. Perché non conosceva quella lingua, che non era la sua.
C’era anche la televisione, che aveva visto per la prima volta dalle suore ed aveva avuto un po’ paura di tutte quelle immagini di gente che parlava e si muoveva, proprio come succedeva nella realtà.
Insomma, in quel periodo faceva tante cose che neanche riusciva ad aver paura, né fame o sete. Era come se tutto arrivasse prima di ogni richiesta.
La faccenda più curiosa era che non la chiamavano più India, come avevano fatto le suore, ma Lucia e lei presto capì che nessuno di quei nomi era il suo, quello vero, con il quale la sua vera mamma l’aveva pensata.
Altra novità era che adesso andava a scuola con altri bambini e c’era una signora che parlava ed era gentile anche lei e la chiamavano maestra o signora maestra. Lì c’era di che divertirsi, ma imparare era una gran fatica. Una volta tornata a casa mangiava e le veniva un gran sonno e allora faceva tutti i sogni più belli del mondo sul morbido che odorava di sapone e non di immondizia. C’era anche il cuscino per alzare la testa.
Poi i bambini erano diventati tutti più alti e qualcuno aveva cambiato voce e il pomeriggio venivano a casa sua a studiare e c’erano le merende della donna che chiamava mamma che erano davvero buone.
Ormai leggere, scrivere e parlare erano un fatto naturale. Come fare la pipì.
Alla festa dei presunti diciotto anni, in un giorno e in un mese di fantasia, c’erano tutti gli amici e quelli che si facevano chiamare zio, zia, nonno e nonna. Era riuscita bene, ma qualcosa era successo.
Fra gli amici, un ragazzo bellissimo che aveva la pelle come la sua. Lucia gli aveva chiesto di chiamarla India, ma solo di nascosto. Erano tanti anni che voleva di nuovo sentirsi chiamare con quel nome. E se poteva baciarlo ed avvertire un brivido, voleva dire che si poteva proprio fidare. Lui si chiamava Rajesh e aveva i capelli un po’ verdi davanti e neri dietro, sulla nuca. Aveva anche delle palline color argento sulla lingua e sul sopracciglio destro. Sul braccio un tatuaggio che mostrava con orgoglio. A Lucia non piaceva granchè quello scarabocchio e non ne capiva il significato. Ma la cotta passava attraverso altri abbellimenti, gli occhi verdi di Rajesh e la sua parlantina sciolta. Lui leggeva tanti di quei libri che, l’anno dopo, sarebbe andato di sicuro all’università e lei voleva seguirlo. Faceva certi discorsi seri che India Lucia provava a seguire, come Pollicino le briciole di pane. Ma era difficile e a volte si perdeva. Allora provava a tirare qualche boccata di quel fumo che lui era capace di preparare. Rollava bene una cartina,
spezzava il blocchetto duro e usava l’accendino. Faceva un giro strano con le mani. Era un artista provetto. Veniva fuori un siluro che dava spensieratezza e forza e ti faceva andare lontano.
Poi c’erano le parole, quelle belle e difficili. Rajesh parlava di filosofia perché aveva sempre otto e l’insegnante gli faceva i complimenti e poi lo sgridava di brutto per i capelli e il tatuaggio e le palline argentate.
Papà e mamma cominciavano a rompere un po’. Non è che ce l’avessero con lei, ma non volevano quel coso fra i piedi e la loro voce cambiava, diventava più dura e certe volte le dicevano di non farlo venire a casa a studiare e non la facevano neanche più uscire con lui.
Una sera Lucia, India, stava mangiando l’insalata. Aveva la nausea, le girava la testa. Sentiva il vuoto in testa e nello stomaco. Era come se le avessero tolto la linfa.
Gli adottivi parlavano, parlavano, parlavano. Lucia India cercava di partecipare al più e al meno e di mantenere il filo del discorso. Le sue mani però non trattenevano nulla, neanche la forchetta, figurarsi le parole. Sembrava che tutto si muovesse seguendo un ritmo alterato, prima al rallentatore, poi troppo in fretta. Non era una bella sensazione, perché Lucia si doveva mostrare normale e dare delle risposte che invece venivano fuori confuse e storte, come rami d’albero deviati dal vento. Era una fatica enorme essere così storta, ma restare finta dritta, fingersi attenta nonostante l’insensatezza, partecipe, ma invece annientata dal senso di fine dei giorni e dal vomito imminente.
Dopo tanti sforzi ed improvvisamente nessuna risposta a domande sempre più insistenti, il viso di Lucia India sprofondava inesorabilmente, irreversibilmente dentro il piatto fra l’olio e l’aceto, pesante come un macigno scaraventato fra verdi foglie di lattuga.
Stop.
Silenzio.
Nessuna parola in entrata o in uscita.
Silenzio di tutti.
Tutto sospeso.
Lucia si risvegliò sdraiata in un letto bianco più stretto del suo. Intorno uomini e donne bianchi di pelle e nei vestiti. Vicino c’era mamma con gli occhi bagnati. Non era proprio un’alluvione, sembrava un temporale appena terminato, l’odore di umido da respirare. Non parlava, le stringeva solo la mano con la stessa forza e tenerezza di quel giorno in aereo.
Gli altri parlottavano piano, sembrava rispetto.
Poi arrivò papà che aveva il viso tirato e pallido. Quando entrò nella stanza abbracciò forte mamma, si strinsero e qualcuno singhiozzava in un pianto a dirotto.
Tutti i signori bianchi che parlavano piano scomparvero e India sentì il profumo inconfondibile della sua immondizia che tornava a trovarla.
Sembrava un incubo. Invece era la realtà, ma provò a far finta di niente e richiuse lentamente gli occhi per non esserci, ferma come un sasso perché nessuno notasse la sua presenza. Respirava piano per restare in segreto.
“Mi spieghi perché si è ridotta così? Mi dici dove abbiamo sbagliato? Le abbiamo dato tutto, tutto quello e di più di quello che potevamo. Ma che le è mancato, che le manca?”
Papà piangeva come una fontana e si capiva anche a occhi chiusi. La scena era da brivido. Un male dentro, ma Lucia doveva restare in silenzio.
Da tanto aspettava la botta, quella famosa che aveva sempre portata con sé, latente. Era arrivata. E c’erano le parole da ascoltare. Sarebbero arrivate di lì a poco. E chi ce l’ha fatto fare, neanche è figlia nostra. E’ una bastarda, chissà chi era la madre, quella vera. Una disgraziata incosciente come lei. Sarebbe stato meglio se fosse rimasta dov’era…
Invece era soltanto acqua salata che sgorgava, per entrambi, papà e mamma abbracciati come rampicanti al muro del giardino, con i ragni che si impigliavano, l’odore di vaga muffa e dell’estate che stava per tornare, come sempre. C’era il mare che Lucia aveva visto grazie a loro, c’era la canna da pesca da lanciare, c’era la parolaccia per il filo intrecciato. C’erano ancora quelle mani che ora se ne stavano timidamente lontane, a cercare il loro perché.
Lucia sentiva che era necessario parlare, era troppo tardi per non dire. Bastava aprire la bocca secca e scartare le frasi cattive. Lasciare uscire le buone.
“Io…io…cercavo solo di…”
Gli occhi ancora chiusi, la lingua inchiodata al palato.
“Io… vi chiedo scusa. Non l’ho fatto apposta…”
Le parole di Lucia uscivano ora, fluide come liquidi. Avevano un so che di incredibile, lei stessa non riusciva a credersi. E dietro c’erano concetti a tutto tondo, chiari e ben esposti; nessun mugolio, grida indefinite, versi animaleschi.
“Non mi è mai mancato niente e voi non avete commesso alcun errore. Non ero abituata a tanto. L’unica cosa che mi manca, che mi è mancata è lei. Loro, ma più lei”
“Lei chi?”
Le domande cadono a terra con un tonfo, quasi ogni volta che se ne conosce la risposta. Ma, una volta partite, è difficile che restino sospese in aria. Anche quando si vorrebbe che tornassero indietro.
“Lei, mia madre. Quella ver…”
“Vera, vero?”
“ Ho fatto finta di niente per tanto tempo. Soffocavo, mi mancava l’aria, annaspavo e non ne capivo la ragione. Mi sentivo fuori posto. Sola in mezzo agli altri, anche con voi. Estranea. Poi ho compreso che avevo un gran bisogno di sapere da chi sono nata, chi era, o forse è, mia madre.
Ho tutto eppure c’è sempre il vuoto di un’immagine, un nome, un ricordo.
Niente. Cancellato dalla mente. Non so se qualche volta lei mi cerca, se mi pensa…e non ricordo neanche più l’India, gli uomini che mi spegnevano le sigarette sulle mani se non facevo quello che mi dicevano, se sottraevo il loro cibo… Io vorrei tornare lì, per cercarmi, per capire…”
Qualche anno dopo la psicologa ascoltava il racconto di Lucia, si vedeva che capiva. Captava anche il giusto tempo del silenzio, quando ogni parola era superflua. Sembrava capirlo, lei, che a volte la vita ha bisogno di risalire, di andare all’indietro.
Lucia aveva letto da qualche parte che i salmoni, quell’anno, per cause attribuite al clima, risalirono la corrente con tanta fatica.
Dopo un grande affanno in molti si dimenarono nelle reti degli uomini, non trovarono una via d’uscita e finirono nei piatti. Altri, raggiunsero la meta. Poi, cadde la pioggia, cambiò stagione e tutto ricominciò da capo.
Le madri e la psicoanalisi
“L’essere (o avere) corpo e l’essere (o avere) parola si formano insieme
e l’opera della madre consiste propriamente in quell’insieme”.
Luisa Muraro, L’ordine simbolico della madre
Tutto il pensiero psicoanalitico moderno post-freudiano si è sviluppato nella cifra del materno. Bowlby ha parlato dei modelli di attaccamento primario alla madre come matrici di ogni successiva modalità di relazione affettiva; Margaret Mahler, nella sua interpretazione dell’autismo infantile, ha postulato un’originaria simbiosi madre-bambino; Donald Winnicott la necessità di una madre “sufficientemente buona” per un sano sviluppo psicologico e cognitivo e ha identificato il corpo materno con il primo “ambiente” del bambino; Wilfred Bion ha messo in risalto la funzione di “reverie” materna come capacità di ospitare il bambino nella propria mente. Fondamentale è stato poi l’apporto di Melanie Klein, che ha teorizzato una primitiva scissione fra “seno buono” e “seno cattivo”, gettando così le basi per la comprensione dell’ambivalenza affettiva che caratterizza il rapporto con la madre.
Nessuno di questi autori si è occupato però di una eventuale differenziazione fra maschi e femmine per quanto riguarda i processi ipotizzati e descritti.
A partire dai primi nuclei identificativi pre-edipici, l’evoluzione dell’identità femminile segue ovviamente un percorso diverso da quello maschile. La bambina deve al contempo abbandonare l’oggetto d’amore primario, che è, come per il maschio, la madre e rivolgersi al padre, “disidentificandosi” da lei per raggiungere la sua autonomia di donna.
Le modalità di separazione-individuazione contrassegnano per la ragazza un passaggio difficile, che spesso non giunge a compimento per tutta la durata della vita.
Secondo Julia Kristeva (1) il matricidio simbolico, l’uccisione metaforica della madre, sono indispensabili per accedere alla separatezza ed all’affermazione di sé. La ragazza deve in sostanza ripudiare la propria madre, rifiutarla come modello, per poter trovare se stessa. Non sono altrimenti percorribili altre strade se non quella di una perdurante identificazione simbiotica.
Melanie Klein (2) evidenzia la paralisi della capacità di simbolizzazione nel caso in cui l’attaccamento alla madre abbia la meglio sulla necessità di separarsene, affrontando la perdita del primo oggetto d’amore. E’ la perdita, afferma anche la Kristeva, che spinge a simbolizzare la cosa perduta e consente il pensiero.
L’immaginario appare dunque, nelle concezioni della Klein e della Kristeva, fortemente dipendente dalle vicissitudini connesse alla relazione primaria con la madre e con il “dentro-fuori” il suo corpo.
Il maschio non perderà mai del tutto la madre, ritrovandola simbolicamente e materialmente in altre donne.
La” teoria della differenza sessuale” compie un balzo teorico notevolissimo perché afferma per il soggetto femminile la possibilità di “rimanere al cospetto della madre”, riconoscendone l’autorevolezza e superando l’ambivalenza, mantenendo comunque la capacità di distinguersi da lei e spostando l’amore sull’alterità costituita dal maschile.
La capacità relazionale verrebbe, secondo la Irigaray (3), enormemente potenziata dall’apprezzamento e dalla costituzione di “genealogie femminili”. La dialettica io-tu fra maschile e femminile ne sarebbe di conseguenza incentivata nelle sue potenzialità relazionali, non più conflittuali.
Fin qui, costrutti teorici forse anche di difficile comprensione per i “non addetti ai lavori”. E’ vero però che la psicologia della donna è senza dubbio del tutto differente da quella maschile.
L’identità di una persona è sempre sessuata; l’appartenenza biologica, anatomica e culturale a un genere o all’altro ne è certamente il principale fondamento. Il pensiero della donna, il suo modo di stare al mondo,a partire dal corpo, sono infatti peculiari e “differenti”.
La “teoria della differenza sessuale”, le cui più note esponenti sono Luce Irigaray per la teoria psicoanalitica e Luisa Muraro per la filosofia (4), pone al centro della propria speculazione la figura materna, al contempo intesa come madre di ciascuna e come “matrice simbolica” dell’esistente, “luogo dell’origine”: “La figura della madre è il rapporto con l’identico per ogni donna, ma anche con la differenza dell’altro da sé per ogni essere umano, sebbene diversamente per un uomo o una donna. Quello con la madre è insomma il rapporto in cui la dinamica fra identità e differenza è ineludibile nell’esperienza individuale”(5).
Restituire valore e autorevolezza alla madre, significa assegnare altrettanto valore e riconoscimento alla propria appartenenza di genere, operare un ribaltamento della trasmissione patrilineare e “patronimica” della cultura e dei saperi, sostanziando genealogie femminili.
Per comprendere pienamente le implicazioni teoriche di tale assunto è necessario introdurre sinteticamente il pensiero di Jacques Lacan, del quale la Irigaray era un’allieva, poi dissidente e scismatica.
Secondo Lacan, ogni soggetto è sottoposto a tre ordini: quello del Reale, del Simbolico e dell’Immaginario, la cui accessibilità è condizionata e resa possibile dalla funzione paterna, che è perciò di fondamentale importanza in ambito sociale e psichico.
In ambito sociale essa è inscritta nelle leggi giuridiche applicate alla genealogia, alla filiazione (patronimico, ovvero trasmissione del cognome in linea paterna), all’alleanza e, più generalmente, alla parentela. In ambito psichico, invece, la funzione paterna si inscrive in ciascuno/a, qualsiasi sia la realtà dell’uomo che incarna il padre: “E’ nel nome del padre che dobbiamo riconoscere il supporto della funzione simbolica, che dal sorgere dei tempi storici identifica la propria persona con la figura della legge”(6).
Affinchè l’individuo sia legittimato dalla funzione paterna, il “posto occupato dal padre” deve essere riconosciuto dalla madre: “Ciò su cui vogliamo insistere è che conviene occuparsi non soltanto del modo in cui la madre si colloca in rapporto alla persona del padre, ma dell’uso che ella fa della sua parola, diciamo il termine giusto, della sua autorità, in altri termini del posto che riserva al Nome-del-Padre nella promozione della legge”(7).
La madre ha integrato il Nome-del-Padre quando accetta che il padre, con il suo intervento, scacci il bambino dalla “posizione duale mortifera” (8), che consiste nel “prendersi per il fallo della madre” (9).
Il bambino nasce da un particolare desiderio ed è inserito, già prima della nascita, in una rete linguistica . Egli “non parlerà” se non a partire da tale rete, autentica catena significante. In tale catena, appare evidente che il testo inconscio preesiste e persiste ben oltre il testo conscio.
Nella sua relazione con il linguaggio, l’individuo non dispone, per quanto lo desideri ardentemente, dell’insieme dei significanti che lo hanno reso capace di parlare (l’ “Origine”, in Luisa Muraro), tale insieme è la risultante dei discorsi consci e inconsci dei suoi ascendenti (la genealogia, la parentela) ed è rappresentato dai padri, si trasmette per via maschile così come la cultura e il sociale, nei quali la storia del soggetto si inscrive. Egli dovrà perciò ripercorrere e superare, tramite il proprio desiderio, le tracce del discorso inconscio di cui è, a propria volta, un significante. Le diverse modalità di inserzione nella catena significante spiegano allora le differenze a livello della struttura psichica: nevrosi, psicosi o “normalità”.
Il sintomo ha per Lacan la funzione di esprimere la questione principale per l’individuo, in riferimento al posto in cui era collocato prima di venire al mondo “come corpo”, lo spazio simbolico occupato, il posto, dice Lacan, “pre-occupato”.
Il ribaltamento concettuale delle teorie lacaniane effettuato dalla Irigaray consiste principalmente nel fatto che l’inscrizione del soggetto nei tre ordini Reale, Simbolico ed Immaginario, avviene in verità per “via materna”, per tramite della madre, anziché del padre.
Il Luogo dell’Origine è per ciascuno il corpo della madre ed è soprattutto nelle sue reti di desideri e pensieri, consci e inconsci, e attraverso genealogie femminili che si configura il nostro spazio nel mondo, il “posto” che in esso occupiamo.
Lo stesso termine “generare” può essere usato nella doppia accezione di “mettere al mondo, creare” e “indurre, motivare a, muovere verso”. Generare conoscenza, saperi, competenze è la più precoce fra le attività materne, della quale spesso le madri hanno “istinto”, ma non consapevolezza.
Restituire autorevolezza alla madre vuol dire superare le attribuzioni contraddittorie di responsabilità-iperinfluenza e secondarietà-impotenza, espresse da tutta l’elaborazione teorica psicologica e psicoanalitica del novecento.
Nella restituzione di dignità alla madre “…la singolarità femminile si stempera nella somiglianza e cerca in essa quel valore, negato dall’autorità patriarcale e dai suoi codici societari, in grado di sottrarre l’essere donna all’insignificanza”(10).
1- Kristeva J., The Maternal Body, in “m/f” nn.5-6, 1981
2- Klein M., Invidia e gratitudine (1928), Martinelli, Firenze 1965
3- Irigaray L., Etica della differenza sessuale (1984), Feltrinelli, Milano 1985 ed
altre op. cit. in bibliografia
4- Muraro L., L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 1991 ed altre
op. cit. in bibliografia
5- Boccia M.L., La differenza politica. Donne e cittadinanza, Il Saggiatore, Milano
2002, p.83
6- Lacan J., Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol.I, p.271
7- Ibidem, vol.II, p.575
8- Ibidem, vol.II, p.576
9- Ibidem, vol.II, p.5761
10- Boccia M.L., op. cit., p.84
Volare via – L’eccesso femminile
“…Laggiù nel manicomio
dove le urla venivano attutite
da sanguinari cuscini,
laggiù tu vedevi Iddio
non so, tra le traslucide idee
della tua grande follia
Iddio ti compariva
e il tuo corpo andava in briciole,
delle briciole a devastare
sciami di rondini improvvise” Alda Merini, Laggiù dove morivano i dannati
A volte il desiderio è quello di volare via. Alleggerire il bagaglio, il cui peso è diventato intollerabile, e dislocarsi in un’altra dimensione al di là dei costrittivi confini del reale.
In alcuni casi, quando la fatica di vivere non trova risorse e l’Io ne risulta troppo impoverito, è suicidio, volontario o mascherato da incidente o malattia. In altri, delirio, episodio francamente psicotico o manifestazione eclatante di un grave disturbo della personalità.
Etichette, diagnosi per far rientrare, con forzature anche evidenti, la soggettività in un “quadro” clinico, in una cornice ciò che ne deborda.
Tale è stato il caso di Valentina, il cui rapporto con l’ “Angelo necessario” le è costato tre TSO (Trattamenti Sanitari Obbligatori), ovvero ricoveri presso i Servizi di Igiene Mentale, pesanti terapie farmacologiche e le conseguenze di un grave e invalidante incidente stradale (tentato suicidio mascherato?), che fortunatamente non si è concluso con la morte come nell’epilogo immaginato da Simona, ma poteva.
L’eccesso, il misurarsi con i limiti, sfidandoli, oltrepassandoli sono caratteristiche diffuse nei disagi psicologici più frequenti al femminile come l’alcolismo, i disturbi del comportamento alimentare ( anoressia, bulimia), gli episodi psicotici delle depressioni post- partum, le nevrosi ossessivo-compulsive, le dipendenze in generale, anche affettive.
A volte sembra che le donne per esprimersi non trovino altri modi che trasgredire ed eccedere la norma. La specifica “estraneità” femminile diviene allora comportamento da sanzionare o patologia da sanare.
L’eccesso spesso rappresenta l’ingresso in uno stato panico, in cui a prevalere sulla realtà e i suoi limiti sono l’indifferenziato e l’orgiastico, “baccanali” senza/oltre misura, durante i quali i confini dell’io sono annullati in una momentanea ed illusoria fusione (con-fusione) con il tutto. Ancora una volta a manifestarsi è la ricerca spasmodica di un assoluto, l’affermazione della totalità sulla separatezza, dell’appartenenza sulla estraneità, di un grembo protettivo, in sostanza, nel quale rientrare o dal quale non uscire. Un bisogno di nutrimento simbolico e di trascendenza. Le cause sono la solitudine, la percezione della propria diversità, l’assenza di relazioni significative.
Il delirio di Valentina è stato generato dall’isolamento e dalla perdita di contatto con altri coinvolti nel suo stesso codice affettivo. A mancare sono state le reti parentali che non hanno supportato il suo fragile e incompleto senso di identità, la continuità con se stessa una volta venute meno le figure di riferimento. Il suo “angelo”, come l’amico immaginario di molti bambini, è nato da una funzione proiettiva che ha creato un “doppio” per riempire un vuoto insostenibile.
La solitudine femminile è culturalmente definita come privativa. E’ un deserto senza meditazione, è vuoto assoluto. Mentre per l’uomo è spesso il frutto di una scelta consapevole e transitoria, dalla donna è subita e vissuta come definitiva e ineluttabile.
Non è uno spazio di elaborazione delle idee in senso filosofico né di riflessione sulla propria identità, ma anzi frequentemente ipostatizza la percezione di inesistenza e di privazione. Scrive Gabriela Marazzita:
“Il soggetto forte, quello maschile, non teme la solitudine, ne ha bisogno per individuarsi, ritagliarsi su uno sfondo e organizzare, in modo sistematico, il proprio pensiero”(1).
La solitudine è quasi sempre per la donna un abbandono, un lutto per le possibilità perdute, le potenzialità non realizzate.
Secondo Resnik (2) anche la psicosi è un lutto non elaborato; il delirio un tentativo di risolvere una depressione originaria. Quanto ai contenuti ideativi, nella maggior parte dei casi hanno a che fare con il “Sacro”, il trascendente, la rivelazione.
Alcuni studi evidenziano il nesso fra precoci esperienze di lutto e vocazione al misticismo (3): quando la perdita di un genitore, in particolare la madre, sopraggiunge nell’infanzia, può svilupparsi una penosa sensazione d’abbandono che facilmente conduce alla ricerca di un interlocutore eterno e immortale. Esempi celebri sono Teresa D’Avila, la cui vita religiosa iniziò all’età di dodici anni nell’immediatezza della morte della madre e Martin Buber, abbandonato dalla madre a soli tre anni. Attenuare il dolore della perdita è una strategia difensiva e consolatoria dell’Io. Oltrepassare i limiti
dell’individualità personale per espandersi fuori di sé in una comunione totalizzante con il divino è certamente la base antropologica di tante psicosi acute a carattere regressivo (4). La differenza fra autentica crisi mistica e psicosi risiederebbe nella capacità dell’Io di tollerare la complessità dell’esperienza e la sua “eccedenza” rispetto alla realtà.
Nella vita di Valentina a un certo punto si manifesta il “numinoso” (5) nella forma di un angelo che le comunica il suo nome. Si tratta di un “Angelo straniero”, Xeniel da “xeno”: estraneo. Come un “ doppio” rappresenta il suo stesso processo di estraneazione da una realtà di solitudine e progressiva emarginazione, divenuta ormai ingestibile.
Lo “straniero” che alberga in ognuno di noi indica la necessità di confrontarci con quanto ci è ignoto, di ridefinire la nostra identità. La psicoterapia interroga lo straniero, l’Ombra junghiana, per comprenderne il nome e il nuovo, la scelta e la via futura che archetipicamente rappresenta. Essere “stranieri”, estranei, vuol dire rinunciare alle certezze e lasciare spazio ad altre possibilità.
Xeniel è un angelo, figura alata che richiama Mercurio, Hermes, nelle sue funzioni di messaggero degli dei, messaggero dei contenuti psicoidi archetipici che, dall’ inconscio, stanno inflazionando il debole Io di Valentina fino alla tracimazione, allo straripamento nel delirio.
Caratteristica del Sacro è che contiene sempre un riferimento all’orrendo, al tremendo, alle potenze non controllabili dalla coscienza. Xeniel si presenta come un angelo custode, ma rappresenta anche il demone personale di Valentina, la sua incapacità di far fronte alle richieste del reale, di adeguarsi al suo Ordine.
L’aspetto immaginale, in casi come questo, sopraffà e inflaziona il soggetto, lo trascina nel vortice primordiale e caotico del delirio.
1- Marazzita Marsili G. in AA.VV., Imparare dalle donne, Comune di Terni Progetto
Donna Centro Culturale Virginia Woolf Università delle Donne gruppoB,
Tipolitografia Visconti, Terni 1992, p.120
2- Resnik S., L’esperienza psicotica, Bollati Boringheri, Torino 1986
3- Stanghellini G., Ballerini A., Ossessione e Rivelazione, Bollati Boringhieri, Torino
1992
4- Ibidem
5- Per “numinoso” Jung intende il manifestarsi di un Numen, ovvero di un contenuto
archetipico che irrompe nella coscienza con le qualità di un oggetto visibile e
l’influsso di una presenza invisibile e crea un particolare cambiamento nella
coscienza. Si vedano op. cit. in bibliografia
L’Angelo Straniero
Angelo di Dio, che sei il mio custode,
proteggi, custodisci, governa me,
che ti fui affidato dalla Grazia del Signore
Amen
Preghiera all’Angelo Custode
Valentina ha sempre avuto gli occhi chiari. Cerulei, come la carta d’identità dichiara e conferma.
Segni particolari: nessuno.
Valentina ha piedi lunghi come panfili. Le lentiggini rallegrano l’aspetto rigido e austero dei giorni dispari, solare e ridanciano di quelli pari.
Valentina ha un po’ di fidanzati, alcuni i giorni dispari, altri quelli pari. Ma nessun amore vero. Altrimenti, forse, ne avrebbe uno. Solo.
Valentina studia architettura perché pensa che le strade e le case siano importanti. Soprattutto le case che ti accolgono. Che sono come nidi. Che sono proprio tue. E colorate, possibilmente.
Lei gira per la città, spesso con un cappello che le trattiene le idee. Non le lascia scappare, perché le idee, se vengono, bisogna tenersele strette.
Quando si specchia nelle vetrine si trova bella e affascinante, alcuni giorni, altri si sente brutta da far paura, ridicola e scema. Non si piace e si detesta che sputerebbe su quel vetro maledetto che le conferma quanto la bellezza conti per sentirsi importanti e sicuri. In città come nel mondo. E il mondo e la città non stanno dando buoni frutti, anzi.
C’è la noia che spunta fuori dai tombini. Ci sono le giornate vuote e piene di niente. C’è la voglia di inventare qualcosa e leggere di situazioni irreali che ti rapiscono. E speri avvengano. Presto.
In città, come nel mondo, non accade poi molto e Valentina spera sempre di sbagliarsi, prima o poi. Meglio prima che poi.
Accanto camminano una madre e una zia. Una a destra, l’altra a sinistra e lei al centro. Come i gendarmi di Pinocchio.
Si somigliano tutte e tre. Sembrano pazze all’unisono, con il volto da folli. Gli occhi grandi, tutti cerulei, tranne uno, della zia Camilla che è nero, come la pece.
E’proprio da quel buco dell’ozono, quella zona vuota e troppo piena che esce la follia, la natura eclettica delle situazioni che Camilla vive e immagina. Valeria, la sorella, madre di Valentina, è diversa, un po’. Ha preferito darsi una regolata, fare una vita quasi normale. C’è riuscita fino a un certo punto. Si è sposata, l’uomo sbagliato. Ha fatto una figlia, sbagliata anche quella. Ha provato ad essere madre, non c’è riuscita.
Mai.
Neanche un secondo.
Lei era una bambina, ancora. Per tutta la vita.
Una pupa. Una ragazzina capricciosa, legata alle immagini che non erano.
Alle fantasie che sostavano.
Cambiava pannolini, bianchi e marroni, toglieva la cacca dal culetto di Valentina, ma era altrove. Era sulla rotonda a ballare, era sul palcoscenico a recitare, era dentro un sogno, a realizzarlo.
Era al centro dell’attenzione di tutti, era sopra una barca di pescatori a mangiare pesce fresco con l’amore della sua vita.
E non era.
Era al supermercato ad incazzarsi per i prezzi, per i soldi, che non aveva, perché non trovava quello che cercava e il latte l’avevano spostato nell’altro reparto.
La madre di Valentina era oltre. Viaggiava dentro pensieri solo suoi. E poi si ritrovava a spingere un carrozzino e parlare di vaccinazioni.
I gendarmi, ad un certo punto, cominciarono a lasciare la presa.
la stretta del braccio destro dell’una, sinistro dell’altra. E Valentina fece la parte del cagnolino con il guinzaglio scorrevole. Poteva cominciare anche a salire sull’aiuola da sola, con qualche metro di filo.
Mai ragazzi al seguito, poche amiche e tanta voglia di specchiarsi nelle vetrine. Le restava dentro il pensiero che da quei vetri sarebbe, prima o poi, uscita la sorpresa. Nell’immagine riflessa, almeno.
Almeno.
Riflessa.
Le vetrine negli anni si allungavano, allargavano e si prendevano lo spazio per poter esporre più merce. Dentro le commesse, fuori la gente che si specchiava, si aggiustava capelli, baveri e cravatte. Tutti a curarsi, a badare all’immagine.
Riflessa.
Valentina, crescendo, conservò la sua passione e il cappello a larghe falde, il basco, il berretto di lana modello coach in pensione.
Donavano alla sua immagine, riflessa, carisma e autostima.
Sola, ma sola perfetta. Bella a giorni alterni, brutta nei rimanenti. Dipendeva dalle vetrine, dai vetri più o meno fumè, dal glass, dal mare di specoli irrisolti.
Al termine di un’idea fissa cui non hai più pensato, sulla soglia di una decisione, quella di smettere di illudersi che qualcosa avvenga, prima o poi, sul cornicione dell’irresistibile desiderio di farla finita con un pensiero, il gran giorno si presentò arido e secco, come sempre. Però c’era qualcosa di strano, almeno un po’ inquietante, diciamo.
Un abile regista, il più famoso di tutti, tolse di scena i due gendarmi e lasciò Valentina, sola a specchiarsi. Madre e zia partirono per un lungo viaggio. Restava lei, una città, il mondo, le vetrine unica salvezza. E poi ogni cosa diventa racconto, fiaba, folletti e gnomi minuscoli che si insinuano fra la verità e vincono, sino a diventare bugiarde trasfigurazioni di una realtà. Cattiva. Una realtà intollerabile.
Accanto alla tomba di sua madre e sua zia. Le foto. Belle, ma già malate. I tratti somatici di chi ha sofferto in silenzio e c’ha saputo fare.
Un riquadro rotondo, una vita che è andata.
Via.
Volata chissà dove, tutti se lo chiedono.
I fiori e il marmo. Il freddo. Poi c’è la storia, più in là. Discreta e latente, ma fa piacere appartenerle. Ti fa sentire immortale, autentico e indispensabile, come un essere umano può credere di essere.
Niente, tutto finto. E’ passaggio di una nuvola.
Accanto all’umidità delle tombe, all’odore di erba tagliata da poco, accanto d’improvviso un uccello enorme. Misura umana, oltre. Ancora più grande. Immenso, disse chi lo vide, quel giorno.
Valentina soltanto, il privilegio dell’incontro.
Accanto, a dirle che la solitudine è come l’afa, il caldo torrido che sente. Una semplice percezione, un condizionamento e nulla più.
“Non temere, non temermi…”
Come da iconografia, come nell’Annunciazione.
A Valentina tremano le gambe mentre una musica lontana si avvicina e chiede permesso. Lei annuisce, impaurita ma pronta. E’ il suo momento.
“Chi sei?”
“Non temere…”, ancora. “Comprendo la perplessità, ma sono innocuo, addirittura benefico…”
“Che vuoi da me?”
“Non mi è concesso volere, scegliere, desiderare. Non ho il libero arbitrio, solo la necessità. Appaio. A chi merita l’incanto”
Non è sogno, verità raccapricciante di qualcosa che sta avvenendo davvero. Pennuto mastodontico ed altero. Uccello.
“Il mio nome è Xeniel, ho il suffisso degli angeli e il marchio dell’estraneità. Qualcuno potrebbe dirti che sono un demone, non credergli. Sono il tuo custode. Lascia che ti guidi, non sarai più sola.
Altro non dico, per ora. Sei di fronte a un bivio: lascerai una strada, ne seguirai un’altra. Tu puoi scegliere”
Valentina si toccava spesso la fronte per spianare un pensiero, ma quella volta il gesto non sortì il risultato. La mente collassata invasa da un’intensità difficile da sopportare.
Si era fatto freddo, ma non proprio. Qualcosa di simile, tipo ghiaccio e umidità. Ghiaccio umido.
Il becco era secco, quello dell’uccello. La bocca, le labbra di Valentina erano umide, perché la paura secca le fauci e bagna gli angoli, del naso e della bocca.
Mamma mia, mormorava fra sé Valentina. Eppure gli occhi di quel pennuto erano dolci e rassicuranti e lei provava una strana tranquillità.
Forse era il luogo. Ricordava quanto l’ospedale le mettesse il terrore addosso, mentre il cimitero le dava una sensazione di solennità e di pace ancestrale. Come un ritornare. A casa.
Da bambina, già grandicella, si divertiva a guardare le tombe e i loculi. Cercava le date, le piaceva osservare quanto brevi fossero a volte gli argini dell’esistenza. Nascere nel 1899 e morire nel 1905. Oppure nascere nel 1915, data poco rassicurante, e morire nel 27. Beffarda la vita, anzi, beffarda la morte quando acchiappa la vita. Oppure è giusto che sia così. Legge naturale. Per fare spazio, per ampliare le vedute, lasciare che la terra non sia troppo piena. Di tutto. E di niente.
La vicinanza estrema fra un inizio e una fine. Brivido che turba e senso di piacere. Malato, morboso? Ma cosa era sano, leniva, guariva, salvava?
Formica in affannoso cammino su una strada sconosciuta, non eri che un minuscolo tassello, una zecca sul grande cane. E tutto continuava ad essere, anche senza di te e senza di noi. Non indispensabili. L’orologio continuava ad andare, senza fermarsi. A prescindere.
Da te.
Da noi.
Tutto qua.
L’Uccello era diventato una catarsi. Era diventato il Significato e l’Occasione. Cimitero assonnato prima della chiusura, verso sera, d’estate. Un mare di calma, serenità.
Questo era l’Uccello e molto di più.
Era vera la storia dell’angelo custode, che ti sta sempre accanto e che se ti giri repentinamente a sinistra forse lo vedi. Un aiuto per vivere e, soprattutto, per non morire, dentro.
Finalmente Valentina non aveva più bisogno di frequentare gente, amici e conoscenti, parenti neanche. Erano quasi finiti e quelli che restavano non valevano un soldo bucato.
Se ne fregavano, in realtà, di che cosa combinasse Valentina in quella sua strana solitudine, di quel suo modo assurdo di parlare, da sola.
“E’ andata fuori di senno”, dicevano
“Povera figlia! Ha perso la madre e, subito dopo, la zia. Erano il suo punto di riferimento. Strane anche loro, però…ora è sola come un cane bastonato, non ha finito gli studi e forse non è neanche capace di cuocersi un uovo”
Ma erano preoccupazioni fittizie, false premure, senza un esito. Nessuno che la invitasse a un pranzo, una cena, un tè. Ospitarla si era rivelato un problema. A volte non si presentava, nemmeno avvertiva. Altre, restava in silenzio, ma il peggio era quando sciorinava le sue assurde teorie, quando pretendeva di vedere e sentire un angelo. Sotto forma di uccello.
Il suo modo di vivere e parlare metteva paura. Zio Carlo e zia Mirena si guardavano l’un l’altra e poi guardavano entrambi Valentina e il vuoto, a cui si rivolgeva. Imperterrita.
Gli zii cercavano di far passare il tempo senza scossoni, evitando gli ostacoli, ma era sempre più difficile rimanere indifferenti alla stravaganza, per usare un eufemismo. Le serate con Valentina duravano un’eternità nelle pause lunghe fra una frase e l’altra. Ma finirono, come ogni situazione sa fare. Finirono per non ritornare. Valentina non fu più invitata.
Valentina si accorse soltanto dell’assenza di contatti successivi e Xeniel liquidò la questione con un semplice “mi pare, in fondo, normale che accada”.
Per la verità lo zio Carlo trascorse alcune notti sveglio. Preoccupato di una nipote così diversa da come se la immaginava. E’ vero, pensava, che anche la madre e la zia erano davvero eccentriche, ma qui ci si trovava di fronte alla follia pura, senza possibilità di ritorno.
Una notte d’estate piena fu l’incanto.
La luna fece il suo egregio dovere entrando dai vetri aperti ed illuminando la camera da letto di Valentina. Xeniel, naturalmente era lì, con lei. Si strinsero, le piume di lui erano soffici e tiepide, accoglienti. Dopo tanti inganni, delusioni e promesse disattese, quel becco e il respiro di lui, un soffio di vento, a sfiorarle la pelle. Abbracciati, loro come i comuni intenti. Era valsa la pena di essere rimasta qui, ad aspettare che qualcosa accadesse. Invece di togliersi di mezzo per non disturbare. Valeva la pena comprendere che si può continuare anche quando sembra impossibile muovere un passo in avanti.
Il loro era un viaggio insieme. E non c’era nessun altro. Perché nessuno avrebbe capito.
Valentina aveva smesso, soprattutto da quella notte, di vivere in grigio. Le vetrine erano un ricordo lontano e tempo perso, l’inutile desiderio di far finta che ci fosse ancora qualcosa di normale da conservare. Valentina non doveva render conto più a nessuno e, con Xeniel accanto, tutto diventava un gioco da ragazzi.
In bicicletta andavano, ormai, in due. Lei pedalava veloce contro il vento,
le automobili erano quasi trasparenti e si trovava sempre il giusto tempo, il giusto modo di schivarle quasi sfiorandole. C’era ebbrezza nella corsa e rispetto reciproco perché Xeniel, secondo pilota, le dava i giusti suggerimenti. Lui, come uomo, maschio di uccello, aveva il dono della vista in lontananza e profondità, lei, come donna, la visione
laterale. Lui, come uccello, poteva volare, lei, come umana, era incollata a terra, ma poteva alzarsi dal sellino con disinvoltura e leggerezza. Lui le aveva trasmesso, oltre alla sicurezza, anche il dono di pensarsi altro. Era come se le gambe di Valentina fossero senza fatica, le ruote giravano che erano una meraviglia e qualcuno diceva, lì in città, quella si andrà ad ammazzare o farà fuori, quel che è peggio, qualcuno.
“Sta veramente diventando un pericolo pubblico. Ogni giorno diventa più pazza. Nessuno che la faccia visitare, la curi o la tenga a casa. E’ abbandonata a se stessa e continua a pedalare e parlare da sola, cantare a squarciagola come una matta. Poveraccia. Certe volte fa pena”
Che ne sapevano loro, tutti intenti a vivere le loro squallide quotidianità, di cosa volesse dire cantare insieme. Xeniel era anche un maestro di controcanto. In due erano un’orchestra. Un’emozione irripetibile.
La gente si girava a guardarla sfrecciare, gridare e cantare. Facevano un cenno con la testa o con il dito indice sulla tempia.
Ma Valentina, ormai, neanche li vedeva.
Poi venne l’idea. Al pennuto uccello divino.
Lei si girò a guardarlo, perché aveva smesso all’improvviso di cantare. Si era interrotto di colpo e non lo aveva mai fatto.
“Dai, passa con il rosso”
“Che rosso?”
“Il rosso del semaforo. Che diamine! Cambiamo un po’ le situazioni. Andiamo controcorrente. Non si possono rispettare le regole sempre. Le regole sono fatte dagli uomini, mortali dediti all’errore, alla fallace idea che tutto si possa controllare, codificare e decidere. Chi lo ha stabilito che con il verde passi e con il rosso ti fermi? Chi? L’uomo. E’ solo una convenzione, una decisione arbitraria. Prova ad andarle contro”
“E se mi investono e mi uccido?”
“Vuol dire che se per te è finita, doveva andare così. E’ arrivata la chiamata, vuol dire che deve finire lì il viaggio. Se succede. C’è sempre una ragione per quanto assurda sembri”
“Ho paura”
“Dai Valentina, amore mio, sfreccia senza pensare, fallo per me, per noi”
A Valentina molte volte veniva la voglia di sfidare il pericolo, poi prevaleva l’autoconservazione, la permanenza e si bloccava poco prima del tuffo. Quello
irreversibile. Ma questa volta l’aria era fresca e quello strano uccello da amare chiedeva una prova, per folle che fosse. Se un Angelo Custode ti chiede una cosa così particolare, vuol dire che ha un senso. Fino a quel giorno, del resto, lui aveva sempre detto, consigliato ed indicato la direzione giusta. Perché questa volta avrebbe commesso un errore? Proprio adesso che tutto andava bene, anzi, a gonfie vele?
Valentina spinse il pedale e poi tutti e due. Il rosso le entrò nel cervello. Non c’era né musica né canto. C’era, ad un certo punto, un sibilo lontano che si avvicinava, di frenata e poi puzza di asfalto.
Tutti intorno a guardare, fermi, impietriti, statue di sale.
Che spettacolo inatteso, che boato inaudito, che rumore sordo, che segno, che sangue, che botta, che sfiga, che matta.
Una pozza indegna sui jeans, un odore di bruciaticcio, come piume arrostite.
Chi è morto, chi è ferito, nooo, era rosso ed è passata.
In terra, la bicicletta sembrava un’installazione di arte contemporanea: “Asfalto violato”, il titolo.
I capelli di Valeria riposavano, dopo anni di velocità e vortici interiori.
Xeniel le stava accanto e l’accarezzava.
Iniziarono a volare insieme. Era la prima volta.
“Ti prego non lasciarmi. Non ho ancora capito se volo da sola o se mi aggrappo alle tue ali. Non sono certa di quello che sento”
“Puoi farcela da sola. Ora tutto ti è concesso. Resteremo insieme fino a che non dovrò tornare a salvare qualcun altro. Ma sappi che, se ti lasciassi ora, potresti raggiungere l’altezza che desideri. Non c’è più pesantezza, non c’è più gravità”
Il giorno dopo, in terra, accanto al semaforo, un modesto mazzo di fiori, un pezzo di gomma sciolta, un biglietto senza firma, una sorta di epitaffio
“Libera scelta per chi libero vuole essere o tessera smarrita di un puzzle senza significato né logica configurazione”.
Le Ombre della maternità
“Tieni lontano il più possibile i figli,
non lasciarli avvicinare alla madre.
L’ho già vista mentre li guardava con occhio feroce,
come se avesse in mente qualcosa”
Euripide, Medea
Percorrendo i tortuosi sentieri delle teorie psicoanalitiche, cerchiamo di trovare delle risposte ai quesiti posti dall’identità femminile in relazione all’esperienza della maternità.
Lo strumento analitico dell’amplificazione e la collocazione delle storie di vita in una cornice simbolica e immaginale consentono restituzione di “potenza” e autorevolezza all’ archetipo materno.
Consideriamo, a tale proposito, l’archetipo della Grande Madre, rappresentato dalle figure mitologiche di Cibale, Astarte, Iside, Ishtar, Demetra, Cerere:
“…la Grande Madre rappresenta un’ampia rete di relazioni di cui la madre è protagonista,…non è però vincolata ad essere rappresentata da una madre concreta, essa agisce endopsichicamente nell’uomo come nella donna, nel figlio come nella figlia, e in ogni altra manifestazione della civiltà che essa influenza: nella struttura sociale, nel diritto, nell’arte e nel costume e così via. In campo psichico essa produce prima di tutto una specifica attitudine materna…quanto più bisognoso il bambino, più sofferente, più povero, più trascurato, tanto più vicino è al suo cuore, all’opposto della psicologia del Grande Padre, che valuta secondo le capacità, esige rendimento ed espone i “minorati”(Sparta)” (1).
La Grande Madre è compassionevole e consolatrice, ma può facilmente trasformarsi nel suo aspetto negativo, la madre cattiva, dominatrice e divoratrice, che impedisce ai figli e alle figlie il raggiungimento dell’autonomia e ne decide la sorte nel bene e nel male. Secondo Jung, grande e frequente è il rischio di identificazione con l’aspetto negativo, d’ “Ombra”, dell’archetipo.
Il cosiddetto “complesso materno” sarebbe allora all’origine della depressione postnatale, deputata a mettere in scena il duplice aspetto dell’archetipo della Grande madre, la sua ambivalenza. Di notevole interesse a tale proposito è il concetto, pure junghiano, di “enantiodromia”, letteralmente “conversione nell’opposto”, secondo il quale un contenuto psichico, un particolare tema, giunto alla propria saturazione, si
trasforma nel suo contrario. Si tratta sostanzialmente di un meccanismo psicodinamico compensativo di contenuti psichici inconsci troppo unilaterali o di un’eccessiva unilateralità della coscienza.
Il mito ci mostra i due volti della maternità, l’uno opposto all’altro, e rimanda alle teorie di Melanie Klein (2) in merito alla scissione primitiva (nelle precocissime fasi di vita neonatale) in “seno buono” e “seno cattivo”, madre che nutre e madre che annienta e divora, dal cui gioco dialettico nascerà l’identità individuale, dopo aver abbandonato la “posizione schizoparanoide” per quella “depressiva” se prevarranno “riparazione” e ”gratitudine” sull’ “invidia” distruttiva e destrutturante.
Nell’interazione madre-bambino si modifica e si costruisce al contempo l’identità dell’una e dell’altro e si stabilisce il destino di sanità o patologia psichica del futuro adulto.
Tornando ai miti della Grande Madre, consideriamo quello di Demetra e Core, madre e figlia, che vivono felici una relazione esclusiva e simbiotica finchè Core, graziosa giovinetta, non viene rapita da Ade, dio degli inferi. Quando questo accade, la generatività di Demetra, dea della Terra, si dissecca e il mondo inaridisce.
Impietrita dal dolore per la perdita della figlia, Demetra fa discendere sulla Terra un freddo gelido come la sua anima rattristata, un inverno inesorabile che rende sterile il suolo e uccide i suoi frutti. L’alternarsi delle stagioni sarà poi determinato da un accordo che Core stabilirà con Ade, secondo il quale trascorrerà con lui un periodo di tempo che corrisponderà ai mesi autunnali ed invernali, causati dal pianto e dalla sterilità materna, e i restanti con la madre, che, felice, restituirà al mondo la primavera e l’estate.
In questo mito, la catastrofe psichica che vediamo abbattersi su Demetra e per rispecchiamento su tutta la natura, potrebbe essere equiparata a una depressione devastante, generata dalla perdita della figlia a causa dell’irruzione di un fattore inconscio (Ade, divinità ctonia che presiede quanto è nascosto, sotterraneo, occulto, infero), che Jung definirebbe un “Animus” negativo e Freud un “Perturbante”.
La storia di Demetra e Core può aiutarci a comprendere e amplificare i temi sollevati dalla depressione post-parto, soprattutto nelle sue manifestazioni più gravi. Questo tipo di depressione è infatti contrassegnato da una devastante e destrutturante sensazione di perdita.
Quando si mette al mondo un figlio, attraverso la nascita lo si consegna al contempo alla morte, lo si consegna ad Ade, divinità che regna sul mondo infero, cioè su quanto si colloca oltre la vita, nell’aldilà. La simbiosi con il bambino vissuta per nove mesi si interrompe bruscamente con la nascita.
Molte madri raccontano di aver sentito una sorta di strappo, una lacerazione viscerale nell’istante in cui il loro bambino è venuto al mondo.
Altre dicono di aver temuto che il neonato venisse scambiato con un altro o rapito, alcune volte persino dallo stesso padre del bimbo.
Freud affronta il perturbante (Das Unheimliche, 1919) prendendo spunto dalla definizione romantica del filosofo Schelling, il quale, giocando sull’ambiguità del doppio significato di “heimlich” come “familiare, domestico”, ma anche “celato, segreto”, afferma che esso rappresenta quanto sarebbe dovuto rimanere occulto, “nascosto in casa” (“heim”) ed invece è affiorato. Nell’interpretazione di Freud il perturbante diviene, al contrario, “qualcosa di familiare che si nasconde in casa” (3) e che, svelandosi, causa turbamento e angoscia.
Nell’ultima parte del saggio di Freud sul perturbante, l’origine dell’angoscia da esso causata è rappresentata dall’ “organo genitale o il corpo della madre” (4) e viene identificato dapprima con l’angoscia di castrazione e poi con quella di morte.
“Das unheimliche” è ciò che è contrario alla tranquillità della casa, che turba profondamente perché non domestico e “inaddomesticabile”. Estraneo e familiare al contempo, è il corpo della madre-origine, dunque la vita stessa, ed è il corpo della madre al quale ritorneremo con la morte.
Gli eventi legati al concepimento e alla nascita sono spesso percepiti come l’irruzione di qualcosa che turba la quiete e interrompe la continuità dei ritmi consueti del corpo-casa della donna. Queste “turbolenze”, in varia misura, innescano la “rivisitazione” del corpo della propria madre, il corpo precedentemente abitato. Ogni donna che è stata incinta, o che ha soltanto immaginato di esserlo, sa come questa condizione favorisca l’affiorare di memorie spesso lontanissime, la produzione di sogni e immagini, a volte una nuova e diversa narrazione della propria storia di figlia e in particolare del rapporto con la madre. Sa anche come, del tutto singolarmente rispetto ad altre fasi esistenziali, si alternino, in continua fluttuazione, “godimenti e pene”. Una volta acquisito il controllo del meccanismo di passaggio da una dimensione all’altra, dal tempo reale del presente a quelli del passato e del possibile, ciò che “perturba” cessa di esistere nel suo aspetto destrutturante e diviene invece un fattore utile alla percezione della pienezza che questi “momenti d’essere”, forse più di ogni altro nella vita, possono donare.
La maternità ha le sue luci e le sue ombre, ma, citando Winnicott, ricordiamo che, per un sano sviluppo del bambino, non è necessaria una madre perfetta, ma una “madre sufficientemente buona”.
1. Bernhard E., “Il complesso della Grande Madre. Problemi e possibilità della psicologia analitica in Italia”, in Tempo Presente, anno VI, n.12, Roma 1965, pp.3-4
2. Klein M., Invidia e gratitudine (1928), Martinelli, Firenze 1969
3. Freud S., Il Perturbante (Das Unheimliche, 1919), in Opere 1917-1923, a cura di Cesare Musatti, Bollati Boringhieri, Torino 1977, vol.IX, pp. 81-118
4. Ibidem
La depressione postnatale
Alle soglie d’autunno
in un tramonto
muto
scopri l’onda del tempo
e la tua resa
segreta
come di ramo in ramo
leggero
un cadere d’uccelli
cui le ali non reggono più
Antonia Pozzi, La vita
Gli episodi di cronaca nera riguardanti maltrattamenti, abusi e uccisioni dei propri figli da parte delle madri, hanno portato alla ribalta una problematica sempre esistita e nei suoi aspetti meno drammatici relativamente frequente, spesso offuscata e in parte anche causata dalla diffusione culturale e sociale di un’immagine retorica e idealizzata della maternità.
La depressione postnatale (DPN) è infatti un fenomeno antico, del quale le donne hanno sempre sofferto, sottostimato e occultato, le cui origini sono multifattoriali e inscrivibili in un modello biopsicosociale.
Alla luce delle ultime ricerche (1) sembrerebbe più appropriata la definizione di “depressione perinatale”, in quanto disagio che può manifestarsi già durante la gravidanza o dopo il primo anno di vita del bambino, caratterizzato da quadri clinici diversi, più o meno evidenti e di differente gravità, i cui sintomi spaziano dall’ ansia alla depressione grave, a volte alternandosi in cicli.
Il DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, 1995) considera la DPN analoga nei sintomi alla depressione maggiore, specificata come “depressione post-partum” se si presenta entro le prime quattro settimane successive al parto. Ulteriori distinzioni devono essere fatte fra il cosiddetto “maternity blues”, una diffusissima instabilità dell’umore nei giorni successivi al parto, causata principalmente dalle
alterazioni ormonali (come un brusco innalzamento della prolattina) e la “psicosi post-partum”, evento fortunatamente più raro (due casi ogni duemila nascite) ed estremamente grave, caratterizzato da agitazione,stato confusionale e/o dissociativo, delirio ed allucinazioni, rifiuto del neonato.
L’ipotesi biopsicosociale considera l’interazione di variabili biologiche, quali la predisposizione individuale (ovvero una sorta di ipersensibilità alle modificazioni ormonali e la “sindrome premestruale” ne sarebbe predittiva), psicologiche (storia personale) e socioaffettive (es. relazione di coppia non soddisfacente, assenza di sostegno familiare, condizione sociale, economica e lavorativa non adeguate, eccessive aspettative verso il ruolo materno,ecc.). Del resto sappiamo che ogni condizione di disagio psicologico è determinata da più fattori concomitanti e che può verificarsi un evento “soglia” al di là del quale l’equilibrio si rompe, a volte senza che se ne abbia alcun sentore o che si manifestino segni di disagio.
La nascita, l’allattamento e l’allevamento di un bambino comportano responsabilità, fatiche, cambiamenti di ruolo e delle dinamiche relazionali in famiglia, talvolta modificazioni nel corpo difficili da gestire e accettare senza una preparazione e un sostegno adeguati.
Il pianto di un neonato, poi i “capricci” di un bambino, sono a volte dei segnali che non vengono interpretati in modo corretto dalle madri, se non come personali inadeguatezze, incompetenze al ruolo materno.
La retorica sul femminile, risalente agli anni cinquanta, ancora alberga insieme ad altre nuove secondo le quali la donna deve essere al contempo un premuroso “angelo del focolare domestico”, abile ed efficiente nell’allevamento e nell’educazione dei figli, nella cura della casa e nella gestione dell’economia domestica (disciplina scolastica ancora negli anni settanta), ma anche moglie lavoratrice produttiva, adeguata nel corpo ai correnti modelli estetici, spesso del tutto irrealistici, proposti dalla società consumistica e mediatica.
E’ ovvio che una tale pressione crei obiettivi la cui irrealizzabilità e vacuità possano lasciare spazio a vuoti di senso.
L’attesa e la nascita di un bambino sono eventi che costringono gli adulti coinvolti a un rinnovamento globale della propria identità all’interno di una rete di relazioni, rappresentazioni e affetti.
L’eccessiva medicalizzazione della gravidanza e la rilevazione precoce dell’immagine del feto nel grembo materno, hanno modificato, rispetto a un passato relativamente recente l’immaginario della donna rispetto al nascituro (l’introduzione dell’ecografia come controllo prenatale di routine risale agli anni settanta).
“Il concetto astratto del feto…si è concretizzato in un fantasma”(2) ed ha alterato la “mentalizzazione” del futuro bambino, creando uno iato, a volte difficile da elaborare,
fra il “bambino della notte” (3), il bambino pensato, la cui immagine è spesso costruita dopo averne scrutate le caratteristiche somatiche tramite le nuove tecniche di indagine prenatale (è recentissima la diffusione dell’ecografia tridimensionale), e il bambino reale, quello che nascerà e avrà esigenze ed “imperfezioni”.
Un tempo l’attesa e la nascita di un bimbo contemplavano l’imponderabile, adesso, le volte in cui tragicamente si manifesta, ad esempio nella prematurità, la donna sente di esserne responsabile, di non essere riuscita a controllare “tutte le variabili”, si sente colpevole o inadeguata ed è possibile che sia ritenuta tale dagli altri di riferimento.
La procreazione medicalmente assistita è stato un altro progresso della scienza che ha contribuito allo sviluppo di fantasie di onnipotenza, spesso seguite da rischiose, se non drammatiche, delusioni.
Le nostre nonne, fino agli anni sessanta, erano solite dire che la gravidanza è come l’uovo di Pasqua: riserva sempre delle sorprese e non si può sapere prima in cosa consistano. Con un atteggiamento di sospensione si creava una maggiore disponibilità all’accoglienza di ogni neonato proveniente “dalla notte”. L’utero era un luogo inaccessibile alle strumentazioni scientifiche. Non si conosceva il sesso del nascituro e si preparavano corredini di vari colori , né rosa né celesti, che andassero bene “per tutte le ruote” , oppure ci si affidava ai sogni, alla forma del pancione, alle superstizioni riguardo i sintomi della madre, ai presentimenti. L’attesa era un’attendere mentre ora, come evidenzia la Duden (4), è cancellato il confine fra interno ed esterno, fuori e dentro il corpo della donna.
Con questo non si vogliono criticare tecniche diagnostiche che hanno permesso di curare precocemente malattie e di salvare vite, ma soltanto sottolinearne le implicazioni psicologiche e culturali.
Fino a non molti anni fa, il movimento fetale era il segnale della vitalità del nascituro. In particolare al primo movimento avvertito dalla madre, descritto da molte come un lieve, quasi impercettibile battito d’ali, era attribuita un’importanza speciale e un significato prognostico diverso a seconda della fase della gestazione in cui si verificava. La gravidanza era un avvenimento poetico e al contempo un “tremendum”, in ogni caso una fase in cui la vita della donna si collegava con quella di tutte le altre prima di lei in una partecipazione profonda alla memoria ancestrale delle Madri.
La gestante era attenta a ciò che accadeva dentro di lei; la sua era un’esperienza soggettiva inenarrabile collocata in un contesto simbolico più ampio. A tutto ciò si è sostituito il tocografo, strumento che “monitorizza” il battito cardiaco del bambino rilevando “tracciati”, ai quali la madre in attesa è sottoposta periodicamente nella totale immobilità e passività, talvolta sin dal settimo mese di gravidanza.
La figura dell’ostetrica, “levatrice”, che era deputata a praticare l’”auscultazione”, è divenuta secondaria a quella del medico ginecologo.
Tutti questi cambiamenti hanno probabilmente contribuito ad amplificare l’insicurezza delle donne nei confronti della gravidanza, del parto, dell’accudimento del neonato e delle proprie capacità e competenze materne.
Il disagio perinatale è recentemente divenuto uno dei motivi più frequenti della richiesta di consulenza psicologica.
Lavorare sulla prevenzione e sulla cura vuol dire in primo luogo individuare le motivazioni profonde implicate nella scelta di filiazione, esplorare l’immaginario rispetto al bambino, capire il posto che occuperà all’interno della famiglia e dare risalto al desiderio della madre. E poi, ancora, favorire e contenere l’esplicarsi delle emozioni, anche quelle negative, l’elaborazione di quanto a volte si configura come un vero e proprio “lutto” a causa della perdita di parti del precedente sé e di stili di vita non più adeguati.
In una fase successiva si dovranno riparare le ferite, razionalizzare le frustrazioni, forse insegnare la gratitudine e indicare una perduta via di accesso alla realtà.
La storia che segue è quella di Giulia che, a causa di una grave depressione post-parto, soltanto a posteriori si è resa conto del grave rischio corso dal suo neonato quando lei, pur di non sentirne il pianto, lo lasciava legato a un seggiolino sul cornicione della finestra. In quel modo, diceva, il bambino si acquietava, con l’aria e il sole si addormentava.
Andrea non è mai caduto di sotto, è un bel bambino di cinque anni e Giulia ha imparato a essere una buona madre. Simona, nel suo racconto, ha immaginato un diverso epilogo che, anche in questo caso, per fortuna non è stato, ma poteva.
1. Milgrom J., Mother-infant interaction and postpartum depression, Final Report of the Victorian Health Promotion Foundation, Melbourne Australia 1991. Si veda anche l’aggiornamento delle ricerche in:
Milgrom J., Martin P.R. e Negri M.L., Depressione Postnatale. Ricerca, prevenzione e strategie di intervento psicologico, Erickson, Trento 2003
2. Duden B., Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto
di vita, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p.88
3.Vegetti Finzi S., Il bambino della notte, Mondatori, Milano 1999
4.Duden B., op. cit.
E’ stato consultato: DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, APA 1995
Golfo madre
Missiva di un neonato a sua madre:
Per non esserti ricordata di essere vento fragile
Per non avermi guardato negli occhi, al centro
Per non aver detto niente di vero
Per non aver rispettato il tempo e il modo
Per esserti fatta credere forte ed eri filo d’erba
Calpestabile come asfalto fresco
Imprendibile come una farfalla
“Certe volte avrei voluto pisciare come un uomo. Comodo per loro, comodo… e senza bisogno di sedute, calate di braghe, bisogno di niente. Comodo e basta. Loro. La fanno in piedi e noi no. Loro la fanno e stop. Si liberano quando sentono lo stimolo e fanno pure le gare a chi schizza più lontano. Acquetta gialla e schizzi qua e là come su una tela. Arte moderna, action painting di minzione.”
“Chissà perché mi hai odiato, se mi hai davvero odiato…, tu donna, moglie e anche un po’ madre. Ma che volevi, che pensavi e provavi davvero? Divertirti, viaggiare, sentirti viva, continuare a giocare come prima. Era questo? E’ stato per questo?”
“Da bambina fingevo di avere quel coso dritto con una banana, una penna, un cartone ripiegato ad imbottire la patta dei calzoni.
Immaginavo di infilzarci sogni, desideri, libertà a me proibite.
Spiedini saporiti per nutrire un’esistenza avventurosa.
Mi fingevo cavaliere al galoppo e invece ero damigella fra le mura del castello. E gli anni sono passati, passano e fanno le rughe come intagli sui tronchi degli alberi. Improvvisamente non c’è più tempo per…”
“Il tempo passa e lascia indietro tante cose. Se potessi parlarti…
parlarmi…Ti sei mai chiesta cos’ero per te e cosa davvero avresti voluto? Da me? O da te e da voi?”
“Adesso vorrei che non te ne fossi andato, volato via.
Speravo che mi avresti dato quello che mi mancava, ma poi sentivo il vuoto, un gran vuoto nero senza speranza e futuro.
Il tempo era fermo, sempre uguale, un giorno dopo l’altro ed ero stanca, tanto stanca. Non ero più io, non mi riconoscevo e non ti riconoscevo. Non riuscivo a vederti, non sapevo tenerti, non ti capivo e mi terrorizzavi. Eri un estraneo, un alieno e allo stesso tempo mi somigliavi, eri tanto di me con quei tuoi bisogni indecifrabili e i pianti inconsolabili. Ma ora, dove sei? Perché sei andato via?”
“Forse come te vago in un tempo e in uno spazio neutri, ma non è stata certo una mia scelta. Potevamo stare ancora insieme. Ti saresti abituata, ti avrei insegnato a capirmi.
Eppure in quella notte di dolori – ricordi? – forse mi amavi.
Eri un golfo ed io una nave in ingresso.
Hai accolto il mio attracco e favorito la mia difficile manovra perché entrassi in porto. Quel porto di mare che è la vita.”
“Non essere retorico e non sentenziare. Avrò avuto i miei motivi per fare quel che ho fatto e se non li ho capiti neanche io, sappi, la sto scontando. Non è che da qui dove sono si veda meglio, anzi.
Ogni giorno ho le idee più confuse.
Mi danno delle compresse per essere vigile, ma non ho piedistalli da cui dirigere il traffico. Sbattuta di qua e di là, evito le auto di sguincio.
Le schivo, non mi travolgono, ma cambia di poco perché è come se non ci fossi, non esistessi. Fluttuo nel nulla, credimi.”
La nave è ferma, nel golfo. Immobile aspetta qualcuno che la pulisca ed elimini le tracce visibili del lungo viaggio.
Una volta lavata, sarà il tepore del sole nel golfo a riscaldarla ed asciugarla. Il calore del golfo si prenderà cura di lei prima che parta per un altro, nuovo, viaggio.
Ma la sosta è stata breve ed imprevista la meta del viaggio successivo.
“E’ stato un attimo, un istante. Qualcuno lo chiama buio, come spegnersi la luce o esserne abbagliati. Io vedevo un colore, forte, forse rosso, lo sentivo aggredire e possedere ogni parte di me, il cervello, i pensieri.
Ogni singola cellula pulsava nelle tempie. Mi faceva male lo stomaco, avevo la nausea. Ho ceduto…
Ho sofferto, sai, da impazzire. Quando sei nato ero felice…cioè dovevo esserlo, mi sembrava…Non mi rendevo bene conto di cosa mi stesse capitando. Qualcuno promise che sarebbe passata. Disse è normale. Succede. Fisiologico. Molte donne provano questa strana sensazione dopo il parto.
Io avevo soltanto paura, quella che invade ogni cosa. E non sapevo dirlo.”
“Ma avrei dovuto aver paura io di una madre come te.”
“Non dirlo per favore, anche se è vero… Ma sì, avresti fatto bene.”
“A restar dentro, cioè fuori dal golfo, per sempre.”
Era caldo quella sera lì al golfo. La nave maestosa e fragile, ammirata e festeggiata da tutti, riposava dopo l’attracco e il doveroso bagnetto.
I mozzi, gli artefici della pulizia, erano tornati nelle loro casette sparse, a cena, a ritrovare una famiglia.
La sensazione per la giovane nave era ancora quella di essere cullata dal mare, protetta dal golfo.
“Ma come ti è venuto in mente? Mi hai appoggiato al davanzale e poi freddo, gelo e le tue braccia a tenermi sospeso nel vuoto.
Quel senso di pericolo imminente quando ho avvertito la presa che cedeva.
Le tue mani di cui mi fidavo e che già amavo mi dicevano ciao, a Dio.
Mi sentivo un uccello sprovveduto. Caduto. Dal nido.”
Sirene spiegate e gente che accorre per una nave che nel sonno a tradimento è stata attaccata.
Dalla Tempesta. In un golfo?
Dai Pirati.
Dal Fuoco.
“E quando mi hai lasciato andare, ti sei sentita meglio?
Quando sono atterrato ed hai sentito il tonfo, e da lassù tremavi, urlavi…Quelle grida mi sono rimaste dentro. La cosa più triste. Lacrime di coccodrillo. Ancora un inganno?
Quando poi è arrivata la polizia e ti ha fatto le domande e ti ha detto stia calma, respiri, non si agiti e qualcuno urlava e mi prendeva da terra e dicevano si muove e…”
La notte scura e la nebbia che avvolge il pacco regalo per la festa finita in dramma, finita per sempre.
Dal giorno di quell’evento strano e speciale il golfo restò in silenzio.
Restò una traccia soltanto, un ricordo conservato a tagliare ogni giorno le vene di quelle braccia di madre sempre più scarne ed inutili. Come un laccio, un piccolissimo bracciale con un nome inciso.
Un nome per sempre inciso sulla pietra di un cuore da golfo.
Una madre, un figlio, un volo a piovere e non a salire.
I giornali parlarono. Una madre aveva ucciso suo figlio,
una nave era affondata.
Un volo a ritroso nell’acqua di mare del golfo.
Acqua di madre, salata.
Gli inganni dell’empatia
Tu sei di quelle che dice a tutti amore
Ti scappa col fornaio, lo dici anche alle suore
Patrizia Cavalli, Amore non mio e neanche tuo
Il termine “empatia” deriva dal greco “empatheia” e significa letteralmente “nell’affetto”, “nella passione”( si compone di “en”/in e “pathos”/ affetto). Indica la possibilità per un soggetto di stabilire una sorta di comunione affettiva con l’oggetto osservato.
In psicologia la parola “empathy” fu usata in primo luogo da Titchener (1) nel 1909 come traduzione dal tedesco “einfuhlung” (“sentire dentro”) per descrivere la naturale tendenza dell’uomo a partecipare emotivamente all’esperienza di un’altra persona.
In filosofia la sensazione empatica è stata riferita da alcuni autori al godimento estetico come proiezione di stati emotivi nell’oggetto osservato (2), mentre Husserl (3) la riconduce a una particolare forma di comunicazione, intensa e non verbale, fra due individui che comprendono reciprocamente lo stato d’animo dell’altro. Per l’autore è alla base dell’etica in quanto consente la consapevolezza e il rispetto della vita dell’altro.
Freud ne parla come una delle componenti del processo di identificazione isterica (4), che consiste in un’appropriazione profonda di vissuti altrui piuttosto che in una semplice imitazione. Nel lavoro analitico l’empatia è da Freud connotata positivamente quando diviene uno strumento dell’interpretazione rendendo possibile l’ “introspezione vicariante”, ovvero una sorta di prestito al paziente della capacità introspettiva dell’analista.
La capacità empatica, a partire dalla teorizzazione di Carl Rogers (5), è indicata come fondamentale in ogni relazione terapeutica, intesa come chiave d’accesso al mondo interno del paziente. L’ascolto empatico è “non direttivo”, si basa sull’accettazione incondizionata dell’esperienza dell’altro, si astiene da valutazioni e giudizi per focalizzarsi sul mondo interno dell’interlocutore al fine di capire cosa provi e condividerne le emozioni.
Nella metà degli anni cinquanta, lo psichiatra Harry Stack Sullivan (6) evidenziò come la risposta empatica fosse vitale nel rapporto madre-bambino e costituisse il primo canale comunicativo utilizzato dal neonato per entrare in contatto con il mondo esterno.
La neuropsicologia ha recentemente postulato l’esistenza di “neuroni specchio” che ci consentirebbero, a livello delle strutture cerebrali, di provare le medesime emozioni di un’altra persona anche quando non ne siamo direttamente coinvolti. Gli esperimenti scientifici hanno evidenziato un rapporto diretto fra intensità del legame con l’altro e risposta cerebrale. Questa è del resto un’esperienza che molte madri conoscono bene: quando il figlio è malato o avverte un disagio la sensazione dolorosa è altrettanto intensa per loro stesse.
L’empatia è dunque, da quanto detto fino ad ora e citando Edith Stein (7), un meccanismo adattativo ed un ponte verso l’altro, la genesi del “noi” e della dualità. Senza di essa la relazione “io-tu” non sarebbe possibile.
Esistono però inganni causati da un eccesso di empatia che possono portare allo smarrimento di sè nel con-fondersi con l’altro. Mettersi al suo posto e non saper restare al proprio, sostituirsi, immaginarne le motivazioni, attribuendogli quelle che sarebbero le proprie nella medesima situazione, annullare le distanze in un rispecchiamento fusionale e simbiotico, divenire dipendenti e passivi nello smarrimento del proprio desiderio in quello, a volte assente, dell’altro. Esperienza che le donne conoscono bene.
Scrive Federica Giardini: “Nel film di Kathryn Bigelow, Strange Days, il cattivo della situazione cattura una donna per torturarla. Le infila in testa una specie di ragnatela di fili ed elettrodi. Lei, oltre a sentire il proprio dolore, prova anche le sensazioni di lui - si immagina siano di piacere – mentre la tortura. Per la donna, prima della morte fisica, arriva la morte psichica. La compresenza tra i propri stati e il punto di vista dell’altro – è questa una possibile definizione dell’empatia – può essere un modo per ridire il motivo per cui spesso accadeva che una donna maltrattata non denunciasse il proprio aggressore” (8).
Donne e bambini picchiati o abusati, per eccesso di comprensione delle motivazioni altrui spesso non denunciano chi li aggredisce, frequentemente subiscono situazioni insostenibili. A prescindere dalle condizioni di violenza, è comune alle donne il fallimento nella presa di distanza dai sentimenti dell’altro quando comportano la negazione dei propri o richieste inesaudibili. Lo stesso rapporto d’amore per un compagno, un genitore anziano, un figlio, può essere male inteso e identificato con il sacrificio di sé e dei bisogni che si hanno.
Anche molti psicoterapeuti e altri professionisti coinvolti nella relazione di cura, soprattutto donne, commettono simili errori ed eccedono in coinvolgimento e atteggiamenti oblativi , quasi mai richiesti e assai dannosi, spesso sperimentando l’ inefficacia del proprio lavoro e il “ burn out”, la sensazione di scacco, di perdita dei confini e di collusione con le aspettative inconsce dell’altro..
Nella relazione empatica occorre allora considerare la distanza e frapporre il “come se”: come se io fossi al posto dell’altro occupando e mantenendo ben presente tuttavia il mio. “…E’ la mancata esaustività conoscitiva dell’esperienza dell’altro a generare lo stesso movimento analogico. Tale limite, che garantisce la conoscenza contro l’assimilazione
interpretativa, contro la fusione nella reversibilità delle posizioni, si dà nel momento in cui l’altro presenta una propria indipendenza” (9).
Ci sono donne che più frequentemente degli uomini credono di avere amori che non hanno e legami affettivi che l’altro non reciproca. A volte l’autoinganno dura per tutta una vita. C’è in alcune la tendenza a interpretare secondo il proprio desiderio sentimenti non espressi e non manifestati a partire da timide o educate attenzioni, toni di voce, abbozzi di frasi di compagni che tali non sono. Queste attribuzioni fondate sulla “intuizione” potrebbero essere facilmente ricondotte a labilità emotiva o a patologici vissuti proiettivi “…Ma l’attenzione alle coincidenze e alle sincronie, alle sottili geometrie…sono elementi forti che vanno accolti ed utilizzati. Essi… premono per la necessità di divenire pensieri, parole, comunque comunicazione, per trasformare l’esperienza di pura “impressione” in “espressione” visibile all’esterno” (10) e cercare così una verifica nella realtà.
1- Titchener E., Experimental psychology of the thought processes, Mc Millian, New York 1909
2- AA.VV., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti, Firenze 1998
3- Husserl E., L’idea della fenomenologia (1950), Il Saggiatore, Milano 1981
4- Freud S., L’interpretazione dei sogni (1899), Boringhieri, Torino 1989
5- Rogers C., La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze 1970
6- AA..VV., op. cit. in nota 2, vedi sopra
7- Stein E., Il problema dell’empatia, Edizioni Studium, Roma 1998
8- Giardini F., Relazioni. Differenza sessuale e fenomenologia, Luca Sossella Editore, Roma 2004, p.129
9- Ibidem, p.133
10- Fabbrini A., Hysterikos: proprio dell’utero in Aa.Vv., Curare nella differenza.
Psicoterapie del disagio femminile (a cura di Paola Leopardi), Franco Angeli,
Milano 2007, p.56
Per amore si sopporta
DENTRO
Che botta, sulla testa
Dentro
Che sollievo, dopo
E invece non era vero
Finita la festa, terminato il gioco
Che botta, un rumore di scacco
Dentro
Quanti giorni a smaltire
Mesi che vanno a briglia sciolta
E nessuno lo ha chiesto
Ho avuto paura che fosse vero
Dentro
Ho capito tardi
Era vita, pensavo uno scherzo
L’aria di festa
Ho sentito una botta
In testa
E batte la botta
Dentro
La violenza domestica e di coppia, dal maltrattamento psicologico fino alle percosse e all’abuso, si instaura gradualmente attraverso banali liti che diventano sempre più frequenti e aggressive. Frequentemente è seguita da periodi di cosiddetta “luna di miele,” in cui il partner si mostra pentito e premuroso, affettuoso e attento, esprimendo un desiderio di cambiamento che non è mai di lunga durata.
Si stabilisce così una ciclicità della violenza che molte donne e a volte, purtroppo, anche i loro bambini subiscono passivamente nel tentativo di salvare la relazione e tenere unita la famiglia o la coppia.
All’altro si offre sempre un’ulteriore opportunità per un eccesso di comprensione e un male-inteso senso dell’amore.
Spezzare un legame in cui si è investito e creduto è per la donna ancor più difficoltoso se sola, senza appoggio familiare o in precarie condizioni economiche. Per questi motivi il problema si manifesta con più evidenza nella vita, spesso socialmente “invisibile”, delle donne migranti extracomunitarie.
Gli uomini abusanti tendono a isolare, umiliare e squalificare le vittime dei loro maltrattamenti, che, soprattutto in assenza di altre relazioni significative, facilmente si lasciano convincere delle proprie colpevolezze, mancanze e inadeguatezze, come se meritassero quanto accade loro.
Innalzare barriere mentali, dimenticare insulti e percosse, divengono allora strategie difensive, modi per “tirare avanti” magari tamponando il dolore attraverso l’assunzione di alcool, psicofarmaci o droghe.
Con il tempo, se non si riesce a chiedere aiuto e un sostegno adeguato, il disagio può strutturarsi in una vera e propria sindrome post-traumatica da stress, caratterizzata da ansia, disturbi alimentari o del sonno, attacchi di panico, malesseri o malattie di tipo psicosomatico.
La lettera che segue mi è stata recapitata personalmente da Elèna, una donna polacca sposata con un italiano e madre di due bambine.
Elèna ha interrotto bruscamente la psicoterapia quando le ho suggerito delle soluzioni alla sua insostenibile situazione coniugale:
“Cara dottoressa, sono passati due anni da quando ho interrotto la terapia.
Certe cose sono cambiate, questo volevo dirle.
Ho trovato un lavoro, un lavoretto a dire il vero: qualche ora in una ditta di pulizie. Ma per me è tanto.
Fra una cosa e l’altra, la spesa, il tragitto, le figlie da portare a scuola e riprendere, trascorro più tempo fuori casa, penso di meno e mi sento più utile e autonoma. Posso fare un regalo alle bambine con i miei soldi e mio marito non riesce del tutto a controllarmi.
Nella ditta ci sono altre donne e posso parlare con loro, mi sento meno sola.
Quanto al resto, beh, un po’ di botte le prendo sempre e come sempre le subisco. Non è come pensa lei, però. Io ci ho riflettuto e ho capito che mio marito lo amo davvero, lo amo lo stesso anche se alza le mani.
Qualche volta poi dipende da me, perché torna a casa stanco dal lavoro e non trova le cose come le vorrebbe. Anche lui ha i suoi problemi e con chi li deve sfogare? Li sfoga con me, perché sono la moglie e non ha nessun altro. E io ho soltanto lui.
Certo, è successo pure che me ne ha date tante e forti come quella volta che sono venuta da lei che ero piena di lividi e lei mi ha detto di andarmene di casa o addirittura di denunciarlo.
Questo volevo dirle ed è il motivo per cui le scrivo: io da lei non ci sono venuta più perché ho avuto paura di quello che mi ha detto di fare.
Io mio marito lo capisco, so che soffre anche lui quando me le dà perché è sempre stato un po’ chiuso e introverso e in quei momenti non si controlla. Quello che riesco a capire meno è che picchia pure le bambine, ma allora mi metto in mezzo e le prendo io. Ma non lo posso lasciare perché credo nella famiglia e lui ha bisogno di me. Mi creda è come un bambino, da solo non ce la farebbe a andare avanti.
Io poi, le sembrerà strano, certe volte quando mi rialzo in piedi, perché mi butta pure per terra, tutta fiacca e dolorante con gli occhi che bruciano e il viso che fa male, mi sento quasi più viva del solito. Anche da bambina, se ci penso, quando prendevo uno schiaffo
forte e la pelle bruciava piangevo tanto e mi sentivo meglio, meglio di prima. Sentivo che vivevo.
Mio marito poi, dopo si scusa e fa l’amore con me. Questa è una cosa bellissima, una festa. E io capisco che mi ama, che non può fare a meno di me e io di lui.
Fra noi è così e sarà sempre così. Perciò la ringrazio e mi dispiace se si è preoccupata per me, ma ho capito che anche se sono un po’ depressa non ho bisogno di nessuna terapia. In qualcosa ho seguito i suoi consigli e, come le ho detto, sto molto meglio. Se mi sento tanto giù prendo le gocce e mi passa subito. Si ricordi però, cara dottoressa, che per amore si sopporta. Se si ama una persona, si sopporta tutto. Grazie, un saluto da Elèna. Se ancora si ricorda di me.”
Oltre il genere, la differenza, l’identità
(E’davvero possibile una “second life”?)
Io?
Ma sono lo stesso che qui è vissuto, che qui è tornato
e che qui è tornato a tornare e a ritornare
e di nuovo a ritornare?
O siamo tutti gli io che qui sono stato o sono stati,
una serie di grani-enti legati da un filo-memoria,
una serie di sogni di me di qualcuno fuori di me?
Fernando Pessoa, Una sola moltitudine
La teoria filosofica della differenza sessuale da qualche anno è inclusa e esposta in quasi tutti i libri di testo di filosofia delle scuole superiori, spesso in appendice, così se l’insegnante, uomo o donna che sia, ne ha “fantasia”, alla fine del programma, al termine dell’anno scolastico, la può illustrare agli alunni come una curiosità, un diversivo alla noia degli ultimi giorni.
Io, che insegno nei licei psicopedagogici, al “pensiero della differenza” ho sempre offerto molto spazio.
Si tende a dire che le giovani lo rifiutano, che intendono “differenza” come “disuguaglianza” delle donne dagli uomini nei diritti e nelle opportunità, che invece devono essere “pari”. Sono d’accordo, ma la “differenza” è altra cosa e ho al contrario generalmente riscontrato un grande interesse delle adolescenti verso questo argomento.
Negli ultimi anni la teoria della differenza e il concetto di genere sono stati criticati e ridiscussi dalla sociologia femminista, principalmente americana, in relazione alle veloci trasformazioni sociali e degli stili di vita.
Secondo l’interpretazione delle studiose statunitensi, il genere, nelle sue declinazioni di maschile e femminile, è semplicemente il risultato di costruzioni storiche e sociali. Il pensiero della differenza sessuale ripropone a loro avviso un’ “essenza” femminile astorica e aprioristica erroneamente identificata con la biologia..
Judith Butler afferma che il genere sessuale è creato dalla ripetizione di atti socialmente performati” dotati di forza normativa (1). Per l’autrice non esiste specificità di genere al di fuori della cultura e del sociale.
Il suo è un modello interazionista post-strutturalista secondo il quale sono i “copioni” che gli attori sociali interpretano a determinarne il genere sessuale.
Il “transgender” esce dalla logica binaria e produce un’auspicabile “disfatta del genere”.
Butler mette in discussione il concetto di sessualità naturale e, riferendosi a Lacan, afferma che la preclusione di alcune identificazioni crea il fantasma dell’abiezione, mentre il “queer” (2) ci costringe a interrogarci sulla relazione fra natura e cultura.
Donna Haraway (3) a propria volta sostiene che il desiderio non ha appartenenza e genere. Le potenzialità di dislocazione e dematerializzazione dei corpi offerte dal cyberspazio consentono la sperimentazione di identità sessuali multiple e alterne, che mettono in discussione il legame fra sesso, genere e differenza sessuale così come fenomeni quali il travestitismo, il transessualismo e i cambiamenti di sesso.
Queste a me personalmente paiono posizioni ingenue, forse provocatorie.
Mentre è infatti verosimile che non esista una naturalità del desiderio sessuale, tali teorie, criticando l’essenzialismo, poi lo ripropongono attraverso la nostalgia dell’androgino di platonica memoria.
Quella dell’incorporeità è soltanto una fantasia messa in scena dagli “avatar” (4) nei mondi virtuali della rete telematica. Dietro gli ”avatar”, a progettarne movimenti, intenzioni e comunicazioni, ci sono sempre soggetti incarnati con la loro anatomia, biologia e storia personale. Il resto non è che un gioco di ruolo.
La differenza sessuale è di fatto situata nel corpo e nella sua biologia che si fondono nell’esperienza e nei vissuti di ciascuno con le costruzioni sociali, storiche e culturali del femminile e del maschile. Anche i travestiti e i transessuali muovono da una primaria appartenenza di genere, che può forse essere cancellata dal corpo ma non dalla memoria e dall’inconscio.
Alcuni anni fa ho lavorato in psicoterapia con Francesco/Isabella, un uomo di trentadue anni diventato nel corpo la donna che riteneva di voler essere, grazie alla chirurgia e a pesanti terapie ormonali. La richiesta di intervento psicologico era motivata dalle difficoltà che riscontrava nel passaggio da un’identità all’altra e dalla necessità di rivisitare aree esistenziali e ricordi appartenenti alla precedente rappresentazione di sé.
Francesco, sin dalla primissima infanzia, era stato “performativamente” orientato verso la femminilità da una madre che, avendo desiderato in gravidanza una bambina, lo pettinava e vestiva come se lo fosse.
Operato all’età di venticinque anni, dopo circa sette di travestitismo, raccontava di avvertire ancora dentro di sé una forte presenza del maschile, che a suo dire si manifestava in particolare nelle relazioni affettive, contrassegnate dalla ricerca di autonomia, e in alcuni comportamenti e interessi.
Francesco, ormai Isabella, mi chiedeva spesso quali scelte avrei fatto io al suo posto, cosa avrei provato e sentito se mi fossi trovata a vivere le sue vicende. Sostanzialmente voleva sapere come sta al mondo una donna ed essere rassicurato e “contenuto” rispetto ad una scelta che non avvertiva come del tutto indipendente dai condizionamenti familiari e dalla sua storia di vita, nonostante la quantità di colloqui avuti con gli psicologi prima dell’operazione.
Il “transito”, contrassegnato scientificamente con la sigla MtF (Male to Female) nei documenti ed attuato grazie alla legge 164/1982, che riconosce il diritto di cambiare sesso e la conseguente rettifica anagrafica del nome, aveva comportato un vero e proprio lavoro di decostruzione della precedente identità maschile verso quella femminile di arrivo.
Con il tempo Francesco ha saputo essere Isabella, ha lasciato il lavoro di “intrattenitrice” in un night-club, profondamente rifiutato e sentito come l’unica chance per quelle come lei, si è laureata in lingue e lavora come traduttrice presso una ditta di import-export. Ha imparato a difendersi dagli altri e a esigerne il rispetto, anche se la sua sofferenza è ancora tanta. Riferendosi al suo passato, parla spesso del riaffiorare di quelli che chiama “residui materiali” del maschile e singolare è il fatto che nei sogni veda sempre se stesso con il corpo di prima, quello di un ragazzo.
La vita reale e quella virtuale, in cui possiamo sperimentare cambiamenti di genere e di identità senza troppa fatica, sono evidentemente due cose diverse.
Donna Haraway, vicina alle correnti filosofiche transumaniste, afferma che la differenza non la fa la donna, ma, testualmente, la macchina. I territori virtuali, fra i quali il primo e più noto fu “Second Life” (5), non sono che palcoscenici delle fantasie e dell’inconscio dei loro “abitanti” e visitatori.
In “Second Life” si può essere rappresentati da un “avatar” dalle sembianze di uomo o di donna o da un “furry” (6),attribuirgli un nome ed un’età, comperargli dei genitali o altre parti del corpo, che possono essere sostituite in qualsiasi momento acquistandone di nuove. In questo mondo virtuale tutto è incentrato sull’economia, il denaro e il consumo seppure virtuali ( ma fino a un certo punto dal momento che sono presenti al suo interno i negozi,virtuali, delle più importanti marche di cosmetici, articoli sportivi,ecc. in un’originale forma di pubblicità).
Per curiosità, come tanti, anni fa ho visitato il sito, ho “creato” un avatar e gli ho dato un nome. Mi somiglia, è una femmina ed ha la mia stessa età.
Ne ho tratto che non sono molto tentata da un cambiamento drastico di identità e tanto meno di genere.
Dopo aver esplorato questo strano luogo e aver conversato in modo molto elementare con “abitanti” e visitatori, mi sono chiesta se in questa seconda vita virtuale, tanto simile alla prima persino nella noia, ci si possa ammalare, avere un incidente o addirittura pretendere di morire. Ancora non l’ho scoperto, ma sono propensa a ritenere che non sia possibile e che, se per uno strano caso dovesse accadere, si ricomincerebbe a giocare, dunque a vivere, con una nuova identità. Il fantasma principale, quello che la postmodernità cerca in tutti i modi di negare è infatti la morte.
Questo è quanto.
E’ evidente però che gli universi virtuali possono avere ricadute psichiche sulla vita reale. Tutti ormai dobbiamo fare i conti con il nuovo, ma la corporeità è la dimensione fondamentale dell’umano e ad essa è collegata la memoria di noi stessi, la nostra continuità nel tempo. I corpi cambiano, crescono, maturano, invecchiano in vista della morte, finiscono. Mutano forma e significato in funzione del loro passato, presente, futuro.
Il sociologo Zygmunt Bauman definisce l’epoca attuale una“modernità liquida” (7), nella quale anche le identità sono fluide, cangianti, disomogenee. La liquidità implica una mancanza di forma stabile, i liquidi, dice Bauman, “scorrono, filtrano, tracimano, colano, traboccano” (8).
Nelle società occidentali le modalità di scambio delle informazioni provocano una sorta di accelerazione del tempo, per cui i cicli di vita ed i loro passaggi appaiono indefiniti e confusi, ma per quanta consuetudine il soggetto possa avere con la virtualità, rimane pur sempre incarnato, legato indissolubilmente alla storicità del suo corpo. Le comunità virtuali si originano nella fisicità e ad essa devono ritornare.
I “lavori in pelle”, gli automi del film “Blade Runner”, come pure gli angeli dei film di Wim Wenders, rivelano una grande nostalgia dell’umano e dell’incarnazione, soffrono per la mancanza di un corpo vulnerabile e mortale. La corporeità virtuale si situa al confine fra corpo vissuto e corpo oggetto e, più che la perdita, favorisce una dispersione dell’identità.
Secondo Lorena Preta “…tutto ciò può costituire una sorta di allucinazione non elaborabile, in cui…le parole non stanno ad indicare dei significati, ma sono immediatamente la cosa che indicano. Non c’è possibilità di distinzione fra piano simbolico e reale” (9).
L’idea di soggetto derivata alla cultura occidentale dalla filosofia e dalla psicologia è quella di un Io forte e definito, che sa effettuare distinzioni fra sè e il mondo esterno, ma i nuovi assetti sociali mettono in discussione questo assunto.
Lo psicoterapeuta Gian Paolo Lai, già molti anni fa parlava di “disidentità” (10) come coesistenza nello stesso individuo di modalità identitarie disomogenee connesse al dissolvimento dei riferimenti familiari, sociali, affettivi, politici, religiosi e culturali.
Lai aggiungeva che sarebbe stato necessario sradicare il pregiudizio secondo il quale la salute mentale corrisponde necessariamente alla conservazione della propria identità.
La Braidotti postula, a tale proposito, un “soggetto nomade” che mantiene però le sue coordinate attraverso un’operazione di “posizionamento” (11). “Posizionarsi” vuol dire partire da ciò che si è avendo ben presenti le proprie origini e genealogie, per muoversi in libertà ed agio nell’apertura al nuovo.
Noi siamo esseri “biologicamente situati” ed investiti dall’appartenenza di genere nella nostra strutturazione profonda.
Le “teorie del queer” della Haraway e della Butler ripristinano l’indifferenziato, l’impersonale e il neutro.
Certamente non esistono “la donna” e “l’uomo”, ma donne e uomini “posizionati” dal loro sesso, razza, cultura, età, stile di vita, contesto socio-economico, eccetera. Alcune di queste componenti sono evidentemente soggette a cambiamenti, le appartenenze non sono date una volta per tutte ma possono modificarsi.
Secondo Braidotti l’inconscio è l’agente che scombina le certezze dell’io, aprendo la soggettività a contraddizioni, paradossi, nuove possibilità.
Il “soggetto nomade” rinuncia al mito novecentesco dell’identità dagli argini solidi e dell’Io forte e accoglie altre possibilità, dà spazio all’altro da sé. Il “nomadismo” indica le potenzialità che, dentro e fuori di noi, hanno necessità di evolversi e consente il confronto profondo con la diversità e con lo “straniero”, con quanto abbiamo considerato estraneo e distante, con quel rimosso che Jung chiamava Ombra. Dentro e fuori di noi perché ogni cambiamento, passaggio, rottura degli equilibri precedenti è sempre intersoggettivo, cioè connesso e appartenente a un ambito di relazione.
In una società tanto veloce e proteiforme è impossibile fermare, definire e rendere statica l’identità individuale e sociale anche se questo genera angoscia e insicurezza.
Chi, come me, esercita professioni in cui è centrale la relazione di cura, deve necessariamente riflettere sulle trasformazioni sociali e integrare i propri saperi con altri emergenti e contigui, ri-orientare paradigmi e pratiche al fine di comprenderne le ricadute sulle strutture e i processi della mente.
L’osservatorio costituito dalla psicoterapia è, a tale scopo, un luogo di vedetta privilegiato: “Occorre evidenziare i nessi socio-culturali che presiedono le mutazioni in corso esplorando, per quanto è possibile, alcune aree specifiche d’interesse quali i cambiamenti della vita quotidiana, la struttura antropologica delle famiglie, alcuni vistosi processi di significazione della realtà che riguardano la comunicazione, le relazioni, l’identità, il rapporto con il corpo, con il tempo…provando a riconoscere nuove “grammatiche dello psichico” in relazione ai fenomeni sociali” (12).
Il terapeuta diventa così mediatore simbolico e accompagnatore in nuove configurazioni psichiche assai diverse da quelle per le quali era stato formato, essendosi venuto a creare un esteso rimescolamento dei disagi psicologici: “…disseminazione degli aspetti psicotici nelle nevrosi, patologia onnipresente del borderline,… diagnosi multiple e dimensioni multiple dei disturbi psichici” (13).
La complessità pone quindi delle sfide di crescente difficoltà a soggettività costantemente attraversate da processi di transizione e cambiamento, il cui senso di continuità ( il “posizionamento” della Braidotti) può forse essere restituito loro unicamente dalla memoria e dalla narrazione di sé .
1. Butler J., La disfatta del genere, Melteni, roma 20062. “Queer” vuol dire letteralmente “strano, strambo, eccentrico, difforme, inquietante,
grottesco”. Il termine è gergalmente riferito a persone omosessuali.
3. Haraway D., Symians, Cyborg and Woman, Free Association Press, London 1991
4. Secondo la religione induista un avatar è la sembianza fisica che le divinità scelgono di assumere per tornare sulla terra. Il termine deriva dalla lingua sanscrita e significa “disceso, incarnato”. Nel mondo virtuale e nei giochi di ruolo, un avatar è una rappresentazione umanoide del visitatore o del giocatore, una sorta di alter ego, che può per suo tramite muoversi,comunicare, avere esperienze.
5. “Second Life” è una comunità virtuale tridimensionale on-line creata nel 2003 dalla società americana Linden Lab. In “Second Life” tutto si compra, si vende e si scambia utilizzando una moneta virtuale. Il sito ha sei milioni di utenti (residenti) in tutto il mondo (stimati nel maggio 2007) e numerosissimi visitatori occasionali. Ogni abitante corrisponde ad un “avatar” o ad un “furry”, da lui scelto e costruito, che lo rappresenta ed al quale attribuisce nome e cognome. L’ “avatar” può essere di aspetto femminile o maschile.
6. Il termine “furry” appartiene allo slang americano ed indica un animale
antropomorfo. Riferito originariamente ai personaggi di fumetti, cartoni animati, giochi interattivi.
7. Bauman Z., Modernità liquida (2000), Laterza, Roma Bari 20028. Ibidem
9. Preta L., Editoriale, in Psiche, anno XI, n.1, 2003
10. Lai G.P., Disidentità (1988), Franco Angeli, Milano 1999
11. Braidotti R., Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, Donzelli,
Roma, 1994
12. D’Elia F., La mission sociale della psicoterapia, parte I, 2005 in www.altrapsicologia.it13. Petrella F., I disagi della psicoanalisi nella postmodernità, in www.spiweb.it
La relazione di cura
Il segreto della cura del paziente
È prendersi cura del paziente
Francis W. Peabody, The cure of the patient
In molti, soprattutto colleghi psicologi e medici, mi hanno domandato se questo testo fosse il risultato di un lavoro “scientifico” e perché avessi inserito allora una parte narrativa. Rispetto alla centralità del discorso sull’ “identità di genere”, poi, si sono detti scettici riguardo all’interesse che ancora, ai nostri giorni, può destare in eventuali lettori o lettrici.
Evidentemente, distinguere fra uomini e donne, occuparsi delle peculiarità psicologiche di un sesso anziché dell’altro e raccontare le storie che hanno preceduto l’inizio di un percorso terapeutico anziché dei “casi clinici”, vuol dire contrapporsi necessariamente alla “scienza”e alle ortodossie della “competenza tecnica” e della “professionalità neutrale”.
In tanti anni di libera professione ho però constatato che la richiesta di intervento psicologico proviene soprattutto dalle donne, i cui disagi e malesseri sembrano essere principalmente determinati dalla difficoltà di definire la propria identità e dai temi connessi alla differenziazione-separazione nelle relazioni interpersonali. Inoltre la mia identità non è sessualmente neutra, ma femminile e senza dubbio influenza la relazione di cura e le sue modalità. Nel rapporto, anche professionale, con altre donne, favorisce infatti rispecchiamenti e simmetrie.
Il modello medico, “scientifico”, asessuato e neutrale, fondato sulla disparità evidenziata dalle “insegne” (camici, strumenti tecnici, diagnosi e prognosi), è spesso invocato e imitato anche dalla psicologia e dalle psicoterapie perché i suoi rituali e copioni generano rispetto e considerazione di autorevolezza. Il rapporto asimmetrico fra chi richiede la cura e chi la eroga, consente passività al primo e acquisizione di potere al secondo. In tale configurazione è immediatamente evidente chi è “malato” e chi è “sano”, sia che si tratti di corpo che di mente.
Quando parliamo di psicoterapia, o comunque di qualsiasi intervento psicologico, è però evidente che alcune caratteristiche personali del “curante” interferiscono con i risultati della cura, compresa la sua appartenenza a un sesso o all’altro.
Come specificato dalla letteratura, il terapeuta, qualunque sia il suo orientamento teorico, deve avere capacità di ascolto, comprensione empatica, contenimento e
sostegno, saper riconoscere le emozioni del paziente nei suoi confronti (in psicoanalisi: transfert) e le proprie in risposta a lui (controtransfert), essere in grado di analizzarne le domande, motivarlo a una forte e salda alleanza terapeutica al fine di raggiungere gli obiettivi comunemente prefissati. Ancora: non deve essere invadente e intrusivo, deve evitare collusioni con le parti “malate” e le tendenze regressive del paziente, comunicare efficacemente e restituire con chiarezza “diagnosi” e interpretazioni.
In realtà tutte queste abilità sarebbero necessarie a chiunque volesse esercitare una cosiddetta professione di aiuto, sia nel campo psicologico e sociale che in quello medico.
I requisiti che fanno un buon psicoterapeuta sono generalmente rifiutati dai medici (1) come riferimenti “bassi”, forse nel timore che vadano a detrimento dell’autorevolezza della loro professione oppure perché, con l’ accento posto sull’ascolto, il contenimento, il sostegno e le emozioni richiamano troppo da vicino modalità connotate come femminili e materne.
Carol Gilligan definisce l’insieme di queste abilità “esperienza della connessione con gli altri” e a suo parere caratterizza l’agire “orizzontale” nella rete sociale tipico del femminile, contrapposto all’ordinamento gerarchico verticale maschile (2).
Gli statuti sono diversi, diversi i codici. Ma le differenze, tutte, non sono un disvalore, piuttosto possibilità di arricchimento.
Scrive Paolo Barcellona a proposito della Medicina:
“C’è un codice scientifico, di tipo paterno, e un codice umano, di tipo materno. Il primo arruola la scienza, la tecnica e lo spirito militare per combattere la morte, come un medico che riduce il malato a un campo di
battaglia…Il codice materno ricorda continuamente che il campo di battaglia non è un terreno inerte, ma una persona umana di cui non possiamo dimenticarci senza negare anche noi stessi” (3).
Nella relazione di cura non si possono ammettere scissioni e dicotomie, ma considerare la persona nell’interezza dei suoi bisogni, mettendogli al servizio tutte le competenze tecniche e scientifiche e le qualità umane che si possiedono.
Letteralmente il termine “cura” indica sia “l’insieme di medicamenti e rimedi per il trattamento di una malattia” che “l’interessamento sollecito e costante per qualcuno” (4); curare unifica i significati, differenziati nella lingua inglese, di “to cure” e “to care”( curare in senso medico e prendersi cura, mostrare premura). In qualunque relazione terapeutica entrambe le accezioni, curare l’altro e aver cura dell’altro, sono centrali e fondanti. Aver cura della relazione è il principio base di ogni relazione di cura. Nella coincidenza dei significati si stabilisce “il primato etico del tu” (5) e si riunisce quanto appare separato e difficilmente coniugabile: la razionalità con le emozioni, la logica con la passione, l’obiettività con la soggettività all’insegna di un radicale cambiamento di prospettiva.
1. Si veda Appendice2. Gilligan C., Con voce di donna, Feltrinelli, Milano 1984
3. Barcellona P., L’egoismo maturo e la follia del capitale, Bollati Boringhieri, Torino 1989
4. Cortelazzo M., Zolli P., Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1979
5. Levinas E., Marcel G., Ricoeur P., Il pensiero dell’altro, Edizioni lavoro, Roma 1999, p.75
.
Congedo
“…Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto “non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero.
La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro”.
Josè Saramago, Viaggio in Portogallo
Il nostro viaggio termina qui.
Abbiamo attraversato territori vasti, che avrebbero meritato soggiorni più lunghi e una conoscenza più approfondita.
Alcuni ci erano precedentemente ignoti, altri li abbiamo personalmente frequentati.
Il nostro è stato un viaggio fluido perché ha toccato luoghi dagli scenari differenti e preso direzioni ampie e varie…
Abbiamo voluto fornire e rifornirci di “cartoline”, assaggi di configurazioni e paesaggi utili alla riflessione.
I temi affrontati sono tutti aperti.
Dal viaggio che qui termina, un altro, nuovo, inizia.
Le storie raccontate da Simona si riferiscono a fatti realmente accaduti a persone realmente esistenti. I nomi sono stati modificati al fine di non renderle riconoscibili e tutelarne la privacy. Le ringraziamo per averci concesso l’autorizzazione a parlare di loro in questa sede.
I testi poetici “Se-If”, “Missiva di un neonato a sua madre” e “Dentro” sono di Simona Pesciaioli.
Bibliografia
AA.VV., Curare nella differenza, Psicoterapie del disagio femminile
(a cura di Paola Leonardi), Franco Angeli, Milano 2007, I ed.2002
AA.VV., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti, Firenze 1998
AA.VV., Il senso del male. Antropologia, storia e sociologia della malattia (a cura di Augè M., Herzlich C.), Il Saggiatore, Milano 1986
AA.VV., Imparare dalle donne, Comune di Terni Progetto Donna, Centro culturale Virginia Woolf, Università delle Donne gruppo B, Tipolitografia Visconti, Terni 1992
AA.VV., Letture bioniane (a cura di Neri C., Correale A., Fadda P.), Borla, Roma 1994
AA. VV., Psicoanalisi e identità di genere (a cura di Anna
Panepucci), Laterza, Roma Bari 199
AA.VV., Verso il luogo delle origini, La Tartaruga, Milano 1999
AA.VV., Verso un orientamento narrativo (a cura di Batini F., Zaccaria P.), Franco Angeli, Milano 2000
Agacinski S., La politica dei sessi, Ponte alle Grazie, Milano 1998
Balint M., Medico, paziente, malattia (1957), Feltrinelli, Milano 1961
Balint M., La regressione, Raffaello Cortina, Milano 1983
Barcellona P., L’egoismo immaturo e la follia del capitale, Bollati Boringhieri, Torino 1989
Bauman Z., Modernità liquida (2000), Laterza, Roma Bari 2002
Bauman Z., Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Laterza, Roma Bari 2006
Bernhard E., “Il Complesso della Grande Madre. Problemi e possibilità della psicologia analitica in Italia” in Tempo Presente, anno VI, n.12, Roma 1965
Boccia M.L., La differenza politica. Donne e cittadinanza, Il Saggiatore, Milano 2002
Braidotti R., Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, Donzelli, Roma 1994
Butler J., La disfatta del genere, Melteni, Roma 2006
Buzzatti G., Salvo A., Corpo a corpo. Madre e figlia nella psicoanalisi, Laterza, Roma Bari 1995
Cavarero A., Nonostante Platone, Editori Riuniti, Roma 1990
Cortelazzo M., Zolli P., Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1979
De Toffolo C., Psicosoma. Il sapere del corpo nel lavoro psicoanalitico, Rivista di Psicoanalisi, XLVII, 3, pp.465-486, 2001
De Toffolo C., Il lavoro somato-psichico della coppia materno-fetale: come “ciò” diviene “tu”, Richard e Piggle, 3, pp.271-284, 2003
Deleuze G., Differenza e ripetizione (1968), Il Mulino, Bologna 1971
Derrida J., La scrittura e la differenza (1979), Einaudi, Torino 1990
Derrida J., Il fattore della verità (1975), Adelphi, Milano 1978
Diotima, Il pensiero della differenza sessuale, la Tartaruga, Milano 1987
Diotima, il cielo stellato sopra di noi. L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 1994
DSM-IV, Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, APA
1995
Duden B., Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto di vita, Bollati Boringhieri, Torino 1994
Fonagy P., Target M., Attaccamento e funzione riflessiva, Raffaello Cortina, Milano 2001
Fornari F., Frontoni L., Riva Prugnola C., Psicoanalisi in ospedale. Nascita e affetti nell’istituzione, Raffaello Cortina, Milano 1985
Freud S., L’interpretazione dei sogni (1899), Bollati Boringhieri, Torino 1989
Freud S., Il Perturbante (Das Unheimliche, 1919), in Opere vol.IX, Bollati Boringhieri, Torino 1977
Freud S., Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica fra i sessi (1925), in Opere vol.X, Bollati Boringhieri, Torino 1978
Freud S., Sessualità femminile (1931), in Opere vol.XI, Bollati Boringhieri, Torino 1979
Giardini F., Relazioni. Differenza sessuale e fenomenologia, Luca Sossella Editore, Roma 2004
Gilligan C., Con voce di donna (1982), Feltrinelli, Milano 1987
Grmek N. D., La vita, le malattie e la storia, Di Renzo Editore, Roma 1998
Haraway D., Symians, Cyborgs and Women, Free Association Press, London 1991
Harding H., I misteri della donna (1929), Astrolabio, Roma 1973
Harding H., La strada della donna (1932), Astrolabio, Roma 1974
Harding H., The I and not I, Princeton University Press, Princeton 1965
Heidegger M., Essere e tempo (1927), UTET, Torino 1962
Hillman J., Re-visione della psicologia, Adelphi, Milano 1992
Husserl E., L’idea della fenomenologia (1950), Il Saggiatore, Milano 1981
Illich I., Nemesi medica, Mondatori, Milano 1976
Ipazia, Autorità scientifica, autorità femminile, Editori Riuniti, Roma 1992
Irigaray L., Speculum (1974), Feltrinelli, Milano 1975
Irigaray L., Questo sesso che non è un sesso (1977), Feltrinelli, Milano 1980
Irigaray L., Etica della differenza sessuale (1984), Feltrinelli, Milano 1985
Irigaray L., Sessi e genealogie (1987), La tartaruga, Milano 1989
Irigaray L., Io, tu, noi (1991), Bollati Boringhieri, Torino 1992
Irigaray L., Amo a te (1992), Bollati Boringhieri, Torino 1993
Irigaray L., Essere due, Bollati Boringhieri, Torino 1994
Jung C.G., “Anima e Animus” (1928), ne “L’Io e l’inconscio”, in Opere vol.VII, Bollati Boringhieri, Torino 1982
Jung C.G., “Aspetto psicologico della figura di Kore” (1941), in Opere vol.IX, t.I, Bollati Boringhieri, Torino 1980
Jung C.G., Simboli della trasformazione (1952), in Opere vol.V, Bollati Boringhieri, Torino 1970
Klein M., Invidia e gratitudine (1928), Martinelli, Firenze 1965
Kristeva J., “The Maternal Body”, in “m/f” nn.5- 6, 1981
Lacan J., Scritti (1966), Einaudi, Torino 1972
Lacan J., Il Seminario, Libro III,”Le psicosi” (1955-56), Einaudi, Torino 1985
Lai G.P., Disidentità (1988), Franco Angeli, Milano 1999
Lemoine Luccioni E., Il taglio femminile, Edizioni delle donne, Roma 1976
Levinas E., Marcel G:, Ricoeur P., Il pensiero dell’altro, Edizioni Lavoro, Roma 1999
Levy P., Il virtuale (1995), Raffaello Cortina, Milano 1997
Milgrom J., Mother- Infant interaction and postpartum depression, final Report of the Victorian Health Promotion Foundation, Melbourne, Australia 1991
Milgrom J., Martin P.R.e Negri M.L., Depressione Postnatale. Ricerca, prevenzione e strategie di intervento psicologico, Erikson, Trento 2003
Muraro L., L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 1991
Muraro L., La folla nel cuore, Il Saggiatore, Milano 2000
Muraro L., Il dio delle donne, Mondatori, Milano 2000
Preta L., Editoriale, in Psiche, anno XI, n.1, 2003
Resnik S., L’esperienza psicotica, Bollati Boringhieri, Torino 1986
Rogers C., la terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze 1970
Rosser W., Shafir S., Evidence Based Family Medicine Decker Inc., Hamilton, London 1998
Stanghellini G., Ballerini A., Ossessione e Rivelazione, Bollati Boringhieri, Torino 1992
Stein E., Il problema dell’empatia, Edizioni Studium, Roma 1998
Stern D.N., Psicoanalisi dell’amore, Laterza, Roma Bari 1993
Stern D.N., La costellazione materna, Bollati Boringhieri, Torino 1997
Stern D.N., Brushweiler, Stern N., Come l’esperienza della maternità cambia una donna, Mondadori, Milano 1999
Tartarelli R., De Pisa E., Girardi P., Curare con il paziente, Franco Angeli, Milano 1998
Titchener E., Experimental psychology of the thought processes, Mc Millian, New York 1909
Tubert S., la sessualità femminile e la sua costruzione immaginaria, Laterza, Roma Bari 1996
Vahinger H., La filosofia del come se, Ubaldini, Roma 1967
Vegetti Finzi S., Psicanalisi al femminile, Laterza, Roma Bari 1992
Vegetti Finzi S., il bambino della notte. Divenire donna Divenire madre, Mondatori, Milano 1996
Winnicott D.W., Dal luogo delle origini, Raffaello Cortina, Milano 1990
Contributi in rete e riferimenti ipertestuali
D’Elia F., La mission sociale della psicoterapia, parte I , 2005 in www.altrapsicologia.it,
Putrella R., I disagi della psicoanalisi nella postmodernità, Argomenti in linea 2005-2006 (a cura di Mario Rossi Monti), in www.spiweb.it-
(sito della Società Psicoanalitica Italiana)
Alessandra Parroni è psicologa, psicoterapeuta e psicologa analista di formazione junghiana. Docente di Psicologia e Scienze dell’Educazione, ha svolto per molti anni attività clinica, mediazione familiare e sostegno nelle separazioni e nei percorsi di genitorialità.Attualmente si occupa di psicologia dello sport come preparatrice mentale ed è istruttrice di Mindfulness.
Simona Pesciaioli, laureata in Lettere e Filosofia, insegnante e formatrice, sceneggiatrice, doppiatrice, giornalista e scrittrice, ha pubblicato “Gregorovius, per gli amici Gregorio”, “Il pollo dei parenti”, “Guida di Narni e d’amore”, “A lume di luna”, “Carta e penna” e “Il Porticaccio”, da cui è stata tratta la sceneggiatura di “Acqua”.


































































































![Invisibilità Identità nascoste · Femminicidio: una parola che sul vocabolario non c'è, come tante altre parole nate di recente che indicano la divisione di genere. […] scrivere](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5c68d65509d3f206678c1ed1/invisibilita-identita-nascoste-femminicidio-una-parola-che-sul-vocabolario.jpg)