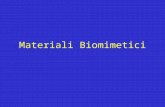UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE DI TRENTO Corso di Laurea … · 2018-09-05 · 3 Ardilouze, 2013...
Transcript of UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE DI TRENTO Corso di Laurea … · 2018-09-05 · 3 Ardilouze, 2013...

1112Marco Muggia
Corso di Laurea Interateneo inViticoltura ed Enologia
Università degli Studi di Udine
Elaborato per il conseguimento dellaLaurea(L-25)
Analisi tecnico-economica della vinificazione in riduzione
Relatore: Prof. Roberto Zironi Laureando: Marco Muggia
Correlatore: Dott. Piergiorgio Comuzzo
ANNO ACCADEMICO:2016 - 2017
UNIVERSITÀ DEGLI STUDIDI UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDIDI TRENTO

2Marco Muggia

3
Indice
Introduzione
Conclusione
Bibliografia
Parte Prima
Parte Seconda
Parte Terza
5
101
107
9
35
67
Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione

4Marco Muggia

5
Introduzione

6Marco Muggia

7 Introduzione
Così scriveva Pasteur secoli fa, a dimostrazione del fatto che il ruolo dell’ossigeno nell’elaborazione ed affinamento di vini è fondamentale.
Nei primi anni 2000 si è diffusa una tecnica di vinificazione, in uso per la produzione di vini bianchi e particolarmente per le cultivar aromatiche, formulata in Francia negli anni ’60. Essa si basa sulla totale esclusione del contatto fra vino ed aria, allo scopo di preservare tutte le frazioni componenti il vino stesso dalle ossidazioni.
In particolare, l’obbiettivo del protocollo in analisi, è quello di preservare quelle com-ponenti più facilmente ossidabili e che, con altre filosofie di vinificazione, andrebbero incontro ad alterazioni già durante le primissime fasi.
L’insieme delle strategie votate a questo obbiettivo prende il nome di Vinificazione in iper-riduzione (IR)2.
In via teorica si ipotizza come la protezione del vino durante tutto l’iter produttivo, dalla pressatura delle uve fino all’imbottigliamento, possa preservare una vasta varietà di sostanze aromatiche e loro precursori. Questo dà così la possibilità di ottenere vini più complessi e aromaticamente ricchi, in virtù della maggior protezione dalle ossidazioni nei confronti delle frazioni più sensibili.
Per conseguire questo risultato è uso comune l’aggiunta di conservanti, l’impiego di macchinari adattati allo scopo uniti all’utilizzo di gas inerti in diverse fasi della vinifica-zione, e sin dal suo principio.
Lo scopo di questa trattazione è molteplice, ed interdisciplinare. Il comun denomi-natore è l’analisi critica dell’applicazione dell’iper-riduzione, indagando quali siano le
L’ossigeno è il più acerrimo nemico del vino, ma è proprio l’ossigeno a fare il vino, che invecchia per anni sotto la sua influenza1.
1 Pasteur L., Études sur le vin, Forgotten books, 1866.2 Antonelli A., Arfelli G., Masino F. Sartini E., 2010.

8Marco Muggia
differenze con le vinificazioni tradizionali e provando a determinare quando sia realmente utile il suo impiego, riconoscendone limiti e pregi.
La prima parte è funzionale al fornire le premesse fondamentali per la comprensione dei fenomeni che si implementano attraverso il mantenimento dei mosti e dei vini in uno stato ridotto, condizione non ordinaria nelle vinificazioni fino a pochi anni or sono. Si affronteranno le dinamiche e l’attività dell’ossigeno nei sistemi enologici, oltre a fornire la nozionistica necessaria al prosieguo della tesi.
La seconda parte ha lo scopo di analizzare in che modo le condizioni specifiche in cui si opera siano mantenute e controllate, specificando quali fenomeni e quali difetti possano verificarsi in tali, particolari, condizioni.
L’ultima parte cerca di integrare alla trattazione alcuni dati economici e statistici sulla produzione ed il consumo, per ricercare dei parametri che consentano di interpretare le nozioni tecniche in chiave imprenditoriale e gestionale. Attraverso una, seppur grosso-lana, analisi della variazione dei costi, si intende confrontare questi dati con quelli di un’indagine statistica. L’indagine è stata redatta per ottenere informazioni sull’interesse di un campione di pubblico riguardo la vinificazione in IR ed i prodotti che attraverso essa si ottengono.

9
Parte PrimaPremesse fondamentali degli equilibri redox nel vino

10Marco Muggia

11 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
La vinificazione in IR è una tecnica di elaborazione delle uve bianche attraverso una fi-liera che prevede un costante controllo dell’ossigeno, allo scopo di operare in sua presen-za solo quando strettamente necessario, praticamente solo in concomitanza con l’attività fermentativa. L’obbiettivo è quindi quello del controllo del potenziale redox durante tutta la filiera, dalla campagna al consumo del prodotto finito, operando in modo da mantenerlo il più basso possibile.
E’ possibile questa applicazione a tutte le uve bianche, ma essa risulta particolarmente impiegata su cultivar ricche di aromi varietali presenti in forma sensibile alla degradazio-ne ossidativa.
La sua diffusione su larga scala si è avuta in Australia e Nuova Zelanda, dove viene impiegata su cultivar quali Sauvignon, Gewurtztraminer, Chenin, Petit, Manseng e Co-lombard. Può essere tuttavia impiegata anche su uve rosse per la produzione di vini rosati, quali Grenache, Merlot e Cabernet3.
Altri autori hanno evidenziato come questa tecnica possa essere impiegata con buoni risultati anche con cultivar non aromatiche: Savino ha rilevato che l’uso della vinificazio-ne IR può essere utile per la produzione di vini assai caratterizzati da sentori varietali4.
Baiano suggerisce di accoppiare il controllo costante dell’equilibrio redox durante la filiera ad una criomacerazione prefermentativa delle uve al fine di ottenere vini aromati-camente esaltati5.
La diffusione di questa tecnica è stata, quindi, così importante a causa della sua capa-cità di dare vini particolarmente intensi dal punto di vista aromatico, con una preponde-ranza dei sentori varietali. Allo scopo di mantenere questa nota di freschezza, sono soli-tamente esclusi l’uso del legno ed un prolungato contatto con le fecce di fermentazione6.
La vinificazione in iper-riduzione
3 Ardilouze, 2013 .4 Savino et al., 2007.5 Baiano et al., 2013.6 Gibson, 2004.

12Marco Muggia
Sono invece di largo uso gli antiossidanti: l’uso accoppiato di anidride solforosa e acido ascorbico, per l’accelerazione della risposta antiossidante dei mosti/vini, è ormai pratica fondamentale per chi redige un protocollo di vinificazione in IR. L’acido ascorbi-co è in grado di ossidarsi più velocemente dell’anidride solforosa, rendendo più dinamica la protezione dei composti del mosto/vino, dando come prodotto il perossido di idrogeno. Questi, a sua volta, scarica il suo potenziale ossidante sull’anidride solforosa. Tali additivi risultano fondamentali sin dalle prime fasi, per preservare i composti aromatici varietali ed i loro precursori dai processi ossidativi enzimatici che si avviano, inevitabilmente, al momento della raccolta.
Altre tecniche enologiche vengono spesso implementate, come l’utilizzo di gas inerti che sono di largo uso in diverse fasi della vinificazione. Essi vengono impiegati in quanto sostituti dell’aria in momenti nei quali un contatto fra mosto/vino e fase gassosa è inevi-tabile, situazione che si verifica abbastanza di frequente durante le movimentazioni ed i trattamenti dei prodotti vitivinicoli.
L’applicazione di questa tecnica prevede anche l’impiego di macchinari idonei per le manipolazioni in ambiente ad atmosfera controllata.
Il suo impiego sembra non causare grandi variazioni, secondo lo studio di Antonelli, nelle concentrazioni di zuccheri riduttori, alcol etilico, acidità volatile ed altri acidi or-ganici7. Altresì, si evidenziano variazioni nelle quantità di sostanze che sono solitamente esposte alle ossidazioni e che con questo protocollo risultano più protette, quali i polife-noli e le sostanze aromatiche.
7 Antonelli et al., 2010.

13
Antonelli A., et al. Modificato Muggia M.
Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
Protocollo di vinificazione in iper-riduzione
Raccolta
Pigiadirasfatura
Am
biente inertizzato
Pressatura sofficecon pressa a polmone
∙ SO2∙ Acido ascorbico
∙ Bentonite∙ Gelatina
∙ Starter di lievito∙ Apporto azotato∙ SO2
∙ SO2∙ Coadiuvanti
∙ Ultime addizionidi coadiuvanti∙ SO2∙ Acido ascorbico
∙ Gas Argon
∙ Ghiaccio secco
Chiarifica statica esedimentazione 8°C 48 h
Travaso
Fermentazione
Sedimentazione
Refrigerazione e affinamento
Chiarifica e filtrazione
Imbottigliamento

14Marco Muggia
E’ conoscenza ormai consolidata il fatto che l’ossigeno assuma un ruolo fondamentale per l’ottenimento e l’evoluzione dei vini8. Esso rappresenta anche un fattore di instabilità nei vini stessi, partecipando alle cinetiche che portano alla degradazione di composti vari, fra cui quelli aromatici, e al loro precoce invecchiamento.
Altresì, l’ossigeno riveste un ruolo fondamentale nei processi metabolici di Saccha-romyces cerevisie, in particolare in quelli necessari per la costituzione della membrana lipidica, intervenendo nella sintesi di steroli e acidi grassi insaturi. Tale struttura, oltre a regolare gli scambi con l’esterno della cellula, è un fattore fondamentale per conferire resistenza all’alcole etilico ed altre sostanze. Sono infatti numerose le sostanze che in-fluiscono negativamente sul metabolismo dei lieviti, e la parete è la principale barriera utilizzata dalla cellula: un suo corretto sviluppo è funzionale alla diminuzione del rischio di precoci arresti fermentativi.
Fondamentale è anche il suo ruolo nella fissazione del colore nei vini rossi. L’ossida-zione dell’etanolo ad etanale rende questa specie disponibile per la formazione di ponti che rendono possibile la combinazione fra gli antociani liberi ed i tannini, stabilizzando gli antociani liberi (facilmente ossidabili) e aumentando la frazione colorante. Seguendo un altro processo chimico si evidenzia come il flavene (complesso che si origina dalla re-azione diretta fra il catione flavilio con un flavanolo) possa subire ricolorazione a seguito all’ossidazione implementata dall’ossigeno o da un’altra sostanza ossidante9.
L’ossigeno riveste un ruolo fondamentale durante i processi di trasformazione delle uve in vino10: esso condiziona molti processi chimici e biologici, in modo determinan-te. Il suo effetto può quindi essere voluto (perché fondamentale), inevitabile (durante la raccolta, ad esempio) o occorrere per errore. Gli effetti dipendono dalla tipologia di vino (alcuni vini a lungo invecchiamento, o vini speciali come il Madera sono in grado di ri-spondere meglio alle esposizioni all’aria rispetto ad altre tipologie), dalla sua protezione antiossidante (con composti endogeni alle uve ed ai lieviti, o addizionati come l’anidride solforosa) e dall’intensità dei processi ossidativi: apporti troppo limitati di ossigeno por-tano all’instaurarsi di un ambiente riducente, che può portare allo sviluppo di difetti orga-nolettici o di arresti fermentativi. Altresì, apporti dosati e controllati di ossigeno possono essere fondamentali per l’evoluzione di composti correlati positivamente con la qualità organolettica. Qualora l’apporto di ossigeno al vino, od ai mosti, sia eccessivo ed avvenga in un momento errato, si può assistere all’insorgenza di ossidazioni incontrollate a carico
Il ruolo dell’ossigeno
8 Pasteur L., Études sur le vin, Forgotten books, 1866.9 Ribereau-Gayon et al, 2003.10 Petrozziello, Il controllo dell’ossigeno nel vino. L’Informatore agrario N.40, 2004.

15 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
del comparto aromatico, e non solo. E’ quindi fondamentale il controllo delle ossigenazioni dei vini, per calibrarne il mo-
mento e l’entità in funzione dell’obbiettivo enologico, o per salvaguardare il prodotto in fasi delicate come l’imbottigliamento.

16Marco Muggia
L’ossigeno si discioglie nel vino, o nel mosto, durante le varie operazioni di movimen-tazione delle masse, ed attraverso i contenitori, sin dalla pigiatura delle uve. Non trascu-rabile è anche l’aliquota di gas disciolto nelle uve in parziale ammostamento prima della pressatura. L’ossigeno gassoso è una molecola apolare, che quindi non ha una particolare tendenza a sciogliersi in un solvente polare come l’acqua. La solubilità è funzione della temperatura e della pressione parziale esercitata dal gas11.
L’aria è una miscela di gas -fra cui i principali sono azoto, ossigeno oltre a frazioni minori di altri gas- e lo scambio fra questa e il vino è regolato pertanto dalla legge delle pressioni parziali: considerando che la pressione a 20° C è pari a 1013 hPa, e la propor-zione fra ossigeno e volume totale di miscela gassosa di circa 1:5, la pressione parziale dell’ossigeno è pari a 206 hPa12. A tali condizioni, l’equilibrio di saturazione dell’ossige-no nei vini è pari a 6 mL/L, pari a circa 8 mg/L.
Il contatto fra un gas e una fase liquida porta al manifestarsi del fenomeno della disso-luzione del gas all’interno della fase liquida, fino alla sua saturazione. Questo fenomeno è regolato dalla legge di Fick:
F: flusso di trasferimento espresso in moli al secondo per metro quadrato.D:coefficiente di diffusione.
Meccanismi dell’apporto di ossigeno
dc
dcdt
dt
11 De Basquiat et al., 2008.12 Devatine et al., 2007.
F=
:si riferisce al gradiente di concentrazione della specie nella direzione del fenome-no di diffusione per unità di tempo.
Nel caso dell’ossigeno, la legge di Fick si esprime come:
C1: indica la concentrazione di ossigeno a saturazione.C0: indica la concentrazione dell’ossigeno disciolto nel solvente.Ki: coefficiente di diffusione dell’ossigeno tra due diverse fasi in m/sec.
La dinamica è funzione della superficie di contatto fra fase gassosa e liquida: tanto
F = Ki ∙ (C1-C0)
∙ D[ ]

17 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
P = k ∙ C
P: è la pressione che il gas esercita sulla soluzione.k: è una costante specifica per un gas che relaziona la concentrazione della specie con
la pressione esercitata sulla soluzione, è specifico per solvente e temperatura.C: indica la concentrazione molare del gas nella soluzione.
E’ importante poter controllare la temperatura del prodotto, vista l’influenza che que-sto parametro assume sulla capacità dell’ossigeno di sciogliersi nel vino e nei mosti.
maggiore risulta qust’ultima, tanto minore sarà il tempo necessario per conseguire la sa-turazione. La velocità di dissoluzione dei gas in fasi liquide è inversamente proporzionale alla temperatura.
La solubilità è la proprietà di una sostanza di sciogliersi all’interno di un solvente, dando origine ad una soluzione. Anche le sostanze presenti in forma gassosa possono sciogliersi in un solvente liquido in determinate condizioni.
In particolare la legge di Henry è in grado di descrivere, a temperatura costante, la so-lubilità di un gas, essendo essa direttamente proporzionale alla pressione che il suddetto esercita sulla soluzione.

18Marco Muggia
Una volta disciolto nel vino, l’ossigeno, non resta costante nel tempo ma è soggetto ad un consumo che risulta in parte funzione della quantità di sostanze che vi possono reagire. Per questa ragione, generalmente, il consumo risulta più rapido nei vini rossi rispetto ai bianchi.
Il consumo dell’ossigeno è diverso nei mosti rispetto ai vini: mentre nei mosti le os-sidazioni sono per lo più catalizzate da enzimi, nei vini ottenuti con una corretta vini-ficazione questo processo risulta preminentemente di tipo chimico. Entrambe le vie di ossidazione risultano essere temperatura dipendenti.
L’ossigeno entra in contatto con il mosto ed il vino durante le operazioni tecnologiche, o a causa di scorretto stoccaggio (contenitori scolmi).
L’ossigeno disciolto nel mosto in fermentazione viene rapidamente consumato dal metabolismo dei lieviti, senza che si evidenzino ossidazioni di rilievo quando l’attività metabolica del lievito è ben avviata.
Quando l’ossigeno è invece disciolto in vino con le operazioni di cantina, reagisce con le varie componenti e progressivamente non risulta più presente nella sua forma elemen-tare fino a valori di decine di microgrammi/L. In seguito la cinetica di diffusione diviene inferiore rispetto a quella di consumo. In tale situazione, quando si stabilisce un contatto fra la superficie della fase liquida ed una miscela di gas contente ossigeno, uno strato superficiale sottilissimo di fase liquida vede un gradiente di concentrazione dell’ossigeno alla superficie del vino13.
Il consumo dell’ossigeno, avvenga esso per via enzimatica, biologica o chimica, è co-munque un processo controllato dalla temperatura. Per tale ragione è possibile affermare che il consumo e la solubilizzazione dell’ossigeno nei vini e nei mosti sono due fenomeni condizionati in maniera opposta dalla temperatura.
Una volta passato in soluzione, esso entra solitamente in contatto con ioni metallici quali Fe3+ e Cu2+, che vengono definite specie autossidabili. Non solo questo fattore in-fluenza l’attivazione dell’ossigeno - vale a dire la sua conversione in una forma a mag-gior potere ossidante - ma si ipotizza un ruolo importante di altri fattori quali la luce ed i radicali liberi.
Consumo dell’ossigeno
13 Moutounet e Mazauric, 2001.

19 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
L’ossigeno allo stato fondamentale, presenta due elettroni spaiati, su orbitali moleco-lari diversi e con spin parallelo (tripletto). In questa forma, non vi è una forte instabilità nella molecola. Al contrario, essa si presenta relativamente inerte.
Affinché possa fungere da ossidante, è necessario che alla molecola venga trasferita una certa quantità di energia, in grado di eccitarla. In conseguenza dell’eccitazione, si avrà il passaggio allo stato di singoletto →+.
In soluzione acquosa l’ossigeno molecolare può accettare un elettrone e ridursi, dando origine ad una forma radicalica, l’anione superossido O2-. Questa specie risulta anfotera, può cioè reagire sia come base che come acido, ma ai valori di pH del vino è presente nella forma protonata del radicale idroperossido HOO* ed è un precursore di altre specie fortemente reattive come il radicale idrossile OH*.14
L’anione superossido può anche essere ridotto a ione perossido O22- con una reazione
catalizzata da ioni metallici come Fe2+/Fe3+ e Cu +/Cu2+. Questa molecola può poi essere protonata dando come prodotto il perossido di idrogeno H2O2, che è un ossidante molto forte.
Processi di ossidazione
14 http://confraternitavitevino.it/public/tesi/2009_2010/Tesi_Scollo.pdf
Reazioni che coinvolgono l’ossigeno.
15 Karbowiak et al., 2010.16 Ribéreau-Gayon et al., 2003.17 Ribéreau-Gayon et al., 2003.
Una volta formatosi, il perossido di idrogeno può convertirsi, con una reazione cata-lizzata da ioni metallici (Reazione di Fenton), in ione idrossile HO- e il radicale idrossido HO*.15
Con tutto questo processo, di fatto, si assiste a una progressiva riduzione dell’ossigeno che si converte in forme via via più reattive. L’ossigeno molecolare, quindi, non risulta essere un ossidante di per sé molto forte, mentre le specie che forma in seguito all’atti-vazione, si rivelano degli ossidanti più forti in grado di ossidare le altre componenti del mosto/ vino16. Si parla in questo caso della via di ossidazione chimica.
Un’altra via importante per il consumo dell’ossigeno, è quella enzimatica. Le polife-nolossidasi, catalizzano l’ossidazione a carico di una vasta gamma di molecole: general-mente, la loro presenza è tecnicamente rilevante solo nelle prime fasi della vinificazione, in quanto, al giorno d’oggi, sono facilmente rimovibili dai mosti prima della fermentazio-ne alcolica17. Hanno diversa origine, ma senza dubbio quella preponderante rimanda alle infezioni di funghi patogeni come Botrytis cinerea (tirosinasi e laccasi).
O2 O2- O2
2- HO2- H2O2
e- e- H+ H+
→ → → →← ← ← ←

20Marco Muggia
Il processo di ossigenazione del vino, dal punto di vista chimico-fisico, è stato prece-dentemente descritto. Dal punto di vista tecnico, tuttavia, è possibile identificare due mo-dalità per l’apporto di ossigeno ai mosti ed ai vini, classificandole in funzione del volume di ossigeno apportato per unità di tempo: macro e micro-ossigenazione.
La macro-ossigenazione consta di un apporto nell’ordine dei mg/L al giorno. Essa si realizza, volutamente o incidentalmente, in concomitanza con le operazioni tecniche. Le operazioni cui ci si riferisce sono quelle riportate nella tabella a pagina 23, ma i dati riportati si riferiscono ad operazioni eseguite in maniera tecnicamente corretta. É da sot-tolineare, tuttavia, che qualora le attrezzature non siano in perfetto stato d’uso, o qualora l’operatore non esegua in maniera corretta l’operazione, l’apporto di ossigeno può essere più consistente (ed è in questa situazione che si corrono i maggiori rischi di ossidazioni che inficiano la qualità del prodotto). La macro-ossigenazione comincia con la raccolta e l’ammostamento, ed in questa fase solitamente è incidentale, mentre assume un ruolo di rilievo durante la fermentazione: qui viene implementata volontariamente per sostenere il metabolismo dei lieviti.
Con il termine micro-ossigenazione, altresì, si intende indicare l’apporto di ossigeno nell’ordine dei mg/L al mese. Questa dinamica si può ottenere grazie all’effetto dei conte-nitori, qualora siano porosi, oppure per mezzo di attrezzature specifiche (micro-ossigena-tori) che lavorano anch’esse in continuo, apportando piccole dosi di ossigeno per lunghi periodi di esercizio. Si utilizza questa tecnica per sopperire alle necessità di ossigeno dei vini in affinamento ed evoluzione.
Il potenziale di ossidoriduzione di un vino esposto all’aria è dell’ordine dei 400-500 mV: per riferimento, quello di un vino mantenuto a lungo a riparo dall’ossigeno si avvi-cina ai 100-150 mV18.
Ossigenazione
18 Ribéreau-Gayon et al., 2003.

21
L’equilibrio redox si instaura in seguito al trasferimento di elettroni fra due specie, una ossidata e una ridotta. La cinetica chimica prevede che una specie ossidata possa cedere elettroni ad una specie ridotta, riducendosi, e viceversa la specie ridotta possa convertirsi nel suo omologo ossidato arricchendosi di elettroni.
Il potenziale elettrochimico è un indice dell’attività degli elettroni in equilibrio con i due partners della coppia redox. La sua unità di misura, riferendosi esso al trasferimento di elettroni, è il mV (millivolt)19.
In particolare, il potenziale E0, indica la dinamica ossidoriduttiva del vino quando il sistema è in condizione di equilibrio.
L’equazione di Nernst, mette in relazione il potenziale ossidoriduttivo con il rapporto fra le concentrazioni dei due partner di una coppia redox, considerando anche altri fattori fra cui il numero di elettroni scambiati, la temperatura, la costante di Faraday e la costante universale dei gas20.
Equilibri redox
19 Ribéreau-Gayon et al., 2003.20 Roure et al..
R∙T EH = E0 + ∙ logn∙F[Ox ]
[Red]
Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
EH: potenziale ossidoriduttivo della coppia redox.E0: potenziale ossidoriduttivo di base della coppia. R: costante universale dei gas. T: temperatura a cui avviene l’equilibrio (in Kelvin).n: numero di elettroni che prendono parte alla reazione. F: costante di Faraday.[Ox]: concentrazione molare della specie ossidata.[Red]: concentrazione molare della specie ridotta.

22Marco Muggia
Le specie che intervengono nel trasferimento di elettroni, sono numerose, ma quelle di maggior rilievo dal punto di vista della tecnologia enologica sono classificabili in due categorie, non nettamente distinguibili, ma che danno una indicazione della loro influenza sul potenziale ossidoriduttivo del sistema.
Le specie caratterizzate da un potenziale più basso, come l’anidride solforosa e l’aci-do ascorbico, il glutatione, i composti fenolici, presentano una tendenza ad ossidarsi21. Questa considerazione ha portato ad assumere come utile, nell’ottica di ottenere vini con minore sensibilità alle ossidazioni, la rimozione dal vino delle sostanze che esprimono questa caratteristica. In particolare, cercando di limitare la presenza di sostanze ossida-bili, con opportune chiarifiche ed evitando macerazioni delle uve, secondo questo stile di vinificazione si mira ad ottenere vini più semplici e poveri in struttura, ma senza una gamma di sostanze che sono sensibili all’ossigeno (enologia sottrattiva).
Dall’equazione di Nernst si evince altresì come il potenziale sia funzione della con-centrazione delle specie ossidata e ridotta. Questo concetto è alla base di una enologia di tipo conservativo, che punta cioè ad avere maggior concentrazione delle specie coinvolte negli equilibri22.
Le specie che presentano un potenziale ossidoriduttivo più elevato, sono quelle specie già presenti in forma ossidata, non più sensibili ad ossidazione e pertanto in grado, in al-cune condizioni, di non cambiare la loro forma anche qualora nell’equilibrio intervenisse una quantità importante di ossigeno23.
Specie che trasferiscono elettroni nei vini
21 Tesi della dott. Scollo.22 Roure et al.23 http://infowine.com/intranet/libretti/libretto3691-01-1.pdf

23 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
Per meglio comprendere la dinamica dell’ossigeno nei vini e nei mosti, a prescindere dalla natura dell’apporto di questa specie, è importante comprendere come le varie fasi della vinificazione presentino dinamiche ossidoriduttive diverse. E’ possibile distinguere tre diverse fasi sotto il profilo del potenziale ossidoriduttivo e della sua gestione: la fase pre-fermentativa, la fase fermentativa e la fase post-fermentativa.
Fase pre-fermentativa.Prende avvio con la raccolta delle uve e l’ammostamento, involontario, che si realizza
contestualmente. Per i vini rossi questa fase ha una durata limitata, in quanto termina con l’avvio della fermentazione alcolica nell’arco di poche ore. In questo momento l’apporto di ossigeno può essere anche consistente. L’ossigeno disciolto nel mezzo, in questo mo-mento, non si combina direttamente con le sostanze più ossidabili, ma per mezzo di una catalisi enzimatica (tirosinasi e laccasi) o ad opera di metalli pesanti come ferro e rame, va ad ossidare composti fenolici semplici quali gli acidi fenolici ed i chinoni. Questo fenomeno avviene in funzione del pH, che regola il rapporto fra fenolo (ossidabile) e fe-nolato. Altre molecole risultano ossidate in questa fase, ed in particolare sono di interesse enologico le ossidazioni a carico di aromi e loro precursori24.
L’ossidazione viene limitata, entro un piccolo intervallo, dalla presenza di alcuni an-tiossidanti già presenti nelle uve: composti fenolici, glutatione e acido ascorbico (anche se poco concentrato).
Riguardo i composti fenolici, è importante sottolineare che la loro protezione è di breve durata, e che comunque si esplica in processi ossidativi a loro carico che si con-cretizzano nell’imbrunimento (si manifesta analiticamente con un incremento della D.O. 420 nm). E’ stato tuttavia rilevato che l’acido ascorbico non è in grado di esplicare questa protezione nei confronti dei vini: da una prova condotta ponendo in condizioni di ossi-dazione vini addizionati di tale composto e testimoni non addizionati, l’aumento della densità ottica a 420 nm non era sostanzialmente diverso25.
Fase fermentativa.E’ una fase nella quale l’equilibrio ossidoriduttivo risulta molto spostato verso le for-
me ridotte. Questa condizione è dovuta al fatto che il metabolismo del lievito assorbe tutto, o quasi, l’ossigeno disciolto nel mezzo e lo impiega per la sintesi degli steroli com-
Stato ossidoriduttivo durante le varie fasi tecnologiche
24 Ribéreau-Gayon et al., 2003.25 Peng et al., 1998.

24Marco Muggia
ponenti la parete cellulare.Oltretutto, il metabolismo degli zuccheri porta alla formazione di grandi volumi di
CO2 che si discioglie nel mezzo e contribuisce quindi a mantenere ridotto il sistema. Lo stato riduttivo cui queste cause concorrono, è talvolta sin troppo accentuato, tanto che si rende necessario l’apporto volontario di ossigeno per permettere un adeguato e corretto sviluppo del lievito26.
Fase post-fermentativa.Durante il periodo di affinamento, sia esso in cisterna, botte o bottiglia, il ruolo dell’os-
sigeno è di assoluto rilievo per il suo concorso all’evoluzione del quadro polifenolico ed aromatico. La sua gestione differisce in questa fase in funzione dell’operazione tecnica, del tipo di contenitore e dell’orizzonte temporale. In particolare la velocità di ossidazione è resa assai maggiore che nei mosti dall’etanolo che, sebbene comporti una modesta ridu-zione del potenziale, aumenta la velocità dell’ossidazione istantanea27.
Innanzitutto, la conoscenza dell’obbiettivo enologico è fondamentale per la determi-nazione della migliore gestione dell’ossigeno nel vino: vini destinati ad un rapido con-sumo necessitano di apporti tali per cui il vino giunga alla giusta maturazione in breve tempo. Molto diverso è l’orizzonte temporale, e quindi il dosaggio dell’ossigeno, per vini destinati ad un lungo invecchiamento: in questo caso la tendenza è quella di dosare l’ossi-geno con molta cura, andando a dilazionare nel tempo gli apporti (sovente con l’ausilio di contenitori idonei allo scopo, o con micro-ossigenatori). Di rilievo risulta anche l’apporto di ossigeno durante le varie fasi tecnologiche: molto spesso questi apporti sono poco considerati, anche se i volumi disciolti sono importanti. Di seguito si riporta una tabella che mostra le quantità che vengono apportate in funzione della tipologia di operazione.
26 Ribéreau-Gayon et al., 2003.27 Ribéreau-Gayon et al., 2003.

25 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
Ribéreau-Gayon et al., pag. 143, 2003.
Origine
Trasferimenti
Interventi
Interventi
Legno
PompaggioTravaso da vasca barrique
Travaso dal basso da vasca a vascaTravaso dall'alto da vasca a vasca
Filtrazioni su terraFiltrazione
CentrifugazioneImbottigliamento
Travaso con ariaggiamentoTravaso senza ariaggiamento
Colmatura delle barrique
Barrique Limousin nuoveBarrique Centre nuove con tappo in legno apoggiato
Barrique Centre nuove con tappo in legno di latoBarrique Centre nuove con tappo in silicone
Barrique usate (5 vini)
2 mg/L6 mg/L4 mg/L6 mg/L
7 mg/L4 mg/L8 mg/L3 mg/L
5 mg/L3 mg/L
0,25 mg/L
20 mg/L28 mg/L36 mg/L45 mg/L10 mg/L
Operazioni Ossigeno Disciolto

26Marco Muggia
Fra le specie in grado di intervenire nei meccanismi di ossidoriduzione dei vini, si ricordano alcune già presenti nelle uve, alcune derivate dalla fermentazioni ed altre che sono addizionate durante la filiera. Ci si sofferma in questa sede sulle componenti di uve e vini bianchi, oggetto di questa trattazione.
I composti che derivano dalle uve sono: glutatione, metalli, polifenoli, acido ascorbico.
Glutatione.É presente in quantità rilevante nelle uve28. Il contenuto in glutatione nelle bacche può
raggiungere i 300 mg/L29, e la sua concentrazione sembra essere in parte dipendente da una corretta concimazione azotata del vigneto30. Una parte di esso è in grado di essere an-cora disponibile con effetto antiossidante anche dopo la pigiatura, tanto da essere uno dei principali antiossidanti naturali nei vini. E’ un tripeptide composto da acido glutammico, cisteina e glicina: si caratterizza per la presenza di un gruppo SH in grado di ossidarsi, esplicando così la funzione riducente. La forma ridotta, detta GSH, alternativa a quella ossidata GSSG, è in grado di essere attiva nella protezione dei composti del mosto sin dall’ammostamento, proteggendo i succhi dall’ossidazione accidentale conseguente alla raccolta. Alcuni studi quantificano in circa il 40% l’aliquota che persiste dopo tale fase31.
Nelle piante, esso è coinvolto nei processi volti al mantenimento dell’acido ascorbico nella forma ridotta.
A sua volta, è mantenuto in forma ridotta nei tessuti vegetali integri, dal ciclo dell’a-scobato-GSH, dove intervengono ascorbato, GSH, diidrossiascorbato reduttasi e gluta-tione reduttasi.
Specie principali che intervengono nei processi di ossidoriduzione nei vini
28 http://www.infowine.com/intranet/libretti/libretto8357-01-1.pdf.29 http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_lisjak_klemen.pdf.30 Cheynier et al., 1989.31 Lisjak, 2007.
Glutatione in forma ridotta.
Metalli.Gli ioni metallici, in quantità anche rilevanti, derivano dalle uve ed avviano processi
che convertono l’ossigeno in forme maggiormente ridotte e quindi più reattive nelle rea-zioni di ossidazione, dei quali si è già trattato.
HO OH
O O SH O
ONH2
N
H
H
N

27 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
Polifenoli.I composti fenolici principalmente presenti nei vini bianchi, estratti dalle bucce e in
minor quantità dai vinaccioli durante l’ammostamento e la macerazione, sono gli acidi idrossicinnamici (specialmente l’acido caftarico). Da ciò si evince che i vini bianchi pos-sano venire facilmente deteriorati per effetto delle ossidazioni chimiche o enzimatiche.
Le alterazioni enzimatiche avvengono quasi esclusivamente nel mosto d’uva. Quando l’acido caftarico viene ossidato nel suo corrispondente chinone dalle polifenolossidasi, il glutatione disponibile (GSH, la forma ridotta) reagisce prontamente con il sopraddetto chinone a formare l’acido 2-S-glutationilcaffeoiltartarico, che a sua volta non sarà più disponibile ad ulteriori ossidazioni mostrandosi, evidentemente, come il limite ultimo del processo di browning32. A seguito della diminuzione di glutatione, i chinoni dell’acido caftarico in eccesso vengono coinvolti in meccanismi ossidativi in cui i glutationil-addotti o la catechina possono subire riduzioni.
Per quanto riguarda invece le ossidazioni non-enzimatiche, esse possono avvenire nel vino in presenza di ioni di metalli di transizione e coinvolgere polifenoli di struttra or-to-diidrossibenzenica o triidrossibenzenica33.
I chinoni formati dall’ossidazione dei suddetti composti sono altamente instabili e possono subire ulteriori attacchi nucleofili, da fenoli, tioli o ammine, dando origine a polimeri colorati. Successivamente questi prodotti possono riarrangiare strutturalmente portando alla formazione di nuovi siti diidrossibenzenici più facilmente ossidabili rispet-to ai fenoli di partenza, essendo i loro potenziali redox più bassi.
Acido ascorbico (vitamina C).Sebbene sia presente in quantità ridotte nelle uve, è sicuramente in grado di preveni-
re le ossidazioni conseguenti a piccoli apporti di ossigeno al momento della pigiatura. Considerando la grande areazione cui sono soggetti i mosti in questa fase, si consuma rapidamente e sicuramente le quantità presenti di questo composto non sono in grado di garantire protezione dalle ossidazioni a tutto il processo di vinificazione.
Il processo chimico dell’ossidazione dell’acido ascorbico evidenzia che esso reagi-sce rapidamente con l’ossigeno, a dare acido deiidroascorbico e perossido di idrogeno (H2O2)
34. Il perossido di idrogeno si qualifica come un ossidante a sua volta più potente dell’ossigeno stesso. Per tale ragione l’acido ascorbico deve essere, per poter agire effi-cacemente come antiossidante nei confronti dei composti presenti nel mosto e nel vino, accoppiato all’anidride solforosa di modo che il perossido di idrogeno possa scaricare su di essa il suo potenziale ossidativo. L’uso di questo composto appare conveniente nella logica di rendere più repentina l’azione antiossidante, andando esso ad ossidarsi prima
32 Cheynier, Trousdale, Singleton, Salgues, & Wylde, 1986.33 Ribéreau-Gayon et al., 2003.34 https://www.awri.com.au/industry_support/winemaking_resources/frequently_asked_questions/pin-
king/.

28Marco Muggia
dell’anidride solforosa, che verrà poi ossidata dal prodotto dell’ossidazione stessa dell’a-cido ascorbico.
Come regola generica si può assumere che 2,8 mg/L di acido ascorbico ossidato pos-sono reagire con 1 mg/L di anidride solforosa.
Ad ogni modo, in un’ottica di IR, può essere sensato addizionare immediatamente alla raccolta delle uve o al loro arrivo in stabilimento di una certa aliquota di anidride solfo-rosa per limitare questi chimismi - oltre che per la generica protezione dalle ossidazioni che essa esprime35.
35 Dimitri et al., 2013.

29 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
La cellula di lievito è racchiusa da una membra interna e da una parete polisaccaridica e proteica esterna, che le garantisce una protezione nei confronti delle condizioni sfavo-revoli del substrato in cui cresce. La parete cellulare è costituita nel suo strato più esterno prevalentemente (35-40%) da mannoproteine e glicoproteine connesse ad una matrice in-terna amorfa di glucani. In seguito alla morte delle cellule di lievito, a fine fermentazione si assiste ad una progressiva lisi delle componenti strutturali della cellula, che rendono disponibili per il vino una serie di sostanze con effetto sull’equilibrio redox36.
Delle componenti citoplasmatiche, uno dei composti che viene ritenuto più importante da questo punto di vista è il glutatione: esso risulta potenzialmente presente nella misura dello 0.5-1% del peso secco della cellula, ed è concentrato principalmente in due siti, nel citoplasma e nei vacuoli37.
Sempre riferendosi al processo di lisi dei lieviti, esistono in commercio diverse tipolo-gie di derivati di lievito anche ad alto contenuto in glutatione. Va però sottolineato che il processo termico per l’ottenimento di questi prodotti sembra, da alcuni studi, degradare parte del glutatione contenuto nelle cellule in maniera consistente l’apporto della forma ridotta al vino38.
L’anidride solforosa è un gas incolore, dal caratteristico odore pungente, con spiccate caratteristiche irritanti. L’anidride solforosa viene impiegata come conservante in virtù delle numerose proprietà che presenta all’interno del vino. Allo stato attuale delle cono-scenze risulta essere l’unico conservante in grado di dare una protezione che perdura nel tempo, è quantificabile in maniera rapida, ha un costo contenuto ed uno spettro d’azione che va oltre la sola protezione antiossidante. Ne è consentito l’uso in base al Regolamen-to (CE) N. 606/2009, che ne stabilisce i limiti di legge per i vini al momento dell’immis-sione al consumo:
a) 150 mg/l per i vini rossi; b) 200 mg/l per i vini bianchi e rosati.
Queste quantità sono incrementate di 50 mg/L per i vini con un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/L; viene poi consentito un utilizzo massimo fino a 300 o addirittura 400 mg/L, per alcune tipologie di vini specifiche, o per determinate zone di produzione.
Composti che derivano dalla fermentazione
36 Caridi Andrea e Sidari Rossana, Attività adsorbente del lievito rispetto a colore ed ota, Dipartimento di sciente e tecnologie agro-forestali ed ambientali, Facoltà di agraria, Università degli studi mediterranea di Reggio Calabria.
37 www.infowine.com- rivista internet di viticoltura ed enologia, 2007, n.5/1.38 Frascaretti et al., 2009.

30Marco Muggia
I limiti legali sono dovuti all’azione irritante che essa esercita anche a dosi contenute: in considerazione della DL50, ed in considerazione della frequenza di consumo di altri alimenti contenenti anidride solforosa, l’OMS ha stabilito la quantità limite al di sopra delle quali si possono verificare conseguenze negative per la salute: 0-0.7 mg/kg di peso corporeo al giorno39. Da questo assunto l’Unione Europea ha stabilito i limiti comunitari sopra riportati, in considerazione della vasta gamma di alimenti che ne fanno uso e del loro tenore di solfiti.
E’ importante sottolineare, nell’ottica del rispetto dei limiti legali, che una aliquota (seppur solitamente contenuta rispetto al totale) dell’anidride solforosa viene prodotta dai lieviti in fermentazione, come sottoprodotto della demolizione degli amminoacidi solfo-rati. Solitamente si assiste alla liberazione di circa 10-20 mg/L di anidride solforosa, pari a meno del 10% del limite legale per un vino bianco.
Questo composto è dotato di una vasta gamma di effetti, nell’ottica della conservazio-ne degli alimenti e del vino: antiossidasica, antiossidante, antisettica, solubilizzante.
Azione antiossidasica.Si consegue immediatamente dall’addizione dell’anidride solforosa. Consiste nella
protezione dei vini e dei mosti dalle ossidazioni di tipo enzimatico, inibendo gli enzimi specifici (principalmente tirosinasi e laccasi) permettendone la successiva precipitazione per interazione con polifenoli o colle addizionate al mosto40.
Azione antiossidante.Si concretizza su reazioni di ossidazione chimica, e questa sua proprietà viene sfruttata
durante l’intera filiera, fino al consumo finale. In virtù della reattività di questo composto, si assiste alla combinazione con molecole di diversa natura.
Azione antisettica.Questo aspetto si basa sul conseguimento di una protezione dei vini e dei mosti dal-
la proliferazione di colonie batteriche o fungine: la protezione è sicuramente agevolata dall’abbattimento della popolazione iniziale con altre tecniche, ad esempio un illimpidi-mento o una filtrazione. I lieviti manifestano una maggior tolleranza al composto rispetto ai batteri, sebbene a termine della fermentazione alcolica si assista ad una sinergia di ef-fetti fra l’etanolo ed i solfiti, essendo anche l’etanolo una sostanza con azione antisettica.
La resistenza dei lieviti all’anidride solforosa non risulta essere, tuttavia, omogenea fra i diversi ceppi: questa variabilità di risposta delle popolazioni risulta utile nella selezione delle stesse, permettendo di mantenere in attività solo le popolazioni con una manifesta
39 http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/1206/1/Tesi%20Guidotti-Val.%20Rischio-PADIS.pdf.40 Margheri e Versini, 1986.

31 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
resistenza alle condizioni avverse.
Azione solubilizzante.L’anidride solforosa risulta avere un effetto estraente sulle sostanze contenute nelle
bucce. Il suo uso sulle uve bianche durante la macerazione, in particolare, deve quindi es-sere commisurato alla coerenza dell’estrazione di sostanze polifenoliche con l’obbiettivo enologico prefissato. L’effetto estraente è funzione della sua concentrazione nell’ammo-stato, e dipende dalla sua capacità di degradare le strutture delle cellule vegetali.
L’anidride solforosa, una volta sciolta in soluzione, instaura i seguenti equilibri:
Inoltre, fra la forma gassosa e quella idrata, si instaura il seguente equilibrio:
Questi equilibri sono pH-dipendenti: ad un abbassamento del pH si assiste ad un riar-rangiamento degli equilibri verso destra.
In ragione di quanto detto, il dosaggio di questo conservante deve essere ragionato in funzione di diversi fattori:
- pH: in vini con pH più alti sarà opportuno aumentare la dose per aumentare la forma molecolare (quella con effetto antisettico);
- esposizione del vino all’ossigeno: al momento di una addizione, è buona norma avere coscienza dell’esposizione che si prevede avrà il vino all’ossidazione, in ragione delle diverse operazioni tecnologiche o del tipo di chiusura scelto per la bottiglia;
- presenza di aldeidi e chetoni: in vini con residui zuccherini importanti, o prodotti di ossidazione dell’alcole etilico, è bene considerare che al momento dell’addizione buona parte della dose viene immediatamente sequestrata da questi composti, impedendo l’e-splicarsi delle diverse funzioni desiderate;
H2SO3 HSO3-
SO2 (g) H2SO3-
HSO3- + H2O SO3
2- + H3O+
acido solforoso
anidride solforosa – acido solforoso
ione bisolfito
ione bisolfito
ione solfito
→
→
←
←
→←

32Marco Muggia
- presenza di microorganismi;
- il contenuto pregresso di anidride solforosa, nell’ottica di contenere la SO2 totale entro i limiti legali per la commercializzazione dei vini.
Nel vino esiste un equilibrio tra la forma molecolare e la forma ionica. Ai valori di pH del vino può esistere in forma molecolare, come SO2, ma generalmente è più presente nella forma di ione bisolfito HSO3
‾. La forma ione solfito SO32‾+ è presente solo a valori
di pH elevati pertanto al pH del vino, sebbene sia presente, la sua concentrazione è molto bassa.
L’anidride solforosa reagisce con diverse molecole fra cui le aldeidi, i chetoni, gli an-tociani. Il meccanismo con il quale la reazione più frequente, quella con un gruppo carbo-nilico, avviene è per formazione di un addotto bisolfitico: il legame che si forma è molto forte. E’ pertanto possibile affermare che, una volta legatasi con l’acetaldeide, l’anidride solforsa presente nei vini è molto difficile possa tornare alla frazione libera.
Il composto che principalmente reagisce con l’anidride solforosa è quindi l’acetal-deide, la quale può essere originata dall’ossidazione chimica dell’etanolo, o può essere originata in quantità rilevanti dai lieviti e dai batteri in caso di fermentazioni stentate.
Tuttavia altre molecole che fungono da intermedi nei metabolismi di lieviti e batteri presentano una alta affinità all’anidride solforosa quali l’acido piruvico e l’acido α-chet-oglutarico. Il diossido di zolfo è in grado di combinarsi anche con le funzioni aldeidiche e chetoniche, come visto, pertanto una parte dei solfiti è sequestrata dagli zuccheri, qualora presenti nel vino: queste combinazioni sono tuttavia reversibili.
In soluzione, l’anidride solforosa è presente in forme diverse, le cui concentrazioni sottostanno a vicendevoli equilibri, che come visto sono influenzati dal pH.
La frazione di anidride solforosa legata ad altri composti, viene definita combinata: questa aliquota di solfiti non è in grado di svolgere altre attività.
Ribéreau-Gayon ipotizza che l’anidride solforosa non svolga un’azione antiossidante consumando l’ossigeno, ma che in virtù del suo basso potenziale redox, la SO2 in forma libera sia in grado di ridurre i chinoni a catechine ossidandosi a solfato41-42.
L’anidride solforosa è in grado di inibire il perossido di idrogeno, prevenendo la sin-tesi di acetaldeide. L’anidride solforsa reagisce con il perossido d’idrogeno comportando una diminuzione del potenziale redox del vino. Si assiste ad uno spostamento nucleofilo di HSO3
- che avviene con la reazione del perossido di idrogeno, dando come prodotto HSO4
-. 43
41 Makhotkina, Kilmartin, 2009.42 Limmer, 2005.43 Karbowiak et al., 2010.

33 Premesse fondamentali degli equilibri redox nel vino
La parte non combinata viene detta libera, ed insieme alla frazione legata costituisce l’anidride solforosa totale.
La libera è poi suddivisibile in SO2 e bisolfito: questo equilibrio è funzione del pH: la frazione molecolare è presente a pH più bassi di quelli del vino, pertanto la sua concen-trazione è molto bassa ai valori del vino44.
44 http://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2015/i-solfiti-in-enologia/.

34Marco Muggia

35
Parte SecondaVinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni

36Marco Muggia

37 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
Va sottolineato che la gestione della vinificazione in riduzione, si basa sulla assoluta correttezza del livello qualitativo delle uve. Questo assunto vale per tutte le produzioni votate alla qualità, ma in questo caso alcuni aspetto normalmente non prioritari, assumo un ruolo decisivo per una corretta applicazione del protocollo.
La concimazione azotata deve essere coerente con un adeguato apporto alle uve dei fattori di crescita che saranno indispensabili ad un lievito che potrebbe trovarsi in condi-zioni di una fermentazione in condizioni di carenza di ossigeno.
I trattamenti fitosanitari a base di zolfo e rame dovranno essere gestiti in modo da limitare la presenza di residui sulle uve, per evitare l’apporto al mosto di agenti della ossidazione chimica e di forme dello zolfo che in ambiente ridotto possono dar origine a composti con il caratteristico odore “di ridotto” (idrogeno solforato e suoi derivati).
La gradazione alcolica potenziale delle uve opportuna sarà non troppo elevata, con-siderando la ridotta capacità del lievito di operare in un substrato povero in ossigeno, fondamentale per la costituzione della parete lipidica che gli conferisce resistenza alle alte gradazioni alcoliche.
Processi produttivi e loro gestione in IR

38Marco Muggia
La raccolta è l’operazione con la quale le uve vengono prelevate dal vigneto, talvolta selezionandole, ed è funzionale alla loro trasformazione. Può essere gestita in diversi modi: la raccolta manuale si effettua andando a selezionare i grappoli trasportandoli ver-so lo stabilimento di trasformazione ancora integri, o perlomeno con gli acini ancora attaccati al raspo tramite il pedicello. La raccolta meccanica si implementa con macchine vendemmiatrici che possono essere semoventi o trainate da una trattrice agricola. La dif-ferenza fra le due tecniche consiste essenzialmente nel processo di selezione, che con la vendemmiatrice non è possibile attuare. Infatti, una delle problematiche correlate all’uso della vendemmia meccanica è quello delle perdite. É inoltre importante ricordare che la vendemmia meccanica non è adatta a tutti gli impianti: alcune forme di allevamento e impostazioni del vigneto sono incompatibili con l’operatività della macchina.
Va inoltre sottolineato che la vendemmia meccanica può comportare un maggiore ammostamento degli acini rispetto alla raccolta manuale, e durante lo stoccaggio ed il trasporto possono innescarsi processi ossidativi di tipo enzimatico. Per porre rimedio a questa problematica, è possibile utilizzare del ghiaccio secco nei serbatoi: tuttavia, l’uso dei ventilatori impiegati per allontanare le foglie accidentalmente cadute nei panieri, è in questo contesto impossibile, sebbene l’abbassamento di temperatura, se sufficiente, può rallentare o bloccare le ossidazioni enzimatiche. Una possibile alternativa la solfitazione delle uve nel serbatoio, eventualmente con preparati contenenti e acido ascorbico. É per-tanto inusuale l’uso dell’anidride carbonica solida per inertizzare i serbatoi, per quanto questa sarebbe in grado di ridurre sensibilmente i processi ossidativi di tipo enzimatico.
Come detto, quindi, questa fase presenta il primo momento nel quale i processi ossi-dativi possono avere inizio: la raccolta manuale è preferibile a quella meccanica, e tutte le pratiche agronomiche volte alla riduzione degli ammostamenti in ambiente ossidante, sono da applicarsi.
La raccolta manuale richiede ovviamente una spesa maggiore, ma consen-te di selezionare i grappoli, di mantenerli integri prevenendo ammostamen-ti, di non avere elementi estranei nella massa raccolta, di limitare le perdite du-rante la raccolta fino ad azzerarle, di effettuare una raccolta di uve ad un miglior livello di maturazione senza danneggiarle. Non ultimo permette di poter operare sca-larmente rispetto ai diversi livelli di maturità dei diversi grappoli sulla stessa pianta45.
Le uve vanno trasportate presso gli impianti di trasformazione nel minor tempo pos-
La raccolta
45 Fregoni, 2005.

39
sibile; può essere vantaggiosa la raccolta notturna per operare in ambiente a più bassa temperatura, in condizioni quindi meno favorevoli all’attività delle polifenolossidasi e nelle quali la catalisi è più lenta.
Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni

40Marco Muggia
La diraspatura è il processo tecnologico al termine del quale si ottiene una separazione fra le bacche ed il rachide, che viene allontanato per lo smaltimento. La pigiatura è un processo spesso contemporaneo votato all’ottenimento di un primo ammostamento degli acini i quali, passando attraverso due rulli in gomma controrotanti, vengono sottoposti ad una pressione variabile in funzione della distanza fra i due rulli (regolabile dall’operato-re) che comporta la fuoriuscita di parte del succo. É funzionale all’ottenimento di cicli di pressatura più brevi, o all’implementazione di una successiva macerazione prima della pressatura.
Le operazioni di pigiatura e diraspatura sono le prime che espongono le uve ad ossida-zioni al loro arrivo negli stabilimenti: nel caso in cui la raccolta fosse stata meccanizzata, la fase di diraspatura (che, spesso, fra le due è quella che più espone il mosto al contatto con l’ossigeno) non è teoricamente necessaria, a causa dell’assenza dei raspi nel raccolto, ma può essere implementata ugualmente per allontanare in questa prima fase alcuni or-gani vegetali (foglie, piccioli, parti di tralcio, ecc…) e che solitamente non sono presenti nella massa. Anche in questo momento una più bassa temperatura può avere l’effetto benefico di rallentare i primi processi ossidativi enzimatici, e comunque la possibilità di inertizzare il sistema è da ricercare.
E’ tuttavia impossibile eliminare del tutto la presenza di ossigeno nella massa, quindi ci si può ragionevolmente aspettare che alcuni processi ossidativi abbiano comunque inizio46.
Il pigiato deve quindi essere trasferito nella pressa: l’utilizzo di una pompa peristaltica, nella cui tramoggia si può dosare del ghiaccio secco, rende agevole il processo di traspor-to all’interno della pressa, e risulta relativamente facile da ammortizzare, rispetto ad altri sistemi comunque in uso nelle cantine.
La pigiadiraspatura
46 Antonelli et Al., 2010.

41
La pressatura è l’operazione con la quale si ottiene la separazione fra il mosto fuoriu-scito dagli acini, e le parti solide di più grandi dimensioni. Durante il ciclo di pressatura, che può durare alcune ore, si consegue anche una macerazione del pigiato, con conse-guente estrazione di sostanze dalle bucce. Può anche essere ricercata dall’enologo, ed è diffuso l’uso del serbatoio della pressa come maceratore per alcune ore prima dell’avvio del ciclo di pressatura.
La pressatura ha sempre dimostrato essere una delle fasi più critiche dal punto di vista del contatto con l’ossigeno, per la presenza di polifenolossidasi che derivano dalle uve e che portano rapidamente allo stato ossidato i polifenoli47. Anche senza far riferimento ai torchi idraulici od alle presse a piatti (con il cui uso le possibilità di ossidazioni risultano evidenti), anche le più moderne presse a polmone presentano questo rischio. Il problema dell’aspirazione di aria atmosferica, con il conseguente contatto fra uve e ossigeno, è problematica non indifferente se l’obbiettivo enologico è quello di una totale esclusione dell’ossigeno dai processi ossidativi.
Per tale ragione è stato sviluppato un nuovo approccio alla pressatura, diffusosi in Italia sulla scia della sua introduzione da parte della cantina Pojer&Sandri. Esso si basa sull’uso di un ulteriore polmone contenente gas inerte (N2 o CO2) che fa affluire il gas ivi contenuto nel serbatoio della pressa a compensazione del volume di mosto pompato all’esterno, evitando quindi l’entrata di aria atmosferica.
Questo approccio permette di risolvere una grossa fetta delle prime ossidazioni a cari-co dei mosti, cioè quella che si concretizza durante la loro fuoriuscita dalle bacche, quan-do la superficie a contatto con l’ossigeno è estremamente elevata, in rapporto al volume del succo.
In questa fase può anche essere implementata, come detto, una macerazione delle uve, per aumentare l’estrazione dalle bucce dei composti al loro interno: certamente, una mag-giore estrazione di composti fenolici è funzionale all’obbiettivo enologico di una vinifi-cazione di tipo conservativo, tuttavia la presenza di questi composti può essere causa di instabilità.
La preparazione della linea di condutture, dalla pompa alla pressa (sempre che non si preveda il carico diretto di uva intera), deve avvenire con inertizzazione a mezzo gas: se nelle condutture l’uso di gas può essere sufficiente, nella pressa è opportuno utilizzare anidride carbonica solida, per accoppiare l’effetto benefico dell’abbassamento di tempera-
La pressatura
47 Antonelli et Al., 2010.
Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni

42Marco Muggia
tura.La neve carbonica, o ghiaccio secco, sublima (passa senza fase intermedia dallo stato
fisico solido a quello gassoso) e si ottiene così il duplice risultato di riempire la pressa con anidride carbonica e di realizzare un abbassamento di temperatura dell’ammostato ivi introdotto, con chiari effetti positivi sul contenimento dell’attività ossidasica di origine enzimatica.

43
Lo stoccaggio è la fase che si pone fra la fermentazione e il confezionamento. Durante questo intervallo di tempo, che va da pochi mesi a diversi anni in funzione dell’obbiet-tivo enologico, il vino è comunque sottoposto ad operazioni tecnologiche quali illimpi-dimenti, chiarifiche, filtrazioni e travasi da un contenitore ad un altro. Durante la fase di stoccaggio il rischio di ossidazioni dipende dalla natura del materiale, o dalla possibilità di commettere errori da parte dell’operatore (contenitori scolmi). Di rilievo è anche il rischio di calo del livello dei liquidi stoccati (a causa degli abbassamenti di temperatura) che richiama ossigeno dalla valvola sul boccaporto o attraverso il materiale (se questi lo permette), qualora non si controlli periodicamente il livello del vino nel contenitore.
Oltre che sullo stoccaggio in sé, è bene porre l’attenzione sulla fase di sedimenta-zione che avviene in concomitanza con lo stesso. Questa avviene per caduta sul fondo del contenitore delle particelle a maggior densità del vino, e per coagulazione di quelle singolarmente troppo leggere: in questi processi intervengono i rapporti di carica fra le particelle stesse.
In fase prefermentativa, il processo può essere conseguito per precipitazione del sur-natante, oppure per sua flottazione: si conseguono attraverso l’uso di coadiuvanti, che è possibile addizionare in modo da non aggiungere ossigeno, se si opera con le dovute pre-cauzioni (durante la loro solubilizzazione/idratazione, e durante l’aggiunta dei preparati alla massa). Il rimescolamento della massa si può conseguire con l’uso di agitatori ad asse orizzontale invece del più classico rimontaggio con pompa, con evidente riduzione dei rischi di solubilizzazione di aria nella massa.
Per quanto concerne la flottazione, l’utilizzo di gas inerti che si implementa con questa tecnica è sicuramente funzionale alla protezione dei mosti dall’ossigeno.
Stoccaggio e sedimentazione
Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni

44Marco Muggia
Il travaso è sicuramente una delle fasi che maggiormente espongono mosti e vini alle ossidazioni. Spesso si rivela inevitabile per l’allontanamento dei depositi, per rendere omogenee le masse in fermentazione o sulle quali si è effettuata una addizione di coa-diuvanti o per conferire ossigeno ai lieviti nel momento della loro moltiplicazione, per le ragioni già descritte.
Gli apporti di ossigeno in questa fase possono derivare da errori nel montaggio della linea di condotte flessibili e loro agganci con la pompa: da giunture non guarnite idone-amente, o da fessurazioni nelle condotte stesse, può avvenire l’assorbimento di aria e la sua miscelazione con la massa.
Un altro problema nel mantenimento dello stato riduttivo può avvenire dal contenuto di aria del tank che può miscelarsi con la massa, ma è di facile soluzione. Innanzitutto la condotta va attaccata alla valvola di scarico, posta in basso nel contenitore (per limitare la miscelazione del liquido con l’aria). Dagli studi di Dal Cin l’aumento dei livelli di ossi-geno nella massa varia in maniera consistente a seconda che l’uscita della condotta venga immersa nella massa (0,1-0,3 mg/L di O2) oppure venga posta in testa al contenitore e fatto cadere verso il basso (2-5 mg/L di O2)
48. Alla luce di ciò risulta quindi importante la saturazione del tank con anidride carboni-
ca. L’anidride carbonica può avere diverse origini: può uscire da una bombola, originarsi dalla neve carbonica, oppure può essere trasferita dalla parte superiore di un contenitore nel quale la fermentazione è già allo stato tumultuoso. Il riciclo dell’anidride carbonica è una pratica che può rivelarsi utile per contenere i costi, importanti, dell’inertizzazione. Si opera collegando una condotta sulla parte superiore di modo da convogliare il gas verso un’altra vasca: se nella prima il tumulto della fermentazione è in grado di spingere il gas, nella seconda l’anidride carbonica si deposita sul fondo del tank, essendo più densa della miscela di gas che compone l’aria.
La neve carbonica, o ghiaccio secco, non è altro che anidride carbonica allo stato soli-do, che permane allo stato solido in virtù della bassa temperatura a cui si trova in tali con-dizioni a pressione atmosferica: -78°C. Qualora si ritrovi a temperatura ambiente, essa passa allo stato gassoso senza passare per quello liquido, sublimando. Con la sublimazio-ne, si consegue la liberazione di anidride carbonica gassosa e l’abbassamento della tem-peratura dell’ambiente in cui si trova. L’anidride carbonica solida può essere trasportata da stabilimenti di produzione, oppure ottenuta direttamente presso le cantine utilizzando
Il travaso
48 Dal Cin, 1991.

45
il gas stoccato presso apposite bombole con un processo che risulta abbastanza costoso e giustificato solo per grossi produzioni.
Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni

46Marco Muggia
La fermentazione alcolica è il processo che, attraverso il metabolismo dei lieviti di glucosio e, in misura minore, fruttosio va a dare anidride carbonica, energia ed etanolo. Quello illustrato è il metabolismo principale degli zuccheri da parte dei lieviti in fermen-tazione, ma esistono vie secondarie che portano all’elaborazione di sostanze aromatiche e non, con un impatto organolettico sui vini così ottenuti. L’alcol etilico è una sostanza dannosa per i sistemi biologici, quindi anche per i lieviti. Questi si proteggono attraverso la parete cellulare, esterna rispetto alla membrana cellulare, la cui sintesi è funzione della quantità di ossigeno nel substrato. La resistenza dei lieviti all’etanolo è quindi funzione della quantità di ossigeno a disposizione di questi microorganismi.
La fermentazione malolattica è il processo metabolico che permette la trasformazione dell’acido malico, accumulatosi nelle uve, in acido lattico. Oltre all’acido lattico, si assi-ste anche ad una degradazione dell’acido citrico: questo metabolismo è quello che porta alla formazione di sentori solitamente ritenuti indesiderati in questo tipo di prodotti. Que-sto processo è operato non da lieviti, bensì da batteri. Tuttavia, anche l’attività dei batteri è funzione della quantità di ossigeno nel substrato: è infatti possibile che si inneschino fermentazioni malolattiche in vini con scarso contenuto di anidride solforosa qualora vengano esposti all’aria (ad esempio durante un travaso).
Le fermentazioni

47 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
L’affinamento è una fase fondamentale per l’ottenimento di vini di qualità. In questa fase il valore qualitativo del vino aumenta attraverso la sua maturazione, che ne incre-menta le positive caratteristiche organolettiche. Durante questo intervallo di tempo i chi-mismi del vino vanno inevitabilmente incontro a modificazioni, che in parte possono es-sere gestite dall’enologo. Si assiste ad un incremento della gamma di sostanze aromatiche In particolar modo, il vino acquisisce una complessità aromatica conseguita attraverso molti tipi di reazione: idrolisi, esterificazioni degli acidi, liberazione di aromi legati ad altre sostanze, riarrangiamento degli equilibri redox, polimerizzazione di fenoli ed altre. Le caratteristiche del contenitore influenzano in maniera importante queste reazioni.
Dal punto di vista della vinificazione in IR, la scelta del materiale del contenitore non è secondaria: si potrebbe anche dire che risulta fondamentale (come lo è, del resto, per gli altri protocolli di trasformazione delle uve), in quanto le caratteristiche intrinseche dei diversi materiali regolano o escludono l’apporto di ossigeno per micro-ossigenazione.
Acciaio inox.I contenitori in acciaio inox sono oramai fra i più diffusi in tutte le cantine: l’acciaio
consta di una lega a base di ferro, cromo e nichel, oltre ovviamente ad una aliquota di carbonio. Ne vengono impiegate due tipologie:
- Il grosso del tank è costituito dal tipo denominato AISI 304, è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di cromo tra il 18% ed il 20% e di nichel tra l'8% e l'11%; carbonio fino a 0,080%.
- l'AISI 316 è una lega di acciaio inox austenitica che presenta un tenore di cromo tra il 16% ed il 18%, di nichel tra l'11% e il 14% di molibdeno tra il 2% ed il 3%. Questa lega, più costosa, viene impiegata per il valvolame e per tutti gli accessori di cui dispone il contenitore.
L’acciaio inox presenta i notevoli vantaggi di essere resistente alle ossidazioni, inattac-cabile a numerose sostanze acide o basiche e di creare una barriera chimica ed alla luce fra il contenuto e l’ambiente. Queste caratteristiche lo rendono facilmente igienizzabile, di lunga durata operativa (e quindi di lungo ammortamento), adatto a conservare vini an-che per lungo tempo, mantenendo lo stato e le dinamiche ossidoriduttive della soluzione al suo interno (essendo impermeabile ai gas). Le cessioni di sostanze al vino sono molto limitate.
Da quanto detto si evince come le sue caratteristiche lo rendano assai adatto all’appli-cazione della vinificazione in riduzione.
E’ inoltre facilmente modulabile per l’aggiunta di accessori, quali valvolame, organi
Materiali dei contenitori per l’affinamento

48Marco Muggia
meccanici in movimento (per agevolare le operazioni durante la macerazione, ad esem-pio), sonde per controllo dei parametri, sistemi di controllo e modifica della temperatura.
Legno.I contenitori in legno sono molto variegati, e in questa sede risulta superfluo darne am-
pia trattazione, anche perché alcuni autori sottolineano come l’impiego del legno non sia funzionale all’applicazione dell’IR, sia a causa delle cessioni di sostanze che solitamente non si integrano in maniera corretta nel profilo aromatico dei vini che tale filiera vuole ottenere, sia per l’ossigenazione che i fusti in legno comportano durante il loro uso49. Ci si limiterà a descrivere quali sono le possibili scelte al riguardo fra le possibilità più comuni, sulle questioni di maggior interesse nell’applicazione di tale tecnica.
Per sommi capi è possibile affermare che la struttura porosa del legno, in grado di cre-are un continuum fra atmosfera esterna e contenuto, non è adatta al mantenimento dello stato redox del vino al suo interno: pertanto potrà essere impiegato solo nella fase di fer-mentazione, dove l’ossigeno viene prontamente consumato dai lieviti in moltiplicazione, e comunque interrotto prima della coda di fermentazione, nella quale il consumo di ossi-geno è contenuto perché la moltiplicazione dei lieviti è ormai sostanzialmente interrotta.
Alcune scelte possono modificare la permeabilità del legno, come l’essenza (che deter-mina la “grana”), la dimensione delle doghe (che possono avere uno spessore più o meno importante, solitamente in relazione alla dimensione del contenitore), il volume interno del contenitore (per ridurre l’ossigenazione sono preferibili contenitori con maggior volu-me in quanto presentano un più basso rapporto fra volume interno e superficie di scambio attraverso il legno), l’età del fusto (con l’aumento dell’età del legno, la microporosità al suo interno tende a diminuire a causa dei colloidi e dei cristalli che intasano i micropori con riduzione dello scambio fra vino ed atmosfera).
È però importante sottolineare la cessione di sostanze fenoliche da parte del legno (specie se nei primi passaggi) con conseguente modificazione del potenziale redox.
Cemento.Il contenitore in cemento può essere ricoperto con resine epossidiche per impedire gli
scambi con l’aria (comunemente ritenuti possibili) e la cessione di sostanze da parte del contenitore. Nell’ottica di controllare l’apporto di ossigeno, il cemento vetrificato risulta adatto allo scopo, ma richiede periodiche verifiche e manutenzioni.
49 Proestoset al., 2005.

49 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
Per filtrazione di una soluzione si intende la separazione di alcune particelle presenti nella soluzione stessa attraverso il passaggio da un setto permeabile. Questo processo, parte integrante della filiera enologica, ha lo scopo di allontanare le particelle colloidali presenti in soluzione che potrebbero in un momento successivo coagulare e formare un precipitato, con un grave danno qualitativo se questo avviene in vini imbottigliati, dove correzioni non sono più possibili.
In questa fase l’inertizzazione dipende in buona misura dalla tecnologia della macchina in uso. Si riassumono di seguito le caratteristiche essenziali delle tecniche di filtrazioni50.
Mentre con i filtri a cartoni ed i filtri pressa il vino subisce una importante esposizione all’ossigeno durante tutto il processo, con il filtro a cartucce e tangenziale il sistema è chiuso, quindi inertizzabile. Il filtro rotativo sottovuoto risulta essere il sistema maggior-mente incline ad ossidare i vini od i mosti.
La filtrazione
50 http://www.viten.net/files/faa/faa7408256a2c5aed3cfbb1885196255.pdf.

50Marco Muggia
Riepilogo tecniche di filtrazione. Fonte: Biondi Bartolini, modificato da Muggia Marco.
Tipologia di filtro Funzionamento Vantaggi
Filtro Pressa
Serie di camere filtranti chiuse dove le impurità, insime a coadiuvanti , fomrano un pannello. La pressione cresce via via che il vino viene filtrato
Di semplice utilizzo, comporta perdite limitate
Filtro rotativo sotovuoto
Un tamburo di supporto è rivestito da perliti a costituire il pannello, che viene eliminato con la rotazione su una lama man mano che si intasa con la filtrazione
Perdite contenute
Filtro ad alluvionaggio
Farine fossili, cellulosa o perliti vengono miscelate al vino formando lo strato filtrante che si deposita e rinnova in continuo sui supporti
Portate elevate
Filtro a cartoni
Il filtro è costutuito da un telaio che supporta pannelli plastici che si intermezzano con gli strati filtranti in cellulosa
Facile utilizzo e igienizzazione
Filtro a cartucce Filtro che opera in una campana chiusa dove la cartuccia viene attraversata dall'interno verso l'esterno dal vino
Facile da igienizzare, sterilizzante, possibile verifica dell'integrità
Filtro tangenziale Filtro nel quale il flusso del vino è tangenziale alla fibra, organica o minerale
Sterilizzante, automatizzabile, lunga durata

51
Per condizionamento si intende l’operazione con la quale il vino sfuso viene immesso in contenitori atti alla vendita, che possono essere di diversa foggia e materiale. Consi-derando che è assai raro il confezionamento in damigiane, tetra-brik, baginbox di vini ottenuti con questa tecnica (per ragioni prettamente commerciali), ci si soffermerà sul confezionamento più comune per questi vini: l’imbottigliamento.
La fase di imbottigliamento presenta numerose criticità dal punto di vista del manteni-mento dell’equilibrio redox all’interno del vino, a causa delle diverse modalità attraverso le quali il vino potrebbe entrare in contatto con l’aria, e che devono quindi essere gestite costantemente e consapevolmente dal tecnico.
Dal momento del prelievo del vino dal contenitore, che deve essere mantenuto iner-tizzato anche al calare del suo volume all’interno (compensando eventualmente con gas inerte), bisogna avere cura di costituire una linea di condotte per il trasporto la cui cor-rettezza nelle connessioni e l’integrità dei materiali sia totale. L’inertizzazione del tank può avvenire per mezzo di gas che vanno inseriti dall’apertura apicale del contenitore ed integrati man mano, preferendo gas più densi che sono in grado di sostituirsi all’aria a livello dell’interfaccia vino/atmosfera esterna. E’ importante anche la gestione della linea in assenza di ossigeno, riempiendo la stessa con il gas prima di iniziare il trasferimento del vino attraverso le condutture.
Solitamente si esegue una filtrazione in linea prima dell’arrivo del vino al serbatoio (“campana”) della riempitrice, e qui si rimanda alla trattazione sulla filtrazione di cui sopra.
Al momento del riempimento, la campana, deve essere a sua volta inertizzata con gas: le attuali riempitrici isobariche sono attrezzate in tal senso, quindi questo aspetto non rappresenta un grosso problema. Un altro aspetto non trascurabile è il contenuto di aria presente nelle bottiglie in uscita dalla sciacquatrice: per gestire questa problematica è op-portuno che la macchina venga attrezzata con un dosatore di gas deputato al riempimento del vetro con gas inerti.
Le macchine imbottigliatrici in commercio, ormai dispongono anche di una pompa del vuoto: tale sistema ha lo scopo di rimuovere l’aria presente nello spazio di testa della bot-tiglia prima della tappatura, sostituendola con gas inerte. Esistono linee isobariche, utili anche per l’imbottigliamento di vini spumanti, in grado di ridurre fino a valori prossimi allo zero la quantità di ossigeno disciolto.
Nel caso di imbottigliatrici più semplici, ad esempio quelle in uso per i grandi forma-ti, è bene porre attenzione al fatto che il becco di riempimento sia vicino al fondo della bottiglia, per limitare il contatto con l’aria. E comunque, anche in questa eventualità,
Condizionamento
Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni

52Marco Muggia
predisporre un'inertizzazione della bottiglia prima del riempimento. Le machine moderne sono in grado di sostituire l’aria con gas inerte all’interno della
bottiglia: la tappatura isobarica è in grado di preservare l’operato della riempitrice. Que-sto in quanto la linea, più è lunga, maggiormente causa l’uscita di gas inerte nello spazio di testa dalla bottiglia in movimento vero la tappatrice. Inoltre, la tappatrice, è dotata di un sistema deputato all’equilibrio della pressione dello spazio di testa con la pressione atmosferica. Questo aspetto risulta utile per evitare che venga richiamata aria dall’esterno verso lo spazio di testa a causa della depressione che potrebbe altrimenti crearsi.
Una volta confezionato, il vino può vedere processi ossidativi in funzione dell’ossige-no disciolto al suo interno ed in funzione dell’ossigeno che può permeare dal contenitore, o dalla chiusura.
Essendo uno dei contenitori più diffusi, e sicuramente il più diffuso per i vini con un certo standard qualitativo, ci si soffermerà sull’analisi della relazione fra il vino e la bot-tiglia in vetro, sottolineando che la struttura a base di silicio che costituisce il vetro, non permette il passaggio dell’ossigeno nel vino, bloccando qualsivoglia scambio fra il siste-ma al suo interno e l’ambiente di stoccaggio.
Una certa aliquota di ossigeno può invece passare al vino attraverso la chiusura: essa può essere realizzata con numerosi materiali, con diversa permeabilità per gli scambi gassosi.

53 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
Per quanto concerne i tappi, l’incidenza che ne risulta sui vini e la loro ossigenazione, è sicuramente di rilievo. Il tappo è uno dei fattori più determinanti nel potenziale redox dei vini dopo l’imbottigliamento. Il tappo è in grado di influenzare il potenziale redox attraverso il controllo della permeazione di ossigeno al nel vino.
In funzione del materiale si hanno quindi queste tipologie di tappi.
Sughero naturale. I tappi in sughero naturale sono i prodotti tradizionalmente in uso e meglio accettati
dai consumatori, che li associano a valori come tradizione e qualità. Il loro impiego si è ridotto negli ultimi anni a causa della carenza della materia prima e alla diffusione di altri materiali. Spesso, per rendere il prodotto più commercialmente appetibile, i tappi vengo-no sbiancati per abbassare la tonalità del colore. Possono essere classificati sulla base di diverse caratteristiche quali la presenza di lenticelle e la grana, ma i caratteri di maggior interesse tecnico sono la permeabilità all’ossigeno e l’assenza di tricloroanisolo. I tappi in sughero in particolare, risultano essere in grado di cedere sostanze polifenoliche al vino. Tuttavia, questa capacità è quantitativamente meno rilevante rispetto all’apporto di ossi-geno, nell’ottica dell’analisi sulla influenza del potenziale redox da parte delle chiusure.
Tappi tecnici. Sono diventati di largo uso a causa dell’aumento dei prezzi del sughero, e grazie alla
purificazione cui sono sottoposti per evitare la residualità di cloro e bromo. Vengono ot-tenuti da granella o polvere di sughero, che viene compattato e mantenuto tale con l’uso di collanti specifici. Possono talvolta essere birondellati, cioè costituiti alle due estremità da uno due rondelle accoppiate di sughero naturale.
Tappi a vite.Sono molto diffusi, in particolare nel mondo anglosassone, ed in uso con il vino da
decenni. Esternamente presentano un involucro di alluminio dotato internamente di una guarnizione a più strati costituita da stagno e alluminio, Saran (PVDC), e uno strato trasparente adatto all’uso alimentare. Necessitano di un collo filettato sulla bottiglia, e di una tappatrice diversa da quella in uso con le altre tipologie. Sono più frequentemente correlati a difetti di riduzione: dopo un periodo di 18 mesi in stoccaggio, Brajkovich ha
Tipi di tappi e relazione con l’ossigeno

54Marco Muggia
rilevato concentrazioni di composti solforati maggiori nei campioni tappati a vite rispetto a quelli con chiusura in sughero51.
Tappi in vetro.Sono da poco in uso nella produzione di massa, molto poco diffusi nell’enologia in-
dustriale. Vengono impiegati con una piccola guarnizione che serve ad escludere scambi con l’atmosfera52.
La relazione fra i tappi e l'ossigeno.L’influenza delle diverse chiusure sulle cinetiche di ingresso dell’ossigeno è stata stu-
diata da Lopes ed è stato accertato che durante i primi 24 mesi di affinamento, indi-pendentemente dall’asse sul quale sono conservate le bottiglie, i tenori più contenuti di ossigeno si misurano nel caso di utilizzo di tappo a vite53. Valori intermedi si misurano nel caso del sughero naturale, mentre le chiusure sintetiche risultano apportare il maggior volume di ossigeno.
Esistono comunque dinamiche diverse nel tempo per i tappi in sughero naturale, così come il tempi di affinamento più lunghi di quelli analizzati da Lopes potrebbero vedere variazioni nelle succitate dinamiche. Tuttavia nell’ambito dei vini prodotti in IR, ci si sofferma principalmente sulle chiusure che non permettono nessun apporto di ossigeno, anche se solo nelle prime fasi, in quanto sono le uniche che possono permettere la preven-zione di fenomeni ossidativi a carico della frazione aromatica e polifenolica preservata sino a questa fase. Questa prevenzione è fondamentale in quanto permette di prevenire l’occorrere di difetti quali il pinking ed il browning.
Altri studi hanno indagato l’effetto della differente quantità di anidride solforosa addi-zionata in pre-imbottigliamento e l’effetto che questa protezione esplica durante i primi 24 mesi in bottiglia54. Dopo i primi 3 mesi in bottiglia, nei quali i vini tappati con sughero naturale dimostrano un calo maggiore degli altri nei livelli di anidride solforosa, non si sono evidenziate variazioni significative fra le quantità di anidride solforosa perse dai vini analizzando gli stessi a 24 mesi. Alcune variazioni, comunque non percepite dal panel di degustazione utilizzato in detta ricerca, hanno riguardato la frazione aromatica: è proba-bile che parte degli aromi siano stati assorbiti dal tappo, ma comunque a livelli tali da non far scendere la concentrazione delle sostanze sotto la soglia di percezione.
51 Brajkovich et al, 2005.52 http://www.infowine.com/docs/Newsletter248_Def.htm#top.53 Lopes et al., 2006.54 Braijovich et al., 2005.

55 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
55 Vidal&Moutounet, 2004.56 Vidal&Moutounet, 2004.
Nonostante tutte queste precauzioni, che sono comuni anche in altri protocolli più aderenti all’enologia tradizionale, una certa aliquota di ossigeno passa inevitabilmente al vino con il processo di imbottigliamento. Alcuni studi lo hanno quantificato in 0.63 mg/L (valore abbastanza contenuto), ma altri studi stimano l’aumento dell’ossigeno disciolto in fase di imbottigliamento nell’ordine di 5 volte tanto55. L’ossigeno apportato in questa fase del processo, è quello che comporta i maggiori problemi: appare evidente che la gestione delle ossidazioni in una bottiglia ormai confezionata sia impossibile. Possono manifestarsi problemi, dopo il confezionamento, correlati alla quantità di ossigeno che si può disciogliere nei vini, come lo svanito.
Pertanto, la cura in questa fase deve essere estrema, di modo da limitare al massimo fenomeni ossidativi successivi sui quali non è possibile avere una gestione tecnica.
Il consumo dell’ossigeno dopo l’imbottigliamento è funzione delle dinamiche già de-scritte all’inizio della trattazione, ma si può assumere che il fattore più rilevante per rego-lare le cinetiche sia la temperatura alla quale il prodotto viene conservato.
Nel corso delle 8 settimane successive all’imbottigliamento si assiste ad un progres-sivo calo dell’ossigeno dallo spazio di testa e dal vino; la diminuzione diventa più lenta nei mesi successivi fino a raggiungere l’1% in volume dello spazio di testa e 0.1 mg/L nel vino56.
Si rileva che la più alta concentrazione nello spazio di testa, sembri indicare che ali-quote di ossigeno passino progressivamente al vino, a dimostrazione di come il sistema si modifichi ricercando l’equilibrio delle concentrazioni. In considerazione di ciò, appaiono evidenti i vantaggi di una sostituzione dell’aria nello spazio di testa, fra le fasi di riempi-mento e tappatura.
Reazione dell’ossigeno dopo il confezionamento

56Marco Muggia
Gli effetti di una ridotta esposizione all’ossigeno dei mosti sono tuttora fase di studio, e numerose sono le prove effettuate, che hanno dato esiti talvolta variabili le une dalle altre. Una delle ragioni nella variabilità dei dati rilevati potrebbe essere riconducibile ai diversi protocolli applicati. E’ effettivamente mancante, all’attuale stato dell’arte, un protocollo univoco applicabile alle diverse casistiche: ci si riferisce, piuttosto, ad una serie di princi-pi e linee guida da applicarsi in misura diversa nelle diverse condizioni.
Uno studio molto ampio è stato effettuato da Antonelli comparando gli effetti della vinificazione in riduzione su mosti di Sauvignon blanc e Trebbiano romagnolo con un testimone vinificato in maniera tradizionale57. Gli approfonditi esami chimici eseguiti sui quattro campioni, hanno rilevato:
- un aumento della densità ottica a 420 nm, che si manifesta in una variazione del co-lore verso una tinta gialla più scura. Questo fattore è dipendente da un maggior contenuto di fenoli nei vini ottenuti tramite la vinificazione in riduzione, grazie a una loro maggior protezione.
- nessuna variazione di rilievo nella concentrazione di catechine, a riprova del fatto che nemmeno applicando la vinificazione tradizionale esse sono state esposte a degradazione ossidativa.
I risultati di questo studio, che si sottolinea essere specifici per la ricerca cui ci si rife-risce e non necessariamente ascrivibili ad una dinamica sempre reale, hanno evidenziato come la protezione dalle ossidazioni durante la vinificazione non comporti una varia-zione del contenuto in catechine, ma una maggior intensità colorante del vino ottenuto a sostanziale parità di preservazione delle catechine. Di conseguenza, si può assumere che in questi vini siano anche altre le altre frazioni fenoliche protette, e si deduce che siano queste le responsabili del colore dei vini.
Effetti dell’IR sulla struttura e composizione di mosti e nei vini
57 Antonelli et Al., 2010.

57 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
58 Andreas-Silva et al., 2014.59 Skouroumounis et al., 2005.60 Iland et al., 2004.
Quando i vini, particolarmente quelli bianchi e particolarmente ancora quelli mante-nuti in stato ridotto fino a quel momento, vengono esposti all’ossigeno, si avviano dei chimismi basati sull’ossidazione che si evidenziano otticamente per una variazione re-pentina di colore.
In tale frangente è possibile assistere a un processo denominato pinking. Il chimismo di base non è molto chiaro all’attuale stato dell’arte, ma alcuni studi nel
corso degli anni hanno portato a formulare alcune ipotesi riguardo queste cinetiche. Secondo Andreas-Silva il processo si basa sulla reazione degli antocianine (princi-
palmente malvidina-3-O-glucoside)58. Lo studio ha permesso di identificare bassissime concentrazioni di antocianine all’interno di polpa e buccia, e ha permesso di stabilire che il fenomeno è correlato negativamente con un aumento di temperatura prima della raccolta, che probabilmente incrementa il metabolismo della bacca permettendo un con-sumo di queste specie all’interno di processi enzimatici secondari. Il contenuto minimo in antocianine per poter rilevare il pinking è stato quantificato dal suddetto studio in 0.3 mg/L. Un altro fattore limitante il fenomeno è stato identificato nella presenza di anidride solforosa: se essa risulta presente in concentrazione sufficiente da proteggere il vino da esposizioni repentine all’ossigeno, si limita la polimerizzazione della forma flavillo delle antocianine, mantenendo il loro ammontare relativo al disotto della soglia di percezione.
Va inoltre ricordato l’effetto decolorante sulle antocianine da parte dello ione bisolfi-tico, quindi una parte del fenomeno può essere anche ricondotta all’ossidazione di parte dell’anidride solforosa, la quale prima dell’ossidazione partecipava al mantenimento in forma incolore delle antocianine.
Alcuni studi affermano che l’implementazione dell’uso di acido ascorbico in fase di imbottigliamento possa aiutare a prevenire il manifestarsi del fenomeno, essendo l’acido ascorbico maggiormente competitivo per l’ossidazione rispetto l’anidride solforosa59.
Iland ha realizzato una metodica per la stima del potenziale effetto pinking su un vino, cioè del rischio in cui si incorre esponendo vini in stato molto ridotto al contatto con l’a-ria60:
1. Etichettare un flacone da 100 mL in vetro trasparente come controllo e un altro come test.
Fenomeni chimici legati allo stato ossido riduttivo durante la vinificazione in IR

58Marco Muggia
2. Riempire completamente la bottiglia di controllo con il vino.
3. Misurare 40 mL dello stesso vino nella bottiglia test' e aggiungere 0,5 mL di peros-sido di idrogeno allo 0,3% p / v. Mescolare.
4. Posizionare il campione test in un armadietto scuro a circa 25 °C durante la notte.
5. Osservare il grado di rosatura del vino test rispetto a quello del controllo. Oltre a questa valutazione visiva, le misure spettrali del test e del controllo del vino possono essere eseguite a 520 nm, il che fornisce un confronto quantitativo. In questo caso, i vini dovranno essere filtrati attraverso un filtro da 0,45 μm per la valutazione.
Il fenomeno del pinking, in base a quanto premesso, risulta uno dei processi che pos-sono concretizzarsi in vini mantenuti ad uno stato particolarmente ridotto. Esso sembra essere possibile in vini suscettibili a causa del livello redox, ma anche in funzione della macerazione delle uve (che consente l’estrazione dei polifenoli responsabili dalle buc-ce). L’evento determinante per la determinazione di questa cinetica, è indubbiamente l’esposizione all’ossigeno di vini aventi le caratteristiche premesse; questa esposizione può causare il viraggio del colore nei vini solo in caso di ridotta protezione antiossidante dell’anidride solforosa.
E’ quindi un fenomeno controllabile attraverso la verifica dei livelli di anidride solfo-rosa libera, a scopo preventivo.

59 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
61 Ribéreau-Gayon et al., 2003.
In alcuni tipi di vino, un fenomeno ossidativo eccessivamente intenso e rapido porta a una scadenza qualitativa che prende il nome di svanito.
In casi di addizioni repentine di ossigeno al sistema, si assiste al susseguirsi di diverse fasi rilevate empiricamente da Ribéreau-Gayon61: in una prima fase il vino modifica o perde gli odori prima presenti, poi si assiste alla comparsa dei descrittori dovuti all’etana-le (mela tagliata), accompagnati da un sapore acro e amaro. Il fenomeno risulta dipenden-te dalla temperatura, che regola le cinetiche chimiche, e reversibile. Infatti, in alcuni casi lo svanito può essere riassorbito dal vino, probabilmente per la riduzione delle molecole ossidate, attraverso l’ossidazione di altri composti.
L’etanale, aldeide sempre presente nei casi di comparsa dello svanito, può derivare dall’ossidazione dell’etanolo in presenza di ioni metallici Fe3+, Cu2+ o per intervento di particolari ceppi di lievito (es. Candida vini). Ad ogni modo, è stato dimostrato che l’eta-nale non è l’unico composto coinvolto nella comparsa dello svanito nei vini.
Una delle operazioni nelle quali è comune la comparsa, anche se temporanea, nello svanito è l’imbottigliamento.
Durante l’imbottigliamento è normale osservare addizioni considerevoli di ossigeno ai vini, ed infatti è conoscenza comune che la “sosta in bottiglia” di alcune settimane prima della commercializzazione possa rivelarsi utile per permettere alle componenti del vino (in particolare l’anidride solforosa) di ridurre le specie ossidatesi. Un aiuto in tal senso può derivare dall’impiego di acido ascorbico, in grado di ossidarsi molto velocemente proteggendo le altre componenti del vino.
Lo svanito

60Marco Muggia
62 Trattato di enologia, pag 281.63 Ribereau Gayon et al., 2003.64 Raukine, 1963.
Il metabolismo dei lieviti, autoctoni o selezionati, in enologia, non vede solo la fer-mentazione degli zuccheri in alcole etilico. Esistono una lunga serie di reazioni parallele, collegate a metabolismi secondari dal punto di vista tecnico, fondamentali per la sua so-pravvivenza ed il suo sviluppo. Numerose molecole, ottenute per mezzo di metabolismi secondari, hanno una rilevanza dal punto di vista organolettico e quindi qualitativo.
In particolare, in questo caso ci si riferisce a una sostanza con effetti negativi, in quanto dà origine a una vasta gamma di odori sgradevoli: l’idrogeno solforato, e i suoi derivati.
L’idrogeno solforato è alla base di specie tioliche che possono formarsi sin dalla fase fermentativa e che presentano odori sgradevoli che si possono manifestare nei vini.
I processi biochimici che portano alla sua formazione sono numerosi, e non è stata ancora fatta una sintesi esaustiva di queste dinamiche. E’ tuttavia possibile fare una prima distinzione fra due categorie:
- composti solforati pesanti. Sono quelli caratterizzati da un punto di ebollizione sopra i 90°C a pressione ambiente.
- composti solforati leggeri. Sono quelli caratterizzati da un punto di ebollizione infe-riore a 90°C a pressione ambiente. In questa categoria si annoverano sostanze che conferi-scono odori assai sgradevoli e repellenti quali il metantiolo (sentori di putrido), l’etantiolo (cipolla), il solfuro di carbonile e l’idrogeno solforato stesso62. La loro concentrazione nei vini ridotti è talvolta di molto superiore alla soglia di percezione.
Lo zolfo può avere diverse origini: una delle principali è lo zolfo elementare che pro-viene dai residui di trattamenti fitosanitari sulle uve63.
Lo zolfo elementare, infatti, è un precursore dell’idrogeno solforato che si riscontra nei vini nelle diverse fasi di vinificazione64.
E’ altresì vero che lo zolfo corrisponde a circa lo 0.2 - 0.9% del peso secco dei lieviti.Perché esso possa essere ridotto chimicamente, sono necessari alcuni requisiti, i quali
sono correlati positivamente con alcuni fattori. Vengono di seguito riportati: ridotta di-mensione delle particelle di zolfo, temperatura, stato del sistema ridotto, concentrazione di etanolo, presenza di ioni metallici.
Sintesi di idrogeno solforato e suoi derivati nel difetto di “ridotto”

61 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
65 Ribereau et Gayon et al., 2003.66 Trattato di enologia 2.
La sintesi biologica dell’idrogeno solforato è assai complessa e, come detto, non del tutto spiegata ancora. Le teorie più accreditate postulano che l’origine biologica dell’i-drogeno solforato sia legata alla riduzione dei solfati, nell’ambito della biosintesi degli amminoacidi solforati cisteina e metionina. Secondo alcuni autori, l’idrogeno solforato si originerebbe dalla lisi enzimatica delle proteine vegetali nei mosti carenti di azoto; altre fonti affermano che le proteasi fungine non siano attive sul substrato di origine vegetale. Ad ogni modo, Riberau-Gayon rileva che, in mosti carenti di azoto prontamente assimila-bile che presentano la sintomatologia classica dell’accumulo di idrogeno solforato65, una integrazione azotata è in grado di eliminare dal sistema la molecola66.
Una delle possibili fonti di idrogeno solforato, il cui rilascio è in parte catalizzato dalle proteasi fungine, può consistere nella degradazione degli amminoacidi solforati per sop-perire alla carenza di fonti azotate nel substrato del lievito. Tuttavia, la quantità di questi amminoacidi nei mosti non sembra sufficientemente alta da permettere l’accumulo delle decine di microgrammi che si rilevano nei mosti problematici.
Appare evidente, da numerosi studi, che esiste un’altra via della sintesi di idrogeno solforato: si tratta della SRS (Sequenza di Riduzione dei Solfati). Questo sistema biochi-mico sembra basarsi sul sequestro dei solfiti (quindi anche quelli aggiunti come conser-vanti) e dei solfati da parte della cellula fungina. Essa li riduce poi, per mezzo di com-plessi enzimatici, ad idrogeno solforato per poterli utilizzare come reagenti nella sintesi di amminoacidi solforati. Qualora però questo meccanismo non trovi abbastanza azoto prontamente assimilabile all’interno del substrato, potrebbe accadere che si assista a un rilascio dell’idrogeno solforato prodotto, nel mosto.

62Marco Muggia
Schema del sistema di riduzione dei solfati. Disegno di Vladimir Jiranek.

63 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
67 Ribereau et Gayon et al., 2003.68 Trattato di enologia 2, pag 290 - 293.
Il fatto che la sequenza non si interrompa in caso di carenze azotate, che renderebbero superflua la riduzione dei solfiti, potrebbe suggerire una interpretazione alternativa. E’ possibile che il chimismo sia sfruttato dal lievito per detossificare il substrato in cui si sviluppa (eliminando quindi i solfiti, che hanno effetto tossico su di loro), e che quindi esso prosegua anche in mancanza di substrato azotato per fissare i disolfuri sintetizzati.
Un altro problema connesso alla presenza di tioli all’interno dei vini, è quello relativo al difetto olfattivo noto come “gusto di luce”.
E’ stata teorizzata una catena di reazioni a partire dalla riboflavina, composto che concorre alla colorazione dei vini bianchi e che funge da coenzima implicato nel ponte citocromico. In assenza di ossigeno, essa costituisce nei vini bianchi un sistema di ossi-doriduzione biologica fotosensibile e elettroattivo.
La riboflavina risulta avere due lunghezze d’onda di assorbimento a 370 e 450 nm. Una volta sollecitata dalla radiazione, la riboflavina sembra essere in grado di passare dallo stato fondamentale di singoletto a quello eccitato di tripletto. In questa forma può reagire con un amminoacido solforato, la metionina. Da questa reazione si ottiene metio-nale, che a sua volta evolve in metanetiolo. Il metanetiolo può ossidarsi a dimetildisolfuro in funzione del potenziale redox del vino, e risponde a diversi descrittori sgradevoli uti-lizzati per la descrizione del gusto di luce.
Questo difetto può essere corretto o prevenuto con l’impiego di rame nel caso di una vinificazione tradizionale: tuttavia il suo uso è sconsigliato nel caso della vinificazione in riduzione, per l’effetto catalizzatore delle ossidazione che potrebbe esplicare in occasione di una ossigenazione, anche leggera.
Un altro rimedio può essere l’impiego di tannini estratti dal vinacciolo67: queste ca-techine sono in grado di assorbire la radiazione UV, e particolarmente di quella con una frequenza di 370 nm che non è quindi in grado di sollecitare la riboflavina e di avviare la degradazione della metionina68.

64Marco Muggia
69 Ribéreau-Gayon et al., 2003.70 Hinrischen, 201771 Hinrischen, 2017.
Il rame può essere presente nei mosti e nei vini in virtù di tre origini principali:- dal valvolame e dalle componenti di vecchia generazione di ottone e bronzo delle
apparecchiature di cantina;- dal vigneto, come residuo di concimazioni o di trattamenti fitosanitari;- dalle aggiunte attuate dal tecnico a scopo preventivo o curativo di alcuni difetti oc-
corsi durante la vinificazione.
Il rame che deriva dai vigneti è in parte allontanato con le chiarifiche ed i travasi, in quanto reagisce con i composti solforati dando solfuri insolubili. Esso risulta avere un ef-fetto negativo essendo tossico per i lieviti ed influenzando negativamente il decorso della fermentazione ed il suo avvio.
Il rame derivante dalle attrezzature risulta essere al giorno d’oggi assai limitato, grazie alla diffusione di altri materiali come l’acciaio inox.
La ragione principale del rame nei vini imbottigliati sembra essere la sua aggiunta at-tuata durante la filiera, per correggere difetti relativi alla riduzione dei composti solforati che si originano quando il vino si trova allo stato ridotto, in virtù della bassissima soglia di percezione di questi composti69. Come già detto, il chimismo che si instaura fra rame e composti tiolici, porta alla formazione di solfuri di rame, composti insolubili.
Questo trattamento, molto comune e diffuso, risulta però avere alcuni limiti:- solitamente si aggiunge un grande eccesso di rame rispetto alla concentrazione nei
vino dei composti solforati;- il solfuro di rame tende a permanere nel vino.
E’ effettivamente vero che si opera normalmente aggiungendo un eccesso di rame pari a circa 25 volte la dose necessaria per avere una equimolarità (qualora si resti a metà della dose massima concessa dai limiti legali)70. Questo fatto sembra indicare che il rame inte-ragisca con altri composti, oltre che con i tioli origine dei difetti olfattivi, ed è possibile che oltre ai tioli varietali (che concorrono a dare fragranze di bosso, pompelmo, frutto della passione) altri composti positivi siano aggrediti dal rame addizionato71.
Un altro aspetto negativo dell’impiego del rame è correlato allo stato di sovrasatura-zione in cui si trovano i composti di rame e zolfo all’interno del vino, rendendo possibile la formazione di precipitati di dimensioni dell’ordine di alcuni nanometri. Questi com-
Impiego del rame per la correzione dei difetti dovuti ai tioli

65 Vinificazione in iper-riduzione: analisi dell’operatività e fenomeni
posti sembrano resilienti alla precipitazione ed alla filtrazione, a causa dell’interferenza di altre componenti del vino che interferiscono con l’aggregazione e la sedimentazione di queste particelle72. I residui che permangono all’interno del vino fino all’imbottigliamen-to sembrano avere comportamenti diversi, tuttavia è stata rilevata la tendenza alla libera-zione di importanti quantità di idrogeno solforato in condizioni di riduzione (quali quelle della bottiglia tappata con una chiusura poco permeabile all’aria) e presenza di metalli.
Da diversi studi appare evidente come la concentrazione di idrogeno solforato nei vini imbottigliati ed in stato fortemente ridotto, sia influenzata dalla quantità di rame nel vino. E’ stato ipotizzato un processo chimico in grado di influenzare la concentrazione di idrogeno solforato in presenza di rame: la desolforazione degli amminoacidi solforati catalizzata dai metalli73.
72 Clarck et al., 2015.73 Viviers, M. Z., Smith, M. E., Wilkes, E., & Smith, P., 2013.

66Marco Muggia

67
Parte TerzaAnalisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione

68Marco Muggia

69 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
La produzione di vini è una attività economica con un grosso impatto sull’economia di diverse Nazioni, e nella situazione italiana è di rilevanza particolare in alcune Regioni. La produzione italiana è cresciuta a oltre 51.6 milioni di ettolitri nel 2016, con una quota di vini bianchi pari a 27.4 milioni di ettolitri, pari al 53% della produzione totale di mosti fermentati74. È importante la conoscenza dei livelli di spesa per comprendere la redditivi-tà di una impresa, sia essa agricola, alimentare o di altra categoria merceologica.
La terza parte di questa trattazione è quindi deputata all’analisi di come il mercato si pone nei confronti di questa tipologia di prodotti, ed al confronto fra le differenze nei costi di produzione che si incontrano per conseguirla, rispetto all’implementazione di un pro-tocollo di vinificazione tradizionale. Lo scopo è quello di delineare un più ampio quadro dell’opportunità d’uso della vinificazione in IR, che possa fornire indicazioni ai produtto-ri con una più vasta descrizione della sola esemplificazione dei chimismi in gioco.
Non si intende quindi analizzare nel dettaglio tutte le voci di spesa, andando a redigere un dettagliato computo dell’ambito della vinificazione in IR calato in una azienda-esem-pio, quanto piuttosto evidenziare quali siano le attrezzature e le conoscenze necessarie per una completa e corretta implementazione di detti protocolli.
Come sarà possibile rilevare nelle prossime pagine, per precisa scelta di chi scrive, non verranno indicate le variazioni di prezzo di minor rilievo, ma si indagherà particolarmente sulle componenti principali della differenza di costo. Tuttavia, non ci si esimerà dall’enu-merare anche le voci di costo caratterizzate da un impatto inferiore sul bilancio.
Parte economica e di mercato
74 http://www.inumeridelvino.it/2017/06/la-produzione-di-vino-in-italia-nel-2016-dati-finali-istat.html

70Marco Muggia
75 Barisan L., Università degli studi di Padova.
Delle varie voci di spesa che si incontrano nell’applicazione completa di un protocollo di vinificazione in IR, è possibile una classificazione in base a centri di costo in grado di evidenziare meglio in quali, fra le diverse fasi della filiera, i costi subiscono una varia-zione rispetto ad una normale vinificazione. Si è deciso di suddividere le variazioni di spesa rispetto al protocollo tradizionale, nei seguenti centri di costo, dei quali si sono poi approfondite alcune voci, andando a generare un parametro per la loro quantificazione nelle diverse realtà. E ancora, si è deciso di ripartire le spese nei seguenti centri di costo: campagna, ammortamenti per attrezzature, costi del personale, trasformazione ed elabo-razione, packaging.
Campagna.La produzione di vini di qualità non può prescindere dall’utilizzo di materia prima,
l'uva, che sia sana e di prima scelta. Le differenze di costo che si rilevano riguardano la necessità di una maggiore attenzione e precisione durante la coltivazione della vite, cali-brando i trattamenti fitosanitari nell’ottica di produrre vini che, per la tecnologia con cui vengono elaborati, sono maggiormente sensibili ai problemi connessi con la riduzione dei composti solforati ed alle ossidazioni. Sarà quindi necessario ridurre i trattamenti a base di zolfo elementare e rispettare un adeguato periodo di carenza per i principi attivi a base tiolica. Sarà inoltre importante prestare particolare attenzione alla copertura ed alla lotta contro le infezioni da Botritys cinerea e marciume acido. Questo perché non sarebbe possibile, in caso di infezione, l’applicazione del protocollo, in quanto non si è in grado di portare all’esaltazione della frazione aromatica varietale di uve nelle quali i pesanti processi ossidativi ad opera della laccasi e delle polifenolossidasi sono già avviati.
Anche la tipologia di raccolta è in grado di influenzare pesantemente i processi ossida-sici, e per questa ragione è sconsigliata la vendemmia meccanizzata. È ormai constatato che la lacerazione dei tessuti delle bucce, che di norma si verificano durante la raccol-ta meccanica con incidenza assai maggiore rispetto alla vendemmia manuale, è causa dell’avvio delle catene ossidative già descritte.
Il costo della vendemmia meccanizzata rispetto a quella manuale risulta essere assai variabile da regione a regione, e dipendente anche dalle trattative che singolarmente l’a-zienda realizza con il terzista, oppure dalla operatività del singolo tecnico che impiega la macchina. Si è assunto che siano verosimili, per questo caso, i dati studiati da Galletto e Barisan, riportati nella seguente tabella75.
Differenze di costo

71 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Tabella della composizione dei costi della vendemmia a confronti. Fonte: Barisan L., Università degli studi di Padova.

72Marco Muggia
Si evince dalla tabella che, a fronte di un costo ad ettaro di 1451.20 euro per la raccolta manuale, l’impiego di una macchina trainata di proprietà dell’azienda assume un costo di 876.06 euro, pertanto76:
Seguendo lo stesso principio, è possibile calcolare la differenza di costo rispetto alla vendemmia con macchina semovente di proprietà dell’azienda (che comporta un costo di 717.09 euro), pertanto:
Riproponendo lo stesso principio di calcolo, è possibile ottenere la differenza di costo dell’intervento di una ditta esterna che si occupi della raccolta (che comporta un costo di 807.32 euro). Pertanto:
Appare quindi evidente che una delle principali voci di spesa per la gestione delle operazioni in campagna, risulti essere l’aumento del costo della raccolta che, alternativa-mente, avrebbe potuta essere gestita attraverso la meccanizzazione. L’aumento di costo è compreso in una forbice fra il 40% ed il 50%.
Ammortamenti delle attrezzature.La vinificazione in riduzione richiede l’uso di particolari attrezzature in grado di ope-
rare senza esporre all’aria mosti e vino. Questi macchinari potrebbero in alcuni casi es-sere non necessari, qualora si fosse considerata accettabile una anche breve esposizione all’ossigeno, ed è pertanto coerente indagare la variazione nei costi dovuta a questa scelta tecnologica.
Per quanto concerne la pressa, essendo una attrezzatura di cui bisogna comunque di-sporre, si considera solo la differenza di costo fra una pressa meccanica ed una pressa pneumatica con mongolfiera.
In seguito alla richiesta di preventivi di spesa per la dotazione di tali attrezzature, è possibile riportare i dati nella tabella a pagina 72.
In occasione delle addizioni di coadiuvanti, è opportuno che gli stessi vengano aggiun-
876.06
717.09
807.32
1451.20
1451.20
1451.20
∙ 100 = 40%
∙ 100 = 51%
∙ 100 = 44%
1 –
1 –
1 –
[
[
[
]
]
]
76 Formule tratte dalla tabella della composizione dei costi della vendemmia a confronti. Fonte: Barisan L., Università degli studi di Padova.

73
77 Medici, 1937.78 http://www.fisco7.it/wp-content/uploads/2013/03/Tabella-dei-coefficienti-di-ammortamento.pdf.
ti con omogeneizzazione della massa, per avere un effetto equamente distribuito e per evi-tare che le componenti del vino entrino in contatto con, ad esempio una colla, in cattiva distribuzione. È quindi importante essere attrezzati con un agitatore, in grado di creare i moti necessari per l’omogeneizzazione della massa in occasione di aggiunte di coadiu-vanti. Questa apparecchiatura viene presa in considerazione in questa analisi in quanto, in applicazione dei principi di un normale protocollo di vinificazione, sarebbe possibile la stessa operazione con il solo ausilio di una pompa e di condotte flessibili.
Il confezionamento dei vini deve avvenire limitando il disciogliersi dell’ossigeno al loro interno, per mantenere più costante possibile lo stato ossidoriduttivo delle specie al suo interno e quindi per evitare alterazioni organolettiche o inerenti la stabilità del pro-dotto. Come detto, l’ausilio di un impianto in grado di creare il vuoto nella fase di testa della bottiglia, prima della sua tappatura, è fondamentale per operare in ambiente ridotto, evitando le ossidazioni in questa delicata fase. Si stabilisce però, in questa sede, di non computare l’aumento di costo dovuto a questo modulo della linea di imbottigliamento, in quanto ormai risulta raccomandabile esserne dotati, qualsivoglia sia il protocollo di produzione.
Un fattore della produzione (capitale) non può, anche qualora il suo impiego avvenga in modo da mantenerlo perfetto, avere una durata illimitata nella sua utilità e pertanto bisogna considerare il costo del suo rinnovo. L’ammortamento è la quota media annuale del capitale necessario per il rinnovo di una fattore della produzione che esprime la sua funzione in più anni77.
Per quantificare l’aumento di costo correlato alle attrezzature, si stabilisce di utilizzare il valore a nuovo delle macchine, applicandolo sotto forma di rateo. Il rateo viene calco-lato utilizzando il parametro percentuale ufficiale previsto per la registrazione nel libro dei cespiti.
Nel dettaglio, alla voce “specie 11 A-macchinari operatori ed impianti”, viene previsto per questa categoria di costi da ammortare il parametro 10%78, pertanto si assume che un decimo del costo della macchina sia l’importo da distribuire sulle bottiglie prodotte in una campagna vendemmiale, per 10 campagne successive le une alle altre.
Il capitale sul quale viene calcolato il rateo, è riferito alle attrezzature di cui è necessa-rio dotarsi per poter controllare l’ossigeno durante le varie fasi tecnologiche, sia operati-vamente che analiticamente.
Ci si riferisce, in dettaglio, ad una pressa della tipologia descritta nelle pagine prece-denti, ad un agitatore per implementare le addizioni di coadiuvanti mantenendo il vino al riparo dall’ossigeno e di un ossimetro per la misura dell’ossigeno disciolto nei vini.
Si assume che la migliore offerta per le due presse sia:
Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione

74Marco Muggia
Tabella della variazione dei costi nelle attrezzature.
79 Medici, 1937.80 ABI, 2017.
∙ Nr. 01 pressa pneumatica Bucher© “mod. XPLUS 50 1P”: 60.000 euro.
∙ Nr. 01 pressa pneumatica Bucher© “mod. XPLUS 50 1P INERTYS”: 72.000 euro La differenza di costo fra i due sistemi di pressatura è quindi pari a 12.000 euro.
E ancora, si sono reperiti i prezzi per:
∙ Nr. 01 agitatore estraibile ad una velocità “Mod. RA45”: 1300 euro.
∙ Nr. 01 ossimetro HI 9146-10 Hanna instruments©, con compensazione di altitudine e salinità: 680 euro.
Attrezzatura Costo in euro
Pressa 12000Agitatore 1300Ossimetro 680
Totale 13980
Oltre alla differenza del costo vivo per la dotazione di macchinari idonei, è opportuno considerare il costo finanziario di questa spesa. Solitamente l’imprenditore si rivolge ad un istituto di credito per ottenere l’anticipazione di capitale necessaria per l’avvio di una attività economica; in alternativa è possibile che l’imprenditore finanzi l’acquisto con capitale proprio, ma è comunque corretto calcolare l’interesse come un costo in quanto ci si riferisce ad un mancato guadagno79. Infatti, l’imprenditore avrebbe potuto ottenere un interesse nel caso in cui avesse investito tale somma in un altro impiego a egual rischio. In questa analisi si assume che l’imprenditore si rivolga ad un istituto di credito per fi-nanziare l’investimento, pertanto si è preso come riferimento il tasso medio di interesse applicato dagli istituti italiani80.
La formula per il calcolo della quota di ammortamento è:

75 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
81 ABI, 2017.82htt://www.confagricolturavr.it/attachments/article/346/CCNL%20OPERAI%20AGRICOLI%20
E%20FLOROVIVAISTI%202014%20-%202017.pdf., pag 27.
Qam è la quota di ammortamento (nel caso in analisi riferita alla differenza di costo fra le due macchine).
Vn indica il valore a nuovo della macchina, nel nostro caso la differenza di prezzo.Vu è il valore della macchina al termine del periodo di ammortamento. Assumiamo,
per approssimazione, che il calo del valore della macchina non sia diverso in funzione delle due tipologie di macchina messe a confronto. Pertanto, a fine ciclo, la differenza di valore fra una pressa meccanica ed una pneumatica per operare in IR è la stessa che ad inizio ciclo. Il valore delle due macchine a fine dei 10 anni si ipotizza essere il 30% di quello iniziale, pertanto anche la differenza di valore a fine ciclo è pari al 30% della differenza a inizio ciclo.
n è il tempo che si prevede per l’ammortamento. Nel nostro caso, si considerano 10 anni.
r è il saggio di interesse attribuito alla spesa per ammortamento per il finanziamento presso un istituto di credito italiano. Il tasso medio italiano, per le imprese, del 2017 è stato pari al 2.79%.81
Il costo annuo dell’ammortamento è quindi pari a:
(13980 – 4194) ∙ 0.0278(1+0.0278)10-1
Qam = = 862 euro
(Vn – Vu)∙r(1+r)n-1
Qam =
Costi del personale.Il livello di automazione degli impianti produttivi è oramai avanzato, ma diversi mac-
chinari ed impianti ad elevata automazione risultano essere molto onerosi per le piccole e medie cantine, che non hanno la possibilità di ammortizzare la spesa in tempi ragione-voli82. E’ quindi normale, allo stato attuale, che nelle cantine (specialmente in quelle di scala ridotta) siano presenti alcune apparecchiature ad elevata automazione, ma che nel complesso la filiera sia ancora condotta con l’impiego di lavoro umano.
I contratti di lavoro in campo agricolo comportano costi meno elevati che quelli appli-cabili ad altri settori (ad esempio quello alimentare), per precisa volontà del Legislatore. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL, d’ora in poi) operai agricoli e flo-rovivaisti, prevede diversi inquadramenti per il personale, in funzione delle competenze

76Marco Muggia
e delle responsabilità correlate. A un diverso inquadramento e ad un variare di mansioni, corrisponde un diverso trattamento economico e quindi una variabilità nel costo del fat-tore produttivo lavoro, per l’azienda.
Questa risulta essere una delle voci più difficili da quantificare, anche per la variabilità di trattamento che normalmente insiste fra le diverse aziende, in particolare per quelle di dimensioni medio-piccole. Si cerca tuttavia di assumere un dato quanto più possibile ve-rosimile, e con questo obbiettivo si è stabilito di fare riferimento al CCNL operai agricoli e florovivaisti 2014 - 2017.
Con l’intenzione di fornire un parametro che permetta di prevedere il costo, e che sia applicabile a diverse realtà produttive, si procede al calcolo della differenza di retribu-zione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per ottenere un parametro che indichi questa differenza sotto forma percentuale.
Come si evince dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), la categoria degli operai agricoli viene scissa in due aree:
∙ Area 1A - DeclaratoriaAppartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze
e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
∙ Area 2A - DeclaratoriaAppartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non
complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Queste sono le due categorie di operai, distinte per mansione e responsabilità correlate, cui ci si intende riferire per raffrontare la differenza fra il costo del personale in uso nella vinificazione in riduzione ed in quella tradizionale.
Si assume che l’area 2A corrisponde a quella di un tecnico di cantina con competenze nella vinificazione, in grado di lavorare in relativa autonomia se dotato di un protocollo stilato dall’enologo.
L’operaio di area 1A presenta un profilo che risponde maggiormente a quello necessa-rio per una gestione continua e certosina dello stato ossidoriduttivo del vino durante tutta la filiera. Si intende identificare un tecnico in grado non solo di azionare macchinari, ma dotato del know-how necessario per il monitoraggio dell’ossigeno disciolto e della pro-tezione fornita dall’anidride solforosa; non ultima responsabilità riconducibile a questo profilo è quello della manutenzione degli impianti e della verifica dell’integrità dei ma-teriali.

77 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Tabella che registra le retribuzioni minime per gli operai agricoli.
83http://www.confagricolturavr.it/attachments/article/346/CCNL%20OPERAI%20AGRICOLI%20E%20FLOROVIVAISTI%202014%20-%202017.pdf., pag 67.
Come si evince dalla tabella che registra le retribuzioni minime per gli operai agrico-li83, la differenza di costo per la prestazione erogata dall’operaio in favore della filiera in IR è pari a:
1140.001250.00
∙ 100 = 8,8%[ ]
Minimi salariali di area mensili
Operai agricoli
Aree professionali
Area 1
Area 2
Area 3
Minimi
1.250,00
1.140,00
850,00
Dal calcolo si deduce quindi una differenza della retribuzione mensile netta di, pres-sappoco, 9%.
Non è possibile standardizzare la differenza nei tempi necessari per l’elaborazione dei vini in ambiente fortemente ridotto rispetto ad una vinificazione tradizionale. Questa impossibilità deriva dal fatto che ogni vinificazione è a sé stante e dipende dalle caratteri-stiche intrinseche dell’uva, e dalla cinetica fermentativa, fattori non sempre controllabili. Si può, tuttavia, ipotizzare che l’elaborazione di vini in IR richieda un numero maggiore di ore lavorate, per la necessità di un costante monitoraggio, anche analitico, dei prodotti, delle attrezzature, del decorso fermentativo.
Trasformazione ed elaborazione.L’ottenimento di vini in IR durante tutta la filiera richiede un diverso uso di coadiuvan-
ti, un controllo analitico costante sulla protezione antiossidante fornita ai vini, l’impiego di gas inerti (ottenibili per sublimazione della loro forma solida, o per passaggio in fase gassosa all’uscita da una bombola).

78Marco Muggia
E’ possibile prevedere un maggiore impiego, come coadiuvanti, di tutti quei prodotti con funzione protettiva dalle ossidazioni: ci si riferisce quindi, principalmente, all’anidri-de solforosa (nelle sue varie forme), all’acido ascorbico, ai gas inerti ed ai lisati li lievito. Non ci soffermerà, tuttavia, sulla determinazione dell’entità di questi costi in quanto, sebbene se riferiti ad un’azienda di grandi dimensioni essi siano importanti, è altresì vero che il loro impatto in tali situazioni è ridotto dal prezzo più vantaggioso che l’azienda è in grado di conseguire, stanti i grandi volumi trattati. Nelle aziende di dimensioni più ridot-te, altresì, il loro impatto è di gran lunga inferiore rispetto a quello di altri centri di costo.
Packaging.Il packaging, inteso come insieme della confezione con la quale viene commercializ-
zato il prodotto, ha assunto un ruolo sempre più rilevante dal punto di vista commerciale. Esso risulta tecnicamente rilevante in quanto è in grado di influenzare l’evoluzione e la shelf life del vino. Assume un ruolo sempre più importante anche sotto il profilo del marketing e della comunicazione, in quanto è uno dei principali canali di comunicazione dell’azienda verso il consumatore, e concorre alla definizione e percezione della sua im-magine da parte del pubblico.
Il packaging comprende diversi materiali fra cui il contenitore, il tappo, l’etichetta, l’e-ventuale fascetta se prevista dalle normative di legge, imballaggi singoli sulla bottiglia, la capsula ed infine la scatola. Per effettuare una stima di detti costi, si assume la situazione più frequente:
∙ etichetta per fronte bottiglia di buona qualità;∙ etichetta per retro della bottiglia di qualità più bassa;∙ scatola in cartone di media qualità da 12 pezzi con separatore;∙ non si considerano fogli per avvolgere la singola bottiglia, né la fascetta (non essendo
essa in uso per gran parte dei vini italiani).Per questi costi, riportati nella tabella seguente, si è richiesto preventivo ad una ditta di
intermediazione che li tratta tutti, riferendosi a 14.000 pezzi per referenza.
Materiale Prezzo unitario in euro
Etichetta Fronte 0,08Etichetta Retro 0,04
Scatola in cartone 0,96Bottiglia 0,225
Totale a bottiglia Tabella che registra i costi fissi del packaging.

79 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
E ancora, per quanto rigurada il packaging, esistono diverse forme e diversi materiali impiegati per il contenitore, anche se il più diffuso è la bottiglia. Essa risulta essere il con-tenitore preferito dai consumatori, per l’immagine che trasmette correlata alla tradizione ed alla qualità del prodotto.
Riguardo alla bottiglia, non si evidenziano aumenti nei costi in funzione dello stile di vinificazione, ma si ritiene doveroso sottolineare due aspetti. Il primo è inerente il forma-to della bottiglia: maggiore è il volume interno del contenitore (a parità di superficie della chiusura), minore sarà lo scambio con l’atmosfera (qualora permesso dal tappo) per vo-lume di prodotto. Si assiste quindi ad una minore ossigenazione del vino quando questo è conservato in un contenitore di maggior volume rispetto alla bottiglia standard da 0.75 L.
Il secondo aspetto che preme sottolineare è quello inerente alla colorazione del vetro. I vetri possono essere colorati con diverse tonalità in funzione dell’aggiunta di sostanze al momento della loro fusione. Via via che ci si muove verso colorazioni del vetro più vicine alla trasparenza, minore sarà la quantità di luce assorbita dallo stesso, e maggiore sarà la radiazione in grado di raggiungere il prodotto. I vini, e specialmente quelli mante-nuti in stato ridotto, sono suscettibili alla permanenza al loro interno di composti solforati che possono interagire con la radiazione ed esserne degradati (ad esempio la metionina), dando origine al difetto olfattivo caratterizzato da diversi descrittori che vengono comu-nemente chiamati gusto di luce84. Per questa ragione, è suggeribile la scelta di bottiglie scure, di modo che il vetro assorba più radiazione, limitando quella che passa al vino.
L’etichetta, la capsula, la fascetta, il contenitore in cartone e l’eventuale imballaggio singolo non risultano incidere in maniera rilevante sulle caratteristiche di un vino, se non per l’assorbimento della possibile radiazione luminosa incidente. Pertanto non si rilevano variazioni nei costi in funzione del materiale, in quanto non sussistono ragioni tecniche per preferire un materiale o formato ad un altro, oltre alle eccezioni di cui sopra.
Riguardo i tappi, si è già spiegato come questi influenzino l’evoluzione del vino im-bottigliato e del loro potenziale ossido-riduttivo. In questo frangente, è sicuramente con-sigliabile l’impiego di tappi a vite, che comportano un costo assai inferiore, rispetto a tappi microgranulati. Se si paragona il costo con quello di tappi in sughero naturale, il risparmio arriva anche a cinque volte tanto.
Il tappo a vite non richiede l’utilizzo di una capsula come nel caso di altre tipologie di tappo. Per utilizzare un valore intermedio fra le varie scelte a disposizione, si decide di impiegare il costo di un tappo tecnico di sughero microgranulato marca DIAM© (la più costosa fra quelle rinvenute), un tappo a vite marca Stelvin©, una capsula in materiale polilaminato. Per il vetro, si è verificato che non esistono differenze sostanziali di prezzo fra bottiglia con collo normale e cercine, rispetto ad una bottiglia con collo filettato.
84 Ribéreau-Gayon et al., 1957.

80Marco Muggia
Da un preventivo di spesa per un ordine di 14.000 pezzi per referenza, risulta:
∙ per la bottiglia da 450 grammi e 750 mL, un prezzo di 225 euro/1000 pezzi, pari a:
225euro /1000 pezzi= 0.225 euro/pezzo
∙ per il tappo microgranulato, tipologia 3, un prezzo di 135 euro/1000 pezzi, pari a:
135 euro/1000 pezzi= 0.135 euro/pezzo
∙ per una capsula in polilaminato (in stagno/alluminio) un prezzo di 32 euro/1000 pez-zi, pari a:
32 euro/1000 pezzi= 0.032 euro/pezzo
∙ per un tappo a vite un prezzo di 72 euro/1000 pezzi, pari a:
72 euro/1000 pezzi= 0.072 euro/pezzo
Si può quindi assumere che, il costo della chiusura con tappo sia dato dalla somma del costo della capsula e del tappo, pertanto:
0.032 + 0.135 = 0.167 approssimato a 0.17 euro a bottiglia
Di seguito si riporta il computo dei costi, che non subiscono variazione in funzione della tipologia di vinificazione, e il computo della differenza di costo utilizzando le due formule di packaging, espresse in euro e percentuale. L’uso del tappo a vite comporta una diminuzione dei costi di produzione, riconducibili al centro di costo packaging, del 16.5%.

81 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Tabella che registra i costi non variabili per tipologia di packaging e la differenza fra le varie soluzioni possibili di costo nel packaging.
Materiale Prezzo unitario in euro Costo totale in euro
Costi non variabili 0,425 0,425Tappatura
microgranulato e capsula
0,17 0,595
Tappatura a vite 0,072 0,497
Rapporto fra chiusura classica e a vite 16,50%
Differenza di costo fra le due chiusure, in euro e %

82Marco Muggia
Avendo descritto le principali variazioni nei costi di produzione, in applicazione della vinificazione in IR, si può ora riassumere il computo per nella seguente tabella:
Appare chiaro come si tratti di aumenti non indifferenti, in particolare misura in azien-de di piccole dimensioni, che devono necessariamente essere assorbiti attraverso un in-cremento del prezzo di vendita del prodotto finito, a meno che non si voglia ridurre la quota di profitto dell’impresa.
Si sono cercati dati riguardo la variazione di prezzo per prodotti realizzati in IR, an-dando ad intervistare diverse aziende del Friuli Venezia Giulia: purtroppo, si è constatata l’assenza di produttori che applicano in toto i dettami del protocollo, ed è pertanto impos-sibile calcolare un dato inerente il diverso prezzo medio di vendita.
Un dato utile è emerso durante le indagini: molti produttori hanno dichiarato di con-durre la filiera in condizioni di assenza dell’ossigeno solo in alcune fasi ritenute strategi-camente più sensibili, quali la macerazione e l’imbottigliamento.
Riepilogo variazioni dei costi
Centro di costo Voce di spesa Variazione totale per centro di costo
Campagana Raccolta 45%
Pressa Agitatore € 862,00Ossimetri
Costo del personale Operai specializzati 9%
Packaging Tappo a vite -16,50%
Ammortamenti: costi specifici
Tabella che riepiloga la variazione dei varia centri di costo.

83 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
In diversi casi non si sono avute risposte del tutto coerenti in merito alle tecniche di applicazione, rendendo difficile comprendere se gli intervistati si stessero riferendo alle normali prassi di prevenzione dei processi ossidativi non gestiti dall’enologo. Non si è chiarito se i produttori si stessero effettivamente riferendo ad un’ottica di gestione della filiera al fine di preservare gli aromi primari, o se la conoscenza dell’operatività della tecnica stessa non sia così diffusa. Una ulteriore ricerca in merito potrà sicuramente fare più chiarezza.
Essendo stato impossibile raccogliere dati sui prezzi di vendita per le suddette ragioni, si è cercato di ottenere una risposta in merito dai consumatori tramite un sondaggio.

84Marco Muggia
Va sottolineato che esistono forme di supporto da parte della pubblica amministrazio-ne, sia nazionali che locali. Ad esempio in Friuli Venezia Giulia è possibile, per le imprese agricole, finanziarsi a tasso zero per i capitali investiti nei processi produttivi: ci si rife-risce al fondo di rotazione regionale in agricoltura, istituzionalizzato con legge regionale 20 novembre 1982, n. 8085.
Va in ogni caso sottolineato che la diffusione della vinificazione in riduzione dipende, come molte altre tecniche e tipologie di prodotti, da una moda fra i consumatori che al momento sembrano apprezzare prodotti con una espressione aromatica molto intensa. Tuttavia, per la natura stessa di questa moda, è difficile prevederne la durata e quindi la domanda del mercato di questo tipo di prodotti. In conseguenza di ciò, si intende sot-tolineare che, sebbene la normativa vigente imponga che il costo venga contabilmente considerato su un orizzonte di dieci anni, non è possibile prevedere se l’orizzonte sia effettivamente tale.
Per quanto riguarda i materiali per il packaging, si sottolinea che i prezzi indicati sono riferiti a forniture di dimensioni assai contenute: probabilmente forniture di volumi mag-giori comportano costi unitari ridotti. Tuttavia, non vi è ragione di credere che la differen-za di costo fra le alternative descritte possa variare in maniera sensibile, ed è per questa ragione che si è deciso di indicarla come variazione percentuale.
Discussione calcolo variazione dei costi
85 Regione Autonoma FVG, 2017.

85 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Ogni investimento produttivo deve, in un’ottica di sostenibilità economica dello stes-so, essere ripagato: deve cioè comportare un aumento del fatturato dovuto ad aumenti della produttività o della qualità del prodotto finito.
Chi scrive ha indagato presso diversi produttori del Friuli Venezia Giulia, di dimen-sioni diverse, per avere evidenza della differenza di prezzo fra un prodotto vinificato tra-dizionalmente ed in IR. Dal riscontro dei tecnici e dei produttori della Regione è emerso che nessuno dichiara di implementare in toto il protocollo di vinificazione in IR. Alcuni di essi hanno affermato di applicarne solo alcuni passaggi nell’ambito di una filiera più tradizionale. È stato quindi impossibile ottenere dati certi sulla differenza di prezzo al pubblico che è possibile conseguire con questa tecnica. Per rimediare a ciò si è deciso di intervistare i consumatori, per ottenere informazioni sulle intenzioni di spesa e l’immagi-ne relativi ai prodotti ottenuti con vinificazione IR.
Per meglio comprendere quale conoscenza e quali aspettative i consumatori finali hanno in riferimento ai prodotti ottenuti in IR, si è ritenuto utile stilare un sondaggio aperto ad un pubblico variegato per poter effettuare una analisi statistica in merito. Si è proceduto stilando un sondaggio in dieci quesiti.
Alcuni di questi sono votati ad identificare il campione in riferimento alla sua cono-scenza del mondo enologico, alla sua inclinazione al consumo ed alla spesa cercando di identificare i valori percepiti che indirizzano queste tendenze. Per valore percepito si intende la relazione fra le caratteristiche intrinseche del prodotto, il modo in cui queste vengono comunicate all’esterno e la risposta che questa comunicazione causa nei consu-matori.
Altri sono impiegabili per comprendere la propensione alla spesa del campione, e come questa vari in funzione di come il prodotto risponde a determinati requisiti di prez-zo, salubrità ed espressione aromatica, cercando di porre in scala di rilievo questi fattori del prodotto.
La popolazione, composta da 100 soggetti, è di seguito descritta in base alla formazio-ne scolastica, all’impiego ed all’età. Si sottolinea che 96 soggetti su 100 sono residenti nel nord/est Italia, in Veneto e Friuli Venezia Giulia.
I dati.Formazione scolastica:∙ 56% diploma di scuola secondaria superiore;∙ 44% laureati.
Indagine statistica interesse dei consumatori

86Marco Muggia
Impiego attuale:∙ 40% studenti;∙ 21% liberi professionisti;∙ 19% impiegati dipendenti;∙ 13% operai dipendenti;∙ 7% disoccupati.
Età:∙ 56% tra i 18 e i 30 anni; ∙ 21% tra i 31 e i 40 anni;∙ 5% tra i 40 e i 50 anni;∙ 18% sopra i 50 anni.
Non ci si illude di aver realizzato uno studio esaustivo al riguardo - in parte per la dimensione e la distribuzione del campione, in parte per il numero di quesiti posti - ed è anzi auspicabile una ricerca dettagliata in merito. Si è però ritenuto utile - al fine di dare completezza all’analisi chimica, tecnica ed economica - indagare la risposta del mercato alla tipologia di prodotti in esame, con il fine di comprendere se la sua risposta giustifichi gli investimenti e le spese necessarie per la loro realizzazione secondo i principi della vinificazione in IR.
Si riportano di seguito i quesiti posti e le risposte ottenute dal campione.

87 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Quesito 1Esiste una tecnica di produzione usata talvolta per ottenere vini con particolari caratte-
ristiche aromatiche, e si consegue attraverso la totale protezione del mosto e del vino dal contatto con l'ossigeno.
Eri a conoscenza della sua esistenza?
A. La conoscevo B. Ne ho sentito parlare, ma non ho una esperienza diretta con questo tipo di viniC. Non ne ho mai sentito parlare
Su 100 intervistati, 2 non hanno risposto alla domanda. Si evince in ogni caso, che la maggior parte, non conosce la tecnica o ne ha solo sentito parlare. Quest'indagine dimo-stra come sostanzialmente solo una piccola parte del pubblico intervistato abbia risposto di conoscere questa tecnica. Tuttavia, questo non fornisce alcuna indicazione sull’apprez-zamento per i prodotti elaborati tramite essa.
È in ogni caso indicativo di come la comunicazione in tal senso probabilmente non sia stata abbastanza mirata ed efficace da creare una consapevolezza nel consumatore sull’investimento e la laboriosità richieste per conseguire l’obbiettivo enologico con que-sta tecnica.
Le risposte a questo quesito spingono ad una riflessione in merito all’impiego di questa tecnica ed alla sua comunicazione al mercato.
7
25
66

88Marco Muggia
L’obiettivo è di portare il vino ad essere un prodotto e non una commodity e solo ag-giungendo valore in termini di qualità percepita si può raggiungere questo obiettivo86.
Appare evidente che in questo ambito non si siano concretizzate efficaci politiche per comunicare ai consumatori la vinificazione in IR come un parametro di differenziazione del prodotto, stando alle risposte del pubblico intervistato. Attraverso la differenziazione è possibile differenziare il prodotto da quelli dei competitors nel lungo periodo, con i con-seguenti benefici sulla percezione del suo valore e quindi sulla propensione al consumo da parte del mercato.
86 Begalli, 2004.

89 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Quesito 2.Saresti interessato ad assaggiare, o hai già assaggiato, un vino prodotto con questa
tecnica?
A. SiB. No
Le risposte al secondo quesito, 98 in tutto, evidenziano una sostanziale curiosità ed un interesse da parte del pubblico per questa tecnica. L'86% degli intervistati reagirebbe positivamente alla possibilità di degustare questi prodotti, o lo hanno fatto in passato. Questo fattore può essere riconducibile alla sostanziale curiosità ed interesse nei confron-ti dei prodotti vinicoli, con un pubblico sempre più alla ricerca prodotti qualitativamente elevati ed interessato alla produzione enologica, alla quale si assiste ultimamente. Un dato utile a comprendere queste dinamiche può essere il numero di iscritti all’Organizza-zione Nazionale Assaggiatori di Vino, che vede una costante crescita negli ultimi anni87.
L’alta percentuale di interessati, suggerisce che, politiche comunicative ed azioni in tal senso da parte dei produttori, potrebbero aiutare a costituire una domanda assai maggiore di questi prodotti, almeno nel primo approccio del consumatore con essi. Questo aumento della domanda potrebbe ridurre l’impatto degli ammortamenti e degli altri costi fissi della produzione, aiutando ad aumentare i margini di profitto o diminuendo il prezzo del pro-dotto, rendendolo più competitivo.
87 Vito Intini, 2016.

90Marco Muggia
Quesito 3.Sei un consumatore di vino?
A. SiB. No C. Saltuario
Il terzo quesito ha lo scopo di meglio conoscere le abitudini del campione, per poterlo anche rapportare rispetto alle statistiche nazionali, basate su una popolazione sicuramente più eterogenea e statisticamente utile.
Si evince che i consumatori sporadici del campione, il 55%, sono superiori alla sta-tistica nazionale, che vede attestarsi questo dato intorno al 35%, così come la più bassa percentuale dei non consumatori, l'8%, è più basso rispetto a quello nazionale. Mentre il risultato sul consumo abituale di vino risulta in linea con la statistica nazionale88.
88 http://www.inumeridelvino.it/2017/05/il-consumo-di-vino-in-italia-dati-2016-per-regione-e-classi-di-eta.html.

91 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Quesito 4.Ti senti di essere un discreto conoscitore di vini?
A. SiB. No
Le risposte al quarto quesito servono, come quelle al terzo, per identificare il campione e poterlo descrivere, e ancora, per poter meglio contestualizzare le risposte fornite.
Dai responsi risulta che due intervistati su tre si sentono di non avere una conoscen-za abbastanza approfondita del mondo enologico. La risposta è in linea con l’interesse all’approfondimento espresso con le risposte al quesito due.

92Marco Muggia
Quesito 5.Normalmente, quanto sei disposto a spendere per acquistare una bottiglia di vino?
A. Fino a 5 euroB. Da 5 a 10 euroC. Da 10 a 25 euroD. Oltre i 25 euroE. Non acquisto vino
Dalle risposte al quinto quesito, si comprende che la maggior parte dei consumatori effettua acquisti in un range di prezzo compreso fra 10 e 25 euro, intervallo che - avvici-nandosi al limite superiore - rende possibile il recupero dei costi relativamente maggiori per la produzione. E’ comunque importante sottolineare che più di un quarto degli inter-vistati ha confermato che spenderebbe una cifra entro i 10 euro a bottiglia, prezzo che non permette grandi spese per l’affinamento e l’elaborazione dei vini, specialmente in cantine di ridotte dimensioni dove l’assenza di economie di scala comporta costi rilevanti.
L’intenzione di spesa può essere correlata con la capacità di spesa del pubblico, per-tanto questo parametro può essere difficile da modificare operando strategie diverse dal lato dell’offerta. Non si può comunque escludere che una migliore promozione della tipo-logia di prodotti possa essere utile in tal senso. Attraverso la promozione e la pubblicità è possibile modificare il valore percepito del prodotto nel pubblico, e quindi influenzarne l’intenzione di spesa89.
89 http://www.osm1816.it/

93 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Quesito 6.Quanto saresti disposto a spendere in più per acquistare un vino prodotto con questa
tecnica?
A. Non ho interesse a spendere più del solitoB. Potrei spendere il 15% in più del budget normaleC. Potrei spendere il 30% in più del budget normaleD. Potrei spendere il 60% in più del budget normale
Le risposte al sesto quesito sono rilevanti nel contesto di un'analisi del vantaggio eco-nomico: dal sondaggio risulta che un terzo dei consumatori non è disposto ad un maggiore esborso, e ciò può risultare un limite alla diffusione di questi prodotti in questo segmento di consumatori. Queste risposte, comunque, comportano una serie di considerazioni e di problemi che è bene analizzare.
In primo luogo il fatto che ci sia una ridotta predisposizione ad un maggior esborso è un limite qualora l’impresa si trovi a dover programmare degli investimenti, siano essi di breve periodo (differente elaborazione di prodotti durante la singola campagna vitivinico-la), ma soprattutto per quelli di più lungo orizzonte (dotazione in attrezzature).
In secondo luogo è bene sottolineare che, non essendo possibile scaricare sul prezzo finale i maggiori costi (se il mercato non è disposto a pagare prezzi più alti), questi pos-sono essere sostenuti solo andando ad intaccare la quota dei profitti.
Un discorso analogo vale per quasi la metà degli intervistati, i quali sono disposti a

94Marco Muggia
spendere solo il 15% in più del normale per un vino ottenuto in IR: va da sé che tale tec-nica dovrebbe essere indicata in etichetta, o con altro canale, perchè questo avvenga, ed è doveroso ricordare che anche la comunicazione comporta dei costi.
Si ritiene poi utile una riflessione in merito al maggior esborso del 15% cui si dichia-rano disponibili quasi la metà degli intervistati. Il problema che si pone è quello di poter contenere i maggiori costi entro il determinato parametro: in quest'ottica, risultano sicu-ramente utili le economie di scala applicabili in realtà di maggiori dimensioni.

95 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Quesito 7.Secondo te, un prodotto ottenuto con esclusione totale del contatto con l'ossigeno, alla
luce di quanto spiegato con il primo quesito, dà l'idea di essere più salubre rispetto agli altri vini? Per salubre si intende un vino con minor contenuto di conservanti.
A. Non ho una impressione al riguardo B. Lo ritengo più salubreC. Penso non ci siano differenze sotto questo aspettoD. Lo ritengo meno salubre
Tale quesito ha lo scopo di comprendere la percezione che il pubblico ha della salu-brità correlata ai vini prodotti con esclusione dell’ossigeno. E’ probabile che la risposta data da oltre metà della popolazione, che afferma di non abbia impressioni al riguardo, sia correlata alla consapevolezza di non avere conoscenze specifiche in merito ai vini, già espressa con il quarto quesito da due terzi della popolazione.
E’ interessante rilevare che circa il 30% del campione ritenga che un vino prodotto in IR abbia un contenuto in conservanti inferiore agli altri vini, e che nessuno degli intervi-stati ritenga i vini prodotti in IR meno salubri degli altri.
Questi risultati segnalano sostanzialmente una tendenza ad apprezzare e ad attribuire un valore anche in termini salutistici a tali vini. Si tratta di un aspetto rilevante, in quanto può essere una delle leve da utilizzare in ambito comunicativo per accrescere il valore percepito di questi prodotti.

96Marco Muggia
Quesito 8.Se nella etichetta fosse riportata una breve spiegazione di questa tecnica produttiva,
pensi che questo ti spingerebbe ad attribuire un maggior valore a quel vino?
A. Penso di siB. Non penso cambierebbe la mia opinioneC. Non so
Le risposte a questa domanda da parte della popolazione indicano chiaramente che in essa la gran parte degli individui ha interesse ad avere maggiori informazioni al riguardo e coscienza del suo impiego tramite la comunicazione in etichetta. Questo sembra sugge-rire che la comunicazione della vinificazione in IR al consumatore possa risultare utile per incrementare la domanda, eventualmente veicolando anche informazioni più specifiche al consumatore.
Stante la complessità del protocollo e delle sue implicazioni con la chimica del vino, risulta difficile che si possa veicolare una informazione esaustiva al riguardo nell’etichet-ta, ma solo informazioni a carattere generale.

97 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Quesito 9.Saresti disposto ad accettare un maggior contenuto in conservanti (es. solfiti) in un
vino purchè questo abbia un maggior contenuto in aromi e profumi?
A. Si, accetterei un vino con più conservanti purchè sia più profumatoB. No, preferirei un vino più povero in conservanti anche se meno profumato
Le risposte al nono quesito sono indicative della tendenza del mercato alla ricerca di prodotti sì qualitativamente elevati, ma dove diventano prioritarie le caratteristiche che vengono associate alla salubrità come, ad esempio, un ridotto contenuto in solfiti aggiunti.
Il mercato tende a ritenere nocivi per la salute i composti aggiunti al vino. Senza voler disquisire sulla correttezza o meno di questa interpretazione, è importante sottolineare che essa influenza i consumi, e pertanto assume un ruolo importante nell’ambito della comunicazione rivolta al pubblico.

98Marco Muggia
Quesito 10.Attribuisci più valore ad un vino in base a:
A. Brand o etichettaB. Intensità gustativa o aromaticaC. Salubrità ed origine della materia prima (basso contentuo in solfiti, produzione
biologica, ecc...)
Anche in quest'ultimo caso, la quota di pubblico interessata più alla salubrità del pro-dotto, è maggiore rispetto alle altre opzioni, così come è di rilievo la quota di pubblico più interessata alle caratteristiche organolettiche.
È interessante rilevare che solo un quarto del pubblico è interessato al Brand, quindi si può supporre che la maggior parte del pubblico (3 soggetti su 4) non ritenga il Brand stesso una garanzia in termini di salubrità. Questo dato è interessante perché potrebbe indicare che il pubblico è consapevole del fatto che le produzioni di qualità sono ormai diffuse, e non solamente concentrate presso una élite di produttori storici.

99 Analisi dei costi e statistiche di mercato nell’ambito dell’iper-riduzione
Alcuni dati sono importanti e meritano di essere rilevati.Innanzitutto è chiaro che la vinificazione in IR è sostanzialmente sconosciuta a questo
pubblico che tende, in riferimento all’esclusione dell’ossigeno dalla filiera, a considerarla in maniera diversa da quella che la tecnica prevede, e cioè con una riduzione dell’uso di antiossidanti aggiunti.
È risultata anche l'evidenza di un pubblico che nutre interesse per le innovazioni in enologia, che si riflettono in una curiosità riguardo la vinificazione in IR, specie se per-cepite come un aumento della salubrità dei vini. Questo dato è confermato dal desiderio espresso dal pubblico di vederne indicazione in etichetta: si può dedurre che il pubblico abbia consapevolezza di attribuire un maggior valore a questi vini, e che desideri sapere quando viene impiegata. Anche le risposte in merito all’attribuzione di valore, danno ri-sultati importanti: di fatto, sembra che il pubblico sia molto consapevole, e che abbia un sistema di attribuzione del valore ai prodotti basato più sulle qualità intrinseche che sul Brand.
È interessante, poi, che gran parte del pubblico spenda una cifra superiore ai 10 euro per una bottiglia di vino, ma che sempre la maggior parte non sia disposta a spendere di più, o al massimo il 15% in più, per una bottiglia ottenuta in IR.
È quindi apparso un sostanziale interesse del pubblico, anche inesperto, nei confronti del livello salutistico dei vini. Questo dato si mostra in tendenza con le statistiche di mag-gior produzione di uve biologiche cui si assiste negli ultimi anni90.
In sintesi, è possibile affermare che il pubblico intervistato ha dimostrato interesse per la tecnica ed i prodotti realizzati con vinificazione IR e, tuttavia non conoscendola, la prima impressione che ne trae non è coerente con la reale strategia di protezione dalle ossidazioni.
L’ultimo aspetto che preme sottolineare è che, a fronte di una capacità di spesa non indifferente, comunque la propensione ad un maggior esborso per questi vini è molto limitata e sembra non sempre sufficiente a coprire i diversi costi di gestione per la sua implementazione.
Discussione delle statistiche
90 http://www.inumeridelvino.it/

100Marco Muggia
Superfici condotte in regime biologico. Fonte: http://www.inumeridelvino.it/

101
Conclusione

102Marco Muggia

103 Conclusione
Dall’analisi è risultato che il protocollo di vinificazione in IR appare essere molto stringente, e che basa la sua efficacia sull'assoluta correttezza di tutte le fasi operative della trasformazione delle uve in vino, dalla raccolta del grappolo fino alla bottiglia. Si parla di una precisione assoluta, che richiede piena consapevolezza di come e perché si lavora in tale maniera, da parte dell’operatore. Un solo errore durante il processo, può inficiare tutti gli sforzi precedenti, portando all’insorgenza di fenomeni come il pinking, il browning e lo svanito. Un aspetto di rilievo è quello per il quale vini gestiti in ambiente costantemente ridotto, risultano maggiormente degradati da una anche blanda ossigena-zione involontaria ed incontrollata.
Lo scopo che si è perseguito è quello di analizzare quali siano le dinamiche chimiche che regolano le ossidazioni, per meglio comprendere quando siano i mosti ed i vini più sensibili a tale fenomeno, analizzare quali sono le tecniche impiegate per conseguire que-sto risultato, discutere l’opportunità d’uso di questa tecnica nella sua applicazione più estrema.
È stata realizzata un'analisi delle principali variazioni nei costi di produzione in appli-cazione della vinificazione in IR. Infine si è voluto indagare sulla risposta del mercato a questi prodotti, attraverso la proposta ad un pubblico di un questionario per la rilevazione delle sue abitudini, del suo interesse e della sua propensione alla spesa.
Una volta (l'enologo) era semplicemente il tecnico di cantina. Oggi, e sempre più spesso, riveste posizioni direttive per diventare il vero e proprio perno dell'azienda viti-vinicola. [...] E questo perché rispetto alla capacità di inventare un vino cult da oltre 100 euro a bottiglia è sempre più apprezzata quella di concepire e sviluppare un prodotto con un buon rapporto qualità|prezzo capace di produrre numeri e fatturato sui mercati91.
91 Dell'Orefice G., Enologia, passione a corto di posti. Articolo pubblicato il 23 marzo 2011 in Il sole 24 ore. http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-03-23/enologia-passione-corto-posti-064312.sht-ml?uuid

104Marco Muggia
Dall’analisi è risultato quella che appare una sostanziale asimmetria in alcuni aspetti dell’applicazione di questa tecnica, che si manifestano già dalla gestione del vigneto. Per le ragioni già citate, è importante che la gestione del vigneto sia certosina, ove possibile con basso impiego di zolfo (o prodotti a base di zolfo), specialmente nelle ultime fasi della maturazione per il rischio di una residualità nei vini che potrebbe comportare - se as-sociata a un ambiente in costante riduzione - difetti olfattivi generalmente descritti come ridotto. Inoltre, la copertura fitosanitaria contro le malattie che comportano marciumi deve essere assoluta.
La fase di raccolta può essere gestita, se l’obbiettivo è quello di una applicazione pe-dissequa di una esclusione dell’ossigeno da tutta la filiera, solo manualmente ed auspica-bilmente su uve a un livello di maturazione tale da non comportare ammostamenti precoci prima dell’elaborazione nello stabilimento.
La filiera di cantina richiede attrezzature specifiche, che necessitano a loro volta com-petenze specifiche da parte degli operatori: ogni fase, ogni movimentazione della massa, devono avvenire sotto stretti controlli preventivi ed in fase attuativa. Questi controlli includono la verifica costante dell’integrità delle attrezzature e del loro impiego, unita-mente alla periodica verifica analitica ed organolettica dello stato di salute del vino. Tali monitoraggi si rivelano necessari in funzione dei numerosi problemi che possono occor-rere in vini così suscettibili a degradazioni ossidative repentine e squilibrate.
Infatti, vini nei quali i composti più ossidabili si trovano allo stato ridotto, possono andare incontro a degradazioni più gravi qualora esposti all’ossigeno rispetto a vini nei quali durante la filiera queste frazioni più sensibili sono state progressivamente ossidate ed allontanate.
La fase post imbottigliamento richiede che la preparazione del vino sia precisa e fun-zionale alla lunghezza del periodo che, si prevede, sia quello di sosta prima del consumo.
La scelta della chiusura è quasi obbligatoriamente volta all’uso del tappo a vite il qua-le, sebbene presenti numerosi vantaggi tecnici ed economici, commercialmente è poco accettato dal mercato italiano e non solo.
Riassumendo si ottengono vini stilisticamente molto tecnici, cioè che sono per gran parte frutto della tecnologia in uso nella filiera, con spiccate note aromatiche varietali e che hanno preservato una ottima dotazione in tioli, tanto che possono assumere caratteri organolettici simili a quelli del Sauvignon anche quando la cultivar è diversa. E’ inoltre vero che in questa filiera l’uso del legno non è praticamente contemplato, e che gli affi-namenti sur lies sono ridotti drasticamente se non totalmente: questa scelta tecnica com-porta l’ottenimento di vini più poveri in mannoproteine, rinunciando quindi all’effetto organolettico ed alla protezione dalle ossidazioni che esse conferiscono ai vini.
I prodotti sono arricchiti in antiossidanti (acido ascorbico ed anidride solforosa), a livelli anche superiori a quelli di vini ottenuti con vinificazione tradizionale, per garantire una costante protezione dall’ossigeno con le note ricadute sull’aspetto salutistico. Risulta

105 Conclusione
anche che una varietà di sostanze ossidabili permangono in maggiore quantità nel vino, e questo spiega perché una esposizione all’ossigeno veda queste tipologie di vini molto sensibili ai minimi contatti con l’aria.
L’analisi della gestione dei costi ha evidenziato un incremento importante nell’ambito della vinificazione in IR.
Questo fatto è riconducibile a spese di gestione sostanzialmente più alte nella raccolta delle uve, nell’ammortamento delle macchine, nel costo del personale.
I risultati del questionario hanno portato interessanti riscontri, evidenziando che la tec-nica desta interesse, anche se parte di questo può essere dovuto ad un generico aumento dell’interesse verso il vino cui si assiste negli ultimi anni, certificato da un aumento dei consumi.
È comunque rilevante che, alla luce delle risposte ottenute, l’aumento dei costi nella gestione della vinificazione in IR non trovi riscontro in una consistente maggior dispo-nibilità alla spesa da parte del pubblico. Questo suggerisce che raramente sussista una giustificazione economica ad una maggiore spesa per la produzione in tal senso, e i due dati suggeriscono che i maggiori costi sono assorbiti da una riduzione del tasso di profitto.
Le risposte ai quesiti hanno evidenziato anche una convinzione, valida per una larga parte del campione, che la vinificazione in riduzione comporti un minore impiego in an-tiossidanti.
Altre risposte hanno sottolineato come a livello di qualità percepita, sono preferibili vini con minori espressioni aromatiche purché con ridotto uso di conservanti. Da questi responsi si è assunto che il pubblico conosca poco questa tecnica nei mezzi e nei risultati e che ne abbia un'impressione edulcorata - presume che l’ambiente ridotto permetta di ridurre o escludere l’uso di conservanti.
Appare anche evidente che l’aspettativa di una parte del mercato è rivolta a vini con minor contenuto di conservanti, ed è disposto ad accettare una complessità ed intensità aromatica inferiori, almeno nelle intenzioni.
In estrema sintesi si è sottolineato il paradosso di operare in modo da preservare dalle ossidazioni tutta una gamma di composti che, potendo comunque ossidarsi in un secondo momento in quanto permangono nel vino, potranno essere ossidati in un secondo mo-mento in quanto permangano nel vino, potranno essere degradati in una fase nella quale, magari, e più nessun intervento tecnico di correzione è possibile.
Si è voluto quindi discutere la convenienza dell’applicazione di questa tecnica nella sua forma più estrema, suggerendo invece l’applicazione di parte della metodica al processo di vinificazione più tradizionale, come peraltro sembra stiano già facendo i produttori. Questo con lo scopo di mantenere uno stato ridotto del vino nelle fasi in cui esso risulti più suscettibile a reazioni che ne possano pregiudicare il livello qualitativo e modificarne il posizionamento sul mercato, gestendo le ossidazioni nelle altre fasi, nell’ottica della li-mitazione della degradazione dei composti correlati positivamente con la qualità del vino.

106Marco Muggia
La figura dell’enologo è al giorno d’oggi chiamata ad un approccio sempre più ampio, che non si limiti alla sola applicazione delle conoscenze tecniche in enologia e viticoltura.
Soprattutto nelle aziende di ridotte dimensioni, ma anche in quelle di struttura indu-striale, è spesso richiesto che compia delle scelte che si fondano su competenze interdi-sciplinari.
La comprensione delle dinamiche gestionali di un’impresa, di quelle inerenti il merca-to di riferimento, passando per un approccio analitico dei costi, appaiono essere la chiave per una più completa e moderna gestione delle scelte tecnico-enologiche.

107
Bibliografia

108Marco Muggia

109 Bibliografia
Antonelli A., Arfelli G., Masino F., Sartini E., Comparison of traditional and reductive winemaking: influence on some fixed components and sensorial characteristics. Europe-an Food Research and Technology, num. 231, pp. 85 - 91, 2010.
Ardilouze C., Reductive vinification of white and rose wines: the question of must ex-traction. Internet Journal of Viticulture and Enology, num. 13, pp. 1 - 9, 2013.
Baiano A., Varva G., De Gianni A., Terracone C., Viggiani I., Del Nobile M. A., Ef-fects of different vinification technologies on physicochemical properties and antioxidant activity of ‘Falanghina’ and ‘Bombinobianco’ wines. European Food and Research Tech-nology, 2013.
Barisan L., Valutazione economica delle alternative alla vendemmia manuale nel Ve-neto Orientale Luigi Galletto, C.I.R.V.E. Università degli Studi di Padova.
Cheynier F., Trousdale E., Singleton V., Salgues M.R., Characterization of 2-S-gluta-thionyl caftaric acid and its hydrolysis in relation to grape wines. Journal of Agricolture and Food Chemestry, num. 34 (2) March, pp. 217 - 221, 1986.
Clarck A. C., Wilkes E. N., Scollary G. R., Chemistry of copper in white wine: a re-view. Australian Journal of Grape and Wine Research, num. 21, pp. 339 - 350, 2015.
Dal Cin G., Elaborazione e stabilizzazione dei vini. Edizioni Dal Cin S.p.A., Sesto S.G., Milano, 1991.
DeBasquiat M., Biondi Bartolini A., Cavini F., Ossigeno e vino, dal ruolo dell’ossige-no alla tecnica della micro-ossigenazione. Parsec S.r.l, Firenze, 2008.
Devatine A., Chiciuc I., Poupot C., Mietton-Peuchot M., Micro-oxygenation of wine

110Marco Muggia
in presence of dissolved carbon dioxide. Chemical Engineering Science, num. 62, pp. 4579 - 4588, 2007.
Dimitri G., Piva A., Arfelli G., Metodo rapido per la determinazione di acido ascorbi-co. Infowine rivista internet di viticoltura ed enologia, num. 7/2, 2013.
Fracassetti D., New yeast metabolites affecting wine properties. Ph. D research on food science technology and biotechnology, University of Sassari-Oristano, 16 - 18 settembre 2009.
Fregoni M., Viticoltura di qualità. Tecniche nuove editore, Milano, 2012.
Gibson R., Vinificazione in riduzione. Rivista internet tecnica del vino, num. 7, 2004.
Iland P.G., Ewart A., Sitters J., Markides A., Bruer N., Techniques for chemical analy-sis and quality monitoring during winemaking. Patrick Iland Wine Promotions Adelaide, SA, 2000.
Lisjack K., The role of oxygen in new vinification technologies of white and red wines. University of Ljubljana, pp. 13 - 2, 30 - 38, 71 - 85, 2007.
Karbowiak T., Gougeon R. D., Alinc J. B., Brachais L., Debeaufort F., Voilley A., Chassagne D., Wine Oxidation and the Role of Cork. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, num. 50 - 52, 2010.
Margheri G., Versini G., Aspetti tecnologici e biochimici connessi con la produzione di vini bianchi di qualità con basso tenore di anidride solforosa. Vignevini, num. 13 (5), pp. 61 - 66, 1986.
Medici G., Lezioni di estimo. Nicola Zannichelli Editore, Bologna, 1937.
Moutounet M., Mazauric J. P., L’oxygenedissous dans le vins. Revue francaise d’oeno-logie, num. 186, pp. 12 - 15, 2001.
Peng Z., Duncan B., Pocock K. F., Sefton M. A., The effect of ascorbic acid on oxi-dative browning of white wines and model wines. Australian Journal of Grape and Wine Research, num. 4, pp. 127 - 135, 1998.
Petroziello M., Il controllo dell’ossigeno nel vino. L’Informatore agrario, num. 40,

111 Bibliografia
2004.
Piva A., Arfelli G., Mengia R., Metodo rapido per la determinazione di acido ascorbi-co. Infowine rivista internet di viticoltura ed enologia, num. 7/2, 2013.
Proestos C., Bakogiannis A., Psarianos C., Koutinas A., Kanellaki M., Komaitis M., High performance liquid chromatography analysis of phenolic substances in Greek wi-nes. Food Control, num. 16, pp. 319 - 323, 2005.
Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A., Trattato di Enologia I. Edagricole, Bologna, 2003.
Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A., Trattato di Enologia II. Edagricole, Bologna, 2003.
Roure F., Kahn N., Morge C., Prodotti derivati dai lieviti e potenziale di ossidoriduzio-ne dei vini. Infowine rivista internet di viticoltura ed enologia, num. 10/1, 2006.
Vidal J.C., Moutonet M., Muller-Spath H., Vivas N., Glories Y., La rimozione dell’os-sigeno disciolto nei vini: studio sull’effetto dei trattamenti di cantina nella dissoluzione dell’ossigeno e applicazione della tecnologia a membrana per prevenire l’ossidazione. Tebaldi innovatori per passioni, rev. 2, 2010.
Rankine B. C., Nature, origin and prevention of hydrogen sulphide aroma in wines. Journal of Science Food and Agricolture, num. 14, pp. 79 - 91, 1963.
Viviers M. Z., Smith M. E., Wilkes E., Smith P., Effects of five metals on the evolution of hydrogen sulphide, metanethiol, and dimethyl sulphide during anaerobic storage of Chardonnay and Shiraz wines. Journal of Agricolture and Food Chemistry, num. 61 - 50, pp. 12385 - 12396, 2013.
Gestione dell’Ossigeno.http://www.infowine.com/docs/Newsletter248_Def.htm#top. Visitato il 10/02/2018.
La produzione di vino in Italia nel 2016, dati finali ISTAT.http://www.inumeridelvino.it/2017/06/la-produzione-di-vino-in-italia-nel-2016-da-
ti-finali-istat.html. Visitato il 24/01/2018.
Rapporto mensile ABI - Giugno 2017 (principali evidenze).

112Marco Muggia
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/ABI%20Monthly%20outlook%20giugno%20(20.6.17).pdf. Visitato il 10/02/2018.
Fondo di rotazione regionale in agricoltura.http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/
FOGLIA1/. Visitato il 16/02/2018.
I numeri della viticoltura biologica in Italia – aggiornamento 2015.http://www.inumeridelvino.it/2017/02/i-numeri-della-viticoltura-biologica-in-ita-
lia-aggiornamento-2015.html. Visitato il 15/02/2018.
ONAV news.http://www.onavnews.it/auguri-e-discorso-di-fine-danno-da-parte-del-presidente-na-
zionale-vito-intini/. Visitato il 05/02/2018.
Aumentare il valore percepito.http://www.osm1816.it/aumentare-il-valore-percepito/. Visitato il 31/01/2018.
Begalli D., Marketing del vino, Università degli Studi di Padova e Verona. http://www.dbt.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid752793.PDF. Visita-
to il 15/01/2018.

113
A mia madre, a mio padre, ai miei cari nonni

114Marco Muggia

115
Sento di dover ringraziare molte persone per questo lavoro e per mio il percorso uni-versitario.
La mia gratitudine va al professor Roberto Zironi, per l'aiuto e lo spirito critico. Al dottor Piergiorgio Comuzzo, per la grande disponibilità e professionalità. Senza di loro la redazione e la qualità di questa tesi non sarebbero state possibili.
A mia madre, per avermi sempre sostenuto.Ai miei cari nonni ed alla mia famiglia, per avermi sempre spronato negli studi.A Veronica, per l'inestimabile aiuto e per esserci.Ai miei amici, per il loro esempio e perchè su di loro ho sempre potuto contare.
Ringrazio la Sign.ra Bortolotto Sarcinelli, per la grande fiducia concessami in questi anni, e al Sign. Del Medico Emilio, per avermi insegnato molto, non solo riguardo il vino.
Senza di loro il mio percorso ed il risultato sarebbero stati diversi, quindi, a loro, ri-volgo la mia gratitudine.