By: Dina Discepolo Google Classroom Project- Animal Habitats.
Se qualcuno vuol venire dietro a me Povo 2014 libretto · passione e croce nella vita di Gesù e...
Transcript of Se qualcuno vuol venire dietro a me Povo 2014 libretto · passione e croce nella vita di Gesù e...
Fr. Francesco Patton ofm
Se qualcuno vuol venire dietro a me…
La vita cristiana alla luce della passione,
morte e risurrezione di Gesù
Esercizi spirituali parrocchiali Povo, 9-14 marzo 2014
Sommario
Presentazione p. 4 1. Con la tua santa croce hai redento il mondo: passione e croce nella vita di Gesù e del discepolo p. 5 2. Dal sentirsi abbandonati all’abbandonarsi con fiducia “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” p. 18 3. L’esperienza del perdono apre le porte della vita piena “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” “In verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso” p. 30 4. Accogliere Maria per sperimentare la maternità della Chiesa “Donna, ecco tuo figlio” “Ecco la tua madre” p. 43 5. Dalla sete al dono dell’acqua viva “Ho sete” “È compiuto” p. 55 6. Il cammino di Emmaus, dalla fuga alla testimonianza
“Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?” p. 68
Presentazione
Nelle pagine dei vangeli troviamo una rilettura di fede della vita, delle parole e della missione di Gesù, che ci porta a scoprire attraverso l’uomo di Nazareth (Gesù), l’inviato di Dio per la nostra salvezza (il Cristo), il Figlio stesso di Dio che vive totalmente la nostra esistenza umana. Nelle pagine dei vangeli troviamo anche una rilettura della nostra stessa vita, a partire dalla relazione che instauriamo con Gesù; e siamo invitati a lasciarci coinvolgere sempre più in questa relazione che prende avvio nello scoprire la bellezza delle sue parole e dei suoi gesti per portarci fino al vertice di questo cammino, che si compie nel mistero pasquale, mistero di morte e di risurrezione, di vita donata e ritrovata. Confrontarci col mistero della passione significa arrivare al cuore della vita di Gesù, ma anche al cuore della nostra vita cristiana. È nel mistero della Pasqua che nasciamo come creature nuove ed è nel mistero della Pasqua che nasciamo come corpo ecclesiale del Risorto. La proposta di questi esercizi spirituali parrocchiali vuol essere perciò un’occasione che ci viene offerta per andare al cuore della nostra fede e lasciarci condurre dallo stesso Gesù a fare una lettura pasquale, caratterizzata dalla speranza, della nostra vita, del tempo in cui ci troviamo, della comunità ecclesiale di cui facciamo parte.
1. Con la tua santa croce hai redento il mondo: passione e croce nella vita di Gesù e del discepolo
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen.
Canto ed esposizione del SS. Sacramento
Invitatorio
T: Ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. (FF 111)
S. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo. T. O adoramus te, Christe. S. Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo
che per noi hai dato il tuo corpo. R. S. Agnello irreprensibile e senza macchia,
che hai sparso il tuo sangue in remissione dei nostri peccati. R.
S. Agnello che togli il peccato del mondo, nostra pasqua immolata. R.
S. Agnello condotto al macello che hai portato i nostri peccati sul tuo corpo. R.
S. Agnello nel cui santissimo sangue è stata sigillata la nuova ed eterna alleanza. R.
Orazione O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio...
Canto al Vangelo
Dal vangelo secondo Marco (15,1-38) Veramente quest’uomo era figlio di Dio
1Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. 2Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 3I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. 4Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». 5Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. 6A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. 7Un tale, chiamato Barabba, si
trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. 8La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. 9Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». 10Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. 11Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. 12Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». 13Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 14Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». 15Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 16Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. 17Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 18Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 19E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 20Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 21Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. 22Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», 23e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. 24Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. 25Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 26La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». 27Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. [28]
29Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 30salva te stesso scendendo dalla croce!». 31Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! 32Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. 33Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 34Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 35Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 36Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». 37Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 38Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. 39Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». PdS
Proposta di riflessione Con la tua santa croce hai redento il mondo:
passione e croce nella vita di Gesù e del discepolo 1. Il nucleo centrale dell’annuncio cristiano Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace! Ci troviamo di nuovo insieme, anche quest’anno, per vivere l’esperienza degli esercizi spirituali parrocchiali, un’esperienza di ascolto della Parola di Dio, di adorazione del nostro Signore Gesù Cristo presente in mezzo a noi col suo corpo eucaristico, di intensa riflessione, preghiera e condivisione comunitaria. Il tema generale che ci accompagnerà nel corso di questa settimana è il nucleo centrale nell’annuncio del vangelo, vale a dire il tema della passione, morte e risurrezione di Gesù.
Negli Atti degli Apostoli, sulla sola bocca di Pietro, questo annuncio centrale ricorre per ben cinque volte (At 2; At 3; at 4; At 5; At 10). Il giorno di Pentecoste (At 2) per la prima volta Pietro annuncia sulla piazza di Gerusalemme che Gesù ha sofferto la passione, è morto ed è risuscitato; e dopo questo annuncio Pietro invita al pentimento, a ricevere il battesimo e il dono dello Spirito per iniziare una nuova vita. Nella sua ultima grande predicazione, a casa del centurione pagano Cornelio (At 10), Pietro riprenderà per la quinta volta questo stesso annuncio. Ma non è un’esclusiva dell’apostolo Pietro, questo annuncio sarà lo stesso che viene fatto dal diacono Stefano, da Paolo e Barnaba, da Filippo, da ogni evangelizzatore della prima generazione cristiana e di quelle successive. È dall’aver accolto questo annuncio, grazie al battesimo e al dono dello Spirito, che noi nasciamo come cristiani, in senso profondamente personale e in senso ecclesiale comunitario. 2. Gli evangelisti e le quattro chiavi di lettura della passione In questi giorni noi ci fermeremo in modo particolare sui racconti della passione così come ci sono stati tramandati dai quattro evangelisti e, all’interno di questi racconti, mediteremo sulle sette parole che Gesù pronuncia mentre si trova appeso al legno della croce. Concluderemo il nostro percorso con un vangelo pasquale, il racconto di Emmaus, all’interno del quale Gesù stesso ci aiuta a cogliere il senso pasquale della sua e della nostra vita nella quale passione e morte si integrano nella risurrezione. Quando, vangeli alla mano, riflettiamo sulla passione di Gesù, ci vengono offerte da Marco, Matteo, Luca e Giovanni quattro distinte chiavi di lettura che avremo poi modo di riprendere anche nei prossimi giorni.
- Marco è chiamato il vangelo del catecumeno, cioè di chi chiede di entrare in relazione con Gesù e far parte del suo corpo che è la Chiesa. È un vangelo che ci conduce passo passo, attraverso l’umanità di Gesù di Nazareth, a scoprire in Lui l’inviato ultimo di Dio, cioè il Cristo, fino a farcelo riconoscere come Figlio di Dio proprio sulla croce nel momento in cui muore in un modo tutto singolare. Solo se arriviamo a seguirlo fin sotto la croce possiamo riconoscere e professare in modo autentico e non ambiguo: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio”. È la professione di fede del centurione, è la nostra professione di fede, che matura quando contempliamo Gesù Cristo Crocifisso e in lui riconosciamo il Figlio di Dio che ci ha amato e ha dato la vita per ciascuno di noi.
- Matteo è invece un vangelo scritto originariamente per
coloro che dal giudaismo erano passati al cristianesimo, e proprio per questo, accentua e sottolinea il tema del “compimento delle Scritture” e l’adempiersi della “giustizia di Dio”, cioè del suo progetto di salvezza. Questo compimento per Matteo si attua nella Pasqua di Gesù e perciò tutto il racconto della passione è narrato come compimento delle Scritture (dei Salmi, di Isaia, di Osea, ecc.) e la giustizia di Dio si manifesta come volontà salvifica per noi.
- Luca ci offre invece un vangelo missionario, aperto a
tutti i popoli, un vangelo in cui si sottolinea la bontà di Gesù che manifesta la misericordia del Padre, un vangelo in cui ha tanto spazio la preghiera. Anche nell’ora della passione Luca ci presenta Gesù come modello di testimonianza fino al martirio (a lui si ispirerà Stefano il primo martire), ma ce lo presenta
anche come modello di perdono e di preghiera, fino all’ultima ora della sua vita.
- Infine Giovanni, l’evangelista della maturità, colui
che ci parla del Verbo eterno che si è fatto carne per la salvezza del mondo, ci dice che nella passione e morte di Gesù c’è il compimento delle Scritture ma anche l’ora della gloria: nel più profondo abbassamento, che manifesta un amore “fino alla fine”, si manifesta la luminosità dell’amore che vince le tenebre del male, della morte e del peccato. Inoltre Giovanni ci descrive la passione come un travaglio, una gestazione, che nell’ora della pasqua genera l’uomo nuovo e la Chiesa stessa.
3. La croce: scandalo e stoltezza Dentro i racconti della passione siamo invitati a confrontarci poi con la realtà della croce e con il suo significato profondo. Essa, ci ricorderà san Paolo, “è scandalo per i Giudei e stoltezza per i greci” (1Cor 1,23). Ma cosa significa la croce? La più antica raffigurazione del Crocifisso è un graffito databile tra la fine del I e il II secolo, ritrovato a Roma sul colle Palatino, raffigurante uno scolaro in ginocchio davanti a un crocifisso con corpo umano e testa d’asino. Il graffito è accompagnato da una scritta ironica: “Alessameno adora il suo Dio” ed è opera di uno scolaro pagano che voleva deridere un compagno di classe cristiano. Ci possiamo chiedere perciò: cos’era la croce al tempo in cui Gesù fu crocifisso?
- Per gli ebrei la croce era la morte dei maledetti, cioè di coloro che erano considerati irreparabilmente lontani da Dio ed esclusi dalla salvezza: “Come sta scritto:
maledetto chi pende dal legno” dice san Paolo nella lettera ai Galati (Gal 3,13) citando Dt 21,23.
- Per greci e romani era la morte dei criminali socialmente pericolosi, da eliminare in modo esemplare, per scoraggiare altri (è il caso dei due crocifissi insieme con Gesù che Luca qualifica come “malfattori”).
- Infine, soprattutto nel mondo romano era la morte riservata agli schiavi, una categoria che veniva equiparata ai beni materiali anziché alle persone.
Perciò la morte in croce è contemporaneamente terribile e dolorosa da un punto di vista fisico, ignominiosa da un punto di vista sociale, scandalosa da un punto di vista morale e religioso. La morte in croce è sconvolgente e scandalosa per tutto ciò che manifesta e significa. E, per un contemporaneo di Gesù che diventa cristiano, accettare il Crocifisso significa accettare che colui che viene riconosciuto e creduto il Figlio di Dio incarnato va a morire della morte del maledetto, del criminale e dello schiavo; si mette al posto di colui che è irreparabilmente lontano da Dio, socialmente irrecuperabile, privo di dignità personale; si fa solidale con il maledetto, il criminale, lo schiavo nel senso che si fa carico della loro vita, della loro persona, del loro destino. Pochi giorni fa, il mercoledì delle ceneri, abbiamo sentito san Paolo proclamare ai Corinti: “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché noi diventassimo giustizia di Dio” (2Cor 5,21). E nella lettera ai Romani leggiamo: “Dio dimostra il suo amore per noi, perché mentre eravamo ancora peccatori Cristo morì per gli empi, nel tempo stabilito” (Rm 5,8). La morte in croce di Gesù è perciò inclusiva di ogni lontananza da Dio, di ogni crimine, di ogni deprivazione di dignità! In altri termini, attraverso la morte in croce del suo
Figlio, Dio stesso ci dice: nessuno è più irrecuperabile! Nessuno è talmente lontano da me che io non possa avvicinarmi a lui, identificarmi con lui, mettermi perfino al suo posto! 4. Fare memoria della croce per seguire il Crocifisso Ora la croce è la realtà verso la quale Gesù è andato consapevolmente e liberamente e la realtà che chiede anche a noi di abbracciare per poterlo seguire: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). In questi giorni di esercizi spirituali vogliamo metterci davanti al Cristo crocifisso e in modo particolare davanti alle sue parole per contemplare anzitutto quello che lui ha fatto per noi, ma anche per imparare da Lui cosa può voler dire seguirlo prendendo ogni giorno la nostra croce. Per metterci con frutto di fronte alla passione e alla croce di Gesù occorre che facciamo nostra la prospettiva della liturgia, che è la prospettiva di chi celebra dentro una logica biblica di memoriale, cioè del fare memoria in modo da rivivere la realtà e percepirne gli effetti. Vale a dire che ci mettiamo di fronte alla passione e alla croce non da spettatori, men che meno da intellettuali da salotto che disquisiscono in maniera oziosa, ma ci mettiamo davanti alla passione e alla croce da persone che sono partecipi di questo dramma e di questo mistero:
- facciamo memoria di questo dramma e di questo mistero rivivendolo, non è qualcosa lontano da noi ma è qualcosa di contemporaneo alla nostra vita, alla nostra storia, alla nostra comunità.
- Facciamo memoria di questo dramma e di questo mistero con un atteggiamento contemplativo, vale a dire l’atteggiamento di chi abbassa le difese e i
pregiudizi e si lascia raggiungere da ciò che sta contemplando, ci lasciamo raggiungere dal dramma della passione, ci lasciamo raggiungere dal mistero della croce.
- Facciamo memoria di questo dramma e di questo mistero lasciandoci coinvolgere in modo personale, rendendoci conto che siamo noi i personaggi di cui narrano i vangeli e che nell’ora della passione ruotano attorno a Gesù, come ci ha suggerito papa Francesco la scorsa estate, mentre celebrava la Via Crucis coi giovani a Rio de Janeiro: “tanti volti hanno accompagnato Gesù nel suo cammino verso il Calvario: Pilato, il Cireneo, Maria, le donne… Io oggi ti chiedo: Tu come chi di loro vuoi essere? Vuoi essere come Pilato che non ha il coraggio di andare controcorrente per salvare la vita di Gesù e se ne lava le mani? Dimmi: sei uno di quelli che si lavano le mani, che fa il finto tonto e guarda dall'altra parte? O sei come il Cireneo, che aiuta Gesù a portare quel legno pesante, come Maria e le altre donne, che non hanno paura di accompagnare Gesù fino alla fine, con amore, con tenerezza. E tu, come chi di questi vuoi essere? Come Pilato, come il Cireneo, come Maria? Gesù ti sta guardando adesso e ti dice: mi vuoi aiutare a portare la Croce? Che cosa Gli rispondi?”.
- Facciamo memoria di questo dramma e di questo mistero adorando, mettendoci cioè nell’atteggiamento di chi sceglie liberamente e per amore di fare propria la volontà del Padre, come ha fatto Gesù nell’ora della passione e della croce, sapendo che la volontà del Padre non è mai contro di noi ma è per il bene nostro, per il bene dell’intera umanità, perfino per il bene di chi lo rifiuta, come proprio la croce ci ricorda.
- Facciamo memoria di questo dramma e di questo mistero sperimentando i benefici della passione e della croce, sperimentandoli in termini profondamente personali, come ci suggerisce san Paolo nella lettera ai Galati quando grida: “Il Figlio di Dio mi ha amato, e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20).
5. Indicazioni per il tempo di adorazione silenziosa Entriamo nel tempo del silenzio e dell’adorazione seguendo le indicazioni che troviamo sulla scheda. Come gli anni scorsi abbiamo la possibilità di scrivere dei brevi pensieri o delle brevi preghiere sui foglietti che sono a nostra disposizione e che poi raccoglieremo per trasformare tutto in preghiera e mettere tutto nelle mani del Signore. In questi giorni possiamo leggere personalmente, a casa, i racconti della passione che ci hanno lasciato i quattro evangelisti, possiamo leggere anche la prima predica di san Pietro, che si trova in At 2. Lo Spirito del Signore ci guidi in questa mezzora di silenzio ad entrare in intimità col Cristo presente nell’Eucaristia, è il Cristo della passione e della croce, ma è anche il Cristo risorto e glorioso, che è con noi fino alla fine del mondo. Silenzio per l’adorazione e la meditazione personale (30’) 1. Rileggi lentamente la Parola di Dio e memorizza un versetto. 2. Fermati sul brano del vangelo secondo Marco e contempla
Gesù nell’ora della sua passione e morte. Lasciati che le parole del Vangelo ti raggiungano con tutta la loro forza d’urto e la loro capacità di interpellarti personalmente. Nei prossimi giorni prenditi il tempo per leggere a casa i quattro racconti della passione (Mt, Mc, Lc e Gv).
3. Rifletti sulla tua vita: � Quali sentimenti suscita dentro di te la riflessione sul
mistero della Passione e della morte in croce di Gesù? Come ti senti davanti al Crocifisso?
� Prova a richiamare alla memoria i personaggi che ruotano attorno a Gesù nell’ora della passione (quelli richiamati nei 4 vangeli: Pietro, Giuda, Giovanni, Maria, le donne, Pilato, il Cireneo, i soldati, il Centurione, i capi del popolo, i malfattori...): in quali loro gesti, atteggiamenti e parole ti ritrovi e identifichi?
� Quale appello ti rivolge Gesù nell’ora della sua passione e morte in croce?
4. Colloquia interiormente col Signore, presente nell’Eucaristia: è Lui nell’atto di donarsi ed è Lui ormai per sempre vivo e glorioso, affidagli la tua persona e la tua vita, chiedigli il dono di riuscire a maturare una fede capace di seguirlo fin sul Golgota, fino alla condivisione della passione, del dono di sé fatto per amore.
5. Esprimi un proposito di impegno concreto per crescere nella
capacità di “seguire Gesù portando ogni giorno la tua stessa croce”.
Canto meditativo (durante il canto vengono raccolte le preghiere) Invocazioni e preghiere - Padre nostro Orazione Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
Tantum Ergo Preghiamo Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. R. Amen. Benedizione eucaristica Litania Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo Cuore. Benedetto il suo preziosissimo Sangue. Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Canto finale
2. Dal sentirsi abbandonati
all’abbandonarsi con fiducia. “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”
“Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”.
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen.
Canto ed esposizione del SS. Sacramento
Invitatorio
T: Ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce
hai redento il mondo. (FF 111) S. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo. T. O adoramus te Christe. S. Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo
che per noi hai dato il tuo corpo. R. S. Agnello irreprensibile e senza macchia,
che hai sparso il tuo sangue in remissione dei nostri peccati. R.
S. Agnello che togli il peccato del mondo, nostra pasqua immolata. R.
S. Agnello condotto al macello che hai portato i nostri peccati sul tuo corpo. R.
S. Agnello nel cui santissimo sangue è stata sigillata la nuova ed eterna alleanza. R.
Orazione Guarda Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa' che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio... Canto al Vangelo Dal vangelo secondo Matteo (27,45-50) Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
45A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 46Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 47Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». 48E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. 49Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». 50Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
Dal vangelo secondo Luca (23,44-46) “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”. 44Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. 46Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. PdS
Proposta di riflessione Dal sentirsi abbandonati all’abbandonarsi con fiducia:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 1. Le sette parole di Gesù in croce Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace! Le parole sulle quali ci fermiamo a meditare e ad adorare questa sera sono le parole riportate in modo quasi uguale dall’evangelista Matteo (27,46) e dall’evangelista Marco (15,34): “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” e quelle riportate da san Luca (23,46) come le ultime parole di Gesù in croce: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Gli autori che cercano di dare un ordine cronologico alle sette parole di Gesù in croce lo fanno seguendo uno schema diventato popolare nella predicazione e nella musica (Mercadante; Haydn; Perosi): 1) “Padre, perdona loro…” (Lc 23,34) 2) “In verità ti dico, oggi con me…” (Lc 23,43) 3) “Donna, ecco tuo figlio…” (Gv 19,26-27) 4) “Dio mio, Dio mio,…” (Mc 15,34 e Mt 27,46) 5) “Ho sete” (Gv 19,28) 6) “Tutto è compiuto” (Gv 19,30) 7) “Padre nelle tue mani…” (Lc 23,46)
Nelle nostre meditazioni di questa settimana noi non seguiremo questo schema, ma cominceremo a meditare sulle parole riportate da Mt e Mc che sono quelle della tradizione più antica e le leggeremo insieme alla parole conclusive di Gesù tramandateci da Lc, perché queste due frasi apparentemente così diverse sono in realtà due facce della stessa medaglia. Entrambe queste parole contengono un riferimento forte ai Salmi, sono rispettivamente l’inizio del Salmo 22 (21)1 e un versetto del salmo 31 (30). Ci mettono di fronte al modo in cui Gesù ha affrontato la sua passione e morte. E dal modo in cui Gesù ha affrontato la sua passione e morte provengono a noi:
- un beneficio da accogliere, - un significato per la nostra vita, una possibile chiave di
lettura della vita, - un modello da assumere.
2. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Nell’interpretazione di questa parola incontriamo due estremi opposti:
- per i razionalisti (del 1700 e delle epoche posteriori), questo è il grido disperato di Gesù che si rende conto del fallimento della sua vita e della sua missione;
- per quelli che fanno fatica a cogliere questa parola in tutta la sua durezza e in tutto il suo dramma si tratta semplicemente di una citazione del Salmo 22, che si concluderà con la certezza dell’intervento divino.
Dietro queste due posizioni ci stanno due difficoltà opposte:
- i razionalisti non credono che Gesù è vero Dio e per questo il suo morire è solo la fine disperata di un messia illuso e fallito;
1 Dove vengono riportati i numeri dei Salmi il primo numero è quello della numerazione della Vulgata e della liturgia, il secondo è quello della numerazione ebraica.
- per quelli che fanno fatica ad accettare queste parole in tutta la loro durezza la difficoltà è inversa, nel senso che credono fermamente che Gesù è vero Dio ma fanno fatica a riconoscere che è anche vero uomo, e che come tale ha vissuto in modo profondo e autentico anche i risvolti psicologici e morali del morire umano e del morire in croce.
La chiave di lettura offerta dai vangeli è piuttosto quella che ci dice che Gesù ha vissuto nella pienezza della sua umanità il dramma della passione, della morte e della croce: nel Getsemani Gesù prega per ben tre volte, cioè fino allo sfinimento, il Padre: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» (Mt 26,39). E l’autore della Lettera agli Ebrei (5,7) ci dice che Gesù «nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà», fu esaudito cioè per il suo abbandono filiale fiducioso. Quando si è incarnato, il Figlio di Dio non ha chiesto sconti sulla nostra condizione umana e per questo ha accettato anche i lati più oscuri della nostra umanità, come la sofferenza e la morte, e ha scelto di farsi carico del lato più oscuro di tutti, quello del nostro peccato, cioè del nostro rifiuto di Dio, per riconciliarci con Dio. Avendo voluto farsi carico della morte dei crocifissi, con tutto quel che significa, non ha chiesto sconti sul dramma del morire. La scelta delle parole del Salmo 22: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”, colte da Mt e Mc sulle labbra di Gesù morente in croce aprono realmente uno spiraglio sul dramma oggettivo e soggettivo della sua morte in croce. Noi non potremmo sentirlo vicino e solidale con la nostra sorte se la sua fosse una semplice recita, una sofferenza e una morte
“apparente”. Al tempo stesso la scelta del Salmo 22, che ha un inizio drammatico, ma anche uno sviluppo pieno di fiducia e di speranza e un tono sempre caratterizzato da un profondo rapporto di amore (“Dio mio, Dio mio”) ci fa comprendere che Gesù ha vissuto questo dramma personale nella più profonda fiducia in Dio. Quel Dio che in tutte le sue preghiere che ci vengono riportate dai vangeli, Gesù sempre chiama “Abbà” cioè “papà”, ed è una fiducia coltivata proprio alla scuola dei Salmi. Le prime comunità cristiane, sostenute dalle testimonianze degli Apostoli che hanno preso forma nei Vangeli, hanno riletto e meditato la morte di Gesù proprio servendosi di alcuni Salmi (Sal 22; Sal 31; Sal 69) e di alcuni passi tratti dal profeta Isaia (es. IV carme del servo di Jahve Is 52,13-53,12) e da altri Scritti dell’Antico Testamento. Se leggiamo anche solo alcuni versetti di questo Salmo ce ne rendiamo subito conto.
- C’è l’apertura del Salmo (vv. 2-3) col grido accorato di Gesù: 2 «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza»: sono le parole del mio lamento. 3 Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo.
- Poi il salmista descrive i motivi per cui Dio dovrebbe
intervenire e descrive la propria situazione (vv. 4-11): 7 Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 8 Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: 9 «Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se è suo amico».
- Nella supplica invoca con fiducia (v. 12):
12 Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
- Poi di nuovo la descrizione della situazione con parole
che ritorneranno nei racconti della passione (vv. 13-19): 16 È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. 17 Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi; hanno forato le mie mani e i miei piedi, 18 posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano: 19 si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte.
- Segue una seconda supplica fiduciosa (vv. 20-22):
20 Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto.
- La parte conclusiva del Salmo (vv. 23-32) è poi una
lunga preghiera di ringraziamento anticipato, che intravede un futuro di vita, di risurrezione, di annuncio: 23 Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. 30 A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per lui, 31 lo servirà la mia discendenza.
Se noi rileggiamo la preghiera di Gesù in croce alla luce del Salmo 22 potremmo dire che Gesù ha vissuto fino in fondo l’angoscia e il senso di abbandono della morte e della morte in croce e per questo si pone accanto non solo al dramma di chi muore solo, angosciato e abbandonato, ma anche al dramma di chi vive solo, angosciato e abbandonato. L’esperienza che Gesù fa nel morire in croce è una vera e propria discesa negli inferi della solitudine, dell’angoscia, della depressione, del vuoto esistenziale, della mortalità, della lontananza da Dio. Proviamo a pensare a quante persone conosciamo anche noi, oggi, che vivono il dramma di sentirsi abbandonate da Dio per una situazione di crisi, per una malattia, per la perdita di una persona cara, perché attraversano un momento di smarrimento o di depressione… Gesù vive fino in fondo tutto questo, ma vive fino in fondo anche il senso di fiducia e di abbandono personale nelle mani di un Dio che è “Abbà” cioè “papà”. Questo secondo aspetto lo cogliamo soprattutto attraverso le parole che ci ha narrato l’evangelista Luca, parole che rendono esplicito il senso globale della preghiera di Gesù sulla croce. 3. “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Questa preghiera è una citazione adattata del Salmo 31,6 nella versione greca dei LXX, che era la traduzione usata normalmente dagli ebrei di lingua greca. Nel testo del Salmo troviamo la frase: “Nelle tue mani, Signore, consegnerò il mio spirito”, mentre Gesù prega: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Gesù perciò fa proprie le parole del Salmo 31,6 ma le attualizza e le prega relazionandosi con Dio nel modo in cui, stando ai quattro vangeli, sempre si è relazionato con Dio, cioè chiamandolo “Padre”, nella sua lingua familiare “Abbà”. Questa espressione, sulle labbra e nell’insegnamento di Gesù, è sempre associata a un senso di profonda fiducia in Dio.
Ecco la preghiera fiduciosa di Gesù: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”, che significa: “Padre, metto con fiducia la mia vita nelle tue mani”. Nell’atto del morire, potremmo dire, Gesù ci manifesta come è vissuto e qual è il senso del vivere: vivere è consegnare la propria vita e la propria persona nelle mani del Padre, con profonda fiducia. Viviamo e moriamo consapevoli che la nostra vita è nelle mani del Padre e solo questo nostro essere continuamente nelle mani del Padre è garanzia di vita, fonte di fiducia e di speranza, sorgente del dono di sé e di costante apertura. Quante volte ha insistito Gesù nel dirci che è importante fidarci del Padre, pensiamo solo al discorso della montagna (Mt 5-7), quanto insiste nel dirci che ci possiamo fidare, che il Padre si prende cura di noi più che dei gigli del campo e degli uccelli del cielo! San Paolo esprime questa idea in un passo della Lettera ai Romani (14,8) quando dice: “sia che viviamo, sia che moriamo siamo dunque del Signore”. Ed è significativo che davanti al modo di morire di Gesù sia Marco e Matteo, sia Luca, riportino la testimonianza del Centurione romano, di un pagano, che riferisce Marco “vistolo spirare in quel modo disse: Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”. Luca (23,48) a sua volta sottolinea che coloro che hanno assistito da lontano alla crocifissione di Gesù se ne tornano a casa “percuotendosi il petto”, sono stati raggiunti dalla testimonianza di un modo di morire paradossale: la morte più terribile e infame affrontata con il più profondo senso di fiducia e abbandono. Il modo di morire di Gesù colpisce proprio perché è un modo di morire che assume il dramma del nostro morire umano e lo vive divinamente. Il modo di morire di Gesù non è quello degli eroi che sfidano i loro uccisori e la morte stessa ma è il modo di morire del credente. Così col suo modo di morire Gesù ci è
totalmente accanto nel far suo il nostro morire e ci apre alla speranza di un morire e di un vivere nelle mani di un Dio che è “Abbà”, cioè Padre. San Paolo arriverà a dire, meditando su questo fatto, che il mistero della croce è apparentemente stoltezza e debolezza in realtà è sapienza e potenza di Dio che trasfigura anche tutta la debolezza del nostro vivere e del nostro essere uomini. Nella lettera ai Galati esprimerà l’esperienza dell’incontro col crocifisso come esperienza personale di sentirsi amato: “Il Figlio di Dio mi ha amato, e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). E nella Lettera ai Romani ricorderà che da questo amore niente e nessuno ci potrà mai separare (Rm 8,35). Il primo martire cristiano, Stefano, farà proprio l’atteggiamento di Gesù e nel momento della morte si affiderà a Gesù come Gesù si è affidato al Padre: “Gesù, accogli il mio spirito” (At 7,59), sarà questa l’ultima preghiera di Stefano. Di fronte alla morte di Gesù e meditando la sua duplice preghiera noi impariamo però non soltanto cosa vuol dire accettare la morte, ma ancor di più cosa vuol dire vivere con fiducia. Come Lui si è fatto solidale con noi, così ha trasmesso a noi, nel battesimo e per il dono del suo Spirito Santo questo suo modo di vivere la nostra debolezza umana con la fiducia di essere diventati figli dello stesso Padre. Non a caso ogni sera, a compieta – che è la preghiera conclusiva della giornata di ogni cristiano e della Chiesa – anche noi preghiamo con le parole del Salmo 31: “Signore, nelle tue mani, affido il mio spirito”. Così ogni nostra giornata e ogni giorno della Chiesa si conclude con un atto di abbandono pieno e fiducioso nelle mani del Signore della vita.
4. Indicazioni per il tempo di adorazione silenziosa Nel silenzio dell’adorazione possiamo seguire le indicazioni che troviamo sul foglietto, possiamo mettere nelle mani del Padre quelle situazioni nostre e di altre persone per le quali ci viene da gridare: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” e possiamo mettere nelle mani del Padre, con fiducia, tutta la nostra vita e la vita di tante altre persone che conosciamo e dire semplicemente: “Padre, nelle tue mani consegno tutta la mia vita”. Silenzio per l’adorazione e la meditazione personale (30’) 1. Rileggi lentamente la Parola di Dio e memorizza un versetto. 2. Fermati sui due brevi brani del vangelo e contempla Gesù
nell’ora della sua morte. Lascia risuonare dentro di te il grido: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” ma anche l’espressione fiduciosa: “Padre nelle tue mani, consegno il mio spirito”.
3. Rifletti sulla tua vita e alla luce della preghiera di Gesù:
� prova a mettere nelle mani del Padre i momenti di solitudine, sfiducia, scoraggiamento, depressione, disperazione che hai sperimentato o sperimenti;
� affida al Padre le situazioni di abbandono, solitudine e disperazione che stanno vivendo persone che tu conosci;
� apri il cuore alla riconoscenza perché in quel dono riassunto nella preghiera di Gesù trova significato anche la tua vita;
� conferma nella preghiera l’abbandono fiducioso della tua persona e della tua vita nelle mani del Padre, è ciò che ti permette di vivere con fiducia.
4. Colloquia interiormente col Signore, presente nell’Eucaristia: chiedigli la capacità di vivere come Lui il passaggio dal
sentirsi abbandonati al sapersi abbandonare fiduciosamente nelle mani del Padre.
5. Esprimi un proposito di impegno concreto per crescere nella
capacità di abbandonarti nelle mani del Padre a partire da una situazione concreta che stai vivendo in questo periodo.
Canto meditativo (durante il canto vengono raccolte le preghiere) Invocazioni e preghiere - Padre nostro Orazione Anche noi, o Padre, vogliamo far salire fino a te il grido dell’umanità che tante volte sente di sprofondare nella solitudine e nell’abbandono e desideriamo ancor più consegnarci con fiducia e interamente nelle tue mani ricche di tenerezza per ogni tuo figlio. Per Cristo nostro Signore. Tantum Ergo Preghiamo O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa' che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. Benedizione eucaristica Litania (p. 16) Canto finale
3. L’esperienza del perdono apre le porte della vita piena
“Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno”
“In verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso”
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen.
Canto ed esposizione del SS. Sacramento
Invitatorio
T: Ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce
hai redento il mondo. (FF 111)
S. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo. T. O adoramus te Christe. S. Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo
che per noi hai dato il tuo corpo. R. S. Agnello irreprensibile e senza macchia,
che hai sparso il tuo sangue in remissione dei nostri peccati. R.
S. Agnello che togli il peccato del mondo, nostra pasqua immolata. R.
S. Agnello condotto al macello che hai portato i nostri peccati sul tuo corpo. R.
S. Agnello nel cui santissimo sangue è stata sigillata la nuova ed eterna alleanza. R.
Orazione Padre, sorgente di infinita misericordia, fa discendere ancora su di noi il tuo perdono che rinnova la nostra esistenza e ci apre le porte del paradiso. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Canto al Vangelo Dal vangelo secondo Luca (23,33-43) Padre perdona loro… oggi sarai con me… 33Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 35Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 36Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 37e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso». 38Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». PdS
Proposta di riflessione 3. L’esperienza del perdono apre le porte della vita piena. “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”
“In verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso”. 1. Il contesto teologico e narrativo di san Luca Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace! Questa sera ci fermiamo a meditare sulle parole del perdono, parole che sono riportate da san Luca: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” e “In verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso”. Il contesto teologico narrativo è quello di san Luca, per il quale Dante Alighieri ha coniato la definizione “lo scriba della mansuetudine di Cristo” (Dante, Monarchia I,16,2). È l’evangelista che ha dedicato al perdono un intero capitolo del suo vangelo (Lc 15 e le parabole della misericordia), l’evangelista che ci presenta Gesù come modello di bontà, di pietà, di misericordia e di perdono, di fiducia e di preghiera. Luca evidenzia anche un altro particolare importante, l’ora della passione è l’ora in cui ritorna in scena Satana, che si era ritirato al termine dell’episodio delle tentazioni: “dopo aver esaurito ogni specie di tentazione il diavolo si allontanò da lui
per tornare al tempo fissato” (Lc 4,13). Il tempo fissato per Lc è proprio il tempo della passione quando Satana entra nel cuore di Giuda (Lc 22,3) e cerca Pietro per vagliarlo (Lc 22,32). Questa entrata in scena di Satana è, per Luca, un elemento che riduce, ma non elimina, la responsabilità personale dei capi dei Giudei, dello stesso Giuda, di Pietro, degli altri personaggi che giocano un ruolo nella condanna a morte di Gesù. Per Luca l’ora della passione è l’ora delle tenebre, proprio come per Giovanni, è cioè l’ora in cui le forze del male cercano di spegnere, senza peraltro riuscirci, la luce del bene e della verità. Nel raccontare la passione di Gesù Luca ha delle particolarità che rendono originale il suo punto di vista:
- non parla di insulti da parte dei soldati ma solo di scherni,
- attenua tutti i gesti di violenza personale, - le folle anziché insultare fanno lamenti su Gesù e
contemplano da lontano, - la responsabilità degli stessi capi del popolo è ridotta, in
accordo con quello che dirà Pietro in At 3,17 “so che avete agito per ignoranza come i vostri capi”, idea che ritorna anche in san Paolo 1Cor 2,8 che parla della sapienza divina rimasta nascosta ai dominatori di questo mondo “se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria”.
2. L’invocazione di perdono per i crocifissori In questo contesto narrativo e teologico dell’evangelista Luca, nel suo racconto, risuonano le parole di perdono dello stesso Gesù che muore in croce: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. Dentro il racconto di Luca i beneficiari diretti e primi di questa preghiera al Padre “Abbà” per ottenere il perdono sono i
responsabili della comunità giudaica. Luca rileva la disponibilità al perdono da parte di Gesù e quindi la necessità di assumere lo stesso atteggiamento anche da parte dei discepoli di Gesù che sarebbero tentati di reagire diversamente alla violenza subita. Stefano sarà esemplare nel fare proprio l’atteggiamento di Gesù e nel momento della morte gli rivolgerà questa preghiera: «Signore, non imputar loro questo peccato» (At 7,60). Il tema del perdono è veramente centrale nel vangelo secondo Luca. Quando Gesù insegna il Padre nostro, nella versione Lucana non si dice “rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” ma “perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore” (Lc 11,4) e al capitolo 15° l’evangelista riporta le tre parabole della misericordia narrate da Gesù. La terza parabola ci fa conoscere il cuore del Padre che è un cuore ricco di misericordia e di perdono, che non solo perdona il figlio minore ma vorrebbe la riconciliazione tra il figlio maggiore (figura dei pii e dei farisei) e il figlio minore (figura dei pubblicani e dei peccatori ormai sulla via della conversione e alla ricerca del perdono). Il Padre vuole che tutti e due possano partecipare alla festa del perdono che è festa di vita e di risurrezione, per legami prima interrotti e ora ricostruiti, per il ritrovamento di chi si era smarrito: “questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). La riconciliazione tra farisei e pubblicani è poi una specie di premessa a una riconciliazione ancor più profonda, quella tra i “figli maggiori” (coloro che appartengono al popolo d’Israele) e i “figli minori” (tutti coloro che provengono dal paganesimo e hanno accolto Gesù come salvatore e Signore della loro vita). Questa seconda riconciliazione, ci dirà l’apostolo Paolo, è stata realizzata da Cristo Gesù nel suo sangue, cioè attraverso il
dono della sua vita fatto per amore, sulla croce. Sono fortissime le parole di Ef 2,14-16: “Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia… per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia”. Quello proposto da Luca è un perdono dai risvolti profondamente personali ma è al tempo stesso un perdono che riguarda un intero popolo, è una riconciliazione che tocca il singolo ma rinnova al tempo stesso l’intera umanità. Nella passione poi questo perdono ha a che fare con l’ignoranza: “Perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. Sembra che l’ignoranza del male e della sua gravità, l’ignoranza del fatto stesso di peccare, sia una caratteristica propria della nostra condizione di peccatori, infatti non è raro che noi stessi facciamo una gran fatica a riconoscere di aver sbagliato, di aver peccato, di aver fatto il male e ci mascheriamo dietro frasi ingenue che segnalano questa incoscienza del tipo: “In fondo che male ho fatto?”. 3. Peccato, perdono e intercessione Il perdono ha a che fare proprio con la realtà del peccato, con la realtà di un male che ha bisogno di essere curato e risanato. Della realtà del peccato la Bibbia parla in più occasioni e lo descrive fin dall’inizio come una situazione in cui ci troviamo a partire da un uso sbagliato della nostra libertà, segnato dalla sfiducia nei confronti di Dio e dalla disobbedienza alla sua parola. I capitoli 3-11 del libro della Genesi ci parlano di questa crescente disobbedienza dell’umanità delle origini, di questa crescente incapacità di fidarci di Dio, che si trasforma in una crescente deresponsabilizzazione personale (nella
continuazione del testo proclamato nella prima lettura di domenica scorsa Gn 2,7-9; 3,1-7 sentiamo lo scaricabarile di Adamo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». E poi quello di Eva: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato»). È una situazione che va via via aggravandosi e rispetto alla quale Dio prende posizione e prende l’iniziativa avviando una relazione di fiducia con un uomo, Abramo, che diventa l’inizio di un nuovo popolo che sarà chiamato a fidarsi di Dio e ad essere santo (Lv 11,44-45; 19,2). Dentro questa storia, che si rivela essere una storia di salvezza, molte volte Dio offre il suo perdono. Emergono anche alcune figure di intercessori, come Abramo (Gn 18) che prega per Sodoma e Gomorra o come Mosè che intercede per il popolo d’Israele dopo che questo ha rinnegato Dio e si è costruito un idolo d’oro (Es 32). Troviamo anche un grande esempio di cosa significhi imparare a riconoscere il proprio peccato, quello di Davide che pecca in più di una occasione e ogni volta riconosce il proprio peccato, al punto che ancora oggi quando vogliamo esprimere il nostro pentimento usiamo le parole del Sal 50 (51), attribuite a Davide: “Pietà di me o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Contro di te, contro te solo ho peccato…”. La cosa sconvolgente dell’invocazione di perdono che Gesù crocifisso rivolge al Padre è data dal fatto che non è in risposta a un pentimento, a un riconoscimento di colpa, a una richiesta di perdono ma è una iniziativa personale e assolutamente gratuita dello stesso Gesù. È perciò un’offerta di grazia, cioè un’offerta di perdono all’insegna della gratuità; un giudizio che giustifica, cioè un giudizio che anziché schiacciarci sotto una condanna ci mette in relazione autentica con Dio.
Il Cristo in croce come ricorda san Paolo ai Romani (5,6-8) fa una scelta paradossale: “Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona per bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi”. Come aveva già intravisto Isaia, il Cristo in croce è l’agnello di Dio che si è caricato il nostro peccato, il servo che si è addossato le nostre infermità (Is 53 IV carme del Servo di Jahve). Quel modo di intercedere per i propri crocifissori: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!” è paradossale e per questo diventerà straordinariamente esemplare lungo tutti i secoli, dal primo martire Stefano che abbiamo già ricordato, a S. Maria Goretti che pregherà per il suo uccisore, a fr. Christian de Chergé, monaco di Tibhrine, che perdona anticipatamente il suo uccisore, ecc. 4. Le varie reazioni di fronte al perdono di Gesù Di fronte a questo modo di perdonare di Gesù in croce Luca racconta che ci sono varie reazioni:
- il popolo sta a vedere a una certa distanza, - i capi – quelli per i quali Gesù sta pregando il Padre –
lo scherniscono riprendendo le parole della tentazione diabolica: “Se è il Cristo, il suo eletto…”,
- anche i soldati lo scherniscono dicendo: “Salva te stesso”,
- uno dei malfattori è sulla stessa linea: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”,
- ma l’altro malfattore ha invece un momento di straordinaria lucidità e di assunzione di responsabilità personale: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato
alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il frutto delle nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male” Poi rivolgendosi a Gesù e chiamandolo per nome fa la propria preghiera in modo profondamente personale: “Gesù, ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno”. La risposta di Gesù è immediata: “In verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso”.
Nell’ultima ora della sua vita questo malfattore, al quale gli apocrifi daranno il nome di Disma, si assume finalmente la responsabilità per le proprie azioni, e riesce ad affidarsi in modo personale a Gesù, che sta subendo – senza alcuna colpa – lo stesso tipo di condanna e che viene riconosciuto per quel che è realmente: Dio che sceglie di mettersi accanto e al posto del peccatore, del criminale, dello schiavo. Davanti a questo episodio comprendiamo il senso di quel che abbiamo sentito risuonare nella seconda lettura del mercoledì delle ceneri: “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché noi diventassimo giustizia di Dio” (2Cor 5,21). Possiamo leggere anche Rm 5,15 (la seconda lettura di domenica scorsa) e quel che segue: “Il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini”. 5. L’oggi della salvezza L’incontro personale con Gesù, il riconoscimento di chi è Gesù e il riconoscimento responsabile del male commesso portano questo malfattore a sperimentare l’oggi dell’incontro con Gesù come l’oggi della salvezza. Anche questo è un tratto tipico di san Luca che fa risuonare per quattro volte, nel suo vangelo, l’oggi della salvezza che si
manifesta quando incontriamo Gesù, quando ci lasciamo accogliere da lui e lo accogliamo nella nostra vita:
- Lc 2 gli angeli annunciano ai pastori: “Oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore;
- Lc 4 Gesù a Nazareth proclama il vangelo dell’anno di grazia e conclude dicendo: “Oggi si è realizzata questa Scrittura che avete udito coi vostri orecchi”;
- Lc 19 Gesù incontra Zaccheo e gli dice: “Oggi devo venire a casa tua” e quando entra a casa di Zaccheo conclude: “Oggi la salvezza è venuta per questa casa”;
- Infine Lc 23, il testo che stiamo meditando: “Oggi con me sarai nel paradiso”.
L’oggi dell’incontro con Gesù è il tempo della salvezza. È un’offerta di incontro e di salvezza su cui medita a lungo la Lettera agli Ebrei nei capitoli 3-4 ricordandoci che è una possibilità che Dio stesso ci offre attraverso il suo Figlio Gesù, di “entrare nel suo riposo”, di entrare cioè in quella comunione con Lui che rende piena e felice la nostra vita, già ora e in una prospettiva di eternità. L’«oggi» offerto al “buon ladrone”, l’«oggi» di cui parla anche la Lettera agli Ebrei è esattamente lo stesso che viene offerto anche a noi nell’incontro personale con Gesù, quando riconosciamo che l’innocente Figlio di Dio crocifisso “per noi e per i nostri peccati”, come professiamo recitando il credo e come prega il sacerdote quando nella Messa pronuncia le parole sul calice, ricordando che quel sangue versato per le moltitudini è “per la remissione dei peccati”. Il nostro oggi può essere anche questa sera nel nostro incontro con il Cristo eucaristico nel tempo dell’adorazione, così come può essere nel momento in cui ci accostiamo al sacramento della riconciliazione con una profonda fede in Gesù, con la capacità di assumerci la responsabilità per i nostri peccati e
metterli nelle mani di Gesù, con la disponibilità ad accogliere questa offerta di perdono che è sempre un atto di amore gratuito che Dio fa nei nostri confronti per mezzo del suo Figlio Gesù. I Padri della Chiesa dicevano che il buon ladrone aveva fatto il suo miglior furto proprio nell’ora della morte, perché era riuscito a rubare il paradiso. Ringraziamolo per questo furto e ringraziamolo perché ci ha insegnato come rubare il paradiso, assumendoci la responsabilità dei nostri peccati e alzando gli occhi verso Gesù per dirgli semplicemente: “Gesù, ricordati di me”. 6. Indicazioni per il tempo di adorazione silenziosa Nel tempo di silenzio che ci sta davanti mettiamoci anche noi fiduciosamente e con riconoscenza nelle mani di Gesù, per sperimentare quanto è bello e quanto ricolma di gioia il lasciarci accogliere e perdonare da Lui. Preghiamo anche per quella larga parte di umanità incosciente, che – soprattutto nel nostro Occidente – si è allontanata da Dio; Gesù continua a pregare, per noi e per loro: “Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno”. Silenzio per l’adorazione e la meditazione personale (30’) 1. Rileggi lentamente la Parola di Dio e memorizza un versetto.
2. Fermati sul brano di Luca e contempla Gesù nell’ora della sua morte. Lascia risuonare dentro di te le sue parole di perdono e accoglienza: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”, “Oggi con me sarai nel paradiso”.
3. Rifletti sulla tua vita e alla luce della scena descritta dal vangelo:
� rifletti sulla gratuità del perdono, che è un’offerta divina che sempre precede il nostro stesso riconoscimento di aver sbagliato, è l’unico innocente a perdonare noi che spesso siamo inconsapevoli del nostro stesso peccato, quali sentimenti nascono da questa consapevolezza?
� Prova a fare una revisione della tua vita, sull’esempio del “buon ladrone”, di quali peccati sei chiamato/a ad assumerti la responsabilità, fidandoti di Gesù e della sua misericordia che è sempre più grande della tua capacità di peccare?
� Prova a metterti a tua volta nei panni di Gesù e intercedere per qualche altra persona che è bisognosa di perdono e “non sa nemmeno quello che fa” o non sa ancora assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Chiedi per chi è in questa situazione di poter incontrare Gesù e fare esperienza che c’è un “oggi” che può cambiare la loro vita.
4. Colloquia interiormente col Signore, presente nell’Eucaristia:
esprimi i tuoi sentimenti di stupore, riconoscenza, gratitudine per l’offerta di perdono e di vita piena che ti sta facendo.
5. Esprimi un proposito di impegno concreto nel vivere il
sacramento della riconciliazione come assunzione di responsabilità per i peccati commessi ma ancor più come atto di fiducia personale in Gesù.
Canto meditativo (durante il canto vengono raccolte le preghiere) Invocazioni e preghiere - Padre nostro Orazione Per quanto grande sia il nostro peccato, sappiamo o Padre che più grande è la tua misericordia e che ce l’hai manifestata nel
tuo Figlio crocifisso; donaci la grazia di sperimentare oggi l’incontro che ci fa scoprire la gioia di una vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Tantum Ergo Preghiamo Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all' Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa' che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. Benedizione eucaristica Litania (p. 16) Canto finale
4. Accogliere Maria per sperimentare la maternità della Chiesa.
“Donna, ecco tuo figlio” “Ecco la tua madre”.
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen.
Canto ed esposizione del SS. Sacramento
Invitatorio
T: Ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce
hai redento il mondo. (FF 111)
S. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo. T. O adoramus te Christe. S. Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo
che per noi hai dato il tuo corpo. R. S. Agnello irreprensibile e senza macchia,
che hai sparso il tuo sangue in remissione dei nostri peccati. R.
S. Agnello che togli il peccato del mondo, nostra pasqua immolata. R.
S. Agnello condotto al macello che hai portato i nostri peccati sul tuo corpo. R.
S. Agnello nel cui santissimo sangue è stata sigillata la nuova ed eterna alleanza. R.
Orazione Padre santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini con la grazia del tuo Spirito di essere inclusi nel numero dei figli di adozione, che Gesù morente affidò alla Vergine Madre. Egli è Dio, e vive e regna con te... Canto al Vangelo Dal vangelo secondo Giovanni (19,25-27) Donna ecco tuo figlio… ecco tua madre 25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèopa e Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse tra ciò che era suo. PdS
Proposta di riflessione
4. Accogliere Maria per sperimentare la maternità della Chiesa
“Donna, ecco tuo figlio” - “Ecco la tua madre”. 1. Il contesto della passione secondo Giovanni: chi è Gesù? Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace! Nel nostro percorso di ascolto delle parole di Gesù sulla croce incontriamo questa sera le parole che rivolge alla madre e al discepolo amato: “Donna, ecco tuo figlio”, “Ecco la tua madre”. Queste parole sono riportate dall’evangelista Giovanni, che più di ogni altro ci presenta il mistero della persona di Gesù, cioè la profondità inesauribile della sua persona, del suo essere il Verbo eterno del Padre, Dio come il Padre, che si è fatto carne, cioè uomo, per introdurre noi nella comunione col Padre attraverso l’adesione di fede e la nuova nascita “dall’acqua e dallo Spirito” (Gv 3,5). Nella passione e morte Gesù viene presentato nella sua realtà profonda, diversi passi di Gv ce lo ricordano, prima della passione e durante:
- “Quando avrete innalzato il figlio dell’uomo saprete che io sono” (Gv 8,28), è un’autoproclamazione solenne della sua divinità, dato che “Io sono” è il modo con cui Dio si auto presenta nel libro dell’Esodo (3,14);
- è il re che viene innalzato per attirare tutti a sé (Gv 12,32);
- è il giudice che mentre viene giudicato emette un giudizio e rivela che né Pilato né il Sinedrio hanno in realtà alcun potere su di lui (Gv 19,11);
- è l’agnello pasquale al quale non viene spezzato alcun osso (Gv 19,36);
- è colui che adempie le Scritture (Gv 19).
Durante la passione Gesù è sempre e comunque padrone della situazione e non subisce nulla, perché nulla accade senza il suo assenso, al punto che può dire: “Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo” (Gv 10,19). Gesù può dire questo perché in lui “è la vita” fin dal principio, come ci ha ricordato l’evangelista nel prologo del suo vangelo. 2. La scena dell’incontro con la madre e il discepolo amato Veniamo ora alla scena sulla quale vogliamo fermarci a meditare, la scena che ha ispirato tantissimi artisti, scultori, pittori, musicisti (pensiamo allo “Stabat Mater”), la scena narrata in Gv 19,25-28.
“25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèopa e Maria Maddalena. 26Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, dice alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi dice al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse tra ciò che era suo”.
Poi l’evangelista prosegue con un inciso che lega questa scena alla successiva: “Dopo ciò, sapendo Gesù che già ogni cosa era stata compiuto (tetèlestai) …” Davanti a questa scena ci poniamo alcune domande che ci aiutano a riflettere: Cosa è successo? Perché Giovanni ci ha voluto raccontare questo episodio che gli altri evangelisti non hanno riportato? Quale significato ha questo episodio che appartiene a quelli selezionati dall’evangelista perché possiamo
credere in Gesù e, credendo in lui, possiamo avere la vita (cfr Gv 20,31), cioè partecipare alla vita di Dio?
- Per alcuni Padri della Chiesa (s. Giovanni Crisostomo, s. Agostino e altri) e anche per alcuni esegeti moderni Gesù morente, con un gesto di pietà filiale affida a Giovanni la propria madre perché non sia più abbandonata a se stessa nella sua solitudine. Nel mondo ebraico infatti una donna rimasta senza marito e senza figli si trovava nella situazione più difficile dal punto di vista economico e sociale.
- Per i mariologi, per alcuni esegeti (R. Brown e altri) e
anche per molti papi, in questo momento Maria viene costituita da Gesù madre spirituale del nuovo popolo di Dio, come cantiamo nelle litanie: “Madre della Chiesa”. Ci sono diversi testi belli e importanti, su questo tema, nell’enciclica Redemptoris Mater (RM), di papa Giovanni Paolo II, un testo che potete trovare anche in internet e del quale, se volete vi invito a leggere i paragrafi da 18 a 24. In RM 18 ci vien detto che Maria sotto la croce partecipa all’umiliazione, all’offerta e al sacrificio del suo Figlio. In RM 21 vengono esse a confronto la presenza di Maria alle nozze di Cana e la presenza di Maria sotto la croce, lì Gesù aveva anticipato la sua “ora”, qui vive in pieno la sua “ora”, cioè l’ora della salvezza. In RM 23 Giovanni Paolo II medita sulle parole che Gesù rivolge alla Madre e al discepolo amato: “Senza dubbio, in questo fatto si ravvisa un'espressione della singolare premura del Figlio per la Madre, che egli lasciava in così grande dolore. Tuttavia, sul senso
di questa premura il «testamento della Croce» di Cristo dice di più. Gesù mette in rilievo un nuovo legame tra Madre e Figlio, del quale conferma solennemente tutta la verità e realtà. Si può dire che, se già in precedenza la maternità di Maria nei riguardi degli uomini era stata delineata, ora viene chiaramente precisata e stabilita: essa emerge dalla definitiva maturazione del mistero pasquale del Redentore. La Madre di Cristo, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero che comprende l'uomo - ciascuno e tutti - , viene data all'uomo - a ciascuno e a tutti - come madre”.
3. La relazione con Gesù come categoria fondamentale Nel brano del vangelo risuonano alcune parole ed espressioni che hanno un significato particolare negli scritti dell’apostolo Giovanni:
- Maria e Giovanni sono definiti a partire dalla loro relazione con Gesù. Maria è chiamata Madre e Donna come alle nozze di Cana (Gv 2), anche lì c’era il tema dell’ora, c’era un dialogo conciso tra Maria e Gesù, c’era la manifestazione anticipata della gloria di Gesù attraverso il segno dell’acqua diventata vino, c’era la fede dei discepoli come conseguenza di tutto questo. Maria Madre e Donna ci riporta anche al libro della Genesi, quando queste due parole sono riferite ad Eva, la donna posta accanto all’uomo per dare origine all’umanità, colei che diventa la madre di tutti i viventi (Gn 3,20). Ora è Maria sotto la croce la donna che viene investita di una maternità universale nel momento in cui nasce, nel mistero della pasqua, la Chiesa, inizio di una nuova umanità. Maria madre e donna ci riporta anche ad Ap 12, quando appare un segno in cielo, il segno della donna che partorisce il messia e il popolo messianico, che
richiama quanto già Gesù aveva predetto paragonando l’ora della passione all’ora in cui la donna entra in travaglio per partorire (Gv 16,21).
- Anche Giovanni è definito a partire dalla sua relazione con Gesù. È “il discepolo che Gesù amava”. Attraverso quel discepolo viene descritta la relazione di Gesù con ogni discepolo, come risulta chiaro nel vangelo di Giovanni, dove Gesù insiste molto nel dire che la sua relazione coi discepoli è una relazione di amore. Così Giovanni ci fa capire che essere discepoli di Gesù significa prima di tutto questo: essere amati da lui, essere oggetto del suo amore, che è l’amore più grande, l’amore di chi arriva fino a dare la vita per i propri amici (Gv 15,13), l’amore di chi rivela ai propri amici tutto ciò che ha udito dal Padre (Gv 15,15).
- Risuona il tema dell’ “ora”, che è l’ora della manifestazione della gloria di Gesù, che è la gloria dell’amore, la luminosità del donare la vita, l’ora della salvezza messianica che si realizza, l’ora dell’ingresso nella vita, nella gioia, nell’amore del Padre.
- Infine quell’incontro con la madre e con il discepolo amato, quel breve colloquio, quelle parole, quel dono, fanno parte del compimento (tetèlestai), di ciò che Dio stesso ha realizzato e che permane come realizzazione piena del senso profondo e del fine dell’incarnazione del Verbo! È proprio perché lì si realizza questo compimento di significato che gli effetti di questo momento possono raggiungere anche ognuno di noi.
4. Proviamo a parafrasare questo brano. Gesù vede la madre e lì accanto il discepolo amato. E si rivolge alla madre, dicendole: “Donna, accogliendo come figlio tuo il discepolo che io amo, tu continui ad essere la mia madre,
continui ad accogliere me e nel volto del discepolo che io amo tu continui a vedere il mio stesso volto”. Poi Gesù si rivolge al discepolo e gli dice: “Accogliendo mia madre come tua madre, tu entri a far parte in modo profondo, per sempre, della mia famiglia, diventi per me un fratello di elezione”. E da quell’ora, che manifesta la gloria dell’amore la madre di Gesù viene accolta ed entra a far parte della vita del discepolo amato. Fa parte del mistero di amore di Gesù dare in dono, come madre, la propria madre al discepolo amato. Fa parte del mistero della maternità di Maria vedere nel discepolo amato da Gesù il suo stesso Figlio. Fa parte del mistero dell’essere discepolo amato da Gesù accogliere per sempre come dono e come madre e come parte della propria vita la madre di Gesù, Maria. Tutto questo sta sotto il segno del compimento, cioè della realizzazione definitiva e permanente, da parte di Dio, di ciò che voleva realizzare inviando a noi il suo Figlio. 5. Gesù, la madre e noi; Gesù, la madre e me. Il racconto e le parole di Gesù non ci sono narrate per gusto di cronaca, ma perché hanno un valore permanente! Non appartengono ai ricordi nostalgici di Giovanni ormai vecchio, ma a ciò che ci viene raccontato perché possiamo credere (= entrare in relazione personale con Gesù il Cristo) e, credendo, avere la vita (= partecipare alla vita stessa di Dio, che è vita piena ed eterna). Tutto questo ci viene raccontato perché riusciamo ad imparare a stare presso la croce di Gesù anziché scappare dalla sua croce, perché fuggire dalla croce vorrebbe dire fuggire dall’amore che si manifesta come vita donata. Maria e
Giovanni stanno presso la croce di Gesù, non fuggono. E stando lì scoprono il dono nuovo di comunione che Gesù fa loro. Stando lì, anziché fuggire, scoprono la bellezza di nascere come Chiesa cioè come famiglia di Gesù. Questo racconto ci viene perciò narrato per aiutarci a scoprire un duplice piano di significati, quello comunitario, ecclesiale e quello più personale.
- Sul piano ecclesiale questo racconto ci fa scoprire la Chiesa appunto come famiglia, come realtà materna (Maria) e come realtà contrassegnata dall’essere amati (Giovanni) e come realtà che nasce quando c’è accoglienza reciproca. È un aspetto che equilibra la Chiesa rispetto al suo essere organizzazione, gerarchia, istituzione (H. U von Balthasar). Giovanni ha scritto per ultimo, tra gli evangelisti, quando la Chiesa era ormai in una fase avanzata di strutturazione e col suo racconto vuol farci recuperare un aspetto importante, che se viene trascurato rischia di far mancare il calore dell’amore nel focolare della Chiesa e trasformare tutto in efficienza organizzativa. Così la relazione Gesù, Maria, Giovanni ci riporta continuamente a considerare la Chiesa come una famiglia, dove il cuore dell’esperienza è dato dal fatto che Gesù ci ama fino a dare se stesso per noi. E dentro questa famiglia, oltre alla presenza paterna, c’è una presenza materna, femminile, che ci fa sperimentare il calore dell’accoglienza e della tenerezza. E dentro questa famiglia è possibile fare l’esperienza di essere figli e di essere amati e di accogliersi reciprocamente. Finché esisterà la Chiesa sarà necessario che sia così, e quando saremo in Paradiso resterà solo questo, perché non ci sarà più bisogno né di organizzazione né del
servizio della gerarchia. La devozione mariana e la spiritualità mariana ci riportano a questa dimensione familiare, materna, accogliente dell’essere Chiesa. Accogliere la madre di Gesù fa parte dell’accogliere ciò che Gesù ha realizzato nella sua ora e ciò che Gesù è venuto a compiere.
- Sul piano personale siamo invitati a metterci nei
panni del discepolo amato, cioè a riconoscerci e sentirci discepoli amati da Gesù “fino alla fine”, fino al compimento dell’amore. Siamo chiamati a stare presso la croce di Gesù insieme con Maria, con tutto quel che significa stare e con tutto quel che significa croce. Siamo chiamati a entrare dentro questa relazione affettiva che riguarda Gesù, la madre e ciascuno di noi: Gesù dona me a Maria come figlio e perciò mi fa fare il passaggio da discepolo a fratello. Gesù dona a me Maria come madre e perciò mi inserisce in questa famiglia che nasce dal dono di amore del Crocifisso. Infine io sono chiamato ad accogliere Maria tra ciò che mi appartiene in modo più personale, tra ciò che fa parte della mia stessa vita. E questo non è sentimentalismo, questo è entrare in punta di piedi nel mistero di amore che Gesù ha portato a compimento sulla croce.
6. Indicazioni per il tempo di adorazione silenziosa Entriamo nel silenzio della contemplazione e dell’adorazione lasciando risuonare dentro il cuore le parole di Gesù a Maria e al discepolo amato. Entriamo nel silenzio della contemplazione e dell’adorazione lasciandoci riscaldare il cuore dalla presenza materna di Maria, che anche adesso sta qui assieme a ciascuno di noi davanti al suo Figlio crocifisso e glorioso. Entriamo nel silenzio della contemplazione e dell’adorazione consapevoli
che anche ora Gesù ci sta affidando a sua madre e ci sta affidando sua madre. Silenzio per l’adorazione e la meditazione personale (30’) 1. Rileggi lentamente la Parola di Dio e memorizza un versetto.
Domani rileggi con calma il racconto della passione secondo Giovanni
2. Fermati sul brano di Giovanni e contempla Gesù nell’ora
della sua morte. Contempla la scena con tre soli attori: Gesù, la madre e il discepolo amato. Immedesimandoti nel discepolo amato lascia risuonare dentro di te le sue parole: “Donna, ecco tuo figlio”, “Ecco tua madre”.
3. Rifletti sulla tua vita e alla luce della scena descritta dal
vangelo verifica la qualità della tua devozione mariana e prova a impostarla su una base biblica solida: � Gesù mi dona sua madre perché sia mia madre,
aiutandomi a scoprire la maternità stessa della Chiesa, della quale Maria è immagine e inizio.
� Sto accogliendo Maria come madre mia e parte essenziale della mia vita cristiana?
� Sto accogliendo Gesù come fratello che mi si offre come tale nel momento in cui “mi adotta” come figlio della stessa madre?
� Sto accogliendo in Gesù ogni altro “discepolo amato”, ogni altro “fratello” divenuto, come me, sotto la croce, figlio di Maria?
� Ho imparato ad accogliere me stesso come figlio di Maria, discepolo amato, chiamato a diventare sempre più figlio e fratello negli atteggiamenti, nelle scelte, nei pensieri, nei sentimenti, nei desideri…?
4. Colloquia interiormente col Signore, presente nell’Eucaristia:
esprimi i tuoi sentimenti di riconoscenza e gratitudine per il
dono che ci ha fatto di accoglierci come fratelli attraverso la maternità di Maria e della Chiesa.
5. Esprimi un proposito di impegno concreto nel vivere la tua
vita cristiana accogliendo la maternità di Maria e della Chiesa e le conseguenze positive che questa ha sulla tua vita.
Canto meditativo (durante il canto vengono raccolte le preghiere) Invocazioni e preghiere - Padre nostro Orazione Accogli, o Signore, le preghiere della tua Chiesa e trasformaci per il dono del corpo e sangue del tuo Figlio, che dal patibolo della croce affidò alla Vergine Maria nella persona di Giovanni tutti i suoi discepoli e li fece eredi del suo amore verso la Madre. Per Cristo nostro Signore. Tantum Ergo Preghiamo Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. Benedizione eucaristica Litania (p. 16) Canto finale
5. Dalla sete al dono dell’acqua viva. “Ho sete” “E’ compiuto”.
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen. Canto ed esposizione del SS. Sacramento Invitatorio T: Ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. (FF 111) S. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo. T. O adoramus te Christe.
S. Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo che per noi hai dato il tuo corpo. R.
S. Agnello irreprensibile e senza macchia, che hai sparso il tuo sangue in remissione dei nostri peccati. R.
S. Agnello che togli il peccato del mondo, nostra pasqua immolata. R.
S. Agnello condotto al macello che hai portato i nostri peccati sul tuo corpo. R.
S. Agnello nel cui santissimo sangue è stata sigillata la nuova ed eterna alleanza. R.
Orazione O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la Croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore... Canto al Vangelo Dal vangelo secondo Giovanni (19,28-37) “Ho sete” “E’ compiuto”. 28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 30Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 31Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. 32Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. 33Venuti però da Gesù, vedendo che
era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 36Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. 37E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. PdS
Proposta di riflessione Dalla sete al dono dell’acqua viva.
“Ho sete” - “E’ compiuto”. 1. La descrizione della scena conclusiva Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace! “Ho sete” e “È compiuto” sono le ultime parole di Gesù in croce riportate da san Giovanni, dopodiché Gesù muore consegnando lo Spirito al Padre e donandolo a noi. Anche questa sera leggiamo la scena nel suo insieme e poi ci soffermiamo sulle singole parole. La scena è quella descritta nel breve brano che abbiamo appena ascoltato: Gv 19,28-37. La scandisco evidenziando i brevi quadri che la compongono:
- Dopo aver affidato il discepolo amato alla madre e la madre al discepolo amato, Gesù ritiene che l’opera affidatagli dal Padre sia stata portata a compimento in modo pieno, definitivo e permanente, è questo il senso del verbo greco “È compiuto” (tetèlestai) espresso al perfetto passivo, utilizzato da Giovanni.
- Poi, perché si adempisse (teleiothè aor. pass. cong.) la Scrittura dice: “Ho sete”. E occorrerà che cerchiamo di vedere qual è la Scrittura che si compie, che raggiunge il suo fine, e perché enfatizzare così una parola tutto sommato essenziale e legata a un bisogno fisico primario.
- In risposta alla sete di Gesù viene impregnata di aceto una spugna e accostata alla bocca di Gesù. L’evangelista annota che la spugna viene collocata su un ramoscello di issopo, che era una pianta aromatica che veniva usata nel rito di purificazione e in quello pasquale (Es 12,22), e che non era capace di reggere una spugna inzuppata. Quindi Gv sta usando un linguaggio che allude a un significato più profondo.
- Presolo è Gesù stesso a dire: “È compiuto” (tetèlestai) e, chinato il capo, consegnò, donò, trasmise lo Spirito. Anche qui Giovanni usa un verbo molto solenne dai molti significati, appunto donare, consegnare, trasmettere anziché usare verbi che descrivono l’atto fisico del morire, come fanno Matteo, Marco e Luca che descrivono la morte di Gesù dicendo “Emise lo spirito” (Mt 27,50) e “spirò” (Mc 15,37 e Lc 23,46).
- Per Giovanni poi siamo al 14 di Nisan, cioè alla vigilia della Pasqua che in quell’anno cadeva di sabato, siamo nell’ora in cui nel cortile del tempio si cominciano a sgozzare gli agnelli per il sacrificio pasquale e per la cena pasquale. È in concomitanza con quanto avviene nel Tempio che i Giudei vanno da Pilato per chiedere che siano spezzate le gambe ai condannati che sono ancora vivi, per affrettare la loro morte e poi la sepoltura. Ma venuti da Gesù vedono che è già morto, per cui non gli spezzarono le gambe, “ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua”. L’evangelista annota una cosa molto importante: “Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.” (v. 35).
- Infine l’evangelista commenta (vv. 36-37): “Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della
Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. Si tratta di due citazioni che riprendono Es 12,46 dove si parla di come deve essere l’agnello pasquale e Zc 12,10 che è un versetto fortemente evocativo per i primi cristiani che meditano sul senso della morte di Gesù: “Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito”. E poco dopo Zaccaria parla di “una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità” (v. 13,1).
2. L’ora del compimento in cui tutto trova senso e pienezza Dopo aver ricostruito la scena proviamo di raccogliere alcuni temi che emergono. Il primo è quello dell’ora del compimento. San Giovanni usa tre verbi per dire il compiersi di qualcosa:
- Il primo (telèo), significa portare a compimento nel senso di portare ad un fine ad una meta;
- Il secondo (teleiòo) nella forma, significa rendere perfetto, perfezionare, completare ma anche portare ad un fine;
- Il terzo (pleròo), significa rendere pieno, portare a realizzazione.
Uno di questi verbi in Giovanni è quasi sempre usato per indicare il compimento dell’opera che il Padre ha affidato al Figlio (telèo), ed è riportato in una forma verbale particolare, il perfetto passivo. Quel che il Padre voleva che si compisse si è compiuto, in modo pieno e definitivo, in modo tale che i suoi effetti sono e saranno permanenti nella storia dell’umanità. Potremmo dire: l’incarnazione del Verbo eterno del Padre (Gv 1), ha raggiunto il suo fine, il suo scopo, il suo
compimento. E questo fine è un fine “per noi”, come ci racconta Giovanni all’inizio e alla fine del suo vangelo: rivelarci il Padre e portarci a credere nel Figlio, “via, verità e vita”, perché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché credendo abbiamo la vita nel suo nome (Gv 20,31). C’è anche un altro fine proposto da Gesù in vari passi del vangelo di Giovanni: la glorificazione del Padre e del Figlio (Gv 7,39; Gv 12,16.23.28; Gv 13,31-32; Gv 17,4-5.10.); in tutti questi passi il verbo glorificare è riferito alla manifestazione del mistero di Dio attraverso il mistero della croce, è come se nell’ora della croce brillasse in modo sublime ciò che Dio è in se stesso, cioè amore: amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre nella comunione dello Spirito, amore del Padre e del Figlio nei nostri confronti mediante il dono dello Spirito. Gli altri due verbi utilizzati da Giovanni per parlare di compimento sono quelli riferiti al “compimento delle Scritture” (pleròo e teleiòo). Sono verbi che stanno a significare pienezza nel senso di riempimento e compimento nel senso di raggiungere lo scopo. È come se l’evangelista ci stesse dicendo che le Scritture, senza la morte in croce di Gesù sono vuote e il loro significato profondo non è svelato e raggiunto finché Gesù non lo rivela con il suo modo di vivere, con le sue azioni, con la sua morte e – lo vedremo domani sera – anche con la sua risurrezione. 3. Gli avvenimenti che fanno parte del compimento Dentro questo compimento, dentro questo definitivo realizzarsi dell’opera di Dio, che cosa troviamo?
- Già ieri abbiamo visto qualcosa che sta sotto il segno del compimento: quando Gesù affida il discepolo amato alla madre e la madre al discepolo amato, questo gesto fa parte del compimento, cioè la Chiesa e la sua
maternità espressa attraverso Maria fa parte del compimento.
- Oggi scopriamo che molti altri aspetti della passione stanno dentro questo compimento: la sete di Gesù sulla quale ci fermeremo a riflettere tra qualche istante; il dono dello Spirito che ci fa comprendere come per Giovanni quando Gesù muore in croce è già Pasqua2; il non subire la frattura delle ossa che indica in Gesù il vero agnello pasquale di Es 12,46; l’aprire il proprio fianco perché ne esca sangue ed acqua che ci fa scoprire in Gesù il nuovo tempio dal quale esce un’acqua che risana Ez 47 e Zc 13,1); il cominciare a volgere lo sguardo a colui che è stato trafitto, che comincia ad attirare a sé tutti (Zc 12,10); e tutti questi particolari ci vengono riportati con una testimonianza volutamente enfatizzata da parte dell’evangelista, che interrompe la narrazione nel suo apice per dirci che lì c’è qualcosa di fondamentale per la nostra fede, per il nostro credere.
4. La sete di Gesù è una sete che disseta Dentro questo quadro pasquale e sacrificale troviamo le parole di Gesù: “Ho sete” e “È compiuto”. Gesù ha avuto sete da un punto di vista fisico? I medici che hanno studiato la passione ci ricordano che tra la flagellazione e la crocifissione Gesù deve aver perso molto sangue e questo spiega la sete fisica. Del resto Giovanni non ha paura di segnalarci, anche in altri passi la fatica di Gesù, che è legata alla sua reale umanità – “si è fatto carne, aveva detto Giovanni nel prologo – e ci ha raccontato anche l’incontro con la
2 Le chiese della Siria, quelle di S. Ignazio d’Antiochia, saranno chiamate quartodecimane proprio perché, seguendo il calendario dell’evangelista Giovanni, celebreranno la pasqua il 14 di Nisan anziché la prima domenica dopo il plenilunio di primavera.
Samaritana, nel quale Gesù si siede stanco sul bordo del pozzo di Giacobbe per chiedere da bere a questa donna (Gv 4). Quale Scrittura sta adempiendo Gesù nel momento dice: “Ho sete.”? Per gli esegeti il riferimento è ad alcuni salmi, il Salmo 22(21) che abbiamo già incontrato: “È riarso come coccio il mio palato” e soprattutto il Salmo 69(68),22: “Mi hanno dato come cibo fiele e nella mia sete mi hanno abbeverato di aceto”. Come abbiamo già visto questi sono Salmi drammatici, ma anche suppliche piene di fiducia. È come se nell’atto di salire sulla croce Gesù ricapitolasse in sé e presentasse al Padre in atto di mediazione sacerdotale “tutte le afflizioni dell’umanità, tutte le suppliche e i lamenti dei giusti dell’Antico Testamento. Il sacrificio supremo del Figlio di Dio sulla croce potrà finalmente appagare la sete di giustizia e di bontà, per la quale l’umanità aveva invocato con lacrime e gemiti il Creatore del mondo” (A. POPPI, Le parole di Gesù in croce, EMP, p. 109). La sete di Gesù, letta nel contesto di Giovanni è in realtà una sete che disseta. Quando Giovanni, nel suo Vangelo, racconta che Gesù ha sete, poi scopriamo che in realtà Gesù sta offrendo da bere un’acqua speciale. È paradigmatico, da questo punto di vista, proprio il racconto dell’incontro di Gesù con la Samaritana, presso il pozzo di Giacobbe (Gv 4). Un incontro che avviene nell’ora più calda, il mezzogiorno. Un incontro nel quale è Gesù che prende l’iniziativa, a partire dal proprio bisogno, e dice alla donna venuta al pozzo per attingere: “Dammi da bere” (Gv 4,7). Ma poco dopo Gesù non è più quello che chiede da bere ma quello che offre da bere: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». (Gv 4,10) e di nuovo: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi,
l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,13-14). Il tema di Gesù che disseta ritorna anche in Gv 6: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete» (6,35). E di nuovo al capitolo 7: “«Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui” (7,37-39). Guarda caso anche nel nostro passo in Gv 19, prima Gesù dice “Ho sete” poi dal suo costato comincia a scaturire una sorgente, comincia a fluire sangue ed acqua, simboli ricchissimi di significato, perché richiamano al dono dello Spirito, ma anche all’acqua battesimale e al sangue della celebrazione eucaristica. Simboli che ci riportano alla visione di Zaccaria 14,8 che parla di una sorgente zampillante, una sorgente di misericordia e di purificazione. Simboli che richiamano la visione di Ezechiele 47,1 che vede una sorgente uscire dal lato destro del tempio, una sorgente che risana tutto ciò che incontra e porta vita. Quando Gesù dice: “Ho sete”, in un modo misterioso e profondo sta offrendoci lui stesso l’acqua vera che disseta; è un tema questo che ritorna anche nell’Apocalisse, dove Gesù, è l’agnello immolato e seduto sul trono (cioè il Cristo crocifisso e glorioso) che conduce alle fonti delle acque della vita (Ap 7,17); è il Principio e la Fine che afferma: “A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita” (Ap 21,6), e l’intera Bibbia si conclude dando risposta a questa sete che noi ci portiamo dentro dicendo: “Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!». Chi ha sete
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita”(Ap 22,17). 5. Nel compimento la piena adesione alla volontà del Padre Infine l’ultima parola di Gesù in croce, per Giovanni, è: “È compiuto”. Abbiamo già riflettuto a lungo sul tema del compimento. È una parola decisiva, che sta ad indicare che l’opera del Padre si è adempiuta in modo pieno, definitivo ed efficace per noi. Il motivo per cui il Verbo eterno che era in principio presso Dio ed era Dio e che nella pienezza del tempo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi si è realizzato. L’incarnazione ha raggiunto il suo scopo: rivelarci il Padre, aprirci la via per poter essere in comunione col Padre, aprirci la via della Vita. Questo compimento ha a che fare con il modo in cui Gesù ha fatto propria la volontà del Padre. Un tema che Giovani ha sondato e che dice qualcosa di fondamentale anche a noi, cristiani del XXI secolo, che viviamo immersi in una cultura che non ha interesse per la volontà di Dio, quanto piuttosto per la volontà dell’io. Gesù ha invece un rapporto di piena sintonia con la volontà del Padre. Bastino alcune brevi versetti che san Giovanni ci riporta:
- “Mio cibo è fare la volontà del Padre” (Gv 4,34); - “Il Figlio da sé non può fare nulla, se non ciò che vede
fare dal Padre, quello che Egli fa, anche il Figlio lo fa” (Gv 5,19);
- “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 6,38) e poco dopo preciserà che la volontà del Padre è “che io non perda nulla, ma lo risusciti nell’ultimo giorno”
Potremmo dire che Gesù è consacrato alla volontà del Padre, se ne nutre, desidera realizzarla, la realizza in modo manifesto e definitivo nella sua pasqua. E chiede a noi di entrare nella stessa logica di vita. Quando nella sinagoga di Cafarnao i suoi uditori gli chiedono: “Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?». Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato»” (Gv 6,28-29). E Gesù stesso prega perché la volontà del Padre si compia, si realizzi, raggiunga il suo significato ultimo anche in noi. Tutto il capitolo 17 di Gv, la grande preghiera sacerdotale di Gesù, non è altro che questo. 6. Indicazioni per il tempo di adorazione silenziosa Entriamo nel silenzio dell’adorazione e della contemplazione; il Cristo presente nell’Eucaristia è il Cristo che ci dice: “Ho sete” e al tempo stesso è il Cristo che disseta i nostri desideri più profondi: il desiderio di bene, il desiderio di vita, il desiderio di felicità; è il Cristo nel quale si è compiuta fino in fondo la volontà del Padre, che ha scelto di nutrirsi della volontà del Padre e che si fa nostro cibo perché anche in noi si realizzi la stessa volontà del Padre e diventiamo capaci di assumerla e farla nostra, perché – come ha cantato Dante nel terzo canto del Paradiso – “E 'n la sua volontade è nostra pace” (Par. III,85). Che il Signore qui presente ci dia la grazia di gustare almeno un po’ di questa pace! Silenzio per l’adorazione e la meditazione personale (30’) 1. Rileggi lentamente il brano evangelico di Giovanni che ci
presenta il “compimento” della missione di Gesù e memorizza un versetto.
2. Fermati sul brano di Giovanni e contempla Gesù nell’ora
della sua morte. Lascia risuonare dentro di te le sue parole:
“Ho sete”, “E’ compiuto”. E contempla il costatalo trafitto al quale esce sangue ed acqua, dono che ci viene fatto “perché anche noi crediamo”.
3. Rifletti sulla tua vita e alla luce della scena descritta dal
vangelo verifica alcuni elementi essenziali della tua vita cristiana: � A partire dal dono di sé che Gesù fa, credo veramente?
fino a che punto l’ho accolto e lo accolgo come fondamento della mia vita? Fino a che punto aderisco a Lui?
� Qual è il rapporto tra la volontà del Padre e la mia volontà? È un aspetto su cui è importante riflettere in un tempo come il nostro in cui tendiamo a tener conto solo della nostra volontà e facciamo una gran fatica a confrontarci con una volontà che ci si rivela!
� Come accolgo i dono del Cristo pasquale che san Giovanni ci testimonia? Doni che sono molteplici: il battesimo, lo Spirito, l’Eucaristia, la Chiesa, l’unità…
� Immedesimandomi nel discepolo amato che “ha visto e dà testimonianza” perché noi possiamo credere, come testimonio a mia volta questo cuore pasquale del vangelo, questo compimento dell’esistenza di Gesù, di modo che altri possano credere, con tutto quel che ne segue e significa?
4. Colloquia interiormente col Signore, presente
nell’Eucaristia: esprimi i tuoi sentimenti di riconoscenza e gratitudine per il dono che ci ha fatto di aprire per noi una sorgente inesauribile che disseta la nostra sete di significato e di vita piena.
5. Esprimi un proposito di impegno concreto nel vivere la tua vita cristiana nella Chiesa e facendo tuo anche l’impegno della testimonianza.
Canto meditativo (durante il canto vengono raccolte le preghiere) Invocazioni e preghiere - Padre nostro Orazione Ci rinnovi profondamente, o Padre, il sacrificio del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della Croce fece uscire dal suo costato sangue ed acqua per lavare il peccato del mondo e donarci la vita divina. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Tantum Ergo Preghiamo Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R. Amen. Benedizione eucaristica Litania (p. 16) Canto finale
6. Il cammino di Emmaus, dalla fuga alla testimonianza.
“Non bisognava che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella sua gloria?”
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen. Canto ed esposizione del SS. Sacramento Invitatorio T: Ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. (FF 111)
S. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo. T. O adoramus te Christe. S. Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo
che per noi hai dato il tuo corpo. R. S. Agnello irreprensibile e senza macchia,
che hai sparso il tuo sangue in remissione dei nostri peccati. R.
S. Agnello che togli il peccato del mondo, nostra pasqua immolata. R.
S. Agnello condotto al macello che hai portato i nostri peccati sul tuo corpo. R.
S. Agnello nel cui santissimo sangue è stata sigillata la nuova ed eterna alleanza. R.
Orazione O Dio, che nel memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito, perché nel mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto che apre il nostro cuore all'intelligenza delle Scritture, e si rivela a noi nell'atto di spezzare il pane. Egli è Dio...
Canto al Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (24,13-35) Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. PdS
Proposta di riflessione
Il cammino di Emmaus, dalla fuga alla testimonianza. “Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?” 1. La Pasqua è la grande sorpresa Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace! Questa sera ci troviamo insieme per il nostro ultimo appuntamento, per la conclusione della nostra riflessione all’interno del percorso degli esercizi spirituali parrocchiali. Abbiamo iniziato con una riflessione generale sulla passione, morte e risurrezione di Gesù; poi abbiamo meditato sulle sette parole di Gesù in croce; questa sera ci lasciamo guidare da Gesù che ci aiuta a leggere tutto ciò a partire dalla sua Pasqua, dalla sua risurrezione, dalla sua vittoria sulla morte. Tutto il capitolo 24 di Lc è contrassegnato dalla Pasqua come la grande sorpresa, l’evento inaspettato:
- è una sorpresa per le donne che vanno al sepolcro per ungere un cadavere e invece trovano una tomba vuota e due uomini in vesti sfolgoranti che fanno loro l’annuncio pasquale come compimento della parola di Gesù (Lc 24,1-10);
- è una sorpresa per l’apostolo Pietro, che dopo aver pensato che le donne vaneggiavano, corre al sepolcro e resta stupito nel vedere il sepolcro vuoto e le bende per terra (Lc 24,11-12);
- è una sorpresa per i due discepoli di Emmaus, uno dei quali si chiama Cleopa, che appartengono al gruppo di discepoli più vicino agli Apostoli, i quali fanno un vero e proprio cammino di conversione aiutati dal loro misterioso accompagnatore, che è lo stesso Gesù risorto. Nel tempo trascorso con lui passano
progressivamente dalla fuga da Gerusalemme al ritorno entusiasta, che è un passaggio dalla fuga dalla comunità (a Gerusalemme sono rimasti gli Undici) al ritorno alla comunità; ma è anche una conversione “dalla speranza perduta alla speranza ritrovata, dalla tristezza alla gioia, dalla Croce come scandalo che impedisce di credere alla Croce come ragione per credere” (B. MAGGIONI, Il racconto di Luca, Cittadella, p. 396). Il cammino dei due discepoli di Emmaus è perciò un cammino fisico, da Gerusalemme a Emmaus e ritorno (in tutto circa 22 Km), ma è ancor di più un cammino spirituale, dal pensare che “è tutto finito” allo scoprire che “è cominciato qualcosa che non finirà più”.
2. Lo scoglio della morte che frantuma la speranza Qual è lo scoglio contro il quale era naufragata la speranza dei discepoli di Emmaus? È lo scoglio della croce. Lo riconoscono loro stessi quando Gesù si accosta a loro lungo il cammino, ascolta i loro discorsi e sollecita il loro sfogo. I due hanno il volto triste, annota Luca, danno voce a tutta la loro amarezza e delusione e – in fondo – descrivono quel che è successo e la loro incapacità di credere nella risurrezione di Gesù, nonostante le testimonianze. Infatti alla domanda che Gesù rivolge loro: Cosa è successo?”, essi rispondono:
“«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto»”.
Ecco lo scoglio contro il quale si è infranta la speranza dei discepoli: lo scoglio della morte di Gesù in croce. Uno scoglio che ha frantumato il loro sogno messianico e che denota come, in fondo, non avessero proprio compreso il messaggio di Gesù e avessero ridotto la loro speranza al desiderio di una liberazione politica di Israele. Ma c’è anche un altro scoglio contro il quale si è infranta la loro speranza ed è lo scoglio della loro incapacità di credere sia a ciò che Gesù stesso aveva predetto, parlando della propria passione, morte e risurrezione; sia alla testimonianza dei messaggeri divini incontrati dalle donne, sia alla testimonianza silenziosa dei segni, come la tomba vuota e il lenzuolo di lino, che non riescono a interpretare come indizi della risurrezione e inviti alla fede. È lo stesso scoglio contro il quale si frantumano normalmente anche le nostre speranze, perché quando incontriamo la morte da vicino, il più delle volte non riusciamo a guardare oltre la morte, non riusciamo a farci toccare in profondità da un annuncio che fa appello alla nostra fiducia, non riusciamo neanche a cogliere i segni di vita che sono davanti ai nostri occhi. 3. La lettura pasquale dell’esistenza alla luce delle Scritture Ciò che Gesù fa è offrire una lettura pasquale di quanto gli è accaduto, e lo fa alla luce delle Scritture, di quella parte della Bibbia che noi chiamiamo Antico Testamento. Gesù fa questo in modo forte, con parole che scuotono e suonano come un rimprovero salutare:
“«Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”.
Gesù fa capire ai due discepoli che è il loro sguardo che deve cambiare: loro hanno pensato alla sua morte in croce come al suo fallimento, egli invece vuole portarli a capire che si tratta di un passaggio necessario per realizzare il progetto di Dio. Come abbiamo visto nei giorni scorsi quello della passione e morte in croce è un passaggio necessario, perché esprime il compimento dell’incarnazione come assunzione piena e totale della nostra condizione umana da parte di Dio stesso. La morte in croce è il punto più basso e profondo che Dio raggiunge nel condividere la nostra vita. Nel fare sua la nostra vita egli arriva fino alla discesa agli inferi, fino alla discesa nel mistero oscuro della nostra morte. Ma non si ferma lì. Dalla morte risale mediante la risurrezione, che è l’altro volto del mistero pasquale, l’evento in cui la morte viene vinta e comincia una condivisione di segno opposto, quella in cui il Cristo porta la nostra umanità, la nostra carne, dentro la vita stessa di Dio. Nell’incarnazione il Figlio di Dio ha assunto la nostra umanità fino a morire, nella risurrezione la nostra carne mortale è assunta per sempre nella vita di Dio. Questa è la Pasqua. Questo vuol dire: “bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria”, che è poi la condizione necessaria perché noi, insieme con Lui, entriamo nella gloria di Dio, cioè nella sua vita, attraverso la morte, ma non più prigionieri né della morte né della paura di morire. Hanno fatto fatica i due di Emmaus a comprendere questo, però hanno sentito il loro cuore riscaldarsi mentre ascoltavano questo annuncio. Anche noi facciamo fatica a capirlo eppure è
questo l’unico annuncio di cui abbiamo bisogno, l’unico annuncio che ci può cambiare radicalmente la vita, l’unico al quale occorre che crediamo veramente. I cristiani della prima generazione hanno concentrato questa fede in una formula antichissima, il più antico nucleo cristologico del credo, che troviamo in 1 Cor 15,1-5 e che san Paolo confessa di aver ricevuto e di trasmettere:
“Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici”.
La morte e risurrezione di Gesù, la lettura pasquale della sua vita è “secondo le Scritture”: insieme coi cristiani della prima generazione e di tutte le generazioni noi cogliamo già nell’Antico Testamento l’annuncio della Pasqua di Gesù e al tempo stesso interpretiamo tutta la Parola di Dio alla luce della Pasqua di Gesù. Lo abbiamo visto anche ieri, senza Gesù morto e risorto non c’è compimento delle Scritture, la Bibbia resta un libro bello ma incompiuto, un contenitore vuoto, una promessa che non raggiunge la sua realizzazione, un percorso che non approda ad alcuna meta, una proposta che non è in grado di realizzare il suo significato più profondo. 4. Imparare una lettura pasquale anche della nostra vita Quando impariamo ad accogliere la lettura pasquale che Gesù fa della propria passione e morte, allora impariamo a fare una lettura pasquale anche della nostra stessa esistenza e, per usare le parole di san Paolo, non siamo più “come gli altri che non
hanno speranza” (1 Ts 4,13) e – di conseguenza – non possiamo più affliggerci per quelli che sono morti e neanche per la certezza di dover noi stessi morire. Quando impariamo ad accogliere la lettura pasquale della passione e morte di Gesù impariamo che un cristiano senza fede pasquale ha semplicemente perso il proprio tempo. È di nuovo san Paolo a ribadirlo con forza in 1Cor 15,12-20:
“12Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? 13Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto! 14Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. 15Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. 16Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 17ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. 18Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. 19Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 20Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti”.
Dopo aver continuato il suo ragionamento, al v. 32 poi tira una conclusione estrema: “Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo”. Vale a dire: se non facciamo nostra la logica pasquale del Cristo morto e risorto e se non crediamo che ciò che è avvenuto in Gesù avverrà anche in noi, siamo dei disperati, ai quali non rimane altro che spremere dalla vita ogni goccia di piacere e soddisfazione per
rendere sopportabile un percorso alla fine del quale non c’è altro che il nulla! La lettura pasquale della nostra vita, cambia il senso del nostro vivere e del nostro morire e cambia il modo con cui possiamo guardare al nostro vivere e al nostro morire, al vivere e al morire delle persone che amiamo, al vivere e al morire che si realizza anche nelle circostanze più tragiche che possiamo immaginare e che sono già incluse nella morte in croce di Gesù ma che sono anche già illuminate dalla luce della sua risurrezione. 5. Lo spezzare il pane come segno di riconoscimento Nel racconto di Emmaus c’è poi un momento speciale di riconoscimento di Gesù risorto, da parte dei due discepoli di Emmaus, è il momento in cui, dopo aver camminato insieme, lo invitano a restare con loro perché ormai si fa sera e lo invitano a sedere alla loro mensa. Essendo egli l’ospite, gli viene chiesto – come gesto di cortesia – di benedire la mensa e tutto quello che fa e dice diventa illuminante ai fini del riconoscimento. Come ha scritto con essenzialità e chiarezza il biblista Bruno Maggioni:
“Il gesto che apre gli occhi dei discepoli è la frazione del pane (24,31), un gesto che riporta la memoria all’indietro, alla vita del Gesù terreno qui riassunta nel ricordo della cena (una vita in dono, un pane spezzato) e alla memoria della croce che di quella dedizione è il compimento. Ma la «fractio panis» è anche un gesto che porta in avanti, al tempo della chiesa, in cui i cristiani continueranno a «spezzare» il pane. Spezzare il pane e distribuirlo (24,30) è un gesto riassuntivo che svela l’identità permanente del Signore: del Gesù terreno, del Risorto e del Signore presente ora nella comunità” (Maggioni, p. 396).
Una volta che il Signore si è manifestato ed è stato riconosciuto non c’è più bisogno di vedere e men che meno di trattenere Gesù risorto, è arrivato piuttosto il momento di testimoniarlo senza indugio e di prolungarne la presenza facendo, come corpo ecclesiale del Risorto, quello che Lui ha fatto come capo dello stesso corpo. Non a caso i tratti distintivi della prima comunità cristiana saranno proprio lo stare insieme “assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42). 6. Un’esperienza che rimette in cammino per testimoniare Il cammino con Gesù risorto, le parole che Lui ha detto interpretando le Scritture, la lettura pasquale che ha fatto della sua passione e morte, il gesto di spezzare il pane e il conseguente riconoscimento sono un’esperienza talmente forte che i due discepoli non possono più aspettare per fare all’indietro quegli undici Km che li separano da Gerusalemme. E lì la sorpresa è grande: il Signore è apparso anche a Pietro! Questo primo, piccolissimo nucleo della Chiesa condivide l’esperienza dell’incontro col Risorto, e di lì a non molti giorni, quando riceverà il dono dello Spirito, riceverà una forza tale da portare questa testimonianza sulla piazza di Gerusalemme (At 2), poi davanti al tribunale del Sinedrio (At 4), ai pagani desiderosi di accogliere Gesù (At 10), negli ambienti di lavoro (At 18) e nei luoghi di culto (At 13), dentro le prigioni (At 16), nei luoghi di sofferenza (At 3,3), nelle case (At 16), sulle strade (At 8), per mare (At 27), fino agli estremi confini della terra (At 28). Durante tutta questa settimana abbiamo cercato di entrare nel mistero pasquale con l’aiuto della parola di Dio, specialmente delle parole che Gesù ha pronunciato in quelle sei ore durante
le quali è rimasto agonizzante sulla croce (Mc 15,25-34), e con l’aiuto di Gesù presente in mezzo a noi nell’Eucaristia, pane spezzato per la vita del mondo, vita donata per la nostra salvezza. Adesso è arrivato anche per noi il momento di lasciarci aprire completamente il cuore all’intelligenza delle Scritture e gli occhi al riconoscimento del Signore presente in mezzo a noi. Ma è giunto anche il momento di rimettere in moto i nostri piedi per raggiungere tutti gli ambienti di vita, è giunto il momento di sciogliere anche la nostra lingua e testimoniare senza indugio e senza timore, che l’incontro con Gesù è quello che ha cambiato la nostra vita e dà significato al nostro vivere e riempie di speranza perfino il nostro morire. Fuori di qui ci sono tantissime persone che non ci credono più, e per questo sono tristi, talvolta sfiduciate fino alla disperazione. Attendono noi, attendono la nostra testimonianza, attendono il nostro entusiasmo. 7. Indicazioni per il tempo di adorazione silenziosa Entriamo nel silenzio dell’adorazione chiedendo al Signore questa capacità di rimetterci anche noi in cammino sulle strade degli uomini e delle donne del nostro tempo, per annunciare assieme a Pietro, assieme ai due di Emmaus, assieme a tutta la Chiesa: «Davvero il Signore è risorto». Silenzio per l’adorazione e la meditazione personale (30’)
1. Rileggi lentamente la Parola di Dio e memorizza un versetto.
2. Fermati sul brano evangelico e medita l’episodio
narrato da san Luca:
� La comunità cristiana non è un gruppo riunito attorno a un interesse umanitario, a un ideale filantropico, a un codice morale. E’ riunito attorno a una persona viva: Cristo risorto, colui che cammina con noi, che ci fa ardere il cuore quando ci spiega le scritture, colui che ci aiuta a cogliere il senso pasquale della sua e della nostra vita, colui che si fa riconoscere nello spezzare il pane, colui che – riconosciuto – chiede di essere annunciato.
� Come i discepoli di Emmaus, anche in noi possono subentrare momenti di scoraggiamento e delusione che ci portano dalla comunione alla disgregazione, dallo “stare con” dell’esperienza ecclesiale al “fuggire nel privato”, dall’impegno animato dalla speranza al disimpegno dettato dallo scetticismo. Questi momenti possono essere sciolti solo quando accettiamo di leggere la storia e l’esistenza – quella di Gesù, la nostra, quella dell’umanità intera – alla luce della logica pasquale fatta di morte (vita donata) e risurrezione (pienezza di vita ritrovata).
3. Rifletti sulla tua vita:
� Come vivi l’incontro con Gesù risorto attraverso l’ascolto della sua Parola ed attraverso il suo spezzare il pane nella comunità?
� Quali sono le delusioni che devi consegnare al Signore risorto perché ti aiuti a scioglierle alla luce della Pasqua?
� Come vivi la dimensione dell’annuncio e della testimonianza?
4. Colloquia interiormente con Gesù morto e risorto per
noi, parola viva e pane spezzato per la vita del mondo, presente nell’Eucaristia, e ripeti interiormente la
preghiera dei discepoli di Emmaus: “Rimani con noi, Signore, perché già scende la sera”.
5. Esprimi un proposito di impegno concreto per
diventare un annunciatore di Gesù morto e risorto per noi.
Canto meditativo (durante il canto vengono raccolte le preghiere) Invocazioni e preghiere - Padre nostro Orazione Signore Gesù, ti sei fatto riconoscere nell’atto dello spezzare il pane. Tu che sei il Pane vivo disceso dal cielo, il Pane spezzato per la salvezza del mondo, accogli le nostre preghiere e presentale al Padre. Tu che vivi nei secoli dei secoli. Tantum Ergo Preghiamo O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. Benedizione eucaristica Litania (p. 16) Canto finale





























































































![[Astrology] Ciro Discepolo - Nuova Guida All Astrologia 2ed](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf8548550346484b8c577f/astrology-ciro-discepolo-nuova-guida-all-astrologia-2ed-55d295965b6b0.jpg)

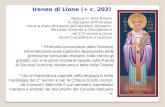




![[Astrology] Ciro Discepolo - Nuova guida all Astrologia 2ed.pdf](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5872030b1a28ab02618bf938/astrology-ciro-discepolo-nuova-guida-all-astrologia-2edpdf.jpg)