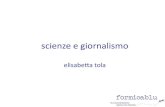Scienza e laboratorio
-
Upload
andrea-checchetti -
Category
Education
-
view
1.058 -
download
0
description
Transcript of Scienza e laboratorio

Istituto Comprensivo “Rita Pisano”
di Pedace (Cs)
PON B-1-FSE-2008-141
Problema
Soluzioni ipotizzate
Critica e prove
sperimentali
Sostituzione delle teorie errate
A.S. 2008/2009
Dirigente Scolastico
Prof. Renato Miceli
Esperto esterno:
Prof. Andrea Checchetti
Tutor:
Prof.ssa Irene Carci
Scienze e laboratorio
Andrea Checchetti

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 2
Istituto Comprensivo “Rita Pisano” di Pedace (Cs)
PON B-1-FSE-2008-141
Dirigente Scolastico Prof. Renato Miceli
Esperto esterno: Prof. Andrea Checchetti
Tutor: Prof.ssa Irene Carci
I corsisti:
Bardella Concetta Cannata Mirella Carravetta Maria De Rose Antonia Granieri Maria Annunziata Leonetti Maria Malito Anna Maria Mattace Maria Oliverio Luciana Teresa Papaianni Mirella Riccio Giuseppe Rovito Antonella Tarasio Giuseppina Tedesco Orestina Turco Carlo Francesco Vigna Angela
Scienze e laboratorio

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 3
Introduzione

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 4
Introduzione
Il presente progetto è stato finalizzato a coinvolgere il corpo docente dell’Istituto Comprensivo “Rita Pisano” di Pedace (Cs) in attività di laboratorio, che hanno comportato la raccolta di informazioni, elaborate e filtrate criticamente, per essere in grado di fornire le soluzioni più adeguate ai quesiti che la scienza si pone ogni qual volta che una curiosità, un problema, una domanda specifica nasce dall’osservazione di un fenomeno, di un processo, di un comportamento.
Il laboratorio scientifico può considerarsi efficace se il processo di apprendimento ha sedimentato nello studente nuovi interessi, nuove curiosità, nuovi stimoli. Più in generale la didattica che fa uso del laboratorio come metodo d’insegnamento diventa un potente strumento se il fare lezione si esplica come attività che conferisce valore alla scoperta perché è in grado di dare risposte. Queste risposte non sono il prodotto di una sequenza di fasi preordinate, ma di un percorso nel quale il soggetto ha l’opportunità di agire, lavorare, relazionarsi decidendo in modo autonomo perché ha la possibilità concreta di calarsi in un ambiente significativo, esclusivo e destinato alla capacità di stimolare appieno ogni abilità e, motivare alla competenza, ottenendo così quegli effetti positivi offerti dalle aspettative cha tale luogo fisico è in grado di proporre.
Nell’esecuzione di questo progetto si è pertanto cercato di simulare quello che può offrire l’uso del laboratorio all’insegnamento/apprendimento delle scienze.
Le attività sono state suddivise in quattro diversi moduli:
1. Le trasformazioni della materia 2. I principi nutritivi 3. I circuiti elettrici 4. Le forze
Il livello di conoscenze, competenze e abilità, acquisite dai corsisti, è stato monitorato attraverso un testo iniziale di autovalutazione, due prove in itinere e una prova finale, gli esiti della quale hanno evidenziato il rafforzamento delle abilità, il conseguimento dei saperi e le competenze previste. I docenti si sono mostrati soddisfatti dell’esperienza maturata durante il corso, partecipando al dialogo educativo, e, opportunamente guidati, realizzando tutta la serie di esperimenti proposti per ogni tematica.
Per la realizzazione del progetto sono state utilizzate le seguenti metodologie:
- presentazione dell’attività laboratoriale - cooperative learning - problem solving
Sono stati raggiunti i seguenti risultati:

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 5
• Conoscenza delle specifiche procedure di laboratorio • Consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza • Capacità di gestire le relazioni di gruppo
Al termine del percorso i docenti coinvolti hanno compreso che il laboratorio permette
• Di innovare la lezione in classe • Di valorizzare la cooperazione tra pari • Di tenere alta l’attenzione per tutta la durata dell’attività • Di mantenere aperte ogni riflessione di gruppo
consente dunque
• La partecipazione attiva degli studenti • L’interdisciplinarietà dei contenuti • Il lavoro di gruppo
Ringrazio la Scuola, il Dirigente Scolastico, prof. Renato Miceli, il tutor, la prof.ssa Irene Carci e i docenti per l’interesse e la partecipazione mostrate per tutta la durata del corso. Infine sono riconoscente alla prof.ssa Mirella Cannata per il lavoro di preparazione del prodotto finale sviluppato dai corsisti.
Pedace 30/12/2009 Prof. Andrea Checchetti

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 6
DIDATTICA
E
LABORATORIO

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 7
E’ facilmente constatabile che nelle scuole del nostro territorio non ci sia una concreta pratica di laboratorio che consenta agli studenti di essere protagonisti attivi del loro saper fare. Allo stesso tempo l’insegnamento-apprendimento delle scienze ha sicuramente toccato un punto molto basso della scala dei valori della scuola. Al di là delle carenze di risorse, è l’organizzazione complessiva del sistema scolastico in quanto a spazi, tempi e preparazione degli insegnanti che andrebbero rivisti e riformati.. I risultati degli ultimi rapporti OCSE-PISA dei nostri studenti dimostrano quanto i modelli di trasmissione del sapere scientifico non siano più sufficienti e quanto sia impellente mettere in campo nuove pratiche, nuovi modelli, nuovi curricoli della conoscenza scientifica e tecnologica a partire dalla scuola dell’obbligo. La messa in opera di questo progetto PON dell’Istituto Comprensivo di Pedace io credo abbia centrato una serie di obiettivi fondamentali per stimolare il rapporto che ogni docente instaura con il sapere scientifico al fine di valorizzare la didattica in cui il laboratorio è il luogo senza il quale non c’è apprendimento, lo spazio nel quale lo studente è in grado di scoprire e costruire la propria visione del mondo e della realtà che lo circonda. In questa direzione si è cercato nell’ambito del progetto di far incontrare due visioni di concepire il laboratorio: da un lato come spazio-tempo di verifica delle leggi, officina per acquisire abilità del misurare e dall’altro come terreno fertile per sviluppare un pensiero critico, capace di fondere le abilità manuali con quelle mentali per creare le giuste sinergie tra il pensare e l’agire, in modo da condividere teorie, concetti con l’elaborazione e il procedere sperimentale. La didattica laboratoriale costituisce dunque uno strumento di forte innovazione che il Piano ISS ha introdotto nella filiera formativa che va dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Utilizzare la didattica laboratoriale significa per l’insegnante guidare processi di auto-apprendimento quali l’analisi, l’osservazione, il confronto, la ricerca di diversi itinerari possibili nella soluzione di un problema che consentono così agli studenti di diventare i protagonisti, attori di un processo in cui acquisiscono competenze. In quest’ottica l’attività di laboratorio promuove la discussione, la riflessione, il ragionamento. Scienze e laboratorio dunque come momento d’incontro per apprendere insieme le strategie necessarie, gli strumenti utili per risolvere un problema. In questo contesto le mappe concettuali rappresentano l’aspetto più qualificante del processo di insegnamento/apprendimento che permettono di esplicitare e sintetizzare e infine valutare l’attività svolta.

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 8

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 9
IL PROGETTO

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 10
Le trasformazioni chimiche
Competenze
• Conoscere la legge della conservazione della massa • Conoscere gli acidi e le basi • Comprendere quando avviene una reazione chimica mediante la formazione di
un solido, il cambio di colore, un’effervescenza, un aumento o diminuzione della temperatura
Attività di laboratorio
1. Trasformazione di sostanze con la temperatura Obiettivi: introduzione al concetto di trasformazione chimica mediante l’osservazione di fenomeni causati dal calore
2. Sviluppo di gas Obiettivi: Constatare che un gas possiede una massa e verificare la legge della conservazione della massa
3. Reazione di un acido forte con una base forte Obiettivi: definire il carattere acido, basico e neutro delle sostanze nelle soluzioni acquose attraverso una reazione chimica.
I principi nutritivi
Competenze
• Saper riconoscere le macromolecole che costituiscono i componenti principali degli alimenti
• Saper riconoscere le trasformazioni a cui vanno incontro le macromolecole
Attività di laboratorio
4. Saggi di riconoscimento degli zuccheri Obiettivi: Stabilire la presenza degli zuccheri in diverse sostanze
5. Saggi di riconoscimento degli amidi Obiettivi: Stabilire la presenza degli amidi in una serie di campioni di cibo
6. Saggio sulle proteine Obiettivi: Constatare la coagulazione delle proteine in alcune sostanze
7. Saggio di riconoscimento dei lipidi: Obiettivi: Constatare la presenza di lipidi in alcune sostanze

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 11
I circuiti elettrici
Competenze
• Saper realizzare semplici circuiti elettrici • Conoscere i componenti di un circuito elettrico • Conoscere le unità di misura della corrente e della tensione nel sistema
internazionale • Saper schematizzare un circuito elettrico
Attività di laboratorio
8. Conduttori e isolanti Obiettivi: indagare sul comportamento elettrico di diverse sostanze distinguendole in conduttori ed isolanti
9. La corrente nei circuiti elettrici in serie Obiettivi: indagare sulle proprietà della corrente elettrica nei circuiti in serie
10. La corrente nei circuiti elettrici in parallelo: Obiettivi: indagare sulle proprietà della corrente elettrica nei circuiti in parallelo
Le forze
Competenze
• Comprendere e spiegare il concetto di forza • Descrivere le forze fondamentali della natura • Distinguere la massa dal peso • Comprendere il concetto di equilibrio tra forze • Conoscere le unità di misura della forza e della tensione nel sistema
internazionale
Attività di laboratorio
11. Statica dei fluidi Obiettivi: applicazioni del principio di Archimede, misura del peso specifico di un liquido e di un solido
12. Le leve Obiettivi: distinguere i tre diversi tipi di leve

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 12
Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:
• Presentazione del progetto e somministrazione di un test d’ingresso di autovalutazione
• Discussione guidata sugli argomenti scelti per il corso • Attività laboratoriale • Spiegazione delle prove effettuate e raccolta dei dati • Elaborazione di diagrammi di Gowin • Produzione di mappe concettuali
Metodologie che sono state utilizzate:
• Presentazione dell’attività laboratoriale • Cooperative learning • Problem solving • Mappe concettuali

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 13
I DIAGRAMMI DI GOWIN

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 14
DIAGRAMMA DI GOWIN
Il metodo del diagramma di Gowin è uno strumento didattico elaborato in ambito cognitivista, allo scopo di favorire l’apprendimento e di consentire una verifica dei livelli di comprensione e di rielaborazione raggiunti dallo studente. Come tutte le metodologie di ispirazione cognitivista, non si tratta di un procedimento meccanico e chiuso; esso però risulta realmente efficace soltanto se inserito in uno stile di lavoro che privilegi la rielaborazione attiva da parte dello studente. Gli studenti apprendono rielaborando informazioni e conoscenze con la tecnica del problem solving. Posti di fronte al problema, cercano di utilizzare le conoscenze in loro possesso per risolverlo. Il problema può essere di diversi tipi: dimostrare un teorema, comprendere una lezione, produrre un testo, eseguire un’esercitazione di laboratorio .... . In ogni caso, si assiste ad un tentativo di rielaborazione della conoscenza condotto attraverso strategie conosciute e il docente non ha la funzione di generatore di apprendimento, ma sempre quella di facilitatore.
L'apprendimento è dunque, in una prospettiva cognitivista, un processo costruttivo durante il quale lo studente assimila nuovi "materiali cognitivi" , familiarizza con essi e procede a ristrutturare in modo più o meno approfondito il proprio sistema cognitivo. Lo studente viene inoltre aiutato dal docente ad osservare e a controllare le proprie modalità di apprendimento, confrontandole con quelle di altri e localizzando i punti deboli nel complesso di strategie a sua disposizione. Da ciò ha origine un lavoro che conduce assai spesso a sensibili miglioramenti nelle prestazioni cognitive, e sempre ad una migliore consapevolezza di sé. Il docente viene percepito non tanto come un dispensatore di conoscenze da replicare meccanicamente, ma come un collaboratore nel processo di rielaborazione cognitiva.
Sono molteplici i modi attraverso i quali il docente può stimolare la rielaborazione personale, "attiva", da parte dello studente. Il principio è sempre lo stesso: un problema, di qualsiasi natura, non è un abisso che il docente debba affrettarsi a colmare, ma una risorsa da utilizzare per l'apprendimento. Questo vale anche per i problemi più semplici e all'apparenza più banali.
In generale, lo studente si abitui a non vedere nell'insegnante il solutore dei suoi problemi, ma il collaboratore alla ricerca della soluzione. Lo spiegare e rispiegare, in termini sempre più "semplici", gli stessi concetti, fa dell'insegnante un protagonista infelice, che finisce per seguire la strada più lunga e meno produttiva – alla fine, in qualche modo, lo studente dovrà pure arrivare alla comprensione da sé. Occorre rovesciare l'atteggiamento di attesa passiva e promuovere (con fiducia, mai in maniera aggressiva) l’elaborazione personale. Dunque: fare molte domande, far sentire gli studenti continuamente interpellati; fermarsi a metà di un'argomentazione e fare trarre agli studenti le conclusioni; far rielaborare dagli studenti paragrafi o lezioni frontali, mediante l'uso, p.es. di mappe concettuali; fare analizzare casi concreti con l’uso dei diagrammi di Gowin.

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 15
Il diagramma di Gowin è stato proposto, negli USA negli anni 80, per aiutare a riflettere su come si impara e su come si costruisce la scienza ed è stato generalizzato ad altri campi e a tutti i livelli scolastici. Si tratta di uno strumento utile per capire la struttura della conoscenza e il processo della sua costruzione.
”Il lato sinistro del diagramma è quello del’elaborazione del pensiero e il lato destro è quello della programmazione dell’azione.”
La V segnala, con la sua forma a punta, gli eventi o gli oggetti che stanno alla radice di tutta la produzione del sapere ed è fondamentale che gli studenti abbiano ben chiaro su che cosa stanno sperimentando. Il diagramma costringe in qualche modo a riconoscere l’effetto reciproco tra il sapere disciplinare costruito attraverso il tempo e la conoscenza che quella specifica indagine, in quel momento e in quella situazione, permette di costruire.

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 16
DIAGRAMMA A V (Scoprire la struttura e il significato della conoscenza)
VERSANTE CONCETTUALE VERSANTE METODOLOGICO
(Pensiero) (Azione)
(8) TEORIA (5) ASSERZIONE DI CONOSCENZA
I principi generali che guidano Sono le risposte alle domande focali e
l’indagine e spiegano perché gli eventi rappresentano delle interpretazioni logiche
o gli oggetti manifestano ciò che viene delle registrazioni e dell’elaborazione dei
osservato. dei dati da esse ricavati.
(1)
DOMANDA FOCALE
Domande che servono
a far convergere l’inda-
gine sugli eventi o
gli oggetti studiati
(7) PRINCIPI (4) ELABORAZIONE
Affermazioni di relazioni tra i concetti che Tabelle, grafici, mappe concettuali, statistiche e
spiegano come si può prevedere che altre forme di organizzazionedelle registrazioni.
appaiano o si comportino gli eventi o gli
oggetti
(6) CONCETTI (3) DATI EMERSI (registrazioni)
Sono le rrappresentazioni ioni degli eventi Dati rilevati dalle oservazioni
definiti con parole –chiave degli eventi presi in esame
(2)
PROGETTAZIONE DELL’ESPERIMENTO
Descrizione del materiale occorso durante la
sperimentazione e delle modalità di esecuzione.
Nota - Diagramma a V della conoscenza: tutti gli elementi presenti nel diagramma interagiscono tra di loro nella creazione della struttura e del significato della conoscenza.

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 17
CHE COSA È Il diagramma a V è uno strumento euristico. E' stato concepito per aiutare studenti ed insegnanti a chiarire a se stessi la natura e lo scopo delle attività sviluppate. A CHE COSA SERVE Per chi impara:
• visualizzare i nessi tra la fase sperimentale della ricerca e la fase analitico-cognitiva
• visualizzare la natura dei concetti • esplicitare le relazioni tra essi • rappresentare graficamente le conoscenze • favorisce quindi la meta-cognizione
Per chi insegna: • valutare il livello di concettualizzazione • far emergere la struttura cognitiva di costruzione della conoscenza.
Il diagramma ha l'obiettivo di mettere in relazione le teorie generali con il percorso sperimentale che si sta attuando.
COME SI USA Gowin prevedeva 5 domande di base per la costruzione del diagramma:
1. qual è la domanda di partenza 2. quali sono i concetti chiave 3. quali metodi si utilizzano per cercare la risposta 4. quali sono le asserzioni di conoscenza a cui si arriva 5. quali sono le asserzioni di valore
Dopo aver definito eventi e domande, si inizia dal lato destro in basso della V procedendo nel verso della freccia riportata in figura.

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 18
1. Vengono definiti gli eventi (qualunque cosa accade o possa esser fatta accadere), e gli oggetti (qualunque cosa sia possibile osservare) da osservare e si trascrivono sul vertice della V
2. Si individua la domanda focale che contiene la tesi da dimostrare o l’ipotesi da verificare; si introduce l'idea della registrazione dei dati
3. Si procede alla raccolta dei dati relativi all’evento prodotto e/o osservato; in questa fase avviene la sola trascrizione delle informazioni quanti-qualitative rilevate
4. definire i concetti (una "regolarità", un insieme di caratteristiche costanti riscontrata negli eventi o negli oggetti e designata con un nome)
5. si elaborano i dati operando confronti , individuando costanti e variabili, e ogni altra operazione che sia connessa con la domanda focale
6. dai risultati delle elaborazioni si formulano le asserzioni di conoscenza (le risposte alle domande da cui siamo partiti)
7. sono riportati i concetti incontrati durante tutto la fase sperimentale 8. si passa all’inserimento dei principi (le relazioni di significato tra due o più
concetti che guidano la nostra comprensione di ciò che accade negli eventi studiati) e teorie (relazioni tra concetti che organizzano i concetti ed i principi in modo da descrivere i fenomeni e le asserzioni di conoscenza). I principi ci dicono il come e le teorie il perché
9. si inseriscono infine le asserzioni di valore che conducono alla esplicitazione delle visioni del mondo, la filosofia di riferimento che orienta la ricerca della risposta alla domanda.

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 19

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 20

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 21

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 22

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 23

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 24

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 25

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 26

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 27
LE MAPPE CONCETTUALI

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 28
Le mappe concettuali La mappa concettuale è un importante strumento meta-cognitivo che sintetizza a grappolo concetti correlati fra di loro
Recenti ricerche hanno dimostrato che i discenti e gli insegnanti hanno quasi sempre delle conoscenze difettose o errate in quasi tutti i campi della conoscenza studiati e che queste conoscenze errate sono notoriamente difficili da superare con l’istruzione tradizionale. E’ stato dimostrato che l’uso delle mappe concettuali è efficace nel rimediare a tali conoscenze errate, soprattutto quando i discenti iniziano con una mappa concettuale "esperta" valida e quando lavorano in modo collaborativo per costruire un nuovo modello di conoscenza Per chi impara • Consente di visualizzare la natura dei concetti
• Permette di stabilire le relazioni tra essi
• Permette di individuare le relazioni gerarchiche
• Consente di visualizzare l’architettura di un modulo
• Permette di rappresentare graficamente le conoscenze
• Favorisce quindi la meta-cognizione Per chi insegna • Permette di valutare il livello di concettualizzazione;
• Permette di far emergere la struttura cognitiva;
• Consente la rappresentazione grafica e concisa delle conoscenze. Perché le mappe? L'apprendimento e l'insegnamento tradizionale o meccanico consiste nella trasmissione e nell'acquisizione di conoscenze attraverso la pura e semplice memorizzazione dei contenuti.
Le mappe cognitive e concettuali permettono, invece, un apprendimento significativo, creativo e attivo. L'alunno è costretto ad operare con il testo e con i concetti per compiere operazioni mentali complesse: scoprire, selezionare, collegare, gerarchizzare, mettere in relazione e generalizzare le nuove conoscenze. Modalità d’utilizzo didattico • Esplorare le preconoscenze
• Per scrivere un testo
• Per comprendere

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 29
• Per spiegare
• Per riorganizzare/ sintetizzare attività didattiche
• Mappe per progettare ipertesti

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 30
1. Le trasformazioni della materia

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 31
2. I Principi nutritivi

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 32
3. I circuiti elettrici

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 33
4. Le forze

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 34
Bibliografia

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 35
1. Ausubel D., Educazione e processi cognitivi, FrancoAngeli, Milano 1995 2. Canas A.J., Novak J. D., Concept Maps: Theory, Methodology, Technology,
Proceedings of Second International conference on Concept Mapping, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, vol . I, pp. 449-456, 2006.
3. Comoglio M., Cardoso M. A., Insegnare e apprendere in gruppo: il cooperative learning, Roma, LAS, 1996
4. Frabboni F., Il Laboratorio, Laterza, Bari 2004 5. Guastavigna M., Graficamente, Carocci, Roma, 2007 6. Novak J. D., L’apprendimento significativo. Le mappe concettuali per creare
e usare la conoscenza, Erickson, Trento, 2001 7. Roletto E., La scuola dell’apprendimento, Trento, Erikson, 2005

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 36
INDICE ANALITICO

Scienze e laboratorio A.S. 2008/2009
I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ R i t a P i s a n o ” d i P e d a c e ( C s )
Pagina 37
Introduzione pag. 3
La didattica laboratoriale pag. 6
Il Progetto pag. 9
I diagrammi di Gowin pag. 13
Le mappe concettuali pag. 27
Bibliografia pag. 34
Indice analitico pag. 36
Andrea Checchetti