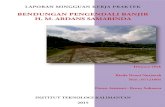rivista mensile fondata da pietro nenni 1 · mondope raio rivista mensile fondata da pietro nenni m...
Transcript of rivista mensile fondata da pietro nenni 1 · mondope raio rivista mensile fondata da pietro nenni m...

mondoperaiorivista mensile fondata da pietro nenni
mon
dope
raio
1/2
015
10 euro
Post
e Ita
liane
S.p
.a. S
pedi
zione
abb
onam
ento
pos
tale
DL 3
53/2
003
(conv
. in l.
27/0
2/04
N. 4
5 ar
t. 1
com
ma
1) D
BC R
OMA
ISSN 0392-1115
praga-roma e ritornocaccamo > intiniquadrante raffone > bloise > scansani > benzonicraxi 2000-2015zoller maccanico e pertinirolando > acquavivamemorie postumegerardipinelli > monaco > magnani > miele > pagnotta > pombeni > bellinazziemiliani > carrieri > crisafulli > romano > di matteo > lo presti > giuliani > covatta
1gennaio 2015

sommario / / / / mondoperaio 1/2015
>>>> sommario
mondoperaiorivista mensile fondata da pietro nenni 1
gennaio 2015
Direttore Luigi Covatta
Comitato di direzioneGennaro Acquaviva, Alberto Benzoni, Luigi Capogrossi, Simona Colarizi, AntonioFuniciello, Pio Marconi, Corrado Ocone,Luciano Pero, Cesare Pinelli, MarioRicciardi, Stefano Rolando.
Segretaria di redazione Giulia Giuliani
Collaborano a MondoperaioPaolo Allegrezza, Salvo Andò, Federigo Argentieri, Domenico Argondizzo,Antonio Badini, Valentino Baldacci,Maurizio Ballistreri, Antonio Banfi,Giovanni Bechelloni, Luciano Benadusi,Felice Besostri, Paolo Borioni, Enrico Buemi,Giampiero Buonomo, Dario A. Caprio,Giuliano Cazzola, Stefano Ceccanti, Luca Cefisi, Enzo Cheli, Zeffiro Ciuffoletti,Luigi Compagna, Carlo Correr, Piero Craveri,Bobo Craxi, Biagio de Giovanni, EdoardoCrisafulli, Gianni De Michelis, GiuseppeDe Rita, Mauro Del Bue, Danilo Di Matteo,Emmanuele Emanuele, Marcello Fedele, Aldo Forbice, Federico Fornaro, FrancescaFranco, Valerio Francola, Ernesto Gallidella Loggia, Vito Gamberale, TommasoGazzolo, Marco Gervasoni, GustavoGhidini, Ugo Intini, Massimo Lo Cicero,Emanuele Macaluso, Gianpiero Magnani,Bruno Manghi, Michele Marchi, PietroMerli Brandini, Matteo Lo Presti, Matteo Monaco, Enrico Morando, RiccardoNencini, Piero Pagnotta, Giuliano Parodi,Gianfranco Pasquino, Claudio Petruccioli,Giovanni Pieraccini, Carmine Pinto,Gianfranco Polillo, Paolo Pombeni, MarcoPreioni, Mario Raffaelli, Paolo Raffone,Giorgio Rebuffa, Giuseppe Roma,Gianfranco Sabattini, Giulio Sapelli,Giovanni Scirocco, Luigi ScoppolaIacopini, Carlo Sorrentino, Celestino Spada,Giuseppe Tamburrano, Giulia Velotti,Tommaso Visone, Bruno Zanardi, Nicola Zoller.
Direzione, redazione, amministrazione, diffusione e pubblicità00186 Roma - Via di Santa Caterina da Siena, 57tel. 06/68307666 - fax. 06/[email protected]
Impaginazione e stampaPonte Sisto - Via delle Zoccolette, 25 - 00186 Roma
© Mondoperaio Nuova Editrice Mondoperaio Srl
Presidente del Consiglio di AmministrazioneOreste Pastorelli
Riproduzione vietata senza l’autorizzazionedell’editore. Il materiale ricevuto anche se nonpubblicato non si restituisce.
Ufficio abbonamenti Roberto Rossi
Abbonamento cartaceo annuale € 50Abbonamento cartaceo sostenitore € 150Abbonamento in pdf annuale € 25Singolo numero in pdf € 5Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento con carta di credito o prepagata sul sito:mondoperaio.netoppure tramite c/c postale n. 87291001intestato a Nuova Editrice Mondoperaio srlVia di Santa Caterina da Siena, 57 - 00186 Romaoppure bonifico bancario codice IBAN IT46 Z0760103 2000 0008 7291 001 intestato a Nuova Editrice Mondoperaio Srl
Aut. Trib. Roma 279/95 del 31/05/95Questo numero è stato chiuso in tipografia il 19/01/2014 www.mondoperaio.net
editoriale 3Luigi Covatta Charlie
craxi 5Nicola Zoller Celebrazione di un latitante
praga – roma e ritorno 11Francesco Caccamo Quando Pelikan scelse l'Italia Ugo Intini Le colonne d’Ercole del Pci
saggi e dibattiti 23Cesare Pinelli La disobbedienza non è più una virtùMatteo Monaco Di che sinistra è RenziGianpiero Magnani Vivere senza lavoroMatteo Miele La Cina a due velocitàPiero Pagnotta Modesta proposta per risparmiarePaolo Pombeni Un riformista cristiano Paolo Bellinazzi L’Italia refrattariaSimone Emiliani Se quantità non fa qualità
maccanico e pertini 63Stefano Rolando Simboli e potere Gennaro Acquaviva La resistenza di una élite
memorie postume 71Franco Gerardi Gabinetto rovesciato
memoria 72Cesare Pinelli L’osservatore della democrazia
biblioteca/recensioni 73Mimmo Carrieri Il lavoro salariato e la sua storia Edoardo Crisafulli Giacobinismo fuori tempo
aporie 84Antonio Romano Le barricate della satira
biblioteca/schede di lettura 85Danilo Di Matteo Orientarsi senza vento Matteo Lo Presti Viaggio nel Bel Paese
quadrante 89Paolo Raffone Il semestre inutileGaetano Bloise Chi ha paura di Putin e TsiprasEmanuele Scansani Il Beijing Consensus Alberto Benzoni Le eque sanzioni

Je suis Charlie è la pietosa ma rassicurante menzogna dietrola quale cerca riparo un Occidente che finora aveva volentieri
appaltato la questione islamica, se non alle retoriche dei vignet-tisti, all’attenzione dell’intelligence ed alla potenza dei droni: eche ora sbanda fra la sguaiataggine dei crociati alla milanese ela vaghezza di un’union sacré all’insegna della matita.Lasciamo stare, estranei come sono al nostro orizzonte cultu-rale, gli argomenti di chi semina il panico evocando lo spettrodello sgozzatore della porta accanto. Ma gli altri, quelli chehanno marciato a Parigi e che in un modo o nell’altro ci rap-presentano, davvero pensano di cavarsela con la litania propi-ziatoria dell’Islam “moderato”? O non è giunto il momento diaffrontare seriamente i tanti e diversi problemi che l’insor-genza islamica ci pone, e di chiederci, per esempio, come mail’Islam “moderato” oggi si incarna nella figura poco mode-rata di un generale egiziano? E perché in seno all’Islam nonc’è una Rossana Rossanda che abbia il coraggio di sfogliareil proprio album di famiglia (come, fra tante affermazioniinfelici, ha felicemente osservato Giuliano Ferrara )?Evidentemente non per una tara genetica. Probabilmente per-ché da tempo, rispetto all’Islam, l’Occidente ha deposto quellestesse armi della critica già usate non senza successo controfanatismi di altra origine; e perché da tempo, del resto, quellestesse armi non vengono indirizzate neanche a neutralizzare itanti piccoli fanatismi di cui è ricca la nostra, di civiltà: quellila cui origine Giuliano Amato ha di recente ricondotto all’idea“di una libertà dai contenuti indefiniti, destinata a definirsi intermini sempre più ampi via via che si avverte il bisogno, o laconvenienza, o l’utilità di comportamenti contrastati da osta-coli legali”: per cui, per esempio, “la satira ha prevalso sull’o-nore delle istituzioni”; e per cui, si può ora aggiungere, solo lasapienza cristiana di papa Francesco e quella laica del NouvelObservateur hanno osato sfidare il politicamente corretto nelvalutare l’opportunità di certe vignette e di certe caricature.Politicamente corrette, del resto, sono anche le “dottrine” chel’Occidente ha elaborato per convivere con l’Islam: quella sepa-razione multiculturale che, a forza di “rispettare” l’altro, inrealtà lo rinchiude in un ghetto che ne protegge non solo la
diversità, ma un’irrilevanza con la quale non vale la pena di con-frontarsi; oppure quella laicità giacobina che ha fatto un desertoe lo ha chiamato libertà religiosa (e che, d’altra parte, vent’annifa digerì la conversione di Garaudy portandolo in tribunale pernegazionismo); o infine quella dello “scontro di civiltà” evocatoa proposito e a sproposito senza neanche pagare i diritti d’autoreall’ignaro (e ignorato) Samuel Huntington. Per carità: anche l’obiettivo dei Lumi, in un primo momento,fu quello puro e semplice di écraser l’infame. Ma poi peralmeno due secoli il conflitto fra città di Dio e città degliuomini fu alimentato da migliaia di intelligenze, da una partee dall’altra, fino a costituire l’ossatura della nostra democra-zia: mentre oggi, in Occidente, non si vede l’ombra né di unJacques Maritain né di un Benedetto Croce, ed il confronto sitrasferisce dalle aule universitarie e parlamentari alle piazze,virtuali o reali che esse siano. Le armi della critica, quindi, sono spuntate. Quanto alla cri-tica delle armi, poi, meglio non parlarne. Meno di due anni fasolo l’iniziativa di papa Francesco scongiurò il rischio che itagliagole dell’Isis venissero armati e finanziati dall’Occi-dente per portare a termine la guerra contro Assad: mentredue anni prima nessuno intervenne perché non accadessealtrettanto in Libia, ed oggi una guerriglia condotta da pochedecine di migliaia di fanatici in Africa e nel Medio Orientesembra poter tenere il mondo sotto scacco. Sergio Romano, sul Corriere dell’11 gennaio, ha opportuna-mente ricordato che quando nel secolo scorso fanatici di tra-dizione cristiana si apprestavano a sterminare sei milioni diebrei, Churchill disse che se Hitler avesse invaso l’inferno luinon avrebbe esitato a parlare bene del diavolo alla Camera deiComuni; ed ha anche fatto presente che Rouhani, Assad, AlSisi e Putin, comunque, non sono il diavolo. Ma nel frattempol’Occidente che marcia dietro la matita di Charlie tieneancora acceso il focolaio ucraino e si fa paralizzare dai veti diNetanyahu nel rapporto con l’Iran.In questi giorni è morto Francesco Rosi, che fra l’altro avevafatto parte di quell’Assemblea nazionale del Psi che troppi cre-tini ancora oggi associano ai nani e alle ballerine. Nelle (un
/ / 3 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / editoriale
>>>> editoriale
Charlie>>>> Luigi Covatta

/ / 4 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / editoriale
po’ avare) rassegne commemorative che qualche emittente gliha dedicato è stato riproposto anche Il caso Mattei: e facevauna certa impressione, dopo che i telegiornali avevano docu-mentato l’impotenza dei potenti, sentire la determinazione concui Gian Maria Volontè rivendicava il sostegno a Mossadeq edal Fronte di liberazione algerino: tanto da far pensare che nelrogo di Bascapè fosse andata perduta anche la nostra capacitàdi influenzare l’evoluzione delle nazioni di tradizione islamica. Rosi ha avuto la fortuna di morire nei giorni degli sciacalliparigini, per cui gli è stato risparmiato il carnevale che haaccompagnato alla tomba un altro artista napoletano. Non gliè stato risparmiato, però, lo stereotipo: nel caso, quello di per-secutore degli “scandali italiani”, come ha detto il giornaleradio della rete cult della Rai, scambiandolo per un autore didocufiction da talk show. Invece, come ha giustamente detto Raffaele La Capria, Rosiera innanzitutto un poeta: un poeta civile che sapeva raccon-tare gli eventi nei minimi particolari, ma sempre secondocategorie universali. Ero al liceo quando vidi Salvatore Giu-liano, e se il racconto mi documentò il banditismo, il lamentodella madre del bandito mi fece capire la tragedia greca. Eroun po’ più grande quando uscì Mani sulla città, e mi convinsidella nobiltà della politica anche identificandomi nella figuradi Carlo Fermariello che interpretava se stesso nel Consigliocomunale di Napoli. E facevo già politica da tempo quandoCadaveri eccellenti mi confermò nella diffidenza verso gliapparati polizieschi e giudiziari.Al funerale del regista Giorgio Napolitano ha riservato la sua
ultima uscita pubblica. Rosi era suo coetaneo, suo concitta-dino, ed aveva frequentato il suo stesso liceo: ed ognuno ha icompagni di scuola che si merita. L’augurio, ora che Napoli-tano ha dovuto cedere al peso dell’età, è che egli abbia ancheil successore che si merita. Su un mensile, fortunatamente, non si è obbligati a parteciparea quel gioco del Totoquirinale al quale i quotidiani non pos-sono sottrarsi. Si possono e si debbono, però, indicare razio-nalmente i termini del problema che dal 29 gennaio dovràrisolvere l’assemblea che si riunirà a Montecitorio. E se lo siè già fatto in un’altra occasione, tanto vale ripetersi. Nelnumero di ottobre del 2012 scrivevo: “La presidenza di Gior-gio Napolitano, pur mantenendosi rigorosamente entro i limitifissati dalla Costituzione, ha innovato profondamente la prassiseguita dai suoi predecessori. Perciò l’elezione del suo suc-cessore sarà un impegno particolarmente arduo, perché si trat-terà di affidare l’esercizio di una prassi costituzionale parzial-mente nuova ad una personalità adeguata”.Allora, per la verità, ero fra quanti (pochi) auspicavano cheNapolitano succedesse a se stesso, nonostante la sua riluttanza equalche suo amichevole rimprovero. Adesso, dopo che quell’au-spicio si è comunque realizzato, e che d’altra parte il presidenteha deciso di concludere il suo mandato, non ho una parola daaggiungere. E non è neanche il caso di perdere tempo per parte-cipare a quell’altro gioco di società che è il profiling del presi-dente ideale. Il presidente ideale lo abbiamo già avuto, ed ora c’èsolo l’esigenza di garantire una successione che sia il più possi-bile coerente con i nove anni che ci stanno alle spalle.

/ / 5 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / craxi
>>>> craxi
C’è una sorta di amnesia collettiva sotto la seconda Re-pubblica italiana, e riguarda la storia del più vecchio
partito della sinistra, fondato a Genova nel 1892: precisamentela storia del socialismo italiano, espunta dalla memoria comunegrazie anche alla caparbia ostilità di vecchi e nuovi politici il-liberali e di intellettuali faziosi col paraocchi. C’è il casoesemplare di Paul Ginsborg, storico inglese naturalizzatoitaliano, docente all’Università di Firenze, che racconta al-l’incredulo Vittorio Foa di non aver inserito il Psi e i socialistinella sua einaudiana Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi.Società e politica 1943-1988 semplicemente perché a suoavviso i socialisti «non esistevano». Foa – che dirigente socialista nel dopoguerra lo è stato alungo, oltre che punto di riferimento per tutta la sinistraitaliana – rivela incredulo questa assurda considerazione nellasua opera Il cavallo e la torre edita nel 1991. Anche le datesono qui importanti per capire il senso delle cose: la ponderosaStoria di Ginsborg è stata pubblicata nel 1989, pensata escritta proprio in quel decennio in cui gli esponenti del Psi ac-cedevano alla presidenza della Repubblica e del Consiglio deiministri, dunque in un periodo di massima visibilità e benprima della caduta del Psi sotto le macerie di Tangentopoli.Lo sottolineiamo perché anche da questo elemento appareplausibile che le accuse di corruzione che hanno contrassegnatola fine del Psi tra il 1992/1993 si siano incanalate in una inten-zionale, deviante operazione di pulizia storico-politica - e poidi polizia tout court - preordinata da tempo. Cosicché è statopiù agevole utilizzare le vicende giudiziarie nel crudo confrontopolitico dei primi anni ’90 (Francesco Alberoni - in Valori,Rizzoli, 1993 - rammenta che soprattutto nelle fasi di transizione«la lotta politica è praticamente tutta combattuta con accusedi immoralità»), per conseguire l’obiettivo politico di unacinica damnatio memoriae annullando la presenza del Psi:non solo di quello craxiano degli anni ’80, ma - come abbiamovisto con la storia ginsborgiana – di tutto il dopoguerra. Epperò l’obiettivo principale riguardava proprio il riformismodel periodo craxiano, come ha spiegato Bruno Pellegrino conL’eresia riformista (Ed. Guerini e Associati, 2010). Commen-
tando questa argomentata ricerca, Pierluigi Battista sul Corrieredella Sera del 13 aprile 2010 rilevava che si è relegatonell’oblio quel mosaico riformista che aveva interessato ognicomparto della cultura, portando «una ondata di riflessioni einnovazione dalle nuove professioni all’informazione, dalcinema all’arte, dall’architettura alle scienze giuridiche, dallastoriografia alla politologia». Col paradosso – aggiungeva –che chi nella sinistra politica aveva ingiuriato fino ad unmomento prima il riformismo in odio ai socialisti, ha poi co-minciato a farsene all’improvviso interprete e vessillifero.
«Dal 1950 al 1990 il reddito nazionalecresce di circa cinque volte collocandol’Italia fra i paesi a più elevato tenore
di vita nel mondo»
Interprete «insincero» però, precisa Battista. Perché i parvenudel riformismo non possono che procedere verso una «desolanteparabola», incapaci come sono di riconoscersi fino in fondonella cultura riformista: cioè in quei valori che il Psi – tanto di-sconosciuto e dimenticato nella stagione politica della secondaRepubblica – aveva saputo rappresentare, e precisamente «lacultura di governo, l’attenzione alla modernità, il rifiuto deipregiudizi ideologici, il gradualismo, il garantismo, il rifiutodell’autoritarismo, insomma tutto il meglio del riformismo so-cialista». Questa è una storia da studiare e da riscoprire: perché– ricordava ancora Battista – «malgrado le perplessità di PaulGinsborg» – non a caso diventato poi vate dell’area sinistro-giustizialista e dell’effimero (questo sì) movimento dei ‘girotondi’con Pancho Pardi – «il riformismo socialista è esistito davvero».E può essere ancora un riferimento non solo utile ma necessarioper la rinascita di una moderna sinistra italiana. A quindici annidalla morte di Bettino Craxi vorremmo qui proporre alcunimeditati spunti, tratti principalmente proprio dalla rilettura dellaricerca - ancora di grande attualità - di Bruno Pellegrino.Ecco come viene concisamente definito il riformismo daAntonio Giolitti, quando diventa ministro del Bilancio nel1963: «L’esperienza di governo immunizza una volta per
Celebrazione di un latitante2000 - 2015
>>>> Nicola Zoller

/ / 6 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / craxi
>>>> craxi
sempre contro il rischio del fanatismo, obbliga a tenere apertigli occhi di fronte alla realtà […] Questa esperienza io feciallora, con indimenticabile trepidazione, e ne ho acquisito lavocazione ad un incorreggibile riformismo: a guardare benela realtà nei dettagli, nelle minuzie, ma conservando la capacitàdi alzare lo sguardo verso obiettivi più lontani e ambiziosi. In-somma, mi sono trovato costretto a imparare che nell’eserciziodell’attività politica in democrazia l’etica della convinzionenon può mai essere disgiunta dall’etica della responsabilità,anzi questa condiziona quella».Questo quadro culturale, questa visione dell’azione politica,contagerà in maniera permanente la parte più moderna delmondo politico progressista italiano, della cultura, del mondodel lavoro e della produzione, con riverberi diretti sulla crescitaeconomica e civile dell’Italia. È infatti in questa temperie chesi produce uno dei fenomeni più miracolosi e duraturi della
vita nazionale come testimonia Carlo M. Cipolla, tra i più au-torevoli storici economici europei: «Dal 1950 al 1990 ilreddito nazionale cresce di circa cinque volte collocandol’Italia fra i paesi a più elevato tenore di vita nel mondo».Sulle differenze tra socialisti e comunisti (differenze cherisalgono alla scissione dal Psi imposta da Mosca che portò allanascita del Pci nel 1921) c’è un flash illuminante su unapersonalità come Rodolfo Morandi, che diresse l’organizzazionedel Psi a cavallo tra gli anni ‘40 e ‘50. Prima di bruciaresull’altare dell’unità frontista social-comunista tante «intuizionifeconde», per Morandi fu chiara la distanza che separava isocialisti dai comunisti nell’intendere il rapporto fra classe epartito. «I primi pensavano – e Morandi era fra questi – che è lamassa ad esprimersi attraverso il partito, mentre i secondi rite-nevano che il partito è lo strumento per manovrare le masse».E’ questa una visione contrastante che più avanti sarà così

/ / 7 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / craxi
spiegata in termini filosofici da Norberto Bobbio su Mondo-peraio: «Per caratterizzare questa differenza in una parola,parlerei di una concezione laica della storia contrapposta auna concezione totalizzante, dove per concezione laica dellastoria s’intende che la storia non soltanto è fatta dagli uomini,ma per essere realmente umanizzata non deve essere concepitacome fatta da uomini che si credono in possesso, come dei, diuna verità assoluta da imporre anche ai recalcitranti». Iinsommauna concezione laica «dove non vi è più posto per i prìncipi,né per il vecchio principe cui Machiavelli aveva affidato ilcompito di liberare l’Italia dal ‘barbaro dominio’, né per ilnuovo principe – il partito - cui Gramsci affidava il compitodi trasformare la società».
Gli anni Ottanta furono anni fervidi per il riformismo socialista italiano
Sempre in tema di differenze tra socialisti e comunisti, Bobbiodeclinerà poi direttamente sul piano politico la sua propensionebocciando – in appoggio a Craxi – la vaga proposta del Pci diBerlinguer di una terza via tra comunismo marxista-leninistae socialdemocrazia con un intervento sulla Stampa del 1°set-tembre 1978: «Personalmente propendo a credere che questaterza via non esiste da nessuna parte e che sia un errore -dovuto a comprensibile ma non irreprensibile amor proprio,una volta bloccata e quindi irripetibile la via leninista, comegli stessi comunisti lasciano credere - voltare le spalle sde-gnosamente alla via già percorsa, anche se incompiuta e irtadi ostacoli, delle socialdemocrazie europee, e sforzarsi diescogitare nuove soluzioni anziché fare il ben più meritevolesforzo di seguire coloro che ci hanno preceduti. L’esito dellasocialdemocrazia non è garantito? Ma è pur sempre megliouna via in cui il successo non è garantito che non quella in cuila storia ha ormai dimostrato essere garantito l’insuccesso […]Non vedo come, escluso il leninismo, il movimento operaioitaliano possa fare a meno di confluire nel grande fiume dellasocialdemocrazia, rinunciando al progetto affascinante mainafferrabile di scavarsi un proprio letto, destinato probabilmentead accogliere una corrente di debole impeto e di corso breve».Riportiamo ora un ampio passo sulle origini dei retropensieriche hanno impedito in modo persistente alla sinistra italianadi derivazione comunista di inserirsi nell’alveo della sinistrasocialdemocratica e laburista europea. Di fronte alla consape-volezza del declino inarrestabile della propria ortodossia, dellafine della spinta propulsiva del comunismo. e per sfuggire alconfronto con l’eresia dei riformisti - gli avversari delle origini
che con Craxi hanno assunto le vestigia di un nemico abbietto,«un avventuriero e un bandito» da abbattere, scriverà nei suoiappunti Antonio Tatò - il Pci negli anni Settanta «trova con-veniente abbandonarsi all’abbraccio con l’altra ortodossiaitaliana, l’integralismo cattolico nella versione cattocomunista.Si consuma così – osserva Pellegrino - un matrimonio mono-gamico fra comunisti e sinistra cattolica che non sarà mai piùrotto e che produrrà effetti profondi sul Pci e sui destinidell’intera sinistra italiana. Il cattocomunismo si rivela unalbero robusto, con radici profonde in grado di sopravvivereal cataclisma del 1989 con la fine del comunismo sovietico eal crollo della prima repubblica.L’intreccio culturale e politico che si compie in seno al Pci fral’integralismo cattolico e comunista pone una pietra tombalesulle aspirazioni della corrente riformista del Pci di portare ilpartito all’approdo socialdemocratico europeo e di dar corpocon i socialisti italiani a una grande formazione politica ingrado di porsi come alternativa di governo, in un quadro di ri-ferimento occidentale. Paradossalmente, mentre il Psi continuaincessantemente a ripensarsi e a cambiare per tenere il passosulle innovazioni del socialismo europeo, il Pci non darà maicorso a una sua Bad Godesberg, ad una revisione profonda insenso socialdemocratico. L’idea, la pratica e finanche l’e-spressione ‘revisionismo’ continueranno ad essere inaccettabiliper la maggioranza dei comunisti italiani. Il Pci - gladius Dei,secondo la definizione di Franco Rodano, consigliere di Ber-linguer – finisce col sommare al proprio dogmatismo marxi-sta-leninista, ancorché in disarmo, il dogmatismo dei cattolicicomunisti entrambi ancorati all’assunto di un loro ruolosuperiore e messianico nella storia e nei destini del paese. Nesortiscono teorie politiche che non hanno riscontro nel restod’Europa e due generazioni di dirigenti politici e d’intellettualiche, smarriti, si pongono alla ricerca di indefinibili terze vie.Si predica un’austerità prossima al luddismo, si teorizzano su-periorità e diversità etiche e antropologiche, si sostituisce lagiustizia giusta con il giustizialismo, la morale con il moralismo,si coltiva il rancore per l’Occidente e gli avversari, si professail terzomondismo e il pacifismo filosovietico».Giungiamo ora ad un passaggio centrale. Ecco come LucianoPellicani espone su Critica Sociale (n.2/1980) la visione pro-gressista del Psi craxiano, che si potrebbe definire ‘neoilluminismoriformatore’ specchiandosi nelle pratiche liberal-socialiste e so-cialdemocratiche europee: «Ci sono due modi di intendere ilprogresso: c’è il modo romantico e c’è il modo illuministico.Per le filosofie romantiche della storia, il progresso è una irresi-stibile legge fondata sulla struttura della realtà. Negli scritti di

/ / 8 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / craxi
Comte, Hegel, Marx il processo storico è visto come un trafficoa senso unico, come una successione di avvenimenti messi ascala. Ognuno di questi avvenimenti è necessario e rappresenta,sempre e comunque, un passo avanti verso la meta finale, che èciò che tutta quanta l’umanità, lo sappia o no, desidera ardente-mente. Ne consegue che l’idea di regressione storica è bandita.Tutto ciò è assai consolante, ma anche illusorio». Per Pellicani esiste un altro modo di concepire la storia cheevita sia il conservatorismo paralizzante delle teorie chenegano l’idea stessa di progresso che l’illusorio ottimismodello storicismo romantico: «Tale modo è quello illuministico.Anche l’illuminismo ha prodotto filosofie progressiste. Mal’illuminismo non concepisce il progresso come una necessitàstorica. La concezione illuministica del progresso è problematica.Si basa sulla categoria della possibilità anziché su quella dellanecessità. In quanto socialisti non possiamo non appoggiarcia una filosofia progressista. Falsa è l’idea di trasformare ilprogresso in una legge necessitante e consolatoria, non già laconvinzione ragionata che possiamo compiere ulteriori passinella direzione di una società più vicina alla costellazione deivalori liberal-socialisti».Gli anni Ottanta furono anni fervidi per il riformismo socialistaitaliano: non solo perché coincisero con il lungo periodo deigoverni Craxi, ma anche perché sul piano teorico vennerorinverdite e reinterpretate le fertili teorie revisioniste del so-cialdemocratico tedesco Eduard Bernstein e di un altro grandepensatore, Carlo Rosselli, autore dell’opera Socialismo liberale,scritta al confino di Lipari ove il regime fascista lo avevarelegato prima di assassinarlo nel 1937. Questo fervore intel-lettuale porterà il socialismo italiano guidato da Craxi ad an-ticipare di qualche lustro una visione utile per tutti i progressistieuropei del XXI secolo, mentre la sinistra comunista italianasta ancora a fare i conti coi residui del leninismo. Al proposito Piero Fassino ammetterà in modo sferzante eautocritico verso la sinistra comunista e postcomunista:«Craxi è uomo profondamente di sinistra. Autonomista,anche all’epoca del Fronte popolare, ha uno spiccato sensodell’identità socialista rispetto all’area maggioritaria dellasinistra italiana, quella comunista. Certo, Craxi non esita afare della competizione a sinistra, puntando ad accrescere ledifficoltà del Pci, inducendoci a reagire nel modo peggiore,con un più alto livello di conflittualità. Ma resta il fatto cheil Pci non appare capace, negli anni ’80, di affrontare il temadella modernizzazione dell’Italia, spingendo così ceti innovatorie produttivi verso chi, come Craxi, dimostra di comprenderli»(Per passione, Rizzoli, 2003).
Altro che anni dissipati rappresentati da una frivola “Milano dabere”, l’icona spregiativa cui la propaganda populista di finesecolo volle ricondurre gli anni Ottanta. Furono anni impegnatinel «governare il cambiamento» attraverso una attiva meditazioneteorica: il socialismo non viene considerato come una metaprefissata meccanicamente, ma come un metodo d’azione («ilmovimento è tutto, il fine è nulla» affermava Bernstein). La so-cialdemocrazia è concepita come «liberalismo organizzatore»che promuove una giustizia retributiva atta a ben temperare l’e-conomia di mercato. I Club socialisti, partendo dagli studi diPaolo Sylos Labini sulle classi sociali, anticipano nel marzo1981 la teoria dei «meriti e bisogni» che Claudio Martelliproporrà alla Conferenza socialista di Rimini del 1982.
Si poteva e si doveva trovare una
soluzione politica generale al problema
del finanziamento dei partiti
«Le rivoluzioni tecnologiche – scrive a nome dei Club socialistilo stesso Bruno Pellegrino – comportano profonde trasformazioninell’organizzazione del lavoro, l’emergere di nuove figureprofessionali, l’estendersi della fascia di lavoratori intellettualiaddetti all’organizzazione della produzione, dei quadri intermedi,dei tecnici ad alta specializzazione. Gli sviluppi tecnologicifavoriscono, nelle società contemporanee avanzate, unariduzione del bisogno di mano d’opera nell’industria, mentrei servizi assorbono progressivamente occupazione e miglioranola qualità dell’offerta. Questa tendenza, visibile in tutti i paesidel mondo occidentale sviluppato, in Italia è accompagnatada un diffuso pregiudizio, soprattutto della cultura vetero-marxista, quasi che il settore dei servizi sia sinonimo di sprecoe di inefficienza, un costo da ridimensionare. Si pone laquestione della cosiddetta ‘centralità operaia’ che tanto hacondizionato la cultura politica della sinistra italiana. Senzaun allargamento del consenso ai ceti emergenti, ai ceti profes-sionali, agli addetti ai servizi è impossibile una politica diprogresso e di riforma in un sistema democratico. I lacci elacciuoli di una visione schematica delle classi e dell’organiz-zazione produttiva devono assolutamente saltare». Argomenterà poi Martelli alla Conferenza riminese teorizzandol’alleanza tra il merito e il bisogno: «Le donne e gli uomini dimerito, di talento, di capacità, sono le persone utili a sé e utiliagli altri, coloro che progrediscono e fanno progredire uninsieme o l’intera società con il loro lavoro, con la loro imma-ginazione, con la loro creatività, con il produrre più conoscenze:sono coloro che possono agire. Le donne e gli uomini immersi

/ / 9 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / craxi
nel bisogno sono le persone che non sono poste in grado diessere utili a sé e agli altri, coloro che sono emarginati o dallavoro o dalla conoscenza o dagli affetti o dalla salute: sonocoloro che devono agire. Senza tener ferma questa alleanza,questa duplicità di destinatari, il riformismo moderno rischierebbedi degenerare in opportunismo, o di rifluire nel classico mas-simalismo. Ancora, se separiamo il merito dal bisogno, il ri-formismo diviene o tecnocrazia o assistenzialismo; se inveceuniamo o alleiamo il merito e il bisogno, il riformismomoderno può produrre una svolta all’altezza dei tempi, puòinterpretare il tempo, può governare il cambiamento».Poi venne Tangentopoli a seppellire nel discredito una dellestagioni più prolifiche del riformismo italiano, un’eresia appunto.Ma questa è un’altra storia. O no? Scrive Sergio Romano inFinis Italiae (ed. All’insegna del pesce d’oro, 1995): «Intravedoall’orizzonte un’altra menzogna: gli italiani stanno addebitandoTangentopoli a Bettino Craxi e a qualche centinaio di uominipolitici, imprenditori, funzionari. Sanno che è una bugia, macederanno probabilmente alla tentazione di credervi per assolversiin tal modo da questo peccato. E dopo, temo, avranno un’altraragione per disprezzarsi». A tale proposito - aggiungo - èprobabile che l’autodisprezzo lieviterà ancora quando, raggiuntala consapevolezza di aver fatto dei socialisti i principali capriespiatori della cattiva coscienza nazionale, rileggeranno gli ina-scoltati richiami alla mitezza dei pochi garantisti che provavanoa proporre un richiamo al discernimento ed alla moderazionedurante la tracimazione dell’ondata illiberale e giustizialistadegli anni ‘90. «La molla di Craxi non era l’arricchimento per-sonale, ma la politica»: parole inascoltate dalla turba e dai capi-popolo a cui conveniva dipingere il leader socialista come unladro, addirittura un «criminale matricolato». Peccato, perché le inascoltate parole sopra citate provengonodall’insospettabile magistrato Gerardo D’Ambrosio e sonostate riportate in una intervista del 23 febbraio 1996. D’altrondemolti degli avversari di Craxi si finanziavano ben più corposa-mente del partito socialista, avendo nel contempo l’impostura- che Craxi per schiettezza non ebbe - di negare che la politicaha dovuto anche ricorrere a finanziamenti aggiuntivi rispetto aquelli ufficiali. Si poteva e si doveva trovare una soluzionepolitica generale al problema del finanziamento dei partiti, unproblema non solo italiano ma europeo. In Italia negli anni ’90si preferì la via giudiziaria, colpendo taluni e salvando altri,soffiando sul fuoco della protesta concentratasi nel referendumche abolì a furor di popolo il finanziamento pubblico ai partiti:salvo poi procedere – dopo aver eliminato gli avversari - a ri-dicolizzare il verdetto popolare moltiplicando per almeno

/ / 10 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / craxi
cinque volte il finanziamento statale alla politica con la formuladei rimborsi elettorali (da moltiplicare impietosamente ancora,se vi aggiungessimo i rimborsi a livello regionale, davverovaso senza fondo di cui resta emblematico rappresentante ‘erBatman’, Franco Fiorito, ex fascista noto per aver partecipato,assieme a ex-comunisti e neo-giustizialisti, al maramaldescolancio di monetine contro Craxi di fronte all’hotel Raphael).Emilio Lussu, spirito libero della sinistra italiana, avrebbecommentato: «Il vero peccato non è commettere una infrazionealle leggi di nostro Signore, ché tutti siamo dei deboli mortali,ma fingere di essere virtuosi e agire da imbroglioni» (solo peril 2017 è stato previsto il venir meno di detti rimborsi elettorali,abolizione azionata dopo l’emersione di come farisaicamentesi finanziava la politica nel ventennio post - Mani pulite).
Il latitante più illustre della storia italiana
fu il padre della nostra lingua, finito
per ritorsione sotto accusa di concussione
Su Bettino Craxi piombò infine anche la reiterata invettiva di«immorale latitante» per essere espatriato in Tunisia - dovemorì in semplicità, fuor dagli ori e dagli agi immaginati dagliavversari - rifiutando i processi politico/giudiziari intentatigliin patria. L’elite in malafede e la moltitudine degli sprovvedutifingono di ignorare (o ignorano proprio) che egli è in buonacompagnia: «latitanti» (secondo il gergo tecnico-carcerario),«fuoriusciti», «rifugiati», «esuli» (nel lessico letterario piùgentile) furono Garibaldi, Turati e Pertini. Ma probabilmenteil latitante più illustre della storia italiana fu il padre dellanostra lingua, finito per ritorsione sotto accusa di concussione.Dante Alighieri, che come priore aveva ratificato una condannacontro tre banchieri papali, finì a sua volta perseguito dopoche papa Bonifacio VIII riprese il controllo di Firenze: «Fugiudicato colpevole di aver ricevuto denaro in cambio dell’e-lezione dei nuovi priori, di aver accettato percentuali indebiteper l’emissione di ordini e licenze a funzionari del Comune edi aver attinto dal tesoro di Firenze più di quanto correttamentedovuto» (testualmente in Carlo A. Brioschi, Breve storia dellacorruzione dall’età antica ai giorni nostri, Tea, 2004, p.55).Dante non si presentò al processo - si difese dunque ‘dal’ pro-cesso, non ‘nel’ processo che reputava evidentemente perse-cutorio - e fu condannato a morte in contumacia. Fu così chea 37 anni intraprese la strada dell’esilio, della «latitanza»avrebbero detto altri nella parlata tribunalizia del XX secolo:per i quali anche Dante, «ghibellin fuggiasco», sarebbe statodunque un individuo altamente immorale.
In questa domanda retorica conclusiva - che allude naturalmentealla posizione di Craxi - non c’è vittimismo: quella di Craxinon è infatti una tragica caduta personale o di una partepolitica, ma riguarda la democrazia italiana, iscrivendosi inuna operazione definita «golpe mediatico giudiziario» da piùdi un commentatore (segnatamente Arturo Diaconale, Tecnicapostmoderna del colpo di stato: magistrati e giornalisti,Spirali/Vel, 1995). Come definire altrimenti una operazioneche è stata presentata come moralizzatrice avendo inveceprincipalmente un obiettivo politico? Tanto che la presuntamoralizzazione ha prodotto l’effetto opposto: il giurista MicheleAinis ha ricordato con plastica efficacia che «all’alba deglianni ’90 la classifica di Trasparency International – l’associa-zione che misura l’indice di percezione della corruzione,partendo dai paesi migliori – situava l’Italia al 33° posto nelmondo; nel 2011 siamo precipitati alla 69a posizione». Ritornano alla mente le menzionate parole di Alberoni: incontesti come questi «la lotta politica è praticamente tuttacombattuta con accuse di immoralità»; poi della moralità nonci si cura, e si procede al repulisti politico. Con stupefatta pre-cisione Michele Salvati ha definito «un fatto unico in Europa»la cruenta scomparsa dei partiti di governo del centro-sinistrapentapartitico a seguito del fenomeno di ‘Mani pulite’, «unesito che solitamente si associa a traumi ben più gravi, aguerre e rivoluzioni». Una eliminazione dunque dai tratti ma-neschi e violenti che ostinandosi particolarmente su Craxi esul partito socialista interroga la sensibilità di tutti i democraticiche concepiscano la politica come confronto mite, secondo ilmagistero di Karl Popper: «Combattiamo le nostre battagliecon le parole invece che con le spade».

/ / 11 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno
>>>> praga-roma e ritorno
Quando Pelikan scelse l’Italia>>>> Francesco Caccamo
,Il convegno di novembre
Il 14 novembre scorso si è svolto a Praga, presso laFacoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo, un
convegno per celebrare il venticinquesimo anniversariodella rivoluzione di velluto del 1989 e per ricordare l’apportofornito alla maturazione di tale evento dall’Italia, dalle sueforze politiche e dalla sua opinione pubblica. Il convegno èstato organizzato da Francis Raška, docente dell’UniversitàCarlo e specialista delle tematiche dell’emigrazione e del-l’esilio, con il sostegno dell’Istituto italiano di cultura edell’Ambasciata italiana. Pur nella molteplicità delle tema-tiche trattate, l’autentico filo conduttore dell’evento è statoil ricordo della personalità di Jiří Pelikán, di Listy, la rivistain lingua ceca da lui fondata Roma con il sostegno del Psi,e dell’attività da lui dispiegata nei due paesi tra i qualidivise la sua esistenza, appunto la Cecoslovacchia e l’Italia. Tra i relatori spiccavano alcuni tra i principali esponentidella Primavera di Praga, del dissenso e dell’esilio ancoraattivi: Antonín Liehm, figura di spicco della scena culturalececoslovacca degli anni Sessanta, che dopo la repressionedell’esperimento del socialismo dal volto umano si stabilìin Francia dando vita a Lettres Internationales; Dušan Ha-vlíček, amico personale di Pelikán e memoria storica di
Listy; Michal Reiman, uno dei giovani intellettuali che col-laborarono col gruppo dirigente dubcekiano, esiliato peraver partecipato alla Biennale del dissenso diretta da CarloRipa di Meana e per essere intervenuto su Rinascita; PavelKohout, non solo tra i massimi scrittori cechi, ma anchefondatore di Charta 77 e ideatore del suo stesso nome;Frantíšek Janouch, che dal rifugio svedese sostenne con laFondazione Charta il movimento cecoslovacco per la difesadei diritti umani. Erano anche presenti due intellettuali chedurante il periodo della normalizzazione trovarono acco-glienza presso le istituzioni universitarie italiane: il filosofoVáclav Bělohradský, interlocutore privilegiato dello stessoHavel, e la poetessa Sylvie Richterová, che ha ricordato lafondamentale figura di Angelo Maria Ripellino. Tra gli studiosi delle tematiche del dissenso e dell’esilio,sono intervenuti, oltre all’organizzatore Francis Raška, lostorico Francesco Caccamo, il cui contributo è riprodottoqui di seguito, il boemista Alessandro Catalano, e l’espertodei media dell’esilio Petr Orság. Una testimonianza d’ec-cezione è stata resa da Ugo Intini, che con Pelikán collaboròcome direttore responsabile dell’edizione italiana di Listy,e che qui recensisce il volume di Francesco Anghelone eLuigi Scoppola Iacopini dedicato allo stesso tema delconvegno.
Quali furono le ragioni che indussero Jiří Pelikán a cercarerifugio in Italia e perfino a sceglierla come seconda
patria? Ricordiamo innanzitutto che fu la dirigenza dubcekianaa nominare Pelikán nel novembre 1968 consigliere per lastampa e la cultura presso l’ambasciata cecoslovacca a Roma.In qualità di direttore della televisione, di presidente dellaCommissione esteri dell’Assemblea nazionale e anche dimembro del Comitato Centrale eletto al congresso “clandestino”del partito comunista cecoslovacco di Visočany, Pelikán si eraguadagnato l’ostilità dei sovietici; Brežnev in persona neaveva preteso in più occasioni le dimissioni dalla guida della
televisione. L’obiettivo primario di Dubček e dei suoi colla-boratori era dunque di allontanare dalla Cecoslovacchia occu-pata un esponente di spicco del nuovo corso e di tutelarlo difronte al pericolo di rappresaglie sovietiche. Al tempo stesso,sin dall’arrivo a Roma Pelikán si fece promotore di un’azionein difesa della Primavera di Praga, sfruttando la grande riso-nanza riscossa dall’esperimento del socialismo dal voltoumano presso l’opinione pubblica italiana e la commozionedeterminata dall’invasione dell’agosto 1968. Particolarmente utili per lui si rivelarono i contatti allacciati sindagli anni Cinquanta con una moltitudine di esponenti politici

italiani in qualità prima di segretario e poi di presidente di unadelle organizzazioni di massa comuniste con sede a Praga, l’U-nione internazionale degli studenti (Uie). Tra i suoi referentispiccavano i fratelli Berlinguer: Giovanni (suo predecessore acapo dell’Uie), ed Enrico, che aveva intrapreso una brillantecarriera ai vertici del Pci fino ad assumerne la guida di fattoproprio all’indomani dell’invasione della Cecoslovacchia. Anchese a un livello gerarchico del tutto diverso, vale la pena di no-minare l’amicizia con Carlo Ripa di Meana, che aveva vissutoa Praga come funzionario comunista distaccato presso l’Uie,ma che dopo la rivolta ungherese del 1956 era transitato insiemea una pattuglia di altri compagni nel Psi. Meno intima, ma in prospettiva altrettanto importante, era laconoscenza con Bettino Craxi, che come dirigente socialistadell’Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana(Unuri) aveva frequentato le riunioni dell’Uie; secondo alcunericostruzioni, proprio gli incontri praghesi con Pelikán avreb-bero fornito al giovane Craxi l’impulso a maturare una visionedecisamente critica dell’ideologia comunista e del socialismorealizzato in Urss e nell’Europa centro-orientale.
La sospensione dei rapporti ufficiali col Pci non significava comunque
che Pelikán fosse isolato
Le amicizie e i rapporti intessuti non comportavano automatica-mente che Pelikán, intrapresa la strada dell’esilio, decidesse difare dell’Italia la sua base operativa. Al contrario, all’inizio l’exdirettore della televisione esplorò la possibilità di stabilire ilcentro delle sue attività in Inghilterra. Proprio qui effettuò ilcoming out con l’intervista al Times del 1° ottobre 1969, con laquale annunciava la decisione di non obbedire al richiamo inpatria della nuova dirigenza husakiana e di impegnarsi dall’esteroper la difesa del socialismo dal volto umano di impronta dubce-kiana. La scena londinese non fu però in grado di soddisfare leaspettative di Pelikán né dal punto di vista lavorativo, né daquello politico. Alla fine del 1969 egli fece ritorno in Italia, doveaveva la prospettiva di una collaborazione con la Rai. Ma, so-prattutto, nella penisola poteva contare su un clima politico pro-pizio al tipo di lotta contro il regime normalizzatore che aveva inmente, vista la presenza di un’opinione pubblica fortementeorientata a sinistra e le ripercussioni suscitate dalla Primavera.Senza dubbio per Pelikán un grave colpo fu rappresentatodalla constatazione che la scelta dell’esilio significava larottura dei rapporti instaurati col Pci finché era consigliere diambasciata. Per sintetizzare una questione su cui si è molto
discusso, si può dire che i comunisti italiani intendevano ri-manere coerenti con la “severa riprovazione e condanna”espresse nei confronti della repressione dell’esperimento ses-santottesco, tanto da farne componente tutt’altro che trascurabiledel loro patrimonio identitario. Ritenevano tuttavia che la so-luzione della questione cecoslovacca andasse cercata all’internodel movimento comunista internazionale, attraverso un dialogocon l’Urss, e in subordine con le stesse autorità normalizzatrici.In questa contesto non c’era spazio per una collaborazionecon quanti avevano rotto di loro iniziativa con il Ksc norma-lizzato, e in primo luogo con Pelikán, che si stava rapidamenteaccreditando come l’ufficioso leader dell’emigrazione post-sessantottesca.A conferma di quanto detto c’è un documento finora ineditorisalente all’inizio dell’estate 1969. Qui uno dei funzionaricomunisti incaricati di seguire la pratica cecoslovacca riferivaai vertici del partito di aver maturato “la convinzione della ne-cessità, per noi, di accrescere le misure di cautela nei contatticon esponenti di quel paese e soprattutto con coloro che at-tualmente svolgono la loro attività all’estero”. Si trattavainfatti di “gente in gran parte bruciata e già sottoposta a con-trollo”, tra la quale si trovavano “‘poeti’ della politica quantomai ingenui e fuori della realtà”, e probabilmente anche agentiprovocatori. Questo discorso si applicava in primo luogoall’“amico di Roma”, del quale non si faceva il nome ma cheera chiaramente identificabile con Pelikán; proprio a lui si sa-rebbe dovuto “far sapere, con tutta la delicatezza dovuta ed informa del tutto personale, in quale situazione si trova, qualiprospettive gli si aprono […] e fargli capire che in questa si-tuazione è meglio interrompere i nostri rapporti”.Queste raccomandazioni di massima ricevettero piena applica-zione. All’inizio del 1970 Pelikán si rivolse direttamente aEnrico Berlinguer per spiegare le ragioni che lo avevano indottoa non tornare in patria, ma anche per ribadire la sua adesione al-l’ideologia comunista e per dare la disponibilità a stabilire unacollaborazione col Pci, perfino di tipo occulto. Non ricevetteperò alcuna risposta. Un anno dopo, durante una riunione dellaDirezione del partito, Arturo Colombi si spinse fino a dichiarareche “l’atteggiamento di Pelikan è l’atteggiamento di un nemico”.Senza dubbio Colombi era uno degli elementi più intransigentidella dirigenza comunista, ma il fatto che le sue parole non ve-nissero contraddette appare significativo.La sospensione dei rapporti ufficiali col Pci non significavacomunque che Pelikán fosse isolato. Grazie alle sue doti orga-nizzative e comunicative, l’esule cecoslovacco riuscì a con-quistarsi una posizione di rilievo nella scena politica e culturale
/ / 12 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

italiana. A lui si rivolgevano gli esponenti non conformisti delPci, che consideravano troppo prudente la linea ufficiale delpartito nei confronti dei paesi del blocco sovietico. Tra loro sicontavano membri del Comitato Centrale come Lucio Lom-bardo Radice e il direttore di Giorni-Vie NuoveDavide Lajolo,o un pubblicista esperto di Cecoslovacchia come Luciano An-tonetti, che con Pelikán avrebbe mantenuto un rapporto dicollaborazione per tutta la vita. Lo stesso discorso valeva perle formazioni della nuova sinistra, a partire dal gruppo delManifesto, che guardavano con interesse e simpatia ai fermentinei paesi dell’Europa orientale. Ulteriori menzioni meritanola sinistra cattolica, i radicali, i repubblicani, ma anche alcuniesponenti centristi o di destra.
Al momento della scelta dell’esilio
egli non si sentiva affatto un dissidente,
ma un membro del gruppo dirigente
riformista che era stato ingiustamente
allontanato
In questo panorama una posizione di assoluto rilievo spettavatuttavia al Psi di Bettino Craxi. In effetti sin dal suo arrivo inItalia Pelikán trovò un referente privilegiato nel vecchio co-noscente dei tempi dell’Uie, che era ormai divenuto vicese-gretario del Psi e leader della sua corrente autonomista. PerCraxi il tentativo di rinnovamento sessantottesco rivestiva unduplice interesse: a livello ideale era fonte di ispirazione per
le indagini tendenti al rinnovamento del pensiero socialista, alivello strumentale era utile per mettere in luce la persistentedipendenza del Pci dall’Urss e i limiti del nascente eurocomu-nismo. Insomma, per il vicesegretario socialista Pelikán eraun interlocutore strategico. Da qui l’appoggio da lui fornito alle iniziative dell’esule, apartire dal finanziamento della pubblicazione della rivista bi-mestrale in lingua ceca Listy, che dalla fondazione (nel 1971)fino alla caduta del regime normalizzatore si sarebbe impostacome uno dei principali strumenti, se non il principale, perdare voce alle forze dell’opposizione e del dissenso in Ceco-slovacchia. Di lì a qualche anno sarebbe stata anche lanciataun’edizione in lingua italiana della rivista, formalmente adopera di un centro studi di area socialista, l’Istituto europeo discienze sociali. In maniera significativa, la sede di questa edi-zione era in Piazza Duomo, allo stesso indirizzo dello storicoufficio milanese di Craxi; se Pelikán rivestiva la carica di di-rettore, a lui era affiancato Ugo Intini in qualità di direttore re-sponsabile, mentre un altro giovane dirigente socialista comeClaudio Martelli figurava con loro nel comitato di redazione.Le vicissitudini di Pelikán sulla scena politica italiana sonopiuttosto note: alla vigilia della scomparsa, lui stesso avrebbeincentrato su di loro il volume-intervista con Antonio Cariotipubblicato col titolo di Io, esule indigesto. Ciò che talvolta sitende a dimenticare è come Pelikan, con le sue esperienze, ilsuo attivismo e il suo entusiasmo, riuscisse a ritagliarsi unaposizione di rilievo nel dibattito culturale italiano. Con unaquantità impressionante di discorsi, di interviste radiofoniche
/ / 13 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

e televisive e di articoli sulla stampa, egli si impose infatticome il referente più competente per l’opinione pubblicaitaliana per quanto riguardava il fenomeno del socialismoreale nell’Europa centro-orientale, l’opposizione, il dissenso;si può anzi dire che egli colmasse una lacuna, considerate lascarsezza di autentici esperti su tali temi in Italia e la tendenzaa delegare la loro trattazione a personalità dal profilo per lopiù politico. Lo stesso Pelikán proponeva del resto un’interpretazione nondel tutto univoca degli sviluppi in corso nei paesi del bloccosovietico. Al momento della scelta dell’esilio egli non si
sentiva affatto un dissidente, ma un membro del gruppo diri-gente riformista che era stato ingiustamente allontanato dalpotere per effetto dell’occupazione straniera e che meritavauna riabilitazione e un reinserimento nella vita politica. Comemostravano le riflessioni da lui svolte sui media italiani e so-prattutto su Mondoperaio, al centro delle sue premure non vierano in origine “gli intellettuali del dissenso”, ma quella chedefiniva, a seconda delle circostanze, “l’opposizione” o “l’al-ternativa socialista”, o anche i “democratici di partito”: in-somma, i membri riformisti del Ksc che erano stati espulsidurante la normalizzazione e che stavano faticosamente cer-cando di organizzare un’alternativa al partito al potere, se nonun vero e proprio “partito degli espulsi”. Questo quadro di riferimento mutò sensibilmente nella secondametà degli anni Settanta. Il cambiamento principale fu rappre-sentato dalla nascita di Charta 77 e dalla risonanza da essa su-scitata a livello internazionale. Pelikán non aveva avuto nessunsentore dell’iniziativa, ma capì immediatamente che Chartarappresentava la principale novità verificatasi in Cecoslovacchiadagli eventi del 1968-69, e mobilitò in suo sostegno Listy. Daquesto momento divenne un attivo sostenitore della causa deldissenso, della difesa dei diritti umani e di una collaborazioneparitetica tra le diverse componenti della cultura alternativacecoslovacca, pur non abbandonando mai la speranza che infuturo si potesse avviare una transizione favorevole agli idealidel comunismo riformista o socialismo democratico.
L’elezione a Strasburgo fu un grandissimo
successo, perché diede una visibilità senza
precedenti alla causa del dissenso
L’altro cambiamento sul quale è opportuno concentrare l’at-tenzione fu l’avvento di Craxi alla segreteria del Psi nel 1976.Il risultato fu il rilancio in grande stile del tentativo di fare deitemi del dissenso e dell’opposizione dell’Est una battaglia perl’identità socialista (e, ovviamente, per mettere in difficoltà irivali del Pci). Tutto ciò si verificava proprio nel momento incui per Pelikán si avvicinava il conseguimento della cittadinanzaitaliana, e dunque si apriva la possibilità di intervenire in ma-niera più incisiva nella vita politica locale. Il caporedattore diListy era perfettamente consapevole degli sviluppi in corso:come scriveva a un altro esponente dell’esilio, “la nostra cit-tadinanza italiana è sulla buona strada e dopo si aprirannonuove opportunità, tanto più che il mio amico Craxi è diventatosegretario generale del Partito socialista”. Bisogna dire che anche di fronte a queste novità l’impulso ini-
/ / 14 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

ziale per Pelikán fu di tornare a rivolgersi al Pci. Alla fine del1976 egli scrisse sia al direttore dell’Unità Luca Pavolini, siaal direttore della sezione internazionale del Comitato centraleSergio Segre per prospettare l’instaurazione di una collabora-zione e perfino l’adesione al partito, ma neanche questa voltale sue proposte furono prese in considerazione: anzi, a renderela vicenda ancora più imbarazzante si aggiunse il fatto che lesue aperture furono fatte filtrare sulla stampa italiana. Il colpo di grazia alla speranza di una collaborazione siverificò nell’estate 1977, quando Pelikan si attivò insieme aLuciano Antonetti per organizzare un incontro tra i vertici delPci e il neoesule Zdeněk Mlynář, che dopo essersi distintocome uno degli ideologi del nuovo corso era divenuto uno deileader dei comunisti espulsi ed era stato tra gli artefici diCharta 77. Il risultato fu però deludente, consistendo in unsemplice incontro tra Mlynář e il direttore di Rinascita Adal-berto Minucci, oltretutto non a Botteghe Oscure ma nella sededella rivista. Questo atteggiamento contrastava con quello dialtri esponenti eurocomunisti, come dimostrava l’intimo col-loquio concesso di lì a breve dal segretario del partito comunistaspagnolo Santiago Carrillo sia a Mlynář che a Pelikán. Con questo fallimento caddero le ultime remore di Pelikán aimpegnarsi apertamente a fianco del Psi. Un primo segnale siebbe nel 1977, quando, con l’aiuto di due altri esuli cechicome Antonín Liehm e sua moglie Mira, divenne uno deglianimatori della Biennale del dissenso diretta dal vecchioamico Ripa di Meana. Ma, soprattutto, nel 1979 egli si assicuròl’elezione al Parlamento europeo presentandosi da indipendentenella lista dei socialisti italiani. L’elezione a Strasburgo fu ungrandissimo successo, perché diede una visibilità senza pre-cedenti alla causa del dissenso e alle correnti di opposizioneesistenti in Cecoslovacchia e nell’intera Europa centro-orientale.Al tempo stesso permise a Pelikán di superare le difficoltà fi-nanziarie con le quali si era dovuto confrontare nel primo de-cennio dell’esilio, e gli offrì l’opportunità di allargare inmaniera esponenziale i suoi contatti sulla scena internazionale. Con il conseguimento della cittadinanza italiana e l’elezione aStrasburgo si può dunque parlare di una crescente identifica-zione di Pelikán col Psi craxiano. L’esule ceco si avvalse delsostegno personale del segretario socialista per dispiegareun’azione a più livelli in favore dell’opposizione e del dissensointerni, ormai ben al di là della pubblicazione di Listy. In par-ticolare, egli contribuì in maniera rilevante alla creazione inpatria della rivista Lidové noviny, stabilì un contatto direttocon l’indiscusso leader della cultura alternativa cecoslovaccaVáclav Havel, e si attivò proprio insieme a Craxi per la sua li-
berazione dal carcere all’inizio del 1989. Ancora alla vigiliadella rivoluzione di velluto l’esule ceco stava progettando lacreazione di un centro studi per il socialismo democratico eper il pluralismo nei paesi dell’Est nel quadro della FondazioneNenni. Eppure Pelikán non interruppe mai i rapporti con altre areepolitiche. Questa linea di condotta rifletteva le remore espresseda altri esponenti dell’esilio e dell’opposizione interna versouna collaborazione esclusiva con il Psi, a scapito dei contatticon altre componenti della sinistra europea e in particolarecol Pci. Lui stesso confidava la preoccupazione di “comeunire la difesa degli interessi italiani con la prospettiva dellasinistra, anche con riguardo per ciò che succede da noi acasa”. In questa prospettiva partecipò con Luciano Antonettialla lunga trattativa che doveva portare alla pubblicazionedella nota intervista di Dubček sull’Unità nel gennaio 1988;in maniera analoga appoggiò gli sforzi posti in essere dal Pciper ottenere dal nuovo segretario del Pcus Michail Gorbačëvuna revisione del giudizio sulla Primavera di Praga e unasconfessione dell’invasione dell’agosto 1968. Con questa multiforme attività Pelikán svolse un ruolo ditutto rilievo nella preparazione di quella “rivoluzione divelluto” di cui si è da poco celebrato il venticinquesimo anni-versario. Al di là dell’oggettiva identificazione con il Psi cra-xiano, l’esule ceco si avvalse di qualunque aiuto potessegiovare alla causa del suo paese, non esitando all’occorrenzaa sfruttare le tensioni e le rivalità esistenti tra le varie compo-nenti della sinistra italiana. Al tempo stesso, proprio attraversotali tensioni e rivalità, anche l’Italia poté contribuire alla ma-turazione dei grandi eventi del 1989.
/ / 15 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

Il libro di Francesco Anghelone e Luigi Scoppola Iacopini1
costituisce un lavoro egregio, al quale c’è poco da aggiungeresul piano della ricostruzione storica, della documentazione edelle conclusioni politiche. A proposito di queste ultime,rimuove un equivoco e una semplificazione che i cancellatoridella storia (o i riscrittori ad uso dei vincitori) erano riusciti afar quasi comunemente accettare. Si dà infatti normalmenteper acquisito che il partito comunista italiano abbia compiutonel 1956 il clamoroso errore di appoggiare i carri armatisovietici a Budapest, ma lo abbia poi corretto nel 1968 capo-volgendo le proprie posizioni sulla Cecoslovacchia e finalmentesostenendo non gli oppressori, bensì Dubcek e la Primaveradi Praga. Non è esattamente così. O almeno non è tutto e non è l’aspettodecisivo. Io stesso, allora troppo naiv (credo alla fine deglianni ’70), sono inizialmente caduto nell’equivoco. In undibattito con Pajetta a un festival dell’Unità osservai (pensandodi trovare il consenso del leader comunista) che il Pci avevafinalmente cambiato la sua linea riconoscendo implicitamente,con il suo appoggio alla Primavera di Praga, di aver sbagliatonel 1956 su Budapest. “Niente affatto”, mi gelò Pajetta con lasua rude franchezza: “Nel 1956 abbiamo fatto benissimo adappoggiare l’intervento sovietico e lo rifarei. Perché a Budapestsi voleva uscire dal comunismo. A Praga invece Dubcek eraed è un comunista il quale voleva semplicemente, all’internodel sistema e dell’alleanza con Mosca, un comunismo nazionalediverso”. In sostanza, per il Pci il comunismo era una conquistairreversibile. Si poteva essere liberi di interpretarlo e applicarloin modi differenti, secondo le esigenze nazionali, ma non difuoriuscirne (tanto meno di fuoriuscire dall’alleanza conMosca). Il libro di Anghelone e Scoppola Iacopini chiarisce moltobene tutto questo. Il partito comunista italiano fu il piùavanzato del mondo e fu sempre coerente. Subito sostenne laPrimavera di Praga e la svolta politica di Dubcek. Criticò
pertanto aspramente l’intervento sovietico che la bloccò sulnascere. E non cambiò affatto posizione negli anni successivi(anche se accettò sostanzialmente la “normalizzazione”). Mamai ruppe con Mosca e mai mise in discussione la sua perma-nenza all’interno della comunità comunista internazionale. Ilsegretario Longo e il suo delfino Berlinguer portarono avantiquesta linea con continuità. Anzi: videro proprio nella libera eautonoma manifestazione delle proprie idee all’interno dellacomunità internazionale (pur guidata da Mosca) la funzionedel più grande e autorevole partito comunista dell’Occidente.Restare leali membri dell’Internazionale comunista e alleatidel Cremlino non era una contraddizione con il dissenso suPraga e su altro. Questa lealtà, al contrario, era proprio lacondizione che consentiva al Pci di esprimere liberamente lesue critiche con credibilità, senza prestarsi all’accusa di tradi-mento o intelligenza con il nemico “imperialista occidentale”.
Pelikan come rifugio naturale avrebbe
dovuto individuare la Germania. Non lo
fece perché i socialdemocratici tedeschi
non lo appoggiarono affatto, esattamente
come i comunisti italiani
Longo e Berlinguer non erano in contraddizione persino conla politica di Togliatti. Infatti, come si ricorda nel libro,citavano spesso, a copertura della loro posizione, proprio illeader scomparso nel 1964: il quale, con il memoriale di Yaltascritto poco prima della morte, aveva esattamente teorizzatoper i partiti comunisti la “unità nella diversità” delle vienazionali. Si trattava (anche in questo Longo e Berlinguer nonvedevano contraddizione) dello stesso Togliatti che nel 1956aveva addirittura sollecitato l’intervento sovietico a Budapest,e che aveva approvato preventivamente la condanna a mortedel capo del governo ungherese deposto dai carri armati, ilcomunista Imre Nagy, redigendo persino – sull’Unità – unasorta di atto di accusa nel quale (particolare a quei tempi
/ / 16 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno
>>>> praga-roma e ritorno
Le colonne d’Ercole del Pci>>>> Ugo Intini
1 Praga 1968. La “primavera” e la sinistra italiana, a cura di F. Anghelonee L. Scoppola Iacopini, Bordeaux edizioni, 2014.

sinistro) lo si definiva non più “compagno”, ma “signore”. Edopo la condanna Togliatti chiese soltanto una cortesia (subitoaccordata): spiegò con una lettera riservata che sarebbe statobene rinviare l’esecuzione a dopo il 25 maggio, perché inquella data si tenevano le elezioni politiche italiane e la“stampa borghese” avrebbe potuto perfidamente usare la mortedell’ex primo ministro ungherese per orchestrare una specula-zione propagandistica contro il Pci. In effetti, il povero Nagyfu impiccato il 16 giugno 1958 ed ebbe pertanto, grazie a To-gliatti, due o tre mesi di vita in più.Il leader comunista italiano, al quale la Camera dei deputatista dedicando nei suoi saloni una mostra fotografica celebrativa,non era d’altronde nuovo nell’aggiungere argomenti contro levittime del regime sovietico. Non a Mosca durante i processistaliniani, bensì ormai al sicuro in Italia, a molti anni didistanza, così scriveva del presidente dell’Internazionale co-munista Bucharin (del quale fu amico e stretto collaboratore)processato e ucciso da Stalin nel 1938, riabilitato da Gorbaciovnel 1988: “Bucharin aveva i caratteri del professorino presun-tuoso, vanitoso e intrigante. Era in lui la stoffa del doppiogiochista
e del traditore”. E tutti i segretari del Pci dopo di lui (Longo,Berlinguer, Natta e Occhetto) mai vollero porre in discussioneil mito di Togliatti (che dura tuttora persino con le tante vie epiazze a lui dedicate), e mai superarono, nel pur continuo rin-novamento e ammodernamento del partito, le “colonned’Ercole” dell’appartenenza alla comunità comunista interna-zionale guidata da Mosca. Questa appartenenza alla comunità(insieme al nome stesso del partito) finì per evidente forzamaggiore soltanto nel 1989 quando, con il crollo del muro diBerlino, finì la comunità stessa.Qualcosa si può aggiungere, al libro di Anghelone e ScoppolaIacopini, allargando l’esame alle reazioni della sinistra nonitaliana ma europea. Oltre che introducendo qualche testimo-nianza e riflessione esplicativa su alcuni dei fatti così ben do-cumentati dagli autori. Jiri Pelikan è diventato il simbolo del-l’opposizione al regime imposto a Praga dai russi dopo la Pri-mavera. I comunisti italiani non hanno mai voluto sostenerloperché ciò era vietato da Mosca e avrebbe comportato il supe-ramento delle “colonne d’Ercole” prima ricordate. Furonodunque i socialisti italiani ad accoglierlo come un compagno
/ / 17 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

e addirittura a farlo eleggere al Parlamento europeo. MaPelikan era quasi bilingue con il tedesco e come rifugionaturale avrebbe dovuto individuare la Germania. Non lofece perché i socialdemocratici tedeschi non lo appoggiaronoaffatto, esattamente come i comunisti italiani. Willy Brandt èancora oggi per i socialisti italiani della mia generazione unmito. Lo era anche per Craxi. Eppure, a distanza di tanti anni,bisogna dire la verità. Brandt gli rimproverava l’apertasolidarietà a Pelikan: “Tu sbagli. Noi non dobbiamo sosteneregli oppositori ai Partiti comunisti dell’Est. Non dobbiamopuntare su chi si contrappone frontalmente al comunismo. Alcontrario, dobbiamo favorire una evoluzione positiva deipartiti comunisti, dialogando con loro e sostenendo al lorointerno le correnti più moderate”. Questa, all’inizio degli anni ’70, era la linea della Spd, e indefinitiva dell’Internazionale socialista, presieduta proprio daBrandt: dove i francesi contavano ancora poco e mancavanoquelli che sarebbero diventati gli alleati (e seguaci) degliitaliani, gli spagnoli di Gonzales e i portoghesi di Soares.Craxi veniva chiamato (spesso sprezzantemente) dalla stampaitaliana “il tedesco” per le sue scelte socialdemocratiche, mala Spd non ci aiutò mai concretamente. Certo, Brandt eraguidato dalla realpolitik e dall’interesse nazionale: aveva ilcomprensibile obiettivo di conservare con i comunisti i rapportinecessari a favorire in un futuro più o meno lontano la riunifi-cazione della Germania. Ma questa è la realtà. Si tratta di una realtà che aiuta anche a spiegare le scelte delPci, niente affatto irrazionali o scomode. A ben vedere, i co-munisti italiani contavano, avevano autorevolezza e interlocutori(a cominciare dai socialdemocratici tedeschi) proprio perchérestavano all’interno dell’Internazionale comunista e potevanoin quella sede, sfruttando il rispetto dovuto al più importantepartito comunista dell’Occidente, rappresentare efficacementele ragioni di chi puntava a una evoluzione morbida dei regimidell’Est. Anche una gran parte del capitalismo italiano avevainteresse all’apparente ambiguità del Pci. Ad esempio, perconquistare il mercato dell’automobile a Est, la Fiat era inconcorrenza con la Renault. Sponsorizzata dai comunistiitaliani, che contavano ben più dei francesi, vinse la partita esi assicurò la costruzione dello stabilimento nella città sulVolga che fu addirittura ribattezzata Togliattigrad. Che il Pci avesse relazioni speciali con Mosca serviva d’altrondea tutta la grande industria italiana (che ricambiava con unapercentuale per le casse comuniste su ciascun affare realizzato).Si potrebbe aggiungere che il mancato sorpasso delle “colonned’Ercole” rendeva impossibile la presenza dei comunisti – e
quindi dell’intera sinistra in alternativa alla destra – nelgoverno nazionale. E che ciò costituiva per l’establishmentitaliano un vantaggio politico da affiancare a quelli economici.
I giornalisti importanti preferirono non
inimicarsi frontalmente un potere che
ormai aveva esteso la sua influenza sulla
Rai, sul cinema, sulle università e su quasi
tutti i giornali
Anche Mosca si giovava (e più di tutti) dello status quo.Infatti la puntuale e coerente critica del Pci la irritava, masulle scelte veramente decisive i comunisti italiani fornivanoun aiuto assolutamente prezioso. La prova del nove fu lagrande battaglia politica sull’installazione dei missili Pershinge Cruise. Lì si giocò, nel 1979-’80, la partita decisiva dellaterza guerra mondiale (fredda) tra Est e Ovest. I russi installaronogli SS-20 minacciando l’Europa occidentale. Se la Nato nonavesse risposto ripareggiando il bilancio missilistico e con-trapponendo le proprie testate, l’Europa sarebbe stata intimiditae potenzialmente separata dagli Stati Uniti attraverso unasorta di silenziosa “finlandizzazione”. Se l’Italia fosse venutameno, anche gli altri paesi europei (come preannunciato dalcancelliere tedesco Schmidt) si sarebbero tirati indietro. Graziealla mobilitazione propagandistica innanzitutto dei comunistiitaliani (schierati in questo caso al cento per cento con Mosca),che portarono nelle piazze milioni di dimostranti contro imissili occidentali, l’Italia fu a un passo dal rinunciare e fusalvata soltanto dalla fermezza dei socialisti.Se il Pci non spinse mai la sua critica verso l’Urss sino alpunto di superare le “colonne d’Ercole” dell’appartenenzaalla comunità internazionale comunista, ciò non fu soltantoper la volontà del suo gruppo dirigente. Il libro di Anghelonee Scoppola Iacopini documenta che la maggioranza della baseoperaia già faticava ad accettare il dissenso dei vertici diBotteghe Oscure dall’Urss su Praga. Ma ancor di più si devericordare il peso degli intellettuali: quegli stessi che costruirononegli anni ’70 l’egemonia culturale comunista, vitale per lesorti del partito. Leggiamo le parole di quello che era forse il più celebratoopinionista fisso non dell‘Unità, ma del Corriere della Sera,dove aveva per primo diffuso lo slogan della necessaria lottadella gente comune contro il “Palazzo”. Pier Paolo Pasolini,descrivendo la costa croata della Jugoslavia, scriveva. “Anchei gruppi di operai che passano per strada hanno visi pieni di
/ / 18 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

certezze e di forza: sembrano sentirsi, sia pure umilmente,protagonisti di questa vita, anche se si presenta così marginalee povera. Il comunismo ha messo dunque direttamente radicisu una vecchia cultura contadina”. Mentre descrivendo l’Italiascriveva: “Sono almeno tre anni che faccio in modo di nonessere in Italia per Natale. Lo faccio di proposito, con accani-mento, disperato all’idea di non riuscirci. Per il nuovo capita-lismo, che si creda in Dio, nella Patria o nella famiglia, è in-differente. Esso ha infatti creato il suo mito autonomo: il be-nessere”. Sulla stessa lunghezza d’onda si trovava Natalia Ginzburg,che ancora nel 1981 scriveva sull’Unità: “Mi ricordo unviaggio in Unione Sovietica. Avvertivo indistintamente un’at-mosfera straordinaria e non riuscivo a capire da cosa fosseprodotta. Alla fine, me ne sono accorta: lì non c’era lapubblicità”. In questo “pauperismo” anti moderno e anti capi-talista sta la base psicologica e quasi antropologica della “di-versità” comunista (e ancor più cattocomunista), dell‘anticon-sumismo, della “austerità” e in definitiva della questione“morale” cara a Berlinguer. Una “questione morale” che nonriguardava banalmente il “non rubare”. Ma delineava le basidi una “moralità nuova” (come Berlinguer stesso la chiamava),contrapposta alla decadente e edonista società capitalista. Le“colonne d’Ercole” non potevano essere superate dal Pci peruna ragione culturale ancor prima che politica. Si deve anche osservare che la Primavera di Praga si collocònel momento della rivoluzione “sessantottina” e della mobili-
tazione per il Vietnam. E che non necessariamente il superamentodelle “colonne d’Ercole” sarebbe stato destinato ad aprire peril Pci una via socialdemocratica e riformista. Al contrario,poteva aprire la via dell’avventurismo rivoluzionario. Leggiamoa tale proposito cosa scriveva nel 1968, in un fondo sull’Unitàdal titolo Autonomia e internazionalismo, il futuro segretariodel partito Achille Occhetto: “La critica del Pci non ha radiciin motivazioni di destra, ma è una critica da comunisti a co-munisti. Stiano quindi attenti i capitalisti: ogni sforzo compiutodal movimento comunista sulla via della democrazia socialistadeve farli tremare perché, in questo modo, si rafforza l’alternativadi una società socialista, perché la democrazia non è per noiun cedimento alla democrazia borghese, ma lo strumento perla realizzazione di una nuova libertà”.
Umberto Eco spiegava che “la visione
marxista della società si sta imponendo
come un valore acquisito
Bisogna aggiungere, a proposito degli intellettuali e della ege-monia culturale comunista, un particolare significativo. Craxidecise di aiutare Pelikan a riprendere la pubblicazione – initaliano, in ceco e in altre lingue europee – del prestigiosomensile Listy, “organo” della Primavera di Praga, sostenutodai nomi più eccellenti della “intellighenzia” cecoslovacca.Ci voleva (per legge, come si sa) un direttore responsabileiscritto all’Ordine dei Giornalisti. Craxi cercò un professionista
/ / 19 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno
>>> L’Alzheimer spirituale. Allavigilia di Natale ci voleva il Papa permetterci in guardia contro “l’Alzhei-mer spirituale” di chi “perde la memo-ria” e vive in “uno stato di dipendenzadalle sue vedute spesso immaginarie”,fino a cadere vittima del “terrorismodelle chiacchiere”. D’accordo, France-sco parlava ai vescovi curiali: ma maicome in questo caso la Curia romanapuò essere considerata specchio delpaese in cui opera (e che in gran partela esprime).Il terrorismo delle chiacchiere affiora(e colpisce) in ogni pagina di gior-nale, in ogni battuta di talk show, in
ogni docufilm che mescola storia eleggenda: ed approfitta dell’Alzhei-mer spirituale che ci affligge perconvincerci di essere vissuti per set-tant’anni sotto il dominio dellamafia, della corruzione e di altreforme di malaffare.E’ il brodo di coltura di un’altradelle malattie segnalate dal Papa,“la schizofrenia esistenziale”: quellaper cui si gode nel privato dei frutti(abbondanti) di stagioni politicheperaltro esecrate in pubblico.Quella, cioè, che considera il wel-fare ereditato – completo di pen-sioni pagate a debito, di sanità pub-
blica universale, di scolarizzazionedi massa, dello stesso articolo 18 –come un dono del Cielo (o un“diritto naturale”, che è lo stesso), enon come il risultato di conflittipolitici e sociali animati dagli stessiattori altrimenti deplorati comemafiosi e corruttori.Perciò oggi chi vuole adeguare aitempi nuovi le riforme di cin-quant’anni fa deve guardarsi innan-zitutto dall’Alzheimer spirituale:perché un popolo senza memoriaguarda al futuro senza speranza.(Luigi Covatta, mondoperaio.net,dicembre 2014)

di fama: ma con suo grande stupore non lo trovò. Accaddecosì, per caso e per necessità, che il direttore responsabile lofeci io, allora giovane e sconosciuto. I giornalisti importanti(comunisti, filo comunisti e niente affatto comunisti) preferirononon inimicarsi frontalmente un potere che ormai aveva estesola sua influenza (occupato “tutte le casematte della societàcivile”, avrebbe detto Gramsci) sulla Rai, sul cinema, sulleuniversità e su quasi tutti i giornali.”L’appoggio entusiasta e incondizionato a Pelikan (ma ancheal russo Sacharov e a tutti gli oppositori del comunismo)quasi isolò i socialisti nella sinistra non solo italiana, maspesso anche europea. E tuttavia li collocò su una posizionedi quasi incredibile lungimiranza. Certo, Filippo Turati, quasifosse un profeta o un veggente, nel 1921, rivolgendosi aGramsci e Togliatti che se ne andavano dalla casa socialistaper fondare il partito comunista, già accusava i bolscevichi(letteralmente) di “imperialismo”, e già descriveva conprecisione come sarebbe finita, l’Unione Sovietica. Forse nelDna socialista è rimasto per generazioni l’imprint dei padrifondatori. Ma la lungimiranza dimostrata dal Psi ha origineprobabilmente più nel cuore che nella testa. Scriveva Craxinel 1975 sull’Avanti!: “La nostra risposta è quella dellasolidarietà attiva con Dubcek e con i suoi compagni. Anche lelotte più disperate, se sono giuste, seminano in attesa dellastagione propizia”. Craxi non faceva una previsione ragionata. Esprimeva unafede e parlava con il cuore. Dalla nascita in poi, i socialisti si
sono sempre schierati seguendo soltanto i loro ideali digiustizia e di libertà. Senza calcoli. Che la battaglia si potessevincere o no. Questa è la loro natura. Siamo anche qui nelcampo della antropologia più che della politologia. Più di Ma-chiavelli (fatto proprio e rielaborato da Gramsci e Togliatti),essi hanno caro De Amicis. Ciò comporta anche una scarsa at-tenzione all’ideologia, trattata soltanto il minimo indispensabileper giustificare le scelte politiche concrete (le uniche importanti,dettate non dalla ideologia stessa, ma da principi morali).Hanno ragione gli Autori: ancora sino alla metà degli anni’70, il marxismo ha avuto anche nel Psi un certo peso. Ma sol-tanto come un lip service che evitasse le reprimende di qualcheprofessore bacchettone. Io stesso, quando nel 1979 ho propagandato, insieme a Bettiza,il socialismo liberale, ho chiarito prudentemente (proprio inquesta logica) che anche il marxismo poteva avere cittadinanzanel partito, perché ne esisteva una versione democratica ecompatibile con il libero mercato. D’altronde Giuseppe Saragat(non certo un estremista di sinistra) si è sempre dichiaratomarxista. Ma a quel tempo per dichiararsi non marxisti asinistra ci voleva un certo coraggio, perché l’egemonia culturalecomunista produceva i suoi effetti. Proprio nel 1977, in piena“egemonia” (quella che portò Montanelli e Bettiza ad abban-donare il Corriere per fondare il Giornale), sulla prima paginadel quotidiano di via Solferino Umberto Eco spiegava che “lavisione marxista della società si sta imponendo come unvalore acquisito”, e si preoccupava del pericolo derivante dal
/ / 20 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

fatto che si potesse dichiarare a parole di aderire al marxismo(ormai “accettato come valore diffuso e indiscutibile”) nonper convinzione ma per conformismo.Se nei salotti, per spiegare il comportamento degli uomini, sidice, seguendo Alexandre Dumas, cherchez la femme, non sicapisce perché gli storici, per spiegare le scelte politiche, nonsi impegnino a chercher l’argent, documentando il peso deldenaro. Gli Autori ci ricordano che il Psiup è stato sugli avve-nimenti di Praga più filosovietico del Pci. E correttamente ri-cordano i finanziamenti ricevuti da Mosca. Si tratta di un ar-gomento assolutamente centrale. Alla fine degli anni ’50,l’allora vice segretario del Pci Luigi Longo andò personalmenteall’ambasciata sovietica a chiedere finanziamenti russi per lacorrente di sinistra del Psi guidata da Vecchietti e Valori.Pietro Nenni faticò a trasformare in una solida maggioranzala vittoria politica ottenuta dopo la svolta di Budapest alcongresso di Venezia del 1957 per la resistenza dell’apparatodel partito, costituito da centinaia di funzionari i quali ben sa-pevano di prendere lo stipendio ogni fine mese grazie ai soldidi Mosca. La scissione socialista del 1964, che portò allanascita del Psiup, fu finanziata dai russi (e forse anche dallaConfindustria, che aveva l’obiettivo tattico di indebolire, conil Psi di Nenni, la spinta riformatrice nel primo governo dicentrosinistra).
Quanti hanno meno di quarant’anni
(se non hanno fatto studi specifici) non
conoscono quasi nulla della storia socialista
Il partito di Vecchietti e Valori dunque, sin dall’inizio fu carat-terizzato dalla totale dipendenza economica da Mosca, senzaperaltro avere, come il Pci, un prestigio internazionale nellostesso mondo comunista. Così si spiega il suo essere sulla Ce-coslovacchia “più a sinistra”, come scrive Scoppola Iacopini,dei comunisti. L’enorme macchina organizzativa e burocraticadel Pci fu sempre alimentata da Mosca (e i partiti democraticifaticosamente furono costretti ad imitarla per non soccombereelettoralmente). I vecchi compagni mi hanno raccontato la disperazione di Nenni,che alla fine degli anni ’50 temeva di essere costretto a chiuderel’Avanti! dopo la fine dei finanziamenti sovietici che rendevanoinvece prospera l’Unità. Alle elargizioni dirette e in contanti sisostituirono con il tempo forme più sofisticate, con il pagamentodi intermediazioni (oggi si chiamerebbero tangenti) per tutte leoperazioni commerciali, turistiche e imprenditoriali italiane non
soltanto con l’Urss, ma anche con tutti gli altri paesi dell’Est.Sino alla caduta del regime, le spese dei corrispondenti dell’Unitàa Mosca venivano pagate dai sovietici. Era consuetudine che idirigenti del Pci passassero le vacanze nelle località balnearirusse: non per caso Togliatti morì in vacanza sul Mar Nero. eLongo apprese nell’agosto 1968 dell’invasione della Cecoslovacchiamentre era al mare con la famiglia nell’Unione Sovietica (non aspese sue, naturalmente). Ci si può domandare come questi dirigenti potessero conciliaretutto ciò con la pretesa di autonomia politica e soprattutto conla loro pur elevata moralità personale. Giancarlo Pajetta eraamico del papà di Craxi, suo compagno nella Resistenza aMilano. Mantenne sempre un rapporto anche con il figlio, cheun giorno mi rimproverò perché, come direttore dell’ Avanti!,in un corsivo mi ero permesso di attaccare il vecchio leader co-munista troppo ruvidamente. Lo ascoltavo con rispetto e ognitanto lasciava trasparire i suoi sentimenti. Una volta mi disse.“Tu non puoi capire il nostro rapporto con l’Urss. Durante il fa-scismo, quando tutto sembrava perso, andavamo davanti al-l’ambasciata sovietica per vedere sventolare la bandiera rossacon la falce e martello. E riprendevamo la speranza”. Infine, un’ultima osservazione, forse l’unica concretamenteutile. Nelle righe precedenti ho parlato spesso di “cancellazionedella storia”, e in effetti la mia insistenza nel ricordareparticolari e nel fornire testimonianze non è casuale. So chequanti hanno meno di quarant’anni (se non hanno fatto studispecifici) non conoscono quasi nulla della storia socialista; eso che le fonti scritte sono state prodotte per lo più da caseeditrici e autori cresciuti nella egemonia comunista o in quelladella retorica “antipartitocratica” e giustizialista successiva.Questo libro contiene una constatazione di fatto e una riflessioneche richiedono di essere valutate congiuntamente e che ci in-dicano un obiettivo preciso. La constatazione di fatto è che mancano o sono difficilmentereperibili le fonti di archivio sulla storia socialista. La riflessioneè quella contenuta nella prefazione di Antonio Iodice: “Si ponea questo punto una questione ineludibile, sulla quale gli storicisi sono a lungo arrovellati. Chi scrive la storia? ‘I vincitori’,secondo una fin troppo scontata risposta. Sarebbero i vincitoria narrare le vicende che li hanno coinvolti e dalle quali sonousciti più o meno a testa alta, condizionando inevitabilmente ilgiudizio dei posteri e il commento degli storiografi. Forsesarebbe più corretto affermare che, al fine di narrare la storia,oltre a ‘vincere’ bisogna anche ‘sopravvivere’. La storia èscritta da chi sopravvive, da chi rimane in piedi alla fine dellacontesa. Un eroe morto in battaglia sarà pure un eroe, ma avrà
/ / 21 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

comunque bisogno di un narratore, cioè di qualcuno che glisopravviva e ne decanti le lodi. Per questo motivo, la scelta deidue Autori di utilizzare i quotidiani e le riviste di area socialistae comunista per raccontare le vicende della Primavera di Praganello specifico della loro incidenza sulla sinistra italiana appareparticolarmente felice: la stampa permette di aprire una brecciatanto nella macro-storia degli Stati e dei blocchi politici, quantonella micro-storia dei singoli cittadini e delle loro vicendequotidiane. Permette, insomma, di congiungere la History e laStory, riprendendo la nota distinzione inglese. Sarà poi compitodello storico aggiungere l’approccio scientifico, senza nullatogliere alla leggibilità del suo lavoro”. Giusto. La storia è scritta da chi “sopravvive” e i socialistinon sono sopravvissuti. La stampa però permette di “aprireuna breccia”. Permette di evitare quella “cancellazionedella storia” sulla quale insisto. La stampa dei socialisti
poi costituisce forse più di ogni altra una fonte importante,quasi esaustiva, per la conoscenza della loro storia (e dellastoria nazionale, perché l’Avanti! è stato il crocevia dell’interavicenda politica e culturale del secolo scorso, non solo so-cialista). Eppure, dell’Avanti! e di Mondo Operaio nonesiste un archivio elettronico che consenta, attraverso datee parole chiave, di individuare e consultare gli articoli ne-cessari agli studiosi. Esiste ormai per quasi tutti i quotidianinazionali. Non per l’Avanti!, che è senza dubbio il piùcarico di storia. Dalla constatazione di fatto degli autori edalla riflessione di Antonio Iodice nascono una proposta eun obiettivo quasi obbligati, di importanza decisiva: bisognafinalmente creare un archivio elettronico dell’Avanti! e diMondo Operaio. Soltanto così si possono fornire glistrumenti indispensabili a chi vuole evitare la cancellazionee riscrittura della storia.
/ / 22 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / praga-roma e ritorno

/ / 23 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
La disobbedienza non è più una virtùPartiti e gruppi parlamentari
Quando i parlamentari sono eletti in base alla loro desi-gnazione su liste di partito, la disciplina di gruppo nelle
deliberazioni legislative e nelle votazioni alle cariche pubblichedi spettanza parlamentare è una regola scrupolosamente seguita.Lo conferma l’eccezione degli Stati Uniti, dove il sistemaelettorale è maggioritario uninominale, il modello di governoè del tipo presidenziale puro, e il radicamento dei partiti è de-bolissimo. La disciplina di gruppo è una regola non scritta dinatura convenzionale, ma di estrema importanza, perché fadel gruppo parlamentare un soggetto capace di assicurarequel funzionamento del Parlamento “per gruppi” che ne harazionalizzato notevolmente le attività rispetto alle assembleerappresentative dominate dai notabili del XIX secolo. In termini costituzionali i gruppi parlamentari, quali proiezionidei partiti in Parlamento, trovano la loro legittimazione nel ri-conoscimento costituzionale del concorso dei partiti alla de-terminazione della politica nazionale (art. 49), prima ancorache nella menzione espressa in alcune disposizioni (artt. 72 e82). D’altra parte il divieto di mandato imperativo stabilitodall’art. 67 protegge i parlamentari che dissentano regolarmentedalla linea politica del gruppo da qualsiasi minaccia di espul-sione dal Parlamento. I dissenzienti potranno essere al massimoespulsi dal gruppo, ed è in questo senso che la disciplina digruppo trova un primo limite. Un secondo limite è costituitodalla regola del voto segreto, che prima della riforma dei re-golamenti del 1988 copriva virtualmente deliberazioni su tuttele materie (comprese le leggi di spesa), e che quella riformaha ristretto alle deliberazioni che coinvolgano materie etica-mente sensibili, e quindi casi di coscienza, e all’elezione dipersone a cariche pubbliche. Fino a questo punto il sistema italiano non si distingue daglialtri. Le differenze si colgono attraverso l’esame dei regola-menti parlamentari. Fin dal regolamento della Camera del1920, che fu riadottato dopo il fascismo, vige la regola dellanecessaria appartenenza del parlamentare a un gruppo. Questaregola aiuta a spiegare da una parte il fenomeno del “transfu-
ghismo” (proprio di quei parlamentari eletti in una certa listadi partito e poi trasmigrati durante la legislatura in un gruppodiverso), e dall’altra l’istituzionalizzazione del gruppo misto,dove sono assemblati i deputati e i senatori che non intendanoiscriversi a gruppi parlamentari politicamente orientati e/o ap-partenenti a formazioni politiche che non raggiungono lasoglia minima stabilita dai regolamenti delle due assembleeper dare vita a un gruppo. Qui siamo già in grado di cogliere alcune specificità del fun-zionamento dei gruppi in Italia: per esempio, il fatto che le so-glie minime siano state tenute molto basse anche durante laseconda fase della Repubblica nonostante lo sbandierato bi-polarismo, in modo da favorire il rimborso delle spese elettorali.Ma non voglio indicare qui tutte le storiche specificità italiane,né dare conto del non nuovo fenomeno del transfughismo.Voglio piuttosto segnalare che nella legislatura in corso igruppi parlamentari hanno perduto ogni compattezza, fino adiventare accampamenti solo provvisori di truppe.
Sartori ha rimproverato i costituzionalisti
di ignorare che per Costituzione gli eletti
nelle liste del M5s non potrebbero entrare
e votare in Parlamento
La vicenda ha riguardato non solo gruppi minori come Listacivica, ma, per ragioni e in momenti diversi, tutti e tre i gruppimaggiori. Prendiamo i casi di espulsione di parlamentari dis-senzienti dal Movimento cinque stelle. All’indomani delleelezioni i suoi capi minacciavano di espellere qualunque dis-senziente dal Parlamento. Da quando sono stati informati chela Costituzione lo vieta, e che un atto di dimissioni in biancosarebbe giuridicamente nullo, hanno cominciato a minacciarel’espulsione dal gruppo parlamentare. Alla fine alcuni dissen-zienti si sono iscritti ad altri gruppi, ma molti altri continuanoa vivere sotto la minaccia dell’espulsione, decisa secondoprocedure abbastanza barbare. Giovanni Sartori ha rimproverato i costituzionalisti di ignorare,o di aver taciuto, che per Costituzione gli eletti nelle liste del
>>>> Cesare Pinelli
1 Corriere della Sera del 6 novembre 2013.

/ / 24 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
M5s non potrebbero entrare e votare in Parlamento, dal mo-mento che sono “vincolati da un mandato imperativo di agire,parlare e votare solo su istruzioni di Grillo e del suo guru; unasudditanza che li obbliga, senza istruzioni, al silenzio o allainazione”1. Sartori parte però dall’erroneo presupposto che laCostituzione vieti lo stesso ingresso in Parlamento di elettivincolati ad agire su mandato di qualcuno. Ciò richiederebbeche la Giunta per le elezioni (o altro organo interno delle Ca-mere) valutasse la sussistenza di un vincolo simile in capo aciascun eletto, cosa non prevista in nessun ordinamento co-stituzionale dove sia riconosciuto il divieto di mandato impe-rativo. Questo istituto, che protegge invece ciascun membrodel Parlamento da revoche del mandato da chiunque comminate,ha svolto perfettamente la sua funzione anche nei confrontidei parlamentari dissenzienti del M5s.Tuttavia chiunque abbia informato i dirigenti e i parlamentaridel movimento della sussistenza del divieto di mandato impe-rativo non sarà riuscito a spiegarne loro il significato: come sefossero andati perduti i lunghi e difficili apprendimenti chehanno assicurato a quell’istituto una vita di oltre due secoli.Come se dovessimo ricominciare daccapo, in presenza di unmovimento che vorrebbe riportare la rappresentanza politicaa uno stadio premoderno, e la cui organizzazione interna è giàpremoderna. Si potrà ironizzare su una simile sottocultura.Diventa più difficile farlo quando il movimento che la esprimeprende milioni di voti sull’onda di una forte protesta controrappresentanti e governi inadeguati, manda alle Camere personeignare della funzione di rappresentanza che sono chiamate asvolgere, e rifiuta ogni confronto politico in nome di unavisione fanatica della rete, concepita come un mondo virtualesuperiore a quello reale.Le cose sono andate diversamente in Forza Italia. Qui è statala perdita di peso politico di Berlusconi ad aver posto le pre-messe prima della scissione del Nuovo centrodestra, e piùtardi dello spettacolo di decine di scrutini andati a vuoto perl’elezione di un giudice costituzionale, con cinque candidatibruciati da faide interne o ritiratisi in tempo utile per evitare ilfuoco, e con una Corte cui tuttora manca il quindicesimo giu-dice. Nel frattempo l’emergere di una potente corrente, orga-nizzata secondo tutti i crismi delle antiche correnti democri-stiane, fa sì che le trattative per l’elezione del nuovo Capodello Stato si debbano di fatto condurre con due soggetti, noncon uno solo. Anche per Forza Italia, dunque, parlare di disci-plina di gruppo è parlare di un sogno.
Ma è nel Pd che si sono viste le cose più incredibili. Tutti ri-cordano i 101 parlamentari che affossarono la candidatura diRomano Prodi al Quirinale: da allora si è aperta la caccia ainomi dei congiurati, ricostruendo gli scontri fra correnti e ca-cicchi. Due particolari andrebbero però utilmente ricordati.Anzitutto pare che durante la precedente votazione interna algruppo il controllo sui consensi effettivamente ottenuti dalcandidato proposto sia stato parecchio rapido e superficiale.Inoltre il gruppo era costituito da giovani alle prime armi,mandati in Parlamento dall’allora segretario per dimostrareche il rinnovamento generazionale era già avvenuto senza chevi fosse bisogno di rottamazioni: giovani che allora erano ap-pena un po’ meno sbandati dei loro colleghi del M5s, e piùsuggestionati dall’ultimo tweet che da ordini di scuderia.
Non è pensabile un ritorno
al Parlamento dei notabili
Con l’ascesa di Renzi alla segreteria e a Palazzo Chigi sipoteva pensare che tornasse la disciplina di gruppo. Ma i rap-porti di forza continuano a essere più sfavorevoli al segretarionei gruppi che nella direzione del partito. E le minoranze (ilplurale è d’obbligo) non dissentono nelle sedi di partito dalleproposte di legge o di candidature, salvo rifarsi subito dopo inParlamento. E’ successo col Jobs Act, con il disegno di leggedi riforma del bicameralismo e del Titolo V, con le candidatureper il rinnovo dei membri della Corte costituzionale e delConsiglio superiore della magistratura. In tutte queste occasionile decisioni prese (non importa con quanta pazienza) dagli or-gani di partito sono state smentite in Parlamento o sonorimaste in forse fino all’ultimo. Si è perciò parlato di “unospettacolo due volte assurdo, con i custodi del partito alla vec-chia maniera a un passo dal convocare i girotondi davanti alNazareno e con i sostenitori del partito liquido a invocareregole e disciplina. Il che poi non è che la conseguenzaultima, e paradossale, di quelle primarie così fortemente volutedai nemici del partito personale nel 2012, perse dai sostenitoridel modello americano e leaderistico”2. Vi è di più: paradosso nel paradosso, quando le sostituzioni inCommissione Affari costituzionali di due senatori dissenzientidal progetto governativo di riforma del Senato (Mineo eMauro) per decisione dei rispettivi gruppi parlamentari vengonoconsiderate “epurazioni” commesse in violazione dell’art. 67della Costituzione. Eppure è stato giustamente osservato chead inizio legislatura non sono i senatori a scegliere a qualecommissione parlamentare appartenere, ma sono i gruppi par-2 Così Francesco Cundari su Il Foglio quotidiano dell’8 novembre 2014.

/ / 25 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
lamentari che, dandone comunicazione alla Presidenza delSenato, provvedono a designare i propri rappresentanti nellesingole commissioni permanenti (art. 21.1 reg. Sen.; analogoè l’art. 19.1 reg. Cam.). Il senatore, dunque, è membro di una commissione non perpropria libera scelta ma perché designato tale dal propriogruppo parlamentare quale suo rappresentante: che è “termine,peraltro, non casuale, con cui il regolamento del Senato vuoleevidenziare il forte legame intercorrente tra il senatore incommissione ed il gruppo a cui (è bene ricordarlo) egli hascelto liberamente di aderire, condividendone la linea politicaed il relativo regolamento”. Per cui i gruppi parlamentari,come nominano, possono anche sostituire i propri rappresentantiin commissione “per un determinato disegno di legge o peruna singola seduta […], previa comunicazione scritta al Presi-dente della Commissione stessa” (art. 31.2 reg. Senato; v. l’a-nalogo art. 19, commi 3-7, reg. Camera)”3. Che l’art. 67 della Costituzione venga evocato a spropositonon è casuale. Le battaglie intorno al divieto di mandato im-perativo, che credevamo non si dovessero più combattere, in-vece si combattono per ragioni che non hanno più nulla a chevedere con quelle originarie. Sono divenute una risorsa in più
in una situazione in cui, come scrive ancora Cundari, “ormainemmeno l’ultimo militante di provincia, figurarsi un parla-mentare, sembra avvertire alcun vincolo di lealtà rispetto alledecisioni del proprio partito, quando il difenderle implichi ilpiù piccolo sacrificio narcisistico per la propria immagine,che in gioco ci sia un’intervista al Tg1 o uno status suFacebook, il governo del paese o l’opinione che si potrebberofare di noi il macellaio e l’edicolante”.Quando, pochi anni fa, alcuni di noi parlarono su Mondoperaiodi una “partitocrazia senza partiti”, c’erano già tutte le premessedel disfacimento della disciplina di gruppo, e dunque deigruppi stessi. Oggi ci siamo quasi arrivati. Sarebbe un traguardobrutto e pericoloso, perché non è pensabile un ritorno al Par-lamento dei notabili, né si possono immaginare fughe inavanti in assenza di soggetti capaci di sostituire le funzionidei partiti in democrazia: e tantomeno possono servire riformecostituzionali o elettorali. In realtà il disfacimento dei gruppiprelude allo scollamento della rappresentanza politica, chetiene insieme elettori ed eletti in ogni democrazia.
3 S. CURRERI, I casi Mauro e Mineo: sostituzioni legittime e conformi aCostituzione, in Confronti costituzionali. Blog di cultura costituzionale,17 giugno 2014.

Imotivi per cui Bersani e la vecchia segreteria del Pd sonoandati incontro alla catastrofe nel 2013 costituiscono come
il negativo di una lastra nel cui positivo si possono leggere in-vece quelli che hanno portato Renzi ad affermarsi. Il risultatoelettorale di Bersani costituisce un pieno di voti (non certodisprezzabile ma insufficiente a conseguire una vittoria) oltreil quale non è più possibile guadagnarne nemmeno uno in più:un pieno insufficiente a vincere. Perché? Guardando con at-tenzione al partito di Bersani si comprende che rappresentavaancora la vecchia struttura organizzativa novecentesca, unastruttura gerarchico-discendente incapace anche di percepireil contesto sociale del tutto modificato in cui si trovava adagire, legato ad un’ideologia consolidata (tardo-berlingueriana)collaudata da decenni, che dava sicurezza al gruppo dirigentee agli elettori più fedeli ma del tutto priva di significato per glialtri: la maggioranza dei cittadini.Dopo la catastrofe, Renzi si è mosso senza commettere errorie ha guadagnato una vittoria impressionante sul vecchiogruppo dirigente. Il suo programma era in grado di rivolgersialla maggioranza dei cittadini e si è visto alle elezioni europeecome il Pd abbia sfondato i tradizionali steccati in cui era rin-chiusa la sinistra, riuscendo a raggiungere quasi il 41% deiconsensi. Una volta messo da parte il sistema ideologico cheavvolgeva il Pd guidato da Bersani, quali idee nuove hannoiniziato ad affermarsi? In parte ovviamente sono state ripresele idee che aveva sostenuto Veltroni, il fondatore del Pd e suoprimo segretario, con il famoso discorso del Lingotto (27giugno 2007), che spostava in avanti, oltre il Novecento, ilbaricentro del partito che stava per nascere, un partito imma-ginato come maggioritario e riformista.Ma Renzi ha voluto aggiungere altre considerazioni, come sipuò desumere dall’introduzione alla riedizione del libro diBobbio, Destra e sinistra: «Le sicurezze ideologiche del No-vecento [...] rendevano più semplice – scrive Renzi – il mondodella rappresentanza delle istanze degli ultimi e degli esclusie del governo del loro desiderio di riscatto». Il mondo, divisoin blocchi sociali, era relativamente più facile da governare:«Oggi quei blocchi sociali non esistono più ed è un bene che
sia così. In fondo tutta la fatica quotidiana della sinistra so-cialdemocratica, cara a Bobbio, era stata quella di scardinarequei blocchi. Allo scopo di offrire agli uomini e alle donne,che erano in quei blocchi costretti, l’opportunità di una vitamateriale meno disagevole e di un’esistenza più ricca di espe-rienze». Al posto di quei blocchi, peraltro chiusi entro i confininazionali, ci sono dinamiche nuove e una grande irrequietezzasociale: «Di fronte a questo potente mutamento di prospettivasociale ed economica, la sinistra deve mostrare di averecoraggio e non tradire se stessa».
/ / 26 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
Di che sinistra è Renzi>>>> Matteo Monaco
La cultura politica del Pd

Questo è dunque il terreno nuovo della sinistra, non l’appello«a blocchi sociali che non esistono più». A questo puntoRenzi si chiede: «Come recuperare, dopo anni di diffidenza,anche tra i progressisti, idee come ‘merito’ o ‘ambizione’?Come evitare che, in un paesaggio sociale tanto mutato, la si-nistra perda contatto con gli ‘ultimi’? [...] Certo l’uguaglianza– non l’egualitarismo – resta la frontiera per i democratici».Ma dopo tanti decenni bisogna che la sinistra allarghi ilproprio orizzonte spaziale, che senza dimenticare le proprieorigini «faccia i conti con i tempi nuovi che ci troviamo avivere, ad attraversare». Sono concetti che si ritrovano di nuovo nella relazione diRenzi alla direzione nazionale del PD del 20 ottobre 2014.Renzi, contravvenendo al diffuso piagnisteo su quanto siabrutta la globalizzazione, sui cattivi monopolisti che lentamenteci vanno strozzando, ribalta la prospettiva: «La globalizzazioneè una grande opportunità per l’Italia, una opportunità insiemeeconomica e culturale», nella quale occorre che il nostropaese si impegni per ritrovare una nuova, ma anche antica,strada: quella della qualità dei nostri prodotti industriali co-niugata con un forte impulso, da riattivare, proveniente dal“Rinascimento italiano” (creatività, capacità di innovazione,alto livello artistico e culturale).
Ad alcuni tornerà in mente il discorso
di Claudio Martelli alla conferenza socialista
di Rimini del 1982
Parlando del Pd Renzi chiarisce che stare in un partito di sinistraoggi significa «attivarsi per creare opportunità; opportunità nonvuol dire opportunismo, non significa trincerarsi dietro renditedi posizione» e aspettare che le cose seguano il loro corso tradi-zionale: ma «liberare il talento», mettere in moto delle dinamicheche consentano di «creare occasioni adatte a chi ha voglia, capa-cità, competenza per provare a realizzare delle nuove realtà a li-vello culturale, economico, imprenditoriale». Tutto ciò, naturalmente, «senza dimenticare dietro nessuno»,senza abbandonare chi non è in grado o è schiacciato dal bi-sogno: «Perseguire l’uguaglianza che crea nuove opportunità,non l’egualitarismo». Vuol dire ancora «non limitarsi acreare solo ‘pari’ opportunità di genere ma pari opportunitàiniziali che consentano a tutti di non partire svantaggiati»;accanto al superamento della distinzione di genere, va per-seguito, dice Renzi citando Augé, anche un modello «inter-generazionale», che veda la partecipazione di persone diogni età ai processi di trasformazione sociale molto intensi.
Tutto ciò diventa poi indispensabile se si pensa di tenere in-sieme e funzionante la formazione partito, cioè una strutturache deve trovare il modo per sviluppare pensieri lunghi,adatti a tenere dietro alla velocità delle trasformazioni socialie politiche.Si tratta di concetti ripetuti anche alla Leopolda fra il 24 e il26 ottobre 2014. Renzi è stato molto netto nell’affermare lanecessità di recuperare il terreno perduto per immettersi deci-samente nell’ultima modernità: bisogna evitare di «pensare diprendere l’iPhone e cercare di metterci il gettone per telefonare.E’ finita l’Italia del rullino, io rivendico l’Italia del digitale,l’Italia del domani!». Occorre, dice Renzi, infondere il sensodella speranza nel futuro: «C’è una parte della politica italianache pensa che l’Italia non ce la farà. Questo atteggiamentodeve cambiare. Lo spirito della Leopolda è lo spirito di chipensa che l’Italia ce la farà a cambiare il proprio posto nelmondo e lasciare un segno. Bisogna avere il coraggio di direche le cose vanno cambiate».Forse ad alcuni tornerà in mente il famoso discorso di ClaudioMartelli alla conferenza socialista di Rimini dei primi diaprile del 1982. Così diceva Martelli: «Soltanto chi può agireperché vuole o perché deve è destinatario delle azioni diriforma e di cambiamento [...] Il senso dell’alleanza riformistae socialista è e non può non essere nella sua essenza altro senon questo: l’alleanza tra il merito e il bisogno», cioè l’alleanzafra i competenti e forniti di mezzi sufficienti e coloro chesono immersi nel bisogno. Gli uni diventano riformisti perscelta, gli altri per necessità. Così Enrico Morando ha commentato nel 2009: «Senza uncambiamento ispirato al riconoscimento del merito non po-tranno trovare risposte le esigenze dei nuovi titolari del bisogno[...] Per dar luogo a questo complessivo riorientamento delleproprie politiche, il partito riformista che voglia affermare lapropria vocazione maggioritaria deve impegnarsi in una bat-taglia politico-culturale molto aspra nel suo campo [...] Edeve assumere, per il successo della sua politica, un orizzontetemporale di medio-lungo periodo».Naturalmente l’attacco portato alle vecchie situazioni di potereconsolidate anche a sinistra non poteva non sboccare nell’accusaclassica con cui si cerca da sempre di delegittimare chi nonpuò vantare una provenienza-doc da una ben determinata cor-rente ideologica: non sei di sinistra. Ovviamente è stato tiratofuori l’argomento del “cambiamento genetico”, ultima arma acui si ricorre in certi ambienti quando si è del tutto privi di ar-gomenti. Così Rossanda: «Neppure un’incorreggibile gufacome me avrebbe immaginato che Matteo Renzi avrebbe cer-
/ / 27 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

/ / 28 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
cato di portare velocemente il Pd verso una mutazione genetica,anche se covava da tempo, forse da quando Achille Occhetto,in qualità di segretario, aveva chiesto il beneficio di inventarionel richiamarsi non alla presa del palazzo d’inverno del 1917,ma alla rivoluzione francese del 1789». E aggiunge, nei com-menti al suo articolo: «Quod non fecerunt padroni e padroncinifecit Renzi cum cislini e uillini. L’ultimo difensore dei credentiè rimasto Landini».
D’Alema non ha perso l’occasione
per colpire con forza il leader del Pd con
argomenti che ritiene irresistibili
In questo modo Rossanda fa capire, meglio di tanti altri, qualesia la valutazione politica - e in un certo senso anche l’antro-pologia - che sta dietro un certo sinistrismo: da una parte siestrae dai cassetti impolverati del vecchio Pci l’accusa di“mutazione genetica” rivolta alla politica di rinnovamento so-cialista dell’epoca ed estesa ora al Pd di Renzi; dall’altra lavalutazione negativa viene estesa, quasi per caso, ad AchilleOcchetto, che smantellò il Pci dichiarandosi continuatore del1789 (la rivoluzione francese) ma non più del 1917 (la rivolu-zione russa). Infine, come tocco finale significativo, Rossandaconsidera Landini non tanto come sostenitore di una linea po-litica, ma come ultimo difensore dei credenti: un’affermazioneironica, almeno così l’abbiamo letta.D’Alema a sua volta non ha perso l’occasione per colpire conforza il leader del Pd con argomenti che ritiene irresistibili:«Quello che io trovo incredibile è che, nel tentativo di offrireun retroterra teorico nobile al governo Renzi, oggi si facciaun’operazione anacronistica». Si capisce bene come D’Alemaconsideri irrilevante la politica dei socialisti europei: il retroterrateorico da lui sostenuto, un certo tipo di storicismo, un ricorsomassiccio all’uso dello Stato, sarebbero sufficienti per l’azionepolitica di oggi. Certo: tutti sono consapevoli, anche Renzi,che oggi l’impostazione di Blair o di Schroeder va rinnovata,e che l’azione politica va costruita sugli attuali problemieffettivi e specifici. Ma l’ispirazione di un socialista europeo(questo dichiara di essere Renzi) si muove sullo stesso percorso,sulla stessa ispirazione democratica e socialista liberale sullaquale si muovono da decenni gli altri socialisti europei:appunto Blair, Mitterrand, Schmidt, Schroeder e altri. La po-sizione di D’Alema (e della piccola minoranza di cui è l’e-spressione) a quali riferimenti culturali e politici si ispira?Ma quali sono le novità immesse da Renzi nel sistema politicoitaliano? Secondo Michele Salvati, Renzi ha introdotto una
innovazione mediatico-organizzativa e una innovazione poli-tico-ideologica. La prima innovazione «parte dal riconosci-mento che la ‘democrazia del pubblico’ [...] sia arrivata ancheda noi e che sia perdente la strategia di attestarsi nelle forme enei riti del partito che ha dominato gran parte del Novecento».Il partito ideologico di vecchio stampo, punto di riferimentoideale e organizzativo, non ha più spazio nella società attuale,perché le profonde, radicali modificazioni avvenute nellastruttura sociale hanno dato luogo di fatto a un’altra società,con interessi, idee, gusti, necessità del tutto differenti. Si èpassati «ad una forte personalizzazione della leadership» el’elettore non ha più bisogno di recarsi in una sede di partito,perché le idee alle quali si sente vicino vengono regolarmentepresentate in televisione o attraverso internet da imprenditoripolitici che – quando sono seri – ancorano il proprio discorsoa problemi concreti, riproducendo di fatto la dinamica destra-sinistra; in caso contrario scivolano verso una qualche formadi populismo. Le difficoltà che tali novità provocano nelle vecchie e tradizionalistrutture politiche sono evidenti in tutti i paesi europei: neiquali, oltre alla crisi economica ancora attiva e presente, si ag-giungono le enormi difficoltà create dalla cessione di quoteimportanti del potere statale alla (peraltro inesistente) federazioneeuropea. La pressione degli organi comunitari non è riuscita atradursi in una politica di sviluppo, né a creare le basi per unrapporto democratico fra la struttura burocratica europea e icittadini dei vari paesi. In tale contesto la reazione populista,muovendo da difficoltà reali esistenti, ha avuto buon gioconell’affermarsi con forza, rimanendo tuttavia forza minoritaria.Qualunque reazione dei partiti tradizionali non ha prodotto an-cora risultati positivi né in Italia né in altri paesi europei.Proprio per fermare tale deriva Matteo Renzi è riuscito, sulpiano dell’innovazione mediatico-organizzativa, a conquistareuna maggioranza schiacciante nel Pd iniziando a trasformarlonel nuovo strumento politico necessario, ed inoltre a interveniresullo stesso terreno dei populisti per cercare di fermarne la cre-scita: «Renzi ha reagito accettando l’inevitabile, la democraziadel pubblico e una forte personalizzazione dello scontro politico:una strategia particolarmente adatta alle sue capacità». Se lanuova forma-partito non è ancora una vera e propria realtà, icolpi assestati al populismo sono stati molto significativi.È stato detto che non si riescono ad afferrare i contorni politi-co-culturali di Renzi; sicuramente ha delle somiglianze conBlair, ma «a differenza di Blair, che fece precedere e seguirela sua svolta da una poderosa campagna teorico-ideologica af-fidata ad uno dei migliori sociologi inglesi, Tony Giddens [...]

/ / 29 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
nulla di paragonabile si ritrova nelle iniziative, nelle dichiara-zioni e nei materiali che hanno accompagnato l’ascesa diRenzi»: una mancanza che andrebbe colmata. In definitiva,secondo Salvati, si potrebbe così considerare la posizione po-litica renziana: certamente Renzi è «attento non solo alle‘libertà da’, ma anche alle effettive ‘libertà per’, ad una ragio-nevole uguaglianza di opportunità per i ceti socialmente piùsvantaggiati». Come ogni liberale è per l’efficienza e per l’e-quità: «l’Italia è ingiusta anche perché è inefficiente». Se lecose stanno così è fondamentale effettuare innanzitutto le ri-forme istituzionali che «diano al governo le risorse ammini-strative, regolamentari e di consenso necessarie ad una lungalegislatura riformatrice guidata da un partito unico» (a sinistra)che abbia vinto le elezioni.
Bisognerebbe valutare se sia una buona
scelta quella di “creare” avversari in serie
su tutto l’orizzonte politico e sindacale
Secondo Eugenio Somaini, nonostante le critiche feroci pro-venienti generalmente da ben determinati ambienti politici,interni o esterni al Pd ma comunque condotti da chi si ritienecustode di un’ortodossia non ben precisabile, si può ritenereche «ci sia del metodo nella sua azione, un’ipotesi che misembra confermata dal fatto che la sua condotta presenti trattiricorrenti, ma adattandosi di volta in volta alle circostanze esenza cadere nella ripetitività e nello stereotipo». Somaini
avanza l’ipotesi che il comportamento effettivo di Renzi rinviialla «nozione di pragmatismo, in una versione alta alla Deweye non come semplice arte dell’arrangiarsi».Ma come procede Renzi nel perseguire degli obiettivi? Somainicosì risponde: «Mi sembra che Renzi proceda: i) individuandoe formulando in modo chiaro dei cluster di obiettivi tra lorostrettamente collegati e reciprocamente funzionali; ii) intra-prenda decisamente le azioni che ritiene necessarie per realiz-zarli, adattando pragmaticamente queste, e in parte aspettinon essenziali degli obiettivi stessi, alle resistenze che incontra;iii) accompagni ogni sua iniziativa a un clima di mobilitazionedemocratica, individuando gli alleati, mettendo nell’angologli avversari, creando divisioni tra loro e mantenendo semprel’iniziativa». Una mobilitazione che si realizza mettendo inmoto degli elementi che fanno ricorso al senso di responsabilità,alla speranza che si possa costruire una politica migliore e piùefficiente, alla necessità di assumersi con coraggio i rischicorrispondenti: «L’idea machiavellica del ruolo della fortunaviene immediatamente alla mente». Non manca in Renzi ilsenso dell’urgenza con cui devono essere realizzati determinatiobiettivi, perché il tempo non è illimitato e il suo scorrere nonè privo di conseguenze: un elemento che in qualche modo ri-prende, in un’altra dimensione, lo here and now degli anniSessanta, con una foga realizzatrice non inferiore, ma tuttaviainterna alle istituzioni liberaldemocratiche, non contro di esse.Da qui l’importanza della spinta propulsiva impressa da Renzialla politica e in qualche modo alla società italiana: una spinta

che punta sulla rete e cerca di mettere in rete tutte le situazionidi difficoltà per puntare ad una svolta, ad un cambio didirezione nella nostra società.Naturalmente ci saranno sempre più reazioni forti all’internodella politica italiana. Bisognerebbe valutare con attenzionese sia una buona scelta quella di “creare” avversari in serie sututto l’orizzonte politico e sindacale italiano: in particolare,un conto è scontrarsi con certi dirigenti discutibili e probabil-mente non molto rappresentativi, altro è scontrarsi con l’interastruttura sindacale e con i suoi iscritti, che forse andrebberomaggiormente coinvolti nell’opera di trasformazione dellasocietà italiana. Si dirà che ci sono state grosse manifestazioni che fannotoccare con mano l’esistenza di due sinistre. Ma vediamocome sono andati i fatti. Per la sinistra sindacale Renzi è ungrosso problema, ha scritto D’Alimonte: «Alla Cgil e alla si-nistra Pd stare al governo in realtà non interessa. Quindivincere le elezioni non è una priorità. Anzi è un fastidio. Co-stringe ad alleanze scomode. E poi vincere vuol dire governaree oggi governare è sinonimo di cambiare». Meglio organizzareuna manifestazione a San Giovanni e sentirsi rinfrancati. Dal1948 (in cui perse le elezioni) la sinistra come tale non ha maivinto. Non ha vinto neppure nella seconda Repubblica. Nonha vinto da quando è nato il Pd: «E alla fine è arrivato ildisastro del 25 febbraio 2013. Quel giorno è morta definitiva-mente la vecchia sinistra. La mobilitazione di piazza San Gio-vanni non la farà rinascere. Il 25 febbraio è stato un traumaper milioni di uomini e donne di sinistra. Il nuovo Pd è natoquel giorno». Come ha fatto Renzi a superare questo limite storico? D’Ali-monte ci dice che il Pd renziano ha per la prima volta abbattutogli steccati tradizionali, andando oltre il proprio elettorato:«Ha fatto breccia tra l’elettorato moderato, tra commercianti,artigiani, piccoli imprenditori. Ma sbaglia chi pensa che questidati servano a dipingere Renzi come un leader di destra [...] Larealtà è che Renzi è il leader di una sinistra diversa, unasinistra che accetta la sfida del cambiamento». Tuttavia questasfida è stata lanciata ad un numero molto alto di organizzazioni,tanto che alcuni avvertono dei pericolosi scricchiolii, di cuiforse è opportuno tener conto. Giuseppe De Rita avverte che«è naturale l’orientamento a rottamare la concertazione; amettere in discussione la capillarità degli apparati di partito; adisconoscere il valore oggettivo delle lotte e delle strutture sin-dacali [...] In altre parole, la volontà politica sembra voler farea meno della rappresentanza e degli enti intermedi». Sembraquasi che il potere politico intenda creare il vuoto fra cittadini
e istituzioni centrali, sgombrando il campo da tutte le istituzioniintermedie, arrugginite e autocentrate. Sicuramente c’è delvero in tale valutazione, ma, secondo De Rita, occorre consi-derare che il consenso oggi è piuttosto labile nel tempo, e chedopo avere rottamato bisogna iniziare a ricostruire, cosa certonon facile. «Questo vuol dire che la disintermediazione èun’illusione?», si chiede De Rita. Sicuramente no, ma occorreràprestare molta attenzione ad alcuni campanelli d’allarme.
Il Pd renziano ha già realizzato una
trasformazione impensabile fino a pochi
mesi fa: ha spedito a casa una
generazione di funzionari rimasti sempre
con la testa dentro il Pci
Su questo punto insiste Marc Lazar: «Matteo Renzi sbaglia asnobbare Confindustria, sindacati e gli altri corpi intermedi.Se continuerà a farlo, le sue riforme non arriveranno danessuna parte». D’altra parte l’Italia ha estremo bisogno di ri-forme. Oggi tuttavia il consenso è liquido, e difficile il rapportofra politica centrale e cittadini. Occorre, dice Lazar, spostarel’accento dal government (un governo che prende delledecisioni e le fa eseguire) alla governance (il governo di unterritorio realizzato attivando tutte le componenti sociali chevi insistono): «Occorre tenere come punti di riferimento parolecome merito, talento ed etica» nell’attività politica, inserendoelementi di diversità etnica, generazionale, di genere e culturale;soprattutto, per «evitare un clash of generations, l’attualeclasse dirigente deve coinvolgere esponenti giovani, qualificati,capaci e che riflettano la diversità della società. Ma senza maidimenticare il criterio del merito». Alan Friedman, nella riedizione di un suo volume, non ha tut-tavia dubbi: «A mio avviso Renzi ha fatto bene quest’anno amettere tutto sul tavolo. Riforme strutturali, pubblica ammini-strazione, fisco, giustizia, welfare [...] Cambiare l’Italia è unasfida ardua. E richiede la capacità di correre una maratona enon tentare solo uno sprint. Per cambiare nel paese dei gatto-pardi bisogna essere disposti a disimparare e disattivare tantadella cultura e mentalità della vecchia Italia degli ultimi de-cenni». Si ferma a considerare un altro punto non meno im-portante Virginio Rognoni: il quale dà atto a Renzi di averproseguito con forza sulla strada della alternanza di governo,da realizzare nel tempo, una volta terminata la fase di rico-struzione istituzionale («l’alternanza al governo di due forma-zioni contrapposte, con programmi e storie diverse»); e per
/ / 30 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

quanto riguarda il Pd, Renzi ha chiarito che si tratta di un«partito collocato sulla sinistra, secondo la storia che ha allespalle, compresa quella del cattolicesimo democratico e senzainfingimenti, come lo prova la sua collocazione, a livello eu-ropeo, fra le famiglie socialiste». Quindi, preso atto che ilnuovo Pd non esiste senza Renzi (e viceversa), Rognoni sichiede se il segretario stia compiendo tutto ciò che è necessarioper far funzionare al meglio il partito: «Spetta soprattutto alsegretario questa opera di manutenzione capace di eliminareincomprensioni che, nel tempo, irrigidendosi, potrebbero di-venire laceranti».Antonio Polito ammette invece che il Pd renziano ha già rea-lizzato una trasformazione impensabile fino a pochi mesi fa:ha spedito a casa una generazione di funzionari rimasti semprecon la testa dentro il Pci, ha ringiovanito il governo rendendoloinoltre molto più femminile. Tuttavia c’è un punto che provocaquasi sgomento: «Il nostro premier offre infatti agli italianiuna spiegazione un po’ troppo consolatoria della crisi grave incui versiamo. Dalla sua retorica, e anche dal suo programma diriforme, si trae un’idea fuorviante». Si potrebbe però rispondereche è compito di un leader essere almeno un poco ottimista ecercare di spingere quanto più è possibile sul pedale della spe-ranza per una riuscita positiva dell’azione politica.
“Ho spinto al massimo perché il Pd, dopo
anni e anni di dibattito, fosse collocato
in Europa dove è adesso,
dentro la famiglia socialista”
E di un cambiamento c’è bisogno, se si tiene mente a ciò cheha scritto di recente Ernesto Galli della Loggia sul senso didisfacimento generale della comunità nazionale connesso allaquasi scomparsa dello Stato. Certo, l’economia si trova in unasituazione di grande difficoltà. Tuttavia non è qui il punto.Molto più grave è la sfiducia crescente nelle istituzioni, il de-grado generalizzato che invade organizzazioni e territori met-tendo in luce «un dato nuovo e inquietante: la latitanza delloStato [...] È la sensazione di questo vuoto ciò che ogginell’Italia delle periferie urbane e della piccola gente, delMezzogiorno mortificato e incarognito, dei tanti microim-prenditori che stentano la vita, nell’Italia del paese reale, piùcontribuisce ad esasperare ogni egoismo ma anche a incrinareogni fiducia. E quindi ad aggravare ulteriormente la stessacrisi economica». Questa è l’Italia che Renzi sta governando.Un paese che va visto nelle sue componenti sociali: nei piani
alti come nei piani bassi. In cui occorre ricostruire il sensodella comunità e la fiducia nelle istituzioni democratiche. Oc-corre «ridarle un senso di sé e uno scopo che vadano oltrel’oggi [...] ridarle il coraggio che sta scemando [...] garantirleche ancora esistono una legge e un’autorità [...] dire le parole,e compiere i gesti, che nei grandi momenti di crisi decidonodel futuro di una nazione».Ma sulla Repubblica del 21 novembre 2014 compare una do-manda secca, rivolta dal direttore direttamente a Renzi: «Unconflitto sull’articolo 18 è comprensibile, ed era anche preve-dibile. Il linguaggio con cui il presidente del Consiglio trattala Cgil è invece molto meno comprensibile [...] La domanda èsempre la stessa: che idea ha il segretario del Pd della sinistrache guida? Un partito che voglia parlare all’intera nazionedeve ospitare culture diverse al suo interno e tocca al leader -mentre decide - garantire loro spazio e legittimità. Sapendoche prima o poi si voterà, e i suoi avversari non saranno Ca-musso e Landini, ma Berlusconi e Verdini. Quando se ne ac-corgerà?». Renzi ha replicato il 22 novembre 2014: «Ho sempre rivendi-cato, con fierezza ed orgoglio, l’appartenenza del Partito de-mocratico alla sinistra, alla sua storia, la sua identità plurale,le sue culture, le sue radici. Per questo ho spinto al massimoperché il Pd, dopo anni e anni di dibattito, fosse collocato inEuropa dove è adesso, dentro la famiglia socialista della qualeoggi, grazie al risultato delle ultime elezioni, è il primo partitocon oltre 11 milioni di voti. Questo per dire che nei comporta-menti concreti, nelle scelte strategiche, il Pd sa da che partestare […] Dalla parte dei più deboli, dalla parte della speranzae della fiducia in un futuro che va costruito insieme». Renzichiarisce che ha un profondo rispetto per il lavoro e per i sin-dacati che lo rappresentano, ma che tale rispetto deve esistereanche da parte dei sindacati nei confronti della politica e delgoverno che sta cercando di cambiare il mondo del lavoro. Datempo c’è in Italia una situazione stagnante che occorre ri-mettere in movimento: «Penso che il modo più utile per di-fendere i diritti dei lavoratori sia quello di estenderli a chiancora non ce li ha, di aprire le porte di uno spazio rimastotroppo chiuso per troppi anni». Ma quale situazione esisteoggi nel mondo del lavoro? «Sono pronto sempre al confronto,da mesi giro l’Italia in lungo e largo, visitando aziende, strin-gendo le mani di chi lavora, parlando del futuro del paese inuna competizione sempre più dura nel mondo. Non siamonoi, non è il governo, non è il Partito democratico a cercare loscontro. Siamo noi, però, a porre il tema di un mondo checambia, nel quale non possiamo più permetterci di non dare
/ / 31 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

/ / 32 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
tutele alle donne che non hanno garanzie se aspettano unfiglio. Un mondo nel quale la selva di contratti precari e pre-carizzanti deve essere disboscata, semplificata. Un mondo nelquale esista una rete di strumenti di welfare che sostenga chiperde il lavoro e lo metta in condizione di trovarne un altro».
Si può vedere nella scelta dei personaggi
citati nella lettera a Repubblica un tentativo
di utilizzare icone dalle caratteristiche
fortemente emotive ed evocative
Proprio per questo Renzi si chiede se il sindacato e tutta lasinistra abbiano capito che occorre cogliere l’opportunità dioperare profonde trasformazioni nel nostro paese: «Perquesto penso che la battuta su Berlusconi e Verdini che fal’editoriale di Repubblica sbagli indirizzo e destinatario. IlPd ha chiara la differenza tra maggioranza e opposizionecosì come ha chiaro che le regole del gioco si prova a cam-biarle assieme per poi tornare a dividersi su tutto il resto.L’alternativa all’Italicum è lo status quo proporzionalistico.Che convince chi ha in mente un disegno neocentrista chefino a qualche mese fa era sul tavolo e che noi abbiamo spa-recchiato». Ed afferma che la sinistra di cui è portavoce èricca di valori e si rispecchia nell’azione di grandi leader delpassato, come Gandhi, Calamandrei, Dossetti, Langer, Man-dela, Berlinguer, La Pira e Kennedy (su questo pantheon cisarebbe qualcosa da ridire, ma vedremo fra poco). Renzi riprende il suo discorso, insiste sui ritardi e sulle in-giustizie tipiche della situazione italiana, e conclude: «Cisono due modi per cambiare l’Italia. Farlo noi da sinistra. Ofarlo fare ai mercati, da fuori. Sostenere che le ricette sianole stesse cozza contro la realtà. In ciò sta tutta la nostra ideadi sinistra. Parole che producono fatti. Perché il tempo delleparole, giuste o sbagliate, slegate dai fatti, è un tempo cheabbiamo deciso di lasciarci alle spalle per sempre».Come va considerato l’elenco di personalità riunite qualiideali di riferimento per il Pd? «Non va sovrastimato il signi-ficato della trovata renziana», scrive Massimo Teodori: ma il«pot-pourri di busti marmorei» non lo convince, e meno con-vincente ancora gli sembra se si cerca di delineare che cosaunisca uno all’altro tali così diversi e contrapposti leaderpolitici. Ora, qui è opportuno riprendere in considerazione ildiscorso svolto in precedenza sull’importanza della comuni-cazione di massa in una situazione come quella attuale.Quando Renzi si presenta sulla scena politica trova un grande
comunicatore (sia pure in una presunta fase calante) comeBerlusconi; e un vecchio comico che è riuscito a convogliarefolle enormi alle proprie rappresentazioni, intercettando unimmenso elettorato. Da queste considerazioni è evidente chealmeno in parte gli interventi pubblici di Renzi tendono acontrastare tali personaggi creando un flusso positivo nei con-fronti di un partito, il Pd, che era stato ridotto al lumicino dalvecchio gruppo dirigente e non riusciva più a veicolare alcunaforma di narrazione nei suoi rapporti con l’esterno.Si può vedere nella scelta dei personaggi citati nella lettera a Re-pubblica un tentativo di utilizzare icone dalle caratteristiche for-temente emotive ed evocative come canali speciali per stabilireo riaprire un contatto con settori di pubblico più distanti; le varieicone, relative a personaggi che già scivolano nella storia, inne-scano una tensione positiva nei confronti del proponente daparte di quei settori del pubblico. In realtà quindi non sono iconein rappresentanza di una qualche idea politica, difficili dacollocare, ma rappresentano propriamente settori dell’elettorato.Una volta attivata una corrente positiva tendono a confondersinel tempo sfumando progressivamente in un’unica indistintaicona, che si sovrappone all’icona umana, cioè a Renzi stesso.Rimane naturalmente una strana sensazione sul fatto cheRenzi abbia sentito l’obbligo di dichiarare il suo essere di si-nistra accompagnando tale dichiarazione con l’esibizione diun pantheon piuttosto strano. Scrive Paolo Pombeni: «Ilfatto è che se Renzi vuole davvero, come dice, ‘porre il temadi un mondo che cambia’, deve evitare di misurarsi con ilterreno obsoleto su cui lo invitano allo scontro avversariche, secondo antichi copioni, usano il richiamo alle ortodossiestoriche come eccitanti per risvegliare fedeltà di massa chestanno loro sfuggendo di mano». Ciò è naturalmente vero,ma si consideri anche l’utilità che consegue Renzi strappandodelle icone agli avversari per anestetizzarle. Al di là dellaquestione iconica, Pombeni si interroga su due punti che co-stituiscono delle questioni essenziali per una politica disinistra che però fuoriesca dal vecchio marxismo-leninismo:«La prima è la questione del rapporto fra la sinistra e il ‘pro-gressimo’. La seconda, ancora più scabrosa, fra la sinistra eil liberalismo».La vecchia cultura impregnata di operaismo di tanta partedella sinistra italiana, negava validità al progressismo, «unconcetto ambiguo, poco connotabile lungo distinzioni diclasse». Nell’ambito della stessa cultura, un punto importanteera quello dell’apporto della sinistra cattolica una volta «ac-colta nelle fila della sinistra [...] nelle vesti del figliol prodigoche si accorge finalmente dove sta la vera casa del padre».

E’ chiaro che per un cattolico non basta stare a sinistra ecitare Dossetti pensando di potersi rifare sic et simpliciter alsuo pensiero: occorre invece storicizzarlo, legarlo ai problemidel suo tempo, così come lui e altri avevano riletto (modifi-candola) la «precedente dottrina sociale cattolica» (aggiun-gerei che forse è ancora più importante rifarsi ai program-matori cattolici come Pasquale Saraceno, di cui si dovrebbecontinuare l’opera). La seconda questione, ancora più complessa, è quella delrapporto fra liberalismo e socialismo, un rapporto antico chein Italia è sempre stato vissuto male. Oggi «c’è un gran biso-
gno di pensiero politico contro la sua riduzione a battute dalanciarsi reciprocamente in faccia sui vari ring televisivi». A questo punto occorrerebbe tornare a riflettere sulla propostaliberalsocialista di Carlo Rosselli (anche qui, si intende, pro-fondamente rinnovata e adattata al presente), punto di arrivodel socialismo riformistico turatiano del primo Novecento.Perché rileggere oggi gli scritti di Carlo Rosselli? Il suo librofondamentale è Socialismo liberale: «Lo scrissi nascostamentea Lipari, isola di deportazione fascista, pochi mesi prima dellamia evasione». Nel 1929 riesce a fuggire dal carcere in moto-scafo e si rifugia in Francia, dove pubblica la prima edizione(1930), in francese, del suo scritto. Punto di partenza nell’analisidi Rosselli è la contestazione radicale del marxismo, ritenutoun «pensiero nettamente deterministico»: tutto, nell’ottica diMarx, viene rimandato al dopo, successivamente alla conquistadel potere: «Allora solo comincerà la vera storia, allora solo siverificherà il famoso passaggio ‘dal regno della necessità alregno della libertà’, e gli uomini diventeranno padroni dellaloro storia». Tale meccanicismo utopistico si spiega «solo col caratteremessianico del profetismo marxista», poco attento, in fondo,alle trasformazioni reali in atto nella società. D’altra parte èproprio la compenetrazione tra mezzi e fini che assicura unvalore “universale” al socialismo, che non va inteso come unideale statico e astratto: si tratta di un ideale regolativo limite(in senso kantiano) che si realizza per quel tanto che riesce apermeare la nostra vita. Le conquiste del liberalismo politicoe della democrazia rappresentativa - per Rosselli - vanno sal-vaguardate e fatte proprie dai socialisti, prendendo atto che«specie il socialismo collettivista, accentratore, il socialismodi Stato, ne è uscito disfatto [...] Si credette che [...] passatetutte le attività allo Stato [...] tutto sarebbe andato per ilmeglio [...] Ormai nessuno crede più in coscienza a codestefavolette» (scriveva queste cose già nel 1924!). E continua:«Occorre gettar via il vecchio bagaglio dogmatico che pesainutilmente sulle spalle e impaccia il cammino e adeguarsi al-l’esperienza». Solo negli anni Settanta del Novecento Norberto Bobbio epochi altri cercarono di innestare nel socialismo italiano latradizione del socialismo liberale, puntando sulla difesadello Stato di diritto e sulle istituzioni liberaldemocratichein polemica non solo con quei marxisti rimasti rigidamentedifensori dell’ortodossia, ma anche con operaisti, leninistie stalinisti di vario tipo: e anche il pensiero di Bobbio do-vrebbe tornare al centro della discussione in un partito li-beralsocialista.
/ / 33 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

Il lavoro è in crisi. Non si tratta di una crisi congiunturalelegata all’andamento del ciclo economico. Neppure di un
problema isolato di singoli paesi che, come l’Italia, sono rimastiindietro nella gara per la globalizzazione dell’economia mondiale.Il fenomeno della crisi del lavoro è qualcosa di ben più profondo,di strutturale, ed è stato attentamente studiato da Jeremy Rifkin,che già vent’anni fa aveva dedicato all’argomento un intero suolibro intitolato non a caso La fine del lavoro. Lo scenario che si sta sempre più delineando, per effetto deigrandi progressi delle tecnologie labour saving, secondo Rifkinè quello di una progressiva riduzione del numero degli occupatinon in un singolo paese ma nel mondo intero: “I big data,l’analisi avanzata, gli algoritmi, l’intelligenza artificiale e la ro-botica stanno sostituendo il lavoro umano nel settore manifattu-riero, in quello dei servizi e in quello del sapere e dell’intratteni-mento, dando concreto spessore alla prospettiva di liberare cen-tinaia di milioni di persone dal lavoro nel contesto dell’economiadi mercato durante la prima metà del XXI secolo” (pag.169).Per Rifkin si tratterà di un processo di liberazione: l’umanità fi-nalmente liberata dall’incubo del lavoro. Ma siamo davverosicuri che chi oggi lavora sia contento di trovarsi, nel prossimofuturo, “liberato” dall’onere del lavoro? Siamo davvero sicuriche i lavoratori siano contenti di essere liberati dal lavoro?Rifkin descrive con toni ottimistici uno scenario che, se si ve-rificasse del tutto, sarebbe drammatico, almeno nel breve pe-riodo: “Poiché una parte sempre maggiore di beni e serviziche costituiscono la vita economica della società muove versoil quasi azzeramento dei costi marginali e diventa praticamentegratuita, il mercato capitalistico si ritrarrà in nicchie semprepiù ristrette, dove le imprese a scopo di lucro sopravviverannoai margini dell’economia, contando su una base sempre più li-mitata e rivolta a prodotti e servizi altamente specializzati”(Rifkin 2014, pag.9). Pochi operatori, altamente professiona-lizzati, sostituiranno nei prossimi anni la gran massa dei lavo-ratori, in un mercato economico che per effetto delle nuovetecnologie sarà destinato sempre più a contrarsi. La terza ri-voluzione industriale già oggi sta cambiando i rapporti dipotere che stanno alla base dell’organizzazione economica
della società, passando dal classico modello gerarchico (dallacaserma alla fabbrica) a forme di potere laterale, distribuitofra più soggetti in un modello a rete: l’Internet delle comuni-cazioni (il world wide web) sta ormai per essere affiancato apieno titolo dall’internet dell’energia (le fonti rinnovabili,come il fotovoltaico e l’eolico) e dall’internet delle cose (conla progressiva diffusione delle stampanti 3D).
Si ripropone con forza il problema
della disoccupazione tecnologica
Scrive Rifkin: “Settore dopo settore, i costi di produzione dibeni e servizi si stanno spostando verso lo zero, con la conse-guenza che i profitti vanno riducendosi e la consistenza del Pilcomincia a vacillare. E dal momento che sempre più beni eservizi stanno diventando pressoché gratuiti, nel mercato sifanno meno acquisti, il che comporta un’ulteriore riduzionedel Pil” (pag.31). Interi settori dell’economia stanno già oggisoffrendo, e pesantemente, per la diffusione delle nuove tecno-logie informatiche e delle telecomunicazioni: pensiamo aglieffetti che il solo internet delle comunicazioni sta producendosull’editoria, sull’operatività bancaria, sull’industria discografica,televisiva e della cultura, effetti materiali che si traducono ine-vitabilmente e inesorabilmente in pesanti tagli occupazionali.E nel libro La Terza Rivoluzione Industriale Rifkin aveva de-scritto i cambiamenti radicali dell’economia capitalistica causatidalle innovazioni tecnologiche in campo energetico e delle co-municazioni: “La trasformazione delle economie americaneed europee dai combustibili basati sulla legna alle tecnologiedel vapore alimentate a carbone è stata completata in mezzosecolo, così come è accaduto con il passaggio dal sistemabasato sul carbone e sulle ferrovie al sistema fondato sulpetrolio e sull’automobile” (Rifkin 2011, pag.48).La crisi del 2008 ha mostrato i limiti del sistema nell’ambitofinanziario internazionale, ma nessuno sembra aver accettatol’idea di un fallimento globale dell’intero modello economicocapitalistico così come finora l’abbiamo conosciuto; ci è sem-brata una crisi ciclica, una Grande Contrazione mentre, per
/ / 34 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
Vivere senza lavoro>>>> Gianpiero Magnani
I gründrisse di Rifkin

dirla con Karl Polanyi, si tratta al contrario di una crisi strut-turale che sta portando l’intero sistema verso una GrandeTrasformazione: “Tra il 1995 e il 2002 l’economia globale havisto l’industria perdere 22 milioni di posti di lavoro e la pro-duzione crescere di oltre il 30%” (Rifkin 2014, pag.173). Il processo di globalizzazione dell’economia mondiale, iniziatonel 1989 col crollo del muro di Berlino ed avviatosi in modoprorompente prima con la fine dell’Unione Sovietica e poi conl’esplosione economica dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina,Sud Africa e gli altri paesi “emergenti”) , viene tuttora percepitoin negativo, specialmente in Italia, per i processi di delocaliz-zazione che hanno interessato la nostra economia a causa dellaconcorrenza di altri paesi nella produzione e nelle condizioni dilavoro (meno tasse, meno salari, meno sindacati, meno burocraziae quant’altro). In realtà questo processo, lungi dall’essere un fe-nomeno negativo per l’economia mondiale nel suo complesso,è stato invece probabilmente il fattore chiave che ha ritardatoproprio la fine del lavoro. L’apertura dei nuovi mercati nell’Este in Asia, in particolare, è servita per inaugurare Nuove Frontiere,ha ampliato le occasioni e le opportunità di lavoro non solo perquei paesi ma per il mondo intero, Occidente in testa.
Ora però il mercato globale è diventato unico, non ci sono op-portunità di allargamento ulteriore (non siamo ancora in gradodi commerciare con gli alieni), e con l’avanzamento – progressivoma inesorabile – delle applicazioni tecnologiche labour savinga tutti i processi produttivi, commerciali e distributivi si riproponecon forza il problema della disoccupazione tecnologica. Unproblema che diventerà centrale per l’intera economia planetarianel futuro prossimo, ma che non è nuovo, tanto che già Schum-peter, nella sua Storia dell’Analisi Economica (il libro è del1954), lo affrontava in questi termini: “La disoccupazione dimassa, chiaramente indipendente da deficienze personali deidisoccupati, era sconosciuta nel Medioevo, eccetto che in con-seguenza di catastrofi sociali, come devastazioni causate daguerre ed epidemie. Questo stato di cose mutò durante e dopo ilsecolo quindicesimo. […] Per di più, quando il ritmo dello svi-luppo industriale s’accelerò, nella seconda metà del secolo di-ciottesimo, la disoccupazione tecnologica giunse ad assumerel’aspetto di un fenomeno di massa” (pag.160).Se la disoccupazione tecnologica non è un fenomeno nuovo,cosa sta cambiando oggi rispetto al passato? Rifkin osservache negli ultimi due secoli lo sviluppo delle tecnologie ha per-
/ / 35 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>> L’eccezione e la regola. Dai titoli dicoda che in tutti i notiziari televisivi rias-sumevano i principali eventi della giornataabbiamo avuto modo di sapere che ilnostro presidente del consiglio seguiva“costantemente” da palazzo Chigi levicende della Norman Atlantic e delle rela-tive operazioni di salvataggio. Di qui unaimmediata sensazione di sollievo. Subitoaccompagnata, occorre dirlo, da una certaqual perplessità.Aggiungiamo subito, a scanso di equi-voci, che tale perplessità non riguardavain alcun modo la veridicità della notizia.Nessuno, infatti, neanche i suoi piùfaziosi denigratori, era in condizione didubitare, fosse solo per un istante, delvivo interesse con cui Renzi avevaseguito (anche se in un modo nonnecessariamente costante) le vicende delnaufragio. Ma proprio per questo, la cosanon poteva costituire una notizia. Men-tre lo sarebbe stata, eccome, quella delsuo mancato interessamento. Magari
accompagnata, e aggravata, da com-menti del tipo “i gufi speculino pure sulnaufragio di una nave; io mi preoccupodi evitare il naufragio dell’Italia”; o peg-gio ancora, “quelli”(camionisti e clande-stini, n.d.r.) “se la sono proprio cercata”.O, per converso, quello di un suo inter-vento attivo in loco come soccorritoreod organizzatore dei soccorsi.Ma nell’un caso come nell’altro saremmoin piena fantapolitica. Perché un presi-dente del consiglio non può mostrarsimai disinteressato. E perché la “presenzasul luogo del disastro” (ma dove, poi? ABrindisi? In un’altra situation room ubi-cata nella regione? Su di una nave? Suun elicottero?) sarebbe stata nel miglioredei casi totalmente inutile, e nel peg-giore foriera di disastri. L’ansia da presta-zione legata all’arrivo di Pertini fu causanon ultima della morte del poveroAlfredo Rampi, e allora eravamo sullaterraferma e davanti a una semplicebuca, mentre, nel nostro caso erano in
ballo centinaia di persone in un mare intempesta.Rimane, dunque, il semplice “interessa-mento”, ancorché “costante”. Nulla chepossa accrescere il prestigio del Nostro;nulla che possa determinare una rea-zione che vada oltre il cortese sbadiglioe/o il passeggero fastidio. Perché, allora,dare fiato alle trombe?Potendo ragionevolmente escludere,almeno in questo caso, l’autopromo-zione, hanno fatto tutto i giornalisti, aconferma di una abitudine all’ossequioe alla piaggeria che viene da lontano.Ma forse questa non notizia solenne-mente assurta ad evento è anche unomaggio allo spirito del tempo: quelloche ci sta portando ad esaltare quanticompiono il loro dovere, soccorrendopersone in difficoltà, fornendo leinformazioni richieste o semplice-mente timbrando regolarmente il car-tellino. (Alberto Benzoni, mondope-raio.net, gennaio 2015)

messo di mantenere elevati livelli occupazionali perché la granmassa dei lavoratori si è spostata, nel tempo, da un settore al-l’altro dell’economia (prima dall’agricoltura all’industria, epoi dall’industria ai servizi): un settore dell’economia perdevaoccupazione, altri ne guadagnavano (e forse in misura superiore).La novità del nostro tempo è che non vale più l’equazionemaggiore produttività ugualemaggiore occupazione: un’equa-zione che poteva valere per le prime due rivoluzioni industriali,quella basata sul carbonio e quella fondata sul petrolio, ma nonper la terza rivoluzione industriale, l’attuale, che è fondata suinternet, sulle energie rinnovabili, e soprattutto sulla riduzioneestrema dei costi marginali di produzione, destinati a raggiungerela soglia dello zero, vale a dire della gratuità.
Se togliamo i redditi da lavoro
al produttore-consumatore, questi alla fine
non disporrà dei mezzi monetari
indispensabili per potersi procurare
ciò di cui ha bisogno
Assistiamo perciò ora al fenomeno della ripresa senza occupa-zione, “la ripresa senza lavoro seguita alla Grande Recessione”(2014, pag.181). L’opinione pubblica, e alcuni leader politici,continuano invece ad associare la perdita progressiva di posti dilavoro alle conseguenze della globalizzazione, ma la realtà è di-versa. E’ stato l’avvio prorompente della terza rivoluzione indu-striale ad aumentare i livelli di disoccupazione: prima l’internetdelle comunicazioni, poi l’internet dell’energia, e fra non moltotempo l’internet delle cose, che darà il colpo di grazia finale allavecchia forma di produzione basata sulle fabbriche e sul lavorosalariato di massa. E’ la natura stessa del lavoro, scrive Rifkin,che sta subendo una trasformazione epocale: “La Prima rivolu-zione industriale pose fine al lavoro schiavistico e servile. LaSeconda rivoluzione industriale ha drasticamente ridotto il lavoroagricolo e quello artigianale. La Terza rivoluzione industriale siavvia a liquidare il lavoro salariato di massa nelle industrie ma-nifatturiere e nei servizi, nonché il lavoro professionale retribuitoin un’ampia area del settore del sapere” (2014, pag.185). Rifkin osserva infatti che l’introduzione delle nuove tecnologieinformatiche nel comparto della produzione materiale, il co-siddetto internet delle cose, produrrà nel futuro prossimoun’ulteriore imponente crollo della produzione industriale, edi conseguenza dell’occupazione; in particolare, la prevedibilefutura diffusione di stampanti 3D sempre più sofisticate esempre più a buon mercato consentirà a ciascun individuo di
divenire un prosumer, cioè di produrre da sé – facilmente ebasso costo – tutta una serie di prodotti materiali per il proprioconsumo diretto che finora richiedevano invece unità produttiveseparate, fabbriche con operai, canali distributivi, servizi com-merciali ad alta intensità di lavoro: “Con il pieno dispiegamentodell’infrastruttura Idc possiamo aspettarci il crollo di molticolossi dell’industria, dal settore dell’energia e della generazioneelettrica a quello delle comunicazioni, della produzione mani-fatturiera e dei servizi” (cit., pag.92). Siamo ancora nella faseiniziale di questo processo, che se non verrà governato inmodo serio produrrà una contrazione dell’occupazione a livellomondiale come mai si è vista nella storia. E la scienza econo-mica attuale non potrà esserci d’aiuto, perché è stata costruitasu modelli organizzativi della produzione che avranno sempremeno possibilità di continuare ad esistere nel prossimo futuro.Ma, ci chiediamo, come potrà svilupparsi un’economia fondatasui prosumers? Come potranno riuscire, questi produttori-consumatori (due categorie economiche finora distinte e cheora stanno per unificarsi in un unico soggetto che consumaciò che egli stesso produce), a generare i redditi che sarannocomunque sempre necessari per acquistare il cibo, le materieprime e tutto ciò che verosimilmente non potrà essere prodottoin proprio attraverso internet, gli impianti fotovoltaici e lestampanti 3D? Oltre alle stampanti stesse, che da qualcheparte nel mondo dovranno pur essere costruite da qualcuno?Se togliamo i redditi da lavoro al produttore-consumatore,questi alla fine non disporrà dei mezzi monetari indispensabiliper potersi procurare ciò di cui ha bisogno: affonderà inevita-bilmente nelle sabbie mobili della povertà, e con lui l’interosistema economico.Rifkin sostiene che l’effetto principale dello sviluppo tecno-
/ / 36 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

logico è il passaggio da un’economia della scarsità ad un’eco-nomia dell’abbondanza, in cui i beni e i servizi continuano adavere un valore d’uso, “un valore d’utilizzo e di condivisione,ma cessano di avere un valore di scambio” (2014, p.387).Questo perché i consumatori possono procurarseli gratuita-mente, senza dover pagare alcunché: è l’economia della gra-tuità, che però presuppone un mondo abitato da cittadinialtruisti e collaborativi non sempre corrispondente alla realtàdella natura umana, che è al contrario ambivalente: un insiemedi bontà e cattiveria (e talvolta anche di cattiveria gratuita).
Rifkin, come fece Marx due secoli fa,
prefigura una trasformazione radicale
dell’economia e della cultura umana; ma
diversamente da Marx fonda la rivoluzione
sull’empatia invece che sul conflitto
Rifkin contrappone i capitalisti ai collaborativisti, i produttorie i consumatori ai prosumers, il potere verticale nelle fabbricheal potere laterale in internet, l’organizzazione gerarchica efordista della produzione alla nuova economia dei Commons,basata sulla cooperazione e sul “capitale sociale”: ma ignora ifree riders, la distribuzione diseguale delle ricchezze, e sotto-valuta i conflitti sociali che inevitabilmente, anche nellamigliore delle condizioni, accompagneranno il processo ditrasformazione dell’economia. Come scriveva Erich Fromm, che Rifkin non cita nei suoilibri (o almeno non in quelli qui esaminati), il cuore dell’uomoè in realtà la sua disposizione al bene e al male, la sua predi-sposizione alla collaborazione ma anche al conflitto: “L’uomoinclina a regredire e a progredire […] Proprio perché il male èumano, perché è il potenziale di regressione e la perdita dellanostra umanità, esso è in ognuno di noi” (Fromm 1971,pagg.195-196). Se l’umanità stesse per davvero progredendoverso l’empatia collettiva, verso la coscienza biosferica di“un’estesa famiglia globale” (2011, pag.306), non si spieghe-rebbero le perduranti divisioni etniche e religiose, i conflittiche continuano ad incendiare varie parti del mondo, e menche meno il terrorismo fondamentalista, che infatti non trovauna collocazione nella teoria di Rifkin se non come uno deglielementi critici che, al pari dei devastanti cambiamenti climatici,verrà risolto proprio dall’emergere della nuova umanità colla-borativa. Una umanità collaborativa che però non trova pienoriscontro neppure all’interno delle nuove forme di comunica-zione che dovrebbero invece costituirne il fondamento tecno-
logico: il world wide web è anche un luogo di abusi e diinsulti, di hackers e talvolta di diffamazione; è un luogo dicultura ma anche di subcultura, di gossip ed altre amenità chedi empatico e di collaborativo hanno ben poco.Potremmo dire che Rifkin, come fece Marx due secoli fa, pre-figura una trasformazione radicale dell’economia e dellacultura umana; ma diversamente da Marx fonda la rivoluzionesull’empatia invece che sul conflitto: i suoi proletari sono idisoccupati, che si riconvertono ad una nuova forma di “lavorogiocoso” producendo da sé i beni di cui hanno bisogno. ComeMarx, Rifkin non sembra in grado di delineare un nuovosistema economico alternativo a quello esistente senza che visia anche, sia pure ridimensionato, il mercato: l’economia deisoli Commons non può funzionare, così come non poteva fun-zionare una economia di solo piano. L’economia della gratuitàha gli stessi problemi della pianificazione economica colletti-vistica: non può funzionare da sola, la compresenza delmercato e dello Stato, insieme ai Commons, è necessaria e in-dispensabile. Ma, come Marx, Rifkin sembra avere terribilmente ragionesulle cause della crisi attuale: che è una crisi culturale ed eco-nomica di vastissime dimensioni, e che trova letteralmentespiazzate le teorie tradizionali, in particolare la scienza eco-nomica vigente, che non sa spiegarne le origini profonde,strutturali e non congiunturali. Di conseguenza la scienzaeconomica non riesce a trovare soluzioni efficaci, ma solopalliativi, come le enormi immissioni di liquidità da partedelle banche centrali e poco altro ancora. Ciò che Rifkin cispiega è che l’organizzazione della produzione derivante dalleprime due rivoluzioni industriali, fondate sul carbonio e sulpetrolio, sta volgendo al termine, creando disoccupazione, edi conseguenza maggiore povertà e diseguaglianza, e nel con-tempo sta anche distruggendo l’habitat naturale dell’uomo, labiosfera. Abbiamo prodotto più cose per devastare l’ambientee stare peggio: davvero un bel risultato per l’economia del(solo) libero mercato.In questo contesto il ruolo degli Stati, ed in particolare delleunioni continentali, diventa decisivo per poter garantire un fu-turo di pace e di prosperità al mondo intero: un ruolo che èpolitico, e che potrebbe anche svilupparsi con forme di inter-vento diretto nell’economia, sotto forma di imprenditoria pub-blica. Ma Rifkin indentifica invece nella cooperazione il mo-dello di organizzazione aziendale che meglio di altri potrà ga-rantire opportunità di lavoro nella terza rivoluzione industriale:“In una società in cui i costi marginali sono vicini allo zero,l’unico modello di azienda in grado di reggere è la cooperativa”
/ / 37 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

(p.301). Il sistema delle cooperative, che è già oggi una com-ponente importante dell’economia mondiale, potrebbe diventareaddirittura prevalente nella nuova economia dei Commons.Rifkin tuttavia non esclude l’integrazione tra forme diverse diorganizzazione della produzione e del lavoro; anzi, ad un mo-dello capitalistico dominato dalla prevalenza di grandi impreseprivate organizzate in forma piramidale e sostanzialmente in-dipendenti l’una dall’altra, si sostituirà una rete globale intel-ligente nella quale la proprietà privata sarà sempre meno im-portante rispetto al diritto d’accesso alle cose ed alla cono-scenza: la libertà verrà intesa sempre meno come diritto diescludere e sempre più come “diritto all’inclusione collettiva”(pag.318). Libertà è partecipazione, per ricordare il testo diuna nota canzone di Gaber di qualche decennio fa.
Il valore di scambio del lavoro sarà
destinato a ridursi sempre più
L’economia non sarà più prevalentemente capitalistica, ma unsistema integrato tra forme diverse di impresa, pubblica,privata e cooperativa: “Nell’era che si sta profilando l’anticosodalizio tra Stato e settore privato per l’organizzazione dellavita economica della società cederà il passo a una cooperazionea tre, dove accanto a Stato e forze del mercato avrà semprepiù voce in capitolo la gestione dei Commons (p.313). In ognicaso, l’intervento dello Stato sembra insostituibile, anche secambiano le dimensioni del pubblico: non più Stati nazionalima amministrazioni pubbliche locali da un lato e Unioni con-tinentali dall’altro: “La più grande economia mondiale non èquella degli Stati Uniti o della Cina, bensì quella dell’Unioneeuropea” (2011, pag.7).Ma il vero problema di fondo, a mio avviso, è che tutto il di-battito sui commons e sui prosumers implica una qualcheforma di reddito minimo garantito per tutti coloro che non po-tranno trovare lavoro: un reddito minimo che, proprio perchéè “garantito”, non potrà che avere una fonte pubblica. Giàoggi, del resto, le categorie sociali dei pensionati, degli esodatie dei cassintegrati percepiscono redditi erogati da fonte pub-blica: ma perché lo Stato dovrebbe garantire ulteriori redditidi questo tipo in cambio di nulla? A parte il problema ditrovare il denaro necessario (da dove arriva: dalle tasse, daldeficit di bilancio, stampando moneta o che altro?), già Keynesosservava come la figura del cittadino che percepisce redditida fonte pubblica senza nulla dare in cambio sia un erroregrave della politica, perché “con l’inattività forzata di milionidi individui si sta sprecando una ricchezza potenziale sufficiente
a compiere mirabilia” (pag.121). A parte chi ha malattie gravied handicap invalidanti, per Keynes tutti i cittadini che nonpossono, per varie ragioni, trovare una occupazione nel privato,indipendentemente dalla loro età, devono essere supportati fi-nanziariamente dal settore pubblico, ma contemporaneamenteal pubblico devono dare qualcosa in cambio, cioè il lorolavoro, la loro operosità: non il lavoro come merce, non illavoro che ha un valore di scambio, ma il lavoro come valored’uso, come ricchezza, come patrimonio della nazione. Ed aproposito delle “implicazioni psicologiche del reddito minimogarantito”, anche Fromm si esprimeva in questi termini: “E’innegabile che l’uomo per sua natura, lungi dall’essere pigro,soffre anzi delle conseguenze dell’inattività. Può darsi che sipreferisca non lavorare per uno o due mesi, ma la stragrandemaggioranza implorerebbe di lavorare, anche senza essernepagata” (Fromm 1982, pag.119).Se l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro,in una situazione di crisi come quella attuale sarebbe ilmomento giusto per far emergere questa forza lavoro in tuttele sue potenzialità: nelle comunità locali, nell’amministrazionedella cosa pubblica, nell’assistenza, nella scuola, nell’universitàe nella ricerca; e di organizzarla da parte delle istituzioni de-mocratiche secondo il principio “da ciascuno secondo le suecapacità”. Certo, il valore di scambio del lavoro sarà destinatoa ridursi sempre più, perché il lavoro nell’odierna economiacapitalistica è un elemento di costo, e come tutti i costi nellelogiche imprenditoriali deve essere ridotto il più possibile, finquasi a zero; ma il valore d’uso del lavoro non è un costo: èricchezza, è un elemento del patrimonio di una comunità, ed èfondamentale per la sua stessa sopravvivenza. Scrive DavidHarvey a tale proposito: “La scelta politica è fra un sistemamercificato che serve bene i ricchi e un sistema che si concentrasulla produzione e la fornitura democratica di valori d’uso pertutti, senza le mediazioni del mercato” (pag. 36).Ripensare il lavoro potrebbe forse voler dire anche ripensare ilvalore sociale dell’operosità umana: il lavoro non è una com-ponente del “conto economico” di una società, non è un costo,ma fa parte dell’attivo dello “stato patrimoniale” della stessa, èun fattore di ricchezza: non a caso gli economisti classici indi-viduavano i tre fattori principali della produzione nella terra,nel capitale e nel lavoro, che costituivano, appunto, la ricchezzadelle nazioni. E non serve andare molto indietro nel tempo perricordare quanto fossero preziosi i figli per la famiglia tradi-zionale e per la sua stessa sopravvivenza economica, e comequesto valore si sia trasformato negli ultimi decenni in un au-tentico disvalore: i figli non sono più ricchezza, nel mondo del
/ / 38 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

precariato e della disoccupazione sono diventati un costo, sonopassati anche loro dallo stato patrimoniale al conto economicodella famiglia moderna che fatica a mantenerli. A nessuno deve essere impedito di avere figli solo perché nonse li può permettere, così come nessuno deve essere lasciatomorire di fame, senza un tetto o senza cure mediche: verrebbeda dire a ciascuno secondo i suoi bisogni; ma ognuno devecontribuire, con la propria operosità, alla ricostituzione delcapitale sociale della comunità in cui vive.
Le occasioni di lavoro, in un’economia
fondata in prevalenza sui commons,
potrebbero diventare addirittura superiori
a quelle dell’economia capitalistica
Scriveva Keynes in proposito (nel 1931): “In tutti i paesi delmondo i bilanci statali presentano oggi pesanti deficit; infattil’indebitamento pubblico di qualsiasi tipo è, per così dire, il ri-medio naturale per impedire che le perdite imprenditoriali di-ventino, in una recessione grave come quella attuale, così fortida portare la produzione stessa ad una stasi. Ma è moltomeglio, sotto ogni punto di vista, che l’indebitamento si affrontiallo scopo di finanziare investimenti in opere, ove questeopere presentino una pur minima utilità, anziché per pagaresussidi ai disoccupati, o assegni ai veterani” (cit., pag.129). In conclusione, un’economia fondata in prevalenza sui commonspuò funzionare solo se regolata dallo Stato (meglio ancora sedi dimensioni sovranazionali) ed organizzata nelle sue modalitàoperative dalle istituzioni pubbliche locali, che devono potergarantire a tutti i cittadini un reddito minimo in cambio del la-voro di ciascuno a favore della comunità in cui vive. In questomodo il rapporto Stato-commons diventa inscindibile e puòessere una fonte di moltiplicazione dell’occupazione. Le comunità locali, organizzate per via politica attraverso lademocrazia rappresentativa, dovranno individuare i settori incui potranno trovare un’occupazione stabile tutti coloro – gio-vani e meno giovani – che non sono impegnati nell’attivitàproduttiva nel comparto privato (il mercato): dall’istruzionedi ogni ordine e grado all’assistenza sociale e sanitaria, fino algigantesco comparto delle infrastrutture pubbliche e del risa-namento dell’ambiente. La sola questione ambientale potrebbeessere una fonte inesauribile di opportunità di lavoro, oltreche un tema che dovrebbe essere messo all’inizio di ogniagenda politica; invece, in merito ai sempre più evidenti cam-biamenti climatici ed alle conseguenze che producono, Rifkin
osserva che “siamo come sonnambuli: anche di fronte all’evi-denza che la Seconda rivoluzione industriale, fondata suicombustibili fossili, sta volgendo al termine e che la terra sista confrontando con un cambiamento climatico potenzialmentedestabilizzante, il genere umano – in larghissima maggioranza– rifiuta di riconoscere la realtà” (Rifkin 2011, pag. 37). Le occasioni di lavoro, in un’economia fondata in prevalenzasui commons, potrebbero in questo modo diventare addiritturasuperiori a quelle dell’economia capitalistica tradizionale:ma solo a condizione che tale nuova economia riesca adessere organizzata in modo efficace dalle istituzioni pubbliche.Senza una organizzazione capace ed illuminata della politica,soprattutto a livello locale, il risultato finale di questa nuovaeconomia potrebbe essere soltanto il caos, la crisi, l’aumentodelle tensioni sociali, lo spreco di risorse, e non ultima unadisoccupazione esponenziale che accrescerebbe ulteriormentetutti i problemi. Senza intelligenza politica, quindi, non c’èfuturo per la nuova economia. Ma senza una nuova economia,permanendo l’irrazionalità dell’attuale sistema capitalistico,la stessa sopravvivenza delle persone, delle democrazie rap-presentative, e – non ultime – delle condizioni climaticheche ci permettono semplicemente di esistere potrebberoessere a rischio. La diagnosi di Rifkin non va sottovalutata, ipericoli sono reali: ma abbiamo i soggetti politici preparatiper affrontarli?
RIFERIMENTIJ. RIFKIN, La società a costo marginale zero. L’internet delle cose,l’ascesa del “Commons” collaborativo e l’eclissi del capitalismo,Milano 2014
ID., La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale el’avvento dell’era post mercato, Milano 1995.
ID., La terza rivoluzione industriale. Come il “potere laterale” statrasformando l’energia, l’economia e il mondo, Milano 2011
E. FROMM, Psicoanalisi dell’amore, Roma 1971 (prima edizioneNew York, 1964).
ID., Le implicazioni psicologiche del reddito minimo garantito, inLa Disobbedienza e altri saggi, Milano 1982.
J.M. KEYNES, Esortazioni e profezie, Milano 2011.D. HARVEY, Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo,
Milano 2014.K. POLANYI, La grande trasformazione, Torino 2010. J.A. SCHUMPETER, Storia dell’analisi economica, Torino 1979.
/ / 39 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

/ / 40 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
>>>> Matteo Miele
Irisultati delle elezioni locali dello scorso novembre a Tai-wan (Repubblica di Cina) sono probabilmente un primo
importante segnale della dimensione geopolitica della prote-sta di Hong Kong. In questo articolo si cercherà di fornire unaanalisi della situazione politica dell’isola e delle considera-zioni sui possibili scenari futuri.L’isola di Taiwan fu un possedimento giapponese tra il 1895(sconfitta dell’Impero Qing nella prima guerra sino-giappo-nese del 1894-1895) e la fine della seconda guerra mondiale.A seguito della vittoria di Mao Zedong nella guerra civile tranazionalisti e comunisti ed alla proclamazione della Repub-blica popolare cinese (1° ottobre 1949), l’isola divenne lasede del governo nazionalista del Guomindang, partito cheprima aveva guidato, per gran parte della sua storia, la Repub-blica cinese nata dalla Rivoluzione Xinhai del 1911. Nel 1952degli oltre otto milioni di abitanti (e questo è significativo perl’evoluzione del quadro politico) solo due milioni venivanodal continente. Anche dopo la vittoria comunista, alle Nazioni Unite i nazio-nalisti rifugiatisi a Taipei continuarono ad occupare il seggiocinese di membro permanente con diritto di veto in Consigliodi sicurezza, lasciando così di fatto fuori dal più alto consessointernazionale l’immenso territorio cinese fino al 1971,quando il governo di Chiang Kai-shek venne espulso con larisoluzione n. 2758 dell’Assemblea generale dell’Onu. Lerelazioni diplomatiche con gli Stati Uniti d’America rimaseroinvece in piedi fino al 1979, anno in cui Washington, sottol’Amministrazione Carter, riconobbe il governo comunista diPechino. Subito dopo, però, con il Taiwan Relations Act del1979 gli Stati Uniti garantivano (e garantiscono) l’appoggiomilitare difensivo all’isola in caso di contrasti con il conti-nente.All’evoluzione dello status internazionale di Taiwan segui-rono, negli anni successivi, anche cambiamenti sul pianointerno, con la nascita, nella seconda metà degli anni Ottanta,del Partito democratico progressista (Min zhu jin bu dang),che se inizialmente reclamava essenzialmente diritti umani edemocrazia, si sarebbe poi trasformato nel rappresentante
politico delle istanze indipendentiste dell’isola. Il Pdp riuscì avincere le elezioni presidenziali prima nel 2000 e poi nel2004, con Chen Shui-bian, presidente fino al 2008, interrom-pendo così il predominio del Guomindang. Gli anni della pre-sidenza di Chen si caratterizzarono dal tentativo di una rot-tura, sia simbolica che effettiva, della tradizione politica pre-cedente, arrivando a chiedere nel 2007 l’ammissione alleNazioni Unite non più come Repubblica di Cina, ma comeTaiwan (richiesta respinta dall’Ufficio legale dell’Onu). Nel2005 Pechino, a seguito della rielezione di Chen, avevaapprovato la Legge anti-secessione, documento che citaespressamente la situazione taiwanese e che prevede l’usodella forza.
L’elezione a Taiwan può fornire nuovi punti
di vitalità alle forze democratiche e liberali
di Hong Kong
Nel marzo 2008, mentre erano in corso le proteste anti-cinesiin Tibet, le elezioni presidenziali furono però vinte dal candi-dato nazionalista Ma Ying-jeou. Pochi mesi dopo, in luglio, siinaugurò il primo collegamento aereo regolare diretto traCina continentale e Taiwan9. Con Ma Ying-jeou ritornavanocosì al vertice del paese i nazionalisti del Guomindang e siaprivano nuovi spazi per approfondire le relazioni tra Pechinoe Taipei, relazioni che nel corso di questi ultimi anni, anchegrazie alla conferma alla presidenza di Ma nel 2012, si eranoulteriormente rafforzate.Consapevole della pericolosità sul piano geopolitico di unaguerra aperta, Pechino ha preferito un lento e costante riavvi-cinamento, fondato sulla dimensione economica, finanziaria ecommerciale: saldando il legame con l’isola in quei settori, neconseguirà (è la speranza del Partito comunista cinese) unasoluzione anche per le questioni politiche. Un percorso chepure gli Stati Uniti possono accettare, nello scenario, eredi-tato dalla Guerra fredda, che li pone a difesa dell’isola. Laformula su cui fondare la riunificazione e strutturare il rap-porto futuro sarebbe naturalmente quella di “Un paese, due
La Cina a due velocitàLe elezioni a Taiwan

/ / 41 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
sistemi”, la dottrina elaborata da Deng Xiaoping nel tentativodi coniugare l’unità della Repubblica popolare cinese con lapluralità delle esperienze storiche, politiche ed economiche.Proprio le recenti proteste degli studenti di Hong Kong hannoperò mostrato la debolezza strutturale di quell’intuizione diDeng. La complessità evidente nel gestire una realtà comun-que relativamente piccola e la difficoltà ad accettare la coesi-stenza di una democrazia sotto l’ombra comunista di Pechinohanno probabilmente avuto un forte effetto sulle elezionilocali dello scorso novembre, che hanno sancito la chiara vit-toria del Partito democratico progressista sul Guomindang esono un segnale per le ben più importanti elezioni presiden-ziali che dovranno tenersi nel 2016. E come un effetto spec-chio, l’elezione a Taiwan può fornire nuovi punti di vitalitàalle forze democratiche e liberali di Hong Kong, pur provatedagli arresti di dicembre (non a caso successivi alle elezionidi Taiwan). Le elezioni del 29 novembre sono state un crollonetto del Guomindang. Presumibilmente hanno pesato sia fat-tori interni che esterni. Tra il marzo e l’aprile del 2014 gli stu-denti taiwanesi avevano protestato contro l’accordo commer-ciale con Pechino, un documento che prosegue l’opera diavvicinamento economico dell’isola al continente, e che seratificato condizionerebbe pesantemente il destino politico diTaiwan.Dal punto di vista amministrativo Taiwan è divisa in cinquemunicipalità speciali (zhi xia shi), tre città provinciali (shi) equattordici contee (xian). In totale il Partito democratico pro-gressista ha ottenuto oltre 5,8 milioni di voti (ovvero il47,55%), mentre il Guomindang si è fermato di poco sotto i 5milioni di voti (ovvero il 40,7%). I restanti voti sono finiti adaltre piccole formazioni politiche, e in gran parte a candidati
indipendenti. Delle ventidue entità amministrative in cui èdivisa Taiwan, soltanto sei sono andate al Guomindang, tre aindipendenti, e le restanti tredici ai democratici-progressisti. Anche i risultati degli indipendenti pesano, considerando chedove sono risultati vincitori il Pdp non aveva candidato nes-suno. A Taipei, ad esempio, Lien Sheng-wen (Sean Lien),candidato del Guomindang, ha preso poco più del 40% deivoti, mentre Ko Wen-je (indipendente) ha superato il 57%. IlPdp non aveva presentato un proprio candidato sindaco nellacapitale, dopo che i sondaggi a giugno avevano dato per favo-rito Ko. Prime conseguenze di rilievo, dopo la devastantesconfitta, sono state le immediate dimissioni del governo delpremier Jiang Yi-huah, che si è assunto la responsabilità poli-tica del risultato e poi le dimissioni di Ma dalla presidenza delGuomindang, sostituito dal presidente facente funzioni WuDen-yih.
Il quadro internazionale attuale concede
pochi margini di manovra alla democrazia
taiwanese
Queste sono le premesse per comprendere la dimensione del-l’evoluzione politica possibile a Taiwan. Le proteste ad HongKong segnalano apertamente le difficoltà del modello “Unpaese due sistemi”, modello che per l’ex-colonia britannicadovrebbe rimanere in piedi almeno fino al 2047 e fino al2049 per Macao. A Taiwan certamente l’unificazioneavrebbe effetti ancora più intensi e traumatici sul pianosociale e politico, ma anche su quello militare. Per Taiwan ilpassaggio a regione autonoma speciale della Repubblicapopolare cinese non sarebbe da colonia, ma da paese cherinuncerebbe così alla propria politica estera e di difesa. Purmantenendo un’ampia autonomia interna (di cui però non siconoscono confini e durata), il saldo politico sarebbe in ognicaso negativo. Su politica estera e difesa il declino è però già evidente datempo. Nella seconda metà del XX secolo il riconoscimentointernazionale del governo di Taipei si è gradualmenteridotto, in particolare dopo la già citata espulsione dalleNazioni Unite nel 1971: ma la diplomazia taiwanese, perquanto piccola, ha ancora relazioni con ventidue paesi, in par-ticolare in America centrale ed in Oceania (mentre in Europaè riconosciuta soltanto dalla Santa Sede). Il governo naziona-lista sta inoltre mettendo in atto una drastica riduzione delnumero dei militari. Le forze armate della Repubblica cinesecontavano nel 2013 oltre 240 mila uomini, tagliati a 215 mila

/ / 42 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
per la fine del 2014, con l’obiettivo di arrivare ad un numerocompreso tra i 170 e i 190 mila uomini entro la fine del 2019,come annunciato nell’agosto 2014 dal Ministro della DifesaYen Ming.Il quadro internazionale attuale concede pochi margini dimanovra alla democrazia taiwanese. Il rafforzamento dellerelazioni tra Cina continentale e l’isola, condotto dal Guomin-dang, viene ora rimesso in discussione dai risultati elettorali.Un voto locale, ma che potrebbe ripetersi nelle elezioni presi-denziali del 2016, portando nuovamente a capo del paese unmembro del Partito democratico progressista, attualmenteguidato da Tsai Ing-wen, sconfitta da Ma nel 2012 (l’ex-pre-sidente Chen Shui-bian è in carcere, dopo essere stato con-dannato per corruzione). La vittoria degli indipendentistipotrebbe riaprire ed esasperare i contrasti con Pechino e cree-rebbe non pochi imbarazzi a Washington. L’opzione indipen-dentista non reggerebbe, sic stantibus rebus, nel quadro inter-nazionale. Però, in ogni caso, rimane un’opzione esplicita.
Come far convivere la democrazia
all’interno di una dittatura è il rebus che
si è finora dimostrato in parte insolubile
Più complessa è la decifrazione dell’altra posizione, ovverocercare di comprendere la strategia di fondo del Guomindang,che in questo percorso pare votato al suicidio politico. Perse-guire l’unità con la Cina comunista significherebbe di fatto larinuncia al proprio ruolo. Se la Cina popolare ha tutto l’inte-resse a consolidare le relazioni economiche con l’isola al fine,come detto prima, di arrivare all’unità politica attraverso l’in-tegrazione economica, è davvero difficile scorgere quali inte-ressi possa avere il Guomindang a favorire questo processo. Difficile mantenere anche lo status quo in questo contesto.Pare necessaria effettivamente, negli anni a venire, una sceltachiara e definitiva: ma il vero problema sta nel codice gene-tico del Guomindang. Partito nazionalista, ma di una nazioneche non controlla più dal 1949 e che ha ormai perso speranzadi ricontrollare. Partito politico che recepisce i principi dellaRivoluzione Xinhai, ma anche la logica territoriale dell’Im-pero Qing, rifiutando dunque la frammentazione delle realtàche si legavano all’imperatore mancese, ma all’interno delsistema imperiale, non di quello repubblicano (dunque Tibete Mongolia). Una logica che sopravvive anche nel Partitocomunista cinese. Fu il Guomindang a reprimere violentemente, nel 1947,quando controllava ancora il continente, la ribellione a Tai-
wan contro il governo centrale, tragedia che pesa ancora oggisull’identità collettiva e politica taiwanese. E fu il Guomin-dang a governare in maniera dittatoriale sull’isola fino allarecente democratizzazione. Il partito nazionalista ha, inultima analisi, gran parte della responsabilità della situazionedi stallo politico in cui si trova l’isola. Un quadro di storie,principi e speranze, quello su cui si struttura il Guomindang,che nel XXI secolo si risolve in un paradosso. È l’identitàstessa del Guomindang, la sua essenza, a segnarne ambiguitàe contraddizioni in questo momento storico.In sostanza Taiwan è di fronte a due percorsi. Uno chiaro(quella dell’indipendenza), che però, almeno per ora, è appa-rentemente impraticabile; ed un altro (quello di un avvicina-mento graduale al continente) per il momento più sicuro, maincapace di mostrare con certezza la destinazione finale.Al di là delle dinamiche partitiche, rimane essenziale inter-pretare infatti anche un altro problema di fondo, ovvero l’in-compatibilità di una realtà democratica e liberale (come èoggi quella taiwanese) con il più ampio sistema comunistacinese. Come far convivere, insomma, la democrazia all’in-terno di una dittatura è il rebus che si è finora dimostrato inparte insolubile: Hong Kong e Macao sono esempi non deltutto positivi.Il senso per la democrazia che i taiwanesi hanno prima con-quistato e poi evidentemente assimilato non permette solu-zioni rapide, ma nemmeno, come dimostrano i risultati eletto-rali analizzati in questo lavoro, percorsi forse più lenti, manon del tutto trasparenti nelle loro dinamiche, nei loro obiet-tivi e soprattutto nei loro possibili esiti. La scommessa taiwa-nese (che, a onor del vero, nasce da lontano) di una democra-zia cinese, di un sistema politico capace di convogliare l’ere-dità culturale e filosofica confuciana nell’articolazione libe-ral-democratica, si è dimostrata vincente sul piano interno,ma rimane drammaticamente ipotecata dalla condizione geo-politica.Qualora si potesse trovare una soluzione pacifica e comunqueesauriente per le istanze liberali di Taiwan (adeguata pergarantire in pieno le libertà fondamentali, tra cui anche lalibertà d’espressione, la libertà di stampa e la libertà reli-giosa), allora quel risultato andrebbe ripercorso anche peraltre realtà dell’universo della Repubblica popolare (come adesempio il Tibet, dopo che il XIV Dalai Lama ha rinunciatoalle istanze indipendentiste a favore di una vera autonomia).È onestamente difficile, però, immaginare la possibilità di unlivello locale di reale autonomia, piena libertà e democrazia,senza un cambiamento politico, più grande, a Pechino.

/ / 43 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
Il piano di riforme del governo Renzi su lavoro e welfare, epiù in generale quanto è venuto cambiando nel mondo del
lavoro, richiederebbero un cambio di passo nelle politiche diformazione, particolarmente di quella professionale. La for-mazione (che sia obbligatoria, professionale, pubblica o pri-vata) è giudicata nel nostro paese insoddisfacente, e la suaqualità troppo spesso scadente. Abbiamo un grande numero discuole superiori che sfornano studenti ignoranti, troppefacoltà universitarie che consolidano un tale risultato, una for-mazione professionale perlopiù scissa dalle richieste del mer-cato del lavoro. Sappiamo anche che la formazione potrebbeavvantaggiarsi di fondi di finanziamento comunitari e nazio-nali a nove zeri. Vediamo con ordine. Nell’importante universo delle piccoleimprese italiane la formazione, se si escludono i corsi obbli-gatori per legge sulla sicurezza, è pochissimo praticata: le sta-tistiche relative alle attività formative svolte all’interno diquesto comparto economico, vitale per la nostra economia,sono sconfortanti se confrontate con quelle dei paesi europeipiù sviluppati. I giovani alla ricerca di una migliore qualifica-zione sono numerosi, e troppo spesso si sperdono in attivitàformative di poca o nessuna utilità. Da una parte assistiamoad un’estensione della scolarizzazione e ad un prolungamentodei tempi della stessa cui non corrispondono una collocazionesoddisfacente nel lavoro né un miglioramento rilevabile dellaqualità della vita: potremmo considerare uno degli indici l’au-mentata dipendenza dei giovani dalle famiglie. Dall’altra ilmercato del lavoro si presenta fortemente segmentato, in con-tinua evoluzione, ed esige una forza lavoro che non pongaproblemi nell’adeguarsi ai tempi sempre più velocizzati dellatecnologia e che anzi sappia corrergli avanti.Bisognerebbe fare della formazione una funzione di miglioreraccordo tra i diversi sistemi: sociale, d’istruzione, del lavoro.I dati ottenuti dall’indagine Piaac 2012 (Programme for theInternational Assessment of Adult Competencies) evidenzianocome il deficit del nostro paese sia più accentuato per i livelli
di istruzione più avanzati, segno che sono i sistemi di istru-zione universitaria a marcare il passo in modo più nettorispetto al contesto internazionale. Se i laureati che vivono nelNord hanno un livello di competenze di base prossimo aquello dei laureati internazionali, i laureati che vivono nel Sudregistrano un deficit molto marcato e al di sotto del punteggioottenuto da chi ha un livello di istruzione secondaria a livellointernazionale. Lo stesso vale per le persone residenti nel Sudin possesso di un titolo di studio secondario (pari al diploma discuola superiore): il loro livello medio di competenze è valu-tato molto insoddisfacente. Di contro troppi nostri giovani ingamba vanno all’estero: nel 2012 sono stati più di 14mila ilaureati che hanno spostato la loro residenza oltre frontiera, esecondo Alma Laurea ogni anno lasciano l’Italia con un con-tratto di lavoro già firmato cinquemila laureati eccellenti: votialti – tempistica perfetta – ottima padronanza dell’inglese.1
Solo nel 2012 l’Italia ha versato all’Ue 16
miliardi di euro e ne ha ricevuti 11
Per cambiare in meglio, il nostro paese potrebbe sfruttare leingenti risorse dei fondi europei. Va ricordato che ogni Statomembro contribuisce al finanziamento dell’Unione e riceveuna dotazione per investimenti per la crescita. L’Italia è ilterzo contribuente netto dell’Ue, dopo Germania e Francia, ericeve una dotazione pari a circa il 60% del suo contributo. Ilcalcolo è fatto su parametri prestabiliti, ma certo ci consegnauna situazione peggiore rispetto ad altri Stati membri chericevono tanto quanto investono o di più (la Spagna, ad esem-pio). Una parte significativa della dotazione che riceve cia-scun paese deve essere utilizzata nell’ambito di programmigenerali di investimento stabiliti dalla Ue, che riguardano:Ricerca e innovazione, Accesso alle tecnologie informatiche,Competitività delle pmi, Difesa dell’Ambiente, ModerniSistemi di Trasporto, Occupazione, Istruzione e FormazioneProfessionale. I programmi sono finanziati mediante specificifondi (detti anche fondi strutturali), principalmente il Fondosociale europeo (Fse), rivolto alla formazione, ed il Fondo
Modesta proposta per risparmiare>>>> Piero Pagnotta
Fondi europei
1 8° Rapporto sulla classe dirigente/2014, Luiss Univ. Press, pag. 158.
>>>> saggi e dibattiti

/ / 44 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
europeo di sviluppo regionale (Fesr) per gli interventi strut-turali2. Con i fondi vengono finanziati progetti sulla base diregole di controllo predeterminate sia a livello locale che cen-trale a Bruxelles. L’obiettivo generale è lo sviluppo sociale edeconomico del complesso dei paesi della Ue. I diversi affidamenti ai diversi Stati vengono regolati sullabase di accordi di partenariato che indirizzano gli investi-menti sulle problematiche di maggiore criticità. Gli Statigestiscono le loro dotazioni, sotto la vigilanza della Ue, ripar-tendole tra le loro amministrazioni centrali e locali nelrispetto di regole generali prestabilite. Gli affidamenti all’Ita-lia sono prevalentemente conferiti alle Regioni, che di conse-guenza si occupano degli obiettivi specifici da realizzare equindi della stesura ed emissione dei bandi di gara che rego-lano l’assegnazione dei fondi a loro disposizione, delle con-seguenti attività di controllo e dei pagamenti. Va sottolineatoche ogni paese è tenuto a cofinanziare con un pari importo ladotazione assegnata dalla Ue; in Italia lo Stato cofinanzia leiniziative, ma chi le attua sono principalmente le Regioni. Si tratta, quindi, di cifre complessive notevoli con le qualialcuni paesi europei hanno per esempio ammodernato i lorosistemi di trasporto, la formazione. I programmi generalieuropei hanno una durata di sette anni: si è appena conclusoquello 2007-2013 ed è all’avvio quello 2014-20203. Viene
concesso di sforare di un anno i termini di realizzazione deiprogetti e la trasmissione degli atti dalle amministrazioni deidiversi Stati a Bruxelles per i controlli definitivi; ma alla fine,si noti bene, le dotazioni eventualmente non spese dai singolipaesi vengono riassegnate dalla Ue ai paesi più virtuosi. Nel periodo di programmazione 2007-2013 l’Italia ha versatocomplessivamente circa 106 miliardi di euro, quale contri-buto spettante al bilancio Ue, e ha ricevuto accrediti per circa65 miliardi di euro (di cui 28,8 miliardi di euro per i fondistrutturali); il nostro apporto netto è stato pari a 41 miliardi dieuro. Più precisamente, come riporta uno studio del Censis,“utilizzando la ricostruzione dei flussi finanziari tra l’Italia el’Unione europea realizzata dalla Corte dei Conti e relativa alperiodo compreso fra il 2007 e il terzo trimestre del 2013, siottiene che il volume di risorse versate dall’Italia – valori aprezzi correnti - è passato dai 14 miliardi di euro del 2007 aicirca 16 miliardi e mezzo del 2012, a fronte di accrediti effet-tuati dall’Unione che nel periodo si sono aggirati intorno ai 9-10 miliardi, determinando in sostanza un saldo a nostro svan-taggio piuttosto consistente (6,6 miliardi nel 2011, 5,7miliardi nel 2012).Il volume complessivo di risorse versatodall’Italia nei sei anni presi in considerazione, peraltro quellidella crisi, ha raggiunto la cifra di 106 miliardi di euro. A que-sto si contrappone un volume di accrediti che ha raggiunto asettembre 2013 circa 65 miliardi di euro, decretando quindiun saldo negativo di oltre 41 miliardi di euro. Anche al nettodelle partite del 2013, che non tengono conto degli accrediticertamente più consistenti che generalmente si realizzano achiusura d’anno, il saldo negativo sarebbe comunque di 35,7miliardi di euro.”4
Flussi finanziari fra l’Italia e l’Unione Europea in miliardi di euro(da La Voce.info, Fonte:European Commission Financial Programming and Budget.)
2 Vi sono anche altri fondi (Feasr per l’agricoltura ad es.) e Bruxelles dis-pone inoltre di una quota di investimenti da gestire sovranazionalmentee aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri.
3 www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Accordo-Partenariato/1_AP_ITALIA_Sezione_1A.pdf; www.dps.tesoro.it/ml.aspdip sviluppo e coesione economica.
4 Censis, Dare avere con l’Europa, marzo/2014, pag. 9.

/ / 45 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
Solo nel 2012, per esempio, l’Italia ha versato all’Ue 16miliardi di euro e ne ha ricevuti 11. Di questi circa 6 miliardiriguardano I’agricoltura, 1 miliardo ricerca e innovazione, 1miliardo altri programmi vari, 3 miliardi i fondi strutturali.Ma il saldo negativo, purtroppo, è destinato a salire perchénon siamo stati in grado di utilizzare tutti gli affidamenti dinostra spettanza. Infatti, se una parte della nostra contribu-zione doveva rientrare grazie alle politiche di sostegno previ-ste con i fondi comunitari, alla fine del periodo di program-mazione le risorse effettivamente impiegate sono risultatepari al 53%. Dovremmo portare a termine entro il 2015 gliinterventi per il restante 47% (quasi 14 miliardi di euro,secondo la rilevazione di agosto del 2014), ma è un obiettivoirraggiungibile. Pertanto, per ogni euro che versiamo all’U-nione europea, riportiamo a casa 60 centesimi: ma teorica-mente, perché in pratica non li spendiamo tutti e quanto nonspeso viene riassegnato a paesi più capaci.
L’Italia spende la gran parte dei fondi
europei a pioggia e per progetti di nessuna
utilità strategica
In sostanza per l’Italia è una partita di giro in perdita: il soste-gno europeo attraverso i fondi è un sostegno che l’Italia deverealizzare con proprie risorse e la perdita si raddoppia perchéle regole comunitarie impongono il cofinanziamento dell’as-segnazione relativa ai fondi con un pari importo. E purtropponon manca il colpo finale: dotazione e cofinanziamento deifondi sono spesi prevalentemente per iniziative di scarsa uti-lità pubblica. L’Italia spende la gran parte dei fondi europei a pioggia e perprogetti di nessuna utilità strategica. I buoni progetti (perammodernamento delle infrastrutture, di servizi, formazioneprofessionale) sono minoranza. I non addetti al settore pos-sono scoraggiarsi leggendo di alcuni modi di impiego di fondicomunitari: 3.541 euro alla trattoria Don Ciccio di Bagheria;12.075 euro all’impresa edile Pippo Pizzo di Montagnareale;
2.271 euro alla gelateria Mozart di Castelvetrano; 3.264 euroall’agenzia funebre Al Giardino dei Fiori di Gangi; 188 milaeuro per la maratona di Palermo (due edizioni); un milione emezzo per il concorso di salto a ostacoli; 2,4 milioni per imondiali di scherma; 127 mila euro per il volley; decine dimigliaia di euro per finanziare corsi di long drink e cocktailnelle principali città del Friuli; la Lombardia ha ottenuto2.239 euro per controllare la genuinità della polenta padana;il Friuli 18.095 euro per le tecniche di pizzeria di Tolmezzo;nelle Marche sono arrivati finanziamenti per le scuole di tat-too e per i centri massaggi5. Ma questa lista tragicomica puòessere allungata a dismisura riportando progetti per infrastrut-ture inutili, superflui portali internet, ricerche fotocopiate, eper corsi di formazione che si esauriscono nel breve periodo,non connessi alla domanda effettiva e non sottoposti a reali-stiche verifiche di outplacement degli allievi. Perché non utilizziamo i fondi disponibili o li usiamo preva-lentemente male? Perché abbiamo una formazione, professio-nale e non, mediamente scadente? Perché è difficilissimoanche ritoccare le impalcature che sorreggono gli attuali risul-tati? La gran parte delle nostre amministrazioni deputate alcompito di rendere fruibili i fondi europei sono poco profes-sionali, farraginose, slegate dal mondo reale della produ-zione, della formazione, dello sviluppo: assolutamente non ingrado di gestire l’enorme afflusso di contributi dei fondi. C’èdi contro un mondo intero di enti che utilizzano tali fondi eche ci guadagnano, perché legati alle politiche del consenso.Vi è una rete di interconnessione tra settori della pubblicaamministrazione, di rappresentanze di interessi, loro enti eaziende, che condiziona negativamente la gestione dei fondistrutturali. Le nostre amministrazioni pubbliche, del resto, sono le legit-time eredi di quelle preunitarie. Senza andare a rivangarequelle pontificie e borboniche, alla base del crollo dellaRepubblica di Venezia vi era la sua pessima organizzazionestatale6; quella sabauda era fondata su formalismi tanto imbat-tibili quanto inefficienti7. E le amministrazioni pubblicheinefficienti sono il brodo di coltura per realizzazioni inutiliquando non soggette all’azione dell’autorità giudiziaria. Èinutile oggi accanirsi per una riforma radicale. Sarebbe piùproficuo limitare i danni riducendo progressivamente il peri-metro di azione, le competenze e di conseguenza le risorseaffidate alle amministrazioni responsabili. Gestire una quotaminoritaria dei fondi europei in modo esemplare. Lavorare aun riequilibrio dei conti con la Ue riducendo gli accrediti e diconseguenza il contributo.
5 G.A. STELLA, S. RIZZO, Se muore il Sud, Feltrinelli, 2014; M. GIOR-DANO, Non vale una lira, Mondadori, 2014.
6 Lo stato maggiore militare veneto all’epoca del crollo della Serenissimanon poteva riunirsi perché molti suoi componenti erano talmente anzianida non potersi alzare dal letto (E. BARBARICH, La campagna del 1796nel Veneto, 1910, pag. 19).
7 Cavour aveva dotato, con grande spesa, l’esercito sabaudo di unamoderna artiglieria ma non gli riuscì di farla uscire dagli arsenalidurante la seconda guerra d’indipendenza per colpa della burocraziacivile e militare (R. ROMEO, Vita di Cavour, Laterza, 1984, pag.421).

In generale nel nostro paese i tempi che intercorrono tra l’u-scita di un bando e l’approvazione delle offerte, e tra l’appro-vazione ed il pagamento dei primi acconti, sono molto lunghi;il saldo finale può poi arrivare anche molti mesi dopo che ilprogetto è stato completato e tutte le spese debitamente soste-nute. Se si aggiunge che quasi sempre il contenuto specificodei bandi non tiene conto della domanda effettiva di forma-zione delle imprese e dei cittadini, tutti questi fattori negativirendono la formazione finanziata per un lato non utile a risol-vere problemi contingenti e dall’altro impossibile da gestirein modo economicamente sostenibile, mettendo fuori giocobuona parte del tessuto delle imprese sane di formazione. Senel bando manca un disegno politico di respiro, se è redattoda chi ignora le esigenze del mercato ma persegue finalitàaltre, diviene difficile presentare proposte che si basino sulladomanda di formazione che viene dal territorio; in tale casoprevarranno proposte generiche, l’offerta di quello che si sagià fare, nessun investimento su metodologie innovative. Se i criteri di valutazione delle offerte sono incomprensibili,tanti verranno scoraggiati dal partecipare; se i tempi di affida-mento delle proposte selezionate sono particolarmente lunghii progetti formativi non potranno più essere legati ad unadomanda emergente; se i responsabili dei controlli sonoincompetenti si perderà tempo prezioso su particolari insigni-ficanti, sugli aspetti formali secondari piuttosto che sui risul-tati. Se i tempi di verifica sono lunghi ed i pagamenti arrivanodopo anni si creerà una situazione perversa che vedrà la fuo-riuscita dallo specifico mercato di tante buone aziende di for-mazione a vantaggio di quelle che hanno altri canali di soste-gno o peggio di chi non spende quanto dichiara. Chi opera professionalmente nel campo della formazione sache esiste un mondo di imprese, ben sviluppato in ampie partidel territorio nazionale, che sono governate solo con la fina-lità di acquisire le risorse economiche comunitarie, senzatenere conto dei risultati, solo perché in qualche modo con-nesse a chi eroga i finanziamenti. È un mondo esteso, conintrecci che lo rendono dominante. È un potere che tiene labarra alla spesa, al fondo amico. Quando le pubbliche ammi-nistrazioni si prestano a legami con gruppi d’appartenenza, odi potere, più che a svolgere il loro ruolo, la formazione finan-
ziata diviene un’occasione per sistemare clientele, per gene-rare consenso elettorale8. Al potere selezionato per apparte-nenza non interessano i risultati, il ruolo istituzionale, ma ilgruppo di riferimento. La misurazione dei risultati, ma ancheil contenuto didattico sono aggirati da resoconti di pessimasociologia. Sono fabbriche di consenso che impegnanorisorse pubbliche. Questa situazione generale determina per soprammercato chele cattive amministrazioni non hanno nessun interesse adinvestire tutte le risorse – comunitarie e nazionali – disponi-bili: sia per incapacità di realizzare progetti, sia per limitare icontrolli della Ue su realizzazioni e spese. Chi prova ad ope-rare con professionalità in questo mercato si trova quindi adover fronteggiare una concorrenza protetta, deve vederselacon amministrazioni e strutture di controllo che perlopiù sonostate inventate per sistemare clientele, organismi inefficientima burocraticamente intrusivi. Si finisce per fare esperienzelogoranti e malriuscite.
Il governo dovrebbe rinunciare a una parte
dei contributi per i fondi europei chiedendo
in cambio una corrispondente riduzione
della quota contributiva da versare
per il bilancio dell’Unione. E dato che i fondi
prevedono il cofinanziamento obbligatorio,
il risparmio raddoppierebbe
Una prima riforma che potrebbe promuovere, a ragionveduta, il nostro governo dovrebbe essere la rinuncia a unaparte dei contributi per i fondi europei chiedendo in cambiouna corrispondente riduzione della quota contributiva da ver-sare per il bilancio dell’Unione. E dato che i fondi prevedonoil cofinanziamento obbligatorio, per pari importo, da parte delpaese beneficiario, il risparmio raddoppierebbe. Una tale pro-posta è stata avanzata di recente da Roberto Perotti, ordinariodi politica economica alla Bocconi, in una audizione allaCamera sull’efficacia delle politiche europee in Italia9. Noncambierebbe sostanzialmente il nostro apporto alla Ue, marisparmieremmo alcuni miliardi di euro. Sarebbe una opera-zione contabile che potrebbe avere la consistenza di unamanovra finanziaria. Il nuovo piano comunitario di investimenti 2014-2020 pre-vede affidamenti della Ue al nostro paese per quanto riguardai fondi strutturali pari a 41.548 milioni di euro, di cui 4.195per la formazione (Obiettivo 10)10. Non sono al momento di-
/ / 46 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
8 Spesso parte dei fondi è impiegata dalle amministrazioni responsabiliper sostenere i costi dei loro stessi enti e società.
9 Si veda anche Il disastro dei fondi strutturali europei di Roberto Perottie Filippo Teoldi, La Voce.info del 3 luglio 2014.
10 Vi sono anche ulteriori risorse per la formazione in diversi settori delPiano; vedi Delibera n. 18/2014-GU Serie Generale n.209 del 9-9-2014.

sponibili i dati ufficiali sul nostro contributo, ma da quelliufficiosi si rileva che continueremo ad essere uno dei mag-giori paesi contribuenti, con un bilancio nel dare/avere a tuttonostro svantaggio. Se per ipotesi riducessimo del 50% sia i nostri affidamentiche contestualmente il nostro contributo risparmieremmocirca 40 miliardi di euro (20 di contributo/affidamenti e 20 dicofinanziamento). Si tratterebbe di una cifra che allevierebbeil nostro bilancio: una manovra finanziaria che potrebbe peresempio favorire una diminuzione delle leva fiscale sul patri-monio immobiliare complessivo su cui grava un carico chenel 2014 raggiunge i 52,3 miliardi di euro11.Considerate le difficoltà ed i tempi necessari a rivedere lasituazione, si potrebbe intanto realizzare una struttura esem-plare alle dirette dipendenze della Presidenza del Consigliocui affidare la gestione di una quota minoritaria del nuovoaffidamento per i fondi europei, sia per realizzare azioni utilie di livello, sia per sperimentare formule alternative digestione. Sarebbe questa una seconda riforma che il nostrogoverno potrebbe realisticamente portare avanti. E’ impossi-bile riformare i nostri apparati: ma si potrebbe stabilire cen-tralmente che una quota del 10% dei fondi venga gestita da unufficio ad hoc, affidato a poche persone qualificate. Non unaennesima authority, ma una soluzione sperimentale, a tempo,misurata sui risultati: una sorta di territorio liberato da chioggi governa quelle risorse. Organizzare al meglio i progettievitando sprechi è possibile quando chi li gestisce prestiattenzione ai risultati che debbono essere conseguiti, e chi ha
la responsabilità di amministrare i fondi crei le premessenecessarie perché questo avvenga. Un progetto formativo (mail ragionamento può essere esteso all’universo delle azionifinanziate dai fondi comunitari) riesce bene se si sviluppaall’interno di una cultura organizzativa e con una amministra-zione finanziatrice vigile e partecipe. La riprova di un lavoroben realizzato sarà poi data dalla misurabilità dei risultaticonseguiti, dal rapporto costo/ benefici.Riguardo la formazione finanziata, l’attenzione principaledovrebbe essere rivolta all’evoluzione dei fabbisogni occupa-zionali ed alla effettiva domanda di competenze per consen-tire solo il finanziamento delle proposte formative conse-guenti garantendo rapidità di valutazioni e semplicità diaccesso ai fondi disponibili. In coerenza con tali criteri la fre-quenza dei bandi dovrebbe avvicinarsi il più possibile ad unamodalità on demand per ridurre il lasso di tempo che inter-corre tra l’individuazione del fabbisogno specifico, la predi-sposizione di una proposta progettuale, l’ottenimento di unavalutazione, i finanziamenti. La riduzione dei tempi di valu-tazione consentirebbe da un lato di predisporre con tempesti-vità risposte concrete a bisogni puntuali, e dall’altro di rimet-tere in gioco le risorse inutilizzate, quando le proposte proget-tuali presentate non siano adeguate agli standard richiesti.Un tale lavoro diverrebbe ancora più semplice se anche i for-mulari per la predisposizione delle proposte formative venis-sero semplificati, magari studiandoli assieme a chi dovrà poiutilizzarli. La semplificazione dei formulari non è da inten-dersi come una banalizzazione dei molteplici aspetti chedevono essere presi in considerazione nella presentazione diun progetto, quanto nella riduzione del numero dei punti inda-gati e nella limitazione del numero di righe ammissibili perciascuna risposta. Tutto questo aprirebbe spazi di partecipa-zione nuovi, consentirebbe di presentare proposte a tutti i por-tatori di idee progettuali rispondenti agli effettivi fabbisogni
/ / 47 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
La nuova programmazione europea, 2014-20Fonte: Accordo di Partenariato, pp. 235-8. Dati in miliardi di Euro. (da La Voce.info)
11 Dato calcolato dall’Ufficio Studi della Cgia sommando i 9,3 miliardidi euro di gettito legati alla redditività degli immobili (Irpef, Ires,Registro e bollo, cedolare secca, etc.), gli 11,9 miliardi di euro riferitial trasferimento degli immobili (Iva, imposta di registro/bollo, impostaipotecaria/catastale, le successioni e le donazioni) e agli oltre 31miliardi di euro riconducibili al possesso dell’immobile (Imu, impostadi scopo, Tari e Tasi).

di competenze. La possibilità di presentare progetti a sca-denza ravvicinata potrebbe consentire alle imprese di utiliz-zare i fondi per la formazione per specifici ed immediati biso-gni: la formazione finanziata diventerebbe interessante per lepmi che troverebbero nell’istituzione pubblica risorse cuioggi non possono accedere. La semplificazione, un accessorapido ai fondi aumenterebbero la concorrenza tra le impresedi formazione e ridurrebbero gli spazi oggi occupati da enti diformazione specializzati nell’utilizzo di risorse senza connes-sione con il mercato e da enti di controllo che congelanopotenzialità e tolgono spazio a chi sa fare. I controlli in itinere e finali, sulle spese ma anche sugli esitioccupazionali, dovrebbero essere rigorosi, e chi dovesse sba-gliare o fallire dovrebbe essere escluso dal settore. Le azioniformative più complesse e che richiedono tempi più lunghi diverifica possono sussistere in presenza di formule di finanzia-mento agevolato a favore di chi le gestisce lavorando conun’ottica customer oriented. La sostanza deve stare nel con-trollo della spesa, nella congruenza dei progetti, particolar-mente nei risultati di outplacement (quanti allievi di un corsodi formazione hanno trovato un lavoro e che tipo di lavoro a3 o 6 o 12 mesi dalla conclusione dell’esperienza formativa,con che tipo di contratto, se si tratta di nuove assunzioniaggiuntive o sostituzioni). Bisognerebbe far partecipare aibandi di questo 10% solo aziende e enti con requisiti di out-placement ben espressi.
Sarebbe opportuno farlo prima che l’agenda
la dettino Nigel Farage e Marine Le Pen
Una tale nuova struttura, se formata da chi conosce il settore,saprebbe dove andare a cercare e cosa verificare. Saprebbeanche escludere da questo mercato importante tanti che hannogià operato in modo inutile e dannoso. Svolgerebbe un ruoloesemplare per le amministrazioni incaricate di gestire i fondistrutturali. Potrebbe partire rafforzando le iniziative che hannoavuto successo formativo - occupazionale; per esempio alcuniIstituti tecnici superiori (Its) hanno mostrato di fare bene for-mazione per realtà produttive presenti nel loro territorio, con-sentendo a tanti giovani di trovare una occupazione qualifi-cata. All’Its Accademia marina mercantile di Genova tutti i 65diplomati hanno trovato un lavoro, e all’Its della meccanica diVicenza 21 dei 22 diplomati sono occupati. Performance dibuon livello si sono avute anche nei sette Its che gravitanoattorno all’universo di Finmeccanica, in Lombardia, Pie-monte, Campania, Puglia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e
Liguria. Vi sono laboratori di ricerca, universitari e non, chehanno prodotto risultati di levatura internazionale grazie aifondi comunitari. Si potrebbe cominciare da quelli che hannoottenuto risultati, allargandone il perimetro di azione.E’ impensabile che le nostre amministrazioni, di cui cono-sciamo livello e intrecci, sappiano investire bene un flusso dimiliardi di euro. Ed alla Ue non interessa come spendiamo isoldi dei fondi (non sono suoi ma nostri): al massimo verificairregolarità macroscopiche o l’uso meramente criminale.Certo sarebbe desiderabile un cambiamento drastico e nonvedere assegnati di nuovo miliardi di euro ad amministrazionipubbliche, del Sud ma non solo, che li spenderanno prevalen-temente in modo utile solo a circuiti di politica locale, a loroenti di controllo senza competenze, a organismi che hannoperso nel tempo rappresentanza ma che debbono attingere arisorse pubbliche per mantenere strutture e aziende: insostanza a vantaggio di quel blocco storico che da decenni èall’avanguardia nel contrastare ogni riforma. Ma sarebbe unaaspettativa irrealistica. Avviare così una riforma graduale,spendere bene almeno una parte di quelle risorse creando unastruttura piccola ma trasparente, sarebbe finalmente un rove-sciamento dei significati: si tratterebbe di una battaglia tradue culture del paese. Invece la riduzione dei nostri contributi (e affidamenti) allaUe sarebbe una battaglia politica interna agli equilibri ed allestrategie comunitarie: potremmo mantenere alto il livello dipartecipazione allo sviluppo comunitario evitando, vista ladrammaticità della crisi, di finanziare prevalentemente lo svi-luppo altrui. E sarebbe opportuno farlo prima che l’agenda ladettino Nigel Farage e Marine Le Pen.
/ / 48 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

Le commemorazioni non sono un genere letterario sem-plice: c’è il rischio di cadere nella retorica celebrativa e
c’è quello speculare di farsi condizionare da esso, per cui sipuò finire per non dare della persona che si vuol ricordare unritratto fedele. Cercherò di sfuggire a queste due trappole,perché davvero Ermanno Gorrieri non ci perdonerebbe mai difare di lui un soggetto retorico: ma non mi perdonerei di nontentare almeno di rendere testimonianza dello spessore e delrilievo di questa personalità. Gli 84 anni della sua vita hanno attraversato un periodo digrande intensità storica rispetto al quale egli potrebbe sempli-cemente ripetere la celebre frase di Pablo Neruda: “Confessoche ho vissuto”. Perché veramente, a rileggere quella singo-lare vicenda, c’è da rimanere colpiti dalla intensità con cuiGorrieri si fece coinvolgere in tutta la complessità del periodoche gli toccò in sorte di attraversare. E’ vero che partì da unaformazione nell’ambito della gioventù cattolica in cui siveniva educati all’ideale del servizio. E’ altrettanto vero cheera un ideale che non era riservato solo a chi viveva in queicontesti, perché era qualcosa legato allo spirito dei tempi: cosìcome si serviva la fedeltà agli ideali del Vangelo, altri servi-vano la fedeltà al Partito (quale che fosse), altri alla Rivolu-zione. Poi, allora come sempre, fra il dire e il fare c’era dimezzo il mare: non sempre chi si dichiarava servitore di unideale lo era davvero, spesso il servizio diventava un mezzoservizio, talora invece si trasformava in fanatismo.Gorrieri seppe per tutta la vita tenere fede all’impegno di spen-dere la propria vita come servizio, mai banalizzandolo in qual-cosa di accomodato al non spendersi troppo, sempre lucida-mente rifiutando di trasformare il suo ideale in una predicazionedi estremismo fanatico. In tempi come quelli in cui ci tocca divivere mi pare importante partire da questi dati, perché monu-mentalizzare le persone ha poco senso, se il loro ricordo non ci
serve di esempio per richiamare non solo che un orizzontediverso da alcune miserie del nostro presente è possibile, maanche che per uscire dalle nostre difficoltà è necessaria lapazienza del costruttore e la tenacia di chi sa che non è lecitoarrendersi.
Per la libertà Gorrieri era salito
in montagna, per l’eguaglianza e per la
fratellanza avrebbe speso tutto il resto
della sua vita
Per questo mi permetto di entrare nel vivo di questa riflessionecitando una frase che Gorrieri scrive nel 1945 sul periodico deidemocristiani modenesi Democrazia: “Noi siamo decisamenterivoluzionari, ma per essere costruttivi occorre arrivare alloscopo attraverso una realistica evoluzione politica, sociale edeconomica a base della quale deve stare come piattaformanecessaria una profonda educazione morale e spirituale”.Quando scrive queste parole Gorrieri è un giovane capo par-tigiano che si è conquistato sul campo una forte credibilità.Ha fatto parte delle bande cattoliche, ha conosciuto una dia-lettica politica non facile con gli uomini di diversa ispirazionepolitica, specialmente con i comunisti, agisce in un contestoche per quelli della sua parte non era certo facile. Esprime però da subito quella che sarà la bussola della suaazione sociale, prima ancora che politica: bisogna non per-dere coscienza che è necessario “rivoluzionare” il mondo chesi è ereditato, ma se si vuole fare azione politica e non inse-guire utopie o rifugiarsi in giacobinismi senza senso è neces-sario convincersi che bisogna costruire una evoluzione che sisviluppi su base realistiche. Questa non è però una scelta di“moderazione”, ma una scelta di grande rigore, perché la sipuò perseguire solo fondandosi su una profonda educazione
/ / 49 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
Un riformista cristiano>>>> Paolo Pombeni
Ermanno Gorrieri
Nel decimo anniversario della sua scomparsa il Comune di Modena ha ricordato la figura di Ermanno Gorrieri. Di seguito il testo della commemorazione tenuta da Paolo Pombeni nella seduta del Consiglio comunale del 1° dicembre 2014.

/ / 50 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
morale e spirituale. Sarà quanto diverrà lo spirito guida delsuo lungo impegno politico: ma è qualcosa che oggi andrebberiproposto con forza se vogliamo che la gente torni a credereche la politica è qualcosa di molto diverso dalla caricatura chese ne sta facendo, purtroppo con l’attiva collaborazione di unbuon numero di quelli che la praticano.Gorrieri è stato l’ultimo grande esponente del cattolicesimosociale, quella corrente che portò i cattolici all’attiva parteci-pazione alla vita pubblica non per difendere una confessionereligiosa e il suo statuto nella sfera pubblica, ma per concor-rere a creare una società in cui giustizia e solidarietà diventas-sero i pilastri della rivoluzione moderna. Libertà, eguaglianzae fratellanza erano scritte sullo stendardo della rivoluzionefrancese, che era stata interpretata per quasi un secolo emezzo come una svolta anticristiana. Per la libertà Gorrieriera salito in montagna, per l’eguaglianza e per la fratellanzaavrebbe speso tutto il resto della sua vita. Ricorderò a questo punto che, ricevendo la laurea honoriscausa in Sociologia all’università di Trento l’8 marzo 1999(dunque quando ormai la sua avventura terrena volgeva al ter-mine), dedicò la lectio magistralis che tocca fare in quelleoccasioni al tema Uguaglianza, una parola in disuso. Sap-piamo bene che nella sua appassionata militanza di riforma-tore sociale Gorrieri non ebbe mai indulgenze verso un usoretorico di quel termine, consapevole com’era che la costru-zione di rapporti sociali equilibrati non si fa comiziando avanvera, illudendosi che sia possibile aggirare con le parole iduri dati della realtà economica e sociale in cui si è immersi,promettendo palingenesi rapide da raggiungere con qualcheforzatura. Basta rileggersi i suoi molteplici interventi su queitemi, ma soprattutto ricordarsi del titolo, davvero emblema-tico, del suo ultimo grande lavoro del 2002, Parti eguali fradiseguali¸ che – corre l’obbligo di ricordarlo – non fu esatta-mente raccolto da un coro di elogi, perché era una critica duradel neoliberismo arruffato del nuovo centro-sinistra nel pas-saggio fra XX e XXI secolo. Oggi anche alcuni di quelli cheallora lo criticarono si sono convertiti a posteriori a queirilievi: anche se temo lo facciano senza accorgersi che stannocontinuando, pur con qualche giro di valzer ideologico, a per-petrare la logica del parti eguali fra diseguali.Gorrieri aveva fatto la scelta del costruttore paziente, di coluiche, come scrisse in un volantino per le elezioni del 1953,voleva “continuare il lungo e difficile lavoro di riconquistacristiana delle masse lavoratrici, attraverso l’azione sociale,sindacale e cooperativistica”. Questo lavoro paziente edappassionato, che qui ovviamente non è possibile rievocare,
lo porterà alla sua esperienza parlamentare fra il 1958 e il1963: anni difficilissimi perché accanto al boom economicocon i problemi che presentava, ci sarà tutto il travaglio dellaDemocrazia cristiana, con il percorso per la “apertura a sini-stra” che porterà la sua componente innovatrice ad un asproscontro con una gerarchia ecclesiastica spaventata dalla seco-larizzazione incipiente ed incapace, salvo eccezioni, di com-prendere che senza rispondere in maniera adeguata alla sfidadello sviluppo non si sarebbe salvato il traguardo raggiuntocon la stabilizzazione repubblicana.
Il Concilio Vaticano II ha indubbiamente
segnato un punto di passaggio
Gorrieri non aveva complessi di inferiorità nel ritenere che lagiovane cultura cattolica fosse ben attrezzata per rispondere aquella sfida, e che potesse farlo non ripetendo le litanie di for-mule storiche canoniche, ma accedendo ad un confrontoaperto con la cultura moderna delle nuove scienze sociali edeconomiche. Ricorderò qui qualche nome di personaggi checon lui operarono in varie occasioni: Beniamino Andreatta,Achille Ardigò, Osvaldo Piacentini, Luigi Pedrazzi, RomanoProdi. Nonostante questo Gorrieri si convinse precocementeche la battaglia per la trasformazione politica non si potevavincere a Roma nelle aule parlamentari, a meno di non riu-scire ad inserirsi, come scrisse agli amici modenesi, nelristrettissimo gruppo di quelli che contavano. La svoltaandava costruita dal basso, come era sempre stata sua convin-zione. Per questo nel 1963 avrebbe rifiutato di ricandidarsi –sarebbe tornato, secondo la sua nota frase, “fra Secchia ePanaro” – per riprendere il lavoro di riforma del sistema daun’altra angolatura. Essa fu il regionalismo, quando si tor-nava a discutere di dar corso finalmente alla previsione costi-tuzionale delle regioni, istituzioni in cui ci si aspettava dicostruire quel laboratorio riformatore che era impossibile, pertante ragioni, a livello nazionale.Anche questa fu una stagione importante della politica ita-liana ed oggi andrebbe ripresa e ricostruita: oggi che leregioni sono riuscite a farsi identificare in larga parte dell’o-pinione pubblica come palle al piede dello sviluppo del paese.Gorrieri unì su questo fronte ancora una volta molte intelli-genze politiche cattoliche, come il lombardo Piero Bassetti eil trentino Bruno Kessler, ma soprattutto si batté perché nellasua terra questo esperimento potesse nascere nel migliormodo possibile. Fu allora che iniziò con maggior forza e inmaniera più proficua il dialogo e il confronto con il partito

/ / 51 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
comunista emiliano, in un’ottica che la grettezza del conser-vatorismo nostrano bollò subito come “la repubblica conci-liare”, mentre fu un generoso tentativo di ritrovare quello spi-rito di larga coesione che aiuta nella storia a gestire inmaniera adeguata i passaggi cruciali.In anni difficili, che vanno dall’autunno caldo del 1969(quando Gorrieri chiederà al suo partito di “abbandonare lamediazione ad ogni costo fra interessi contrastanti ed inconci-liabili e che faccia una scelta precisa fra le forze in gioco”, marifiuterà anche “l’anarco-sindacalismo”), alla fase finale dellavoro del comitato politico-scientifico regionale per la pro-grammazione nell’autunno del 1973, maturerà in lui il primomomento di quella crisi che lo porterà a ripensare l’adegua-tezza del sistema dei partiti uscito dalla svolta resistenzialerispetto al grande cambiamento sociale che stava avanzando.Sono anni complicati ed aspri, perché si assiste all’aprirsi diquella che sarà la questione fondamentale della seconda partedella vita di Gorrieri: la possibilità o meno di rinnovare la tra-dizione dell’impegno politico del cattolicesimo sociale nel qua-dro dei tempi nuovi che si vanno annunciando. Il Concilio Vati-cano II ha indubbiamente segnato un punto di passaggio. Da unlato molti giovani, pur allevati nelle tradizionali filiere di for-mazione del mondo cattolico, non sentono più come prioritariol’impegno sul terreno tradizionale della politica: alcuni predili-gono l’impegno più diretto nel dibattito ecclesiale sulla riformadella Chiesa; altri – vivendo ormai in simbiosi con le inquietu-dini che percorrono il mondo universitario, dove i vecchi stec-cati delle subculture sono caduti in disuso – spostano la loroottica verso un radicalismo che guarda ai miti del Terzo mondo.Per Gorrieri forse la prova più dura è che tre dei “suoi” giovani,i fratelli Francesco e Filippo Cavazzuti e Luciano Guerzoni,escono dalla sinistra Dc per entrare nel dissenso, con la produ-zione del periodico Note e Rassegne. Dall’altro lato il partito
della Democrazia Cristiana sembra spostarsi decisamente sulcentro-destra: dopo la brillante performance di Donat Cattin alministero del Lavoro (quando chiude il 21 dicembre 1969 ilcontratto nazionale dei metalmeccanici e l’anno seguente faapprovare lo Statuto dei lavoratori), arriverà nel 1972 ilgoverno Andreotti, che vira, sia pure momentaneamente, perun recupero del vecchio centrismo.In una riunione del suo gruppo, a Serramazzoni nel giugno1972, Gorrieri pone senza mezzi termini la questione sul tap-peto: “La Democrazia cristiana non è il fine ultimo dellanostra azione politica, ma rappresenta lo strumento di cui ciserviamo per raggiungere i nostri obiettivi di progresso civilee sociale”. Obiettivi che subito specifica: “Trasformazionedell’attuale assetto in una società in cui trovino più concretae reale attuazione i principi e i valori cristiani ed umani dellalibertà e dell’uguaglianza di tutti gli uomini”. Sullo sfondoquello che si delinea come un altro passaggio cruciale, lavicenda del referendum sulla legge che introduce il divorzio,quando un gruppo autorevole di cattolici contrasta la deci-sione di Amintore Fanfani, segretario del partito, di schierarela Dc a favore del voto per l’abrogazione della normativa.Gorrieri, militante disciplinato che sa cosa significhi stare inun partito anche quando non si concordi colle sue posizioni,non si schiera: ma significativamente lo farà sua moglie, chesottoscrive l’appello dei “cattolici per il no”.Ciò che è significativo non è però tanto questo fatto, quantol’interpretazione da dare del referendum del maggio 1974: lalegge è confermata dal 59,3% dei votanti (con l’87,7% diaffluenza, è bene ricordarlo), cosa che significa la certifica-zione della fine di quella vaga immagine della “Italia catto-lica” che tanto piaceva ad una certa retorica conservatrice. Daqui inizia il percorso di ripensamento della posizione che ilcattolicesimo sociale deve assumere in una società che non è

/ / 52 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
più né quella del tardo Ottocento, né quella dei primi duedecenni dell’era repubblicana. Ovviamente ciò porrà il temadel confronto con le altre culture che si sono poste il mede-simo problema di interpretare questo passaggio storico.Sembra a me che questo sia il tema chiave dell’ultimo tren-tennio di presenza pubblica di Ermanno Gorrieri. La culturache per semplificazione definirò “progressista” aveva allorain Italia quattro anime. Di quella cattolica, che costituisce ilcampo da cui muove il leader modenese, si è in parte giàdetto. Dirimpettaia è la posizione del partito comunista, chenon è ormai più quello togliattiano. Berlinguer ha già lan-ciato, dopo i tragici fatti cileni, lo slogan del “compromessostorico”, ma assai più di questo passaggio conta qui la prassidi governo del Pci nell’area emiliano-romagnola, che è giàorientata ad una dialettica positiva con tutte le forze in campo.Abbiamo poi il versante socialista, che dopo l’elezione asegretario del Psi di Bettino Craxi nel 1976 ha ricominciato amuoversi e punterà anch’esso a proporsi come il punto di coa-gulo del nuovo progressismo italiano. Infine c’è quello chepotremmo chiamare l’arcipelago laico-radicale, che è più unatradizione culturale che un movimento politico, ma che staguadagnando spazi ed importanza soprattutto per le vicendedel mondo dell’editoria (prima la direzione di Piero Ottone alCorriere dal 1972 al 1977, poi la fondazione di Repubblica daparte di Eugenio Scalfari nel 1976).È un momento fortemente creativo della politica italiana, esembra che – pur in una accesa dialettica – ci siano gli spaziper affrontare di petto il problema dell’adeguamento delnostro sistema politico alle trasformazioni che sono in atto. Ilclima di dialogo fra le forze politiche è rilanciato dal trenten-nale della nostra fase costituente, e sembra che esista uno spa-zio per gli intellettuali impegnati nel recupero della memoriastorica di quella fase di grandi intese (impropriamente chia-mate, mi sia consentito dirlo, “compromesso costituente”).Gorrieri, che lavora nella formazione politico culturale deno-minata “Lega democratica nazionale”, rafforza qui alcunecollaborazioni con questi intellettuali, fra cui ricorderò pertutti Pietro Scoppola e Roberto Ruffilli.Quella prospettiva di nuova grande intesa neo-costituente saràtroncata di fatto dal rapimento e poi dall’assassinio di AldoMoro, l’uomo che, anche a detta di Gorrieri, doveva essere iltessitore delle basi di questo passaggio. Non ci si rende imme-diatamente conto di questa congiuntura, perché anzi, per uncerto periodo, sembra che il cambio di clima possa sopravvi-vere e fare qualche passo avanti. Al vertice della Dc, dopo laconclusione della fase rifondativa di Zaccagnini, arriverà
Ciriaco De Mita, che nel 1982 apre il partito agli “esterni”: agliAndreatta, ai Prodi, ai Ruffilli. Si potrà tornare a ragionare diriforma del welfare (un passaggio essenziale per governare unatransizione, varrebbe la pena di ricordarlo): Gorrieri presiedeuna commissione per lo studio dei problemi della famiglia, cheprodurrà nel febbraio 1983 un famoso rapporto. Sempre a testi-monianza di questo clima, nello stesso anno si varerà unanuova commissione bicamerale per le riforme, purtroppoinconcludente, mentre, su suggerimento di Giuliano Amato, ilgoverno Craxi affiderà a Gorrieri una commissione d’indaginesul problema della povertà in Italia.
Diventa sempre più chiaro che è finita
l’unità politica dei cattolici e che dunque
la Dc entrerà inevitabilmente in crisi
In realtà la fase che stiamo descrivendo è ambigua, e le lotteinterne per l’egemonia politica fra molti spezzoni delle classidirigenti dei partiti impediscono che i dibattiti sulle riformenecessarie producano azioni incisive di intervento nei varisettori. In questo turbinio di eventi, nel 1987 Gorrieri correràpersino l’avventura di essere, per un pugno di giorni, ministrodel Lavoro in un governo Fanfani che non otterrà la fiducia.Inevitabilmente per l’uomo politico modenese e per i suoicompagni di avventura si pone allora il problema di trarre unalezione dall’evolversi della situazione: nel 1987 Pietro Scop-pola pubblica sulla rivista della “Lega Democratica” le sueNove tesi sull’alternanza, in cui pone il problema del “ruolodei cattolici democratici anche fuori della Dc”.Si arriva così alla questione cruciale di ciò che io chiamo lacostruzione dell’alleanza progressista, tema storico della nostravicenda politica: ma in una fase in cui diventa sempre più chiaroche è finita l’unità politica dei cattolici e che dunque la Dcentrerà inevitabilmente in crisi. Il tema fondamentale diverràsempre più, anche se non è mai stato esplicitato nei termini cheora esporrò, quanto la questione del progressismo possa esserelasciata in mano all’egemonia sempre crescente del suo versantelaico-radicale, che cerca di imporre la sua cultura come misuradell’essere “di sinistra”. In una significativa intervista del 1990Gorrieri dichiarerà: “Se io ho un rammarico è che il Pci non èabbastanza di sinistra: da quando tenta di resistere al declino vaalla ricerca di movimenti radicali e radicaleggianti”.Per la verità questa era una piega culturale che stava, in varieforme, conquistando molte componenti, anche cattoliche.Non posso qui ripercorrere gli eventi tumultuosi che si susse-guono in quegli anni. Gorrieri tenta (vorrei dire sperando con-

/ / 53 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
tro ogni speranza) di aiutare una ricomposizione del sistemapolitico con la formazione, come dirà in un convegno aRoma nell’aprile del 1993, di “un’area tendenzialmente pro-gressista” dove si possano “coniugare le esigenze dell’effi-cienza con quelle dell’equità sociale”. Come si vede non haabbandonato le sue due stelle polari.La strada però per arrivare a quella meta si capisce che saràlunga e tortuosa. Certo il politico modenese è un combattente:per cui, come dirà ad un altro convegno nel maggio, “l’impor-tante è non rassegnarsi al declino”. Non è semplice, con lacomponente del cattolicesimo progressista che si divide inmolti rivoli, mentre lui non rinuncia del tutto al tentativo disalvare l’esperienza della “democrazia cristiana”, proponendoalla assemblea programmatica del partito, il 23 luglio 1993, difondare “un nuovo partito di ispirazione cristiana interpretatacome impegno a favore delle persone, dei ceti, dei popolisvantaggiati, e che in coerenza con questa scelta di fondo par-tecipi alla costruzione di uno schieramento progressista”.
Ciò che aveva portato eguaglianza
e promozione del benessere ora rischiava
di destrutturare la società in una giungla di
diseguaglianze e di nuove contrapposizioni
È un invito a tornare alle origini della sua battaglia politica, a que-gli ideali che la “sinistra giovane” che aveva fatto capo in misuradiversa alla leadership di Giuseppe Dossetti aveva cercato di fardiventare le ragioni cardine del partito. Ormai però si è fuoritempo massimo, e il vecchio partito non ha né le forze, né la cul-tura, né il personale politico per rifondarsi. Col senno di poi dob-biamo dire: né di rifondarsi a sinistra, né di rifondarsi a destra.Per Gorrieri ovviamente il campo in cui confluire è comunqueil primo. Fra settembre ed ottobre fonda il movimento dei cri-stiano-sociali, che vuole porsi sin da subito come una compo-nente del polo progressista: ci si rivolgerà “al mondo di ispira-zione cristiana impegnato nel sociale”, per confluire in un poloche unisca “la liberal-democrazia, il riformismo socialista, ilcattolicesimo democratico, l’ambientalismo non fondamenta-lista”. E’ il sogno di quella fase politica, un sogno che dureràa lungo, ma che sconterà il problema di unire, se mi è consen-tito dirlo, ambiti e culture in crisi, nessuna capace di egemoniaper indurre se stessa e le altre ad un ripensamento radicale.Nella tornata elettorale del 1994 lo spappolamento del sistemapolitico italiano emergerà con chiarezza. Gorrieri è ormai unpersonaggio accreditato di notevole spessore perché ha dimo-
strato coi suoi studi, contenuti sia in importanti libri che in unaserie di interventi sulla stampa, di avere percepito con luciditàil travaglio fondamentale di una società che affronta una tran-sizione epocale allora forse ancora agli albori: quel travaglioera il venir meno delle tradizionali reti di connessione delsistema sociale, fenomeno che portava ad una distorsione delsignificato delle antiche conquiste. Se posso semplificare, ciòche aveva portato eguaglianza e promozione del benessere orarischiava di destrutturare la società in una giungla di disegua-glianze e di nuove contrapposizioni fra le sue varie compo-nenti. Non si intravvedeva una capacità di risposta fondatatanto sul coraggio dell’analisi intellettuale non di maniera,quanto sulla pazienza del costruttore di stabilità e di integra-zioni sociali. Nel febbraio 1995, parlando all’assemblea delsuo movimento, Gorrieri non si limiterà ad attaccare quelloche con Berlusconi gli appare un trionfo del plebiscitarismoche annega tutto in un confuso rapporto tra capo e popolo, maesprimerà un severo giudizio anche sul Pds, che rischiava di“uscire dal comunismo” per le strade o del “radicalismo indi-vidualista” o dell’”estremismo utopico”, mentre “stenta[va] ademergere un ancoraggio per la mediazione razionale”.In fondo nei suoi ultimi anni di impegno, resi difficili dallecondizioni di salute della moglie, è il disagio per questa debo-lezza culturale nella ricerca dell’ancoraggio per la media-zione razionale ciò che sembra lo tormenti più di tutto.Ancora una volta non vorrà far mancare il suo contributo persuperare questa impasse, e mi pare molto significativo tornarea richiamare due opere fondamentali: la sua critica al neo-liberismo (mi permetterei di aggiungere “neoliberismo all’ita-liana”), che trova forma nel suo volume del 2002 Parti egualifra diseguali, che esce, come di consueto, dal Mulino; e, purpubblicato postumo, sempre presso lo stesso editore il suoRitorno a Montefiorino, che non a caso è la riproposizione diuna lettura non irenica, ma non perciò divisiva, dell’originedella nostra Repubblica nella esperienza della Resistenza.In fondo la grande battaglia di colui che è stato forse l’ultimovero cattolico sociale, tale rimasto sino alla fine, potrebbe essereraccolta emblematicamente in due elementi: nel rigore di chiaveva coniugato una vita personale integerrima dedicata al servi-zio degli altri, e nella passione di chi aveva sempre creduto chenon si è utili agli altri se non attraverso un impegno che non puòmai essere disgiunto dalla tensione per capire razionalmente ilmondo e la storia con cui ci si confronta. Questa è la lezione cheErmanno Gorrieri consegna a tutti coloro per i quali, quale chesia la parte in cui intendono impegnarsi, politica significa servi-zio a quella società che poi trova forma nella città degli uomini.

Se c’è una nazione che si e dimostrata refrattaria all’assun-zione delle teorie weberiane sullo Stato e sulla società,
questa è l’Italia. Prendiamo un concetto a caso del grandesociologo tedesco: quello dello Stato moderno, reso capace dioperare secondo un «principio di razionalità» quanto ai«fini», ai «mezzi» ed «agli effetti» dal «diritto formale razio-nale». Su questa rivista Luigi Capogrossi ha affermato giusta-mente che ad un certo punto della storia del nostro paesealcuni di siffatti elementi costitutivi della modernità delineatida Weber hanno iniziato a perdere valore e forza propulsiva.Questo processo, a sua detta, avrebbe investito in Italia tuttigli ordinamenti, sino a mettere in dubbio la possibilità di con-siderarci adeguati a quella che è la corrente idea di sviluppo. Mi chiedo con lui se tali elementi di razionalità siano mai statiin voga nella nostra nazione. Non credo si possa dimenticareche l’Italia fin dal secondo dopoguerra è stata governata da unpartito confessionale, la Democrazia cristiana, la cui ideolo-gia era informata ai principi del cattolicesimo e la cui linea dicondotta era dettata non di rado da uno Stato come il Vati-cano, i cui fini ed i cui mezzi non si potevano certo definirerazionali nel senso abituale della parola. Non parliamo poi degli effetti di questa ideologia. Capo-grossi limita generosamente questi effetti negativi al periodoin cui un simile partito ebbe quale cardine delle sue azioni la«visione palingenetica» del dossettismo. La domanda daporsi, però, è fino a che punto abbia condizionato la capacitàdelle forze politiche di governare l’Italia razionalmenteavere al proprio interno una compagine ideologica che agivacome uno Stato nello Stato in base alla propria dogmatica. Equesto non solo negli ultimi anni della prima Repubblica(quando i socialisti si presero delle responsabilità in questosenso, prima con Nenni e poi con Craxi), ma anche moltoprima, quando la Dc strinse delle alleanze con altre forzepolitiche disposte a collaborare: dai liberali ai repubblicani aifascisti. Si pensi a vicende come quella del governo Tam-broni, o quella dell’approvazione del divorzio e della leggesull’aborto. Si pensi all’agonia dell’ultimo governo Prodi,contestato in tutto per tutto da quella corrente del Pd che si
rifaceva ai principi del cattolicesimo sulla fecondazione assi-stita e sull’uso delle cellule staminali, e non si avranno moltidubbi sulla risposta da dare.Per elencare tutti gli episodi in cui gli ex-democristiani, chepure stavano al governo, misero i bastoni tra le ruote ariforme che non profumassero di incenso ci vorrebbe non unarticolo, ma una enciclopedia Treccani. Non sembra di poterdire che questo indirizzo politico abbia mai avuto una idea diStato e di governo intesi in senso weberiano, alla stregua diun punto alto della politica come «vocazione». I fini e larazionalità c’erano. Per carità, nessuno vuole negare che ilpensiero cattolico abbia fini e razionalità in abbondanza. C’e-rano pure le «vocazioni». Ma si trattava di vocazioni, di finie di una razionalità che prima di realizzarsi sulla terra dove-vano «passare per il cielo», con grave compromissione dellaloro possibilità di realizzarsi razionalmente «quaggiù da noi».
Max Weber aveva avuto da tenzonare
con i «socialisti della cattedra»
Non parliamo, poi, dell’opposizione, che fin dalla nascitadella Repubblica era monopolizzata dal Partito comunista edal Partito socialista di Nenni, che dopo essersi fatto strapparela maggior parte dei consensi elettorali da Togliatti gareg-giava con il suo alleato-rivale in forme sempre più esasperatedi massimalismo. Qui la teologia «politica» nel senso schmit-tiano della parola regnava incontrastata, o meglio contrastatasolo dal fatto che i tentativi nenniani di «andare a sinistra»erano via via superati da analoghi tentativi togliattiani di sca-valcare il Psi in quella direzione, nel tentativo inane di rag-giungere la sinistra democristiana, che con il suo cattolice-simo aveva già scavalcato a priori tutti quanti.Max Weber aveva avuto da tenzonare con i «socialisti dellacattedra», che già allora si distinguevano per gli empitimistici che li spingevano alla lotta politica. I socialisti italianiebbero da duellare con i comunisti ed i cattolici ex cathedra,purtroppo «senza Weber»: nel senso che si trovarono a com-battere avversari politici che parlavano dall’alto della sedia
/ / 54 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
L’Italia refrattaria>>>> Paolo Bellinazzi
Max Weber

/ / 55 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
gestatoria su cui erano comodamente assisi, senza che ci fossenessuno in grado di farli scendere rispondendo alle loro spa-rate teologiche con un paio di battute a carattere laico diquelle in cui Weber era un maestro imbattibile. Non c’eranoallora, nella classe dirigente italiana - che pure poteva vantarenelle sue file la presenza di uomini di altissimo valore - per-sonalità dotate di una cultura fermamente ed autenticamentelaica e liberal-democratica, salvo che nel campo dei repubbli-cani e dei liberali malagodiani, che però contavano poco.Del resto questo era lo spirito del tempo e dei tempi. Pocoaveva potuto fare Weber contro la marea montante del nazi-smo, che già nella sua epoca, in Germania, «scaldava imotori» nell’ambito dei partiti cattolici allora in essere; pocopoterono fare i socialisti in Italia contro la marea montante deicomunisti e dei democristiani di base. I risultati di questaimpotenza si videro poi da quello che accadde negli anni suc-cessivi, ai tempi del terrorismo, di tangentopoli e della cadutadella prima Repubblica. Weber si scaglia contro i «profetidella cattedra», i docenti suoi colleghi che intendono la loroprofessione non come se fosse una «scienza», ma come sefosse una occasione per indottrinare i loro allievi. Chiunqueha presenziato a una lezione dei nostri docenti di lettere e sto-ria in una scuola di qualsiasi ordine e grado - specie negli annisettanta, quando lo scopo dell’insegnamento era «fare la rivo-luzione» e indurre a farla - ha già capito quale era la situa-zione in cui si muoveva Weber nel 1919, anno in cui il paeseaveva appena perso la guerra e si preparava il trapasso tempe-stoso dalla monarchia alla repubblica. Le aule dell’università,continua il grande sociologo tedesco, non sono il luogo in cuidevono parlare i «capi» o i demagoghi di un partito politico,ma il luogo dove devono parlare i «docenti» o i «maestri» dipensiero. La scienza non deve trasmettere dei valori, maessere «avalutativa».Weber avverte che in quegli anni e nella sua epoca sono ormainaufragate tutte le illusioni che la scienza fosse un mezzosicuro per raggiungere il «vero essere», la «vera natura», la«vera arte», il «vero dio». Chi potrebbe dire in un momentostorico come quello che la Germania stava vivendo, dal puntodi vista rigorosamente «scientifico», se fosse più valida la cul-tura tedesca o quella del paese d’oltre Reno? Evidentementenessuno. Il professore deve obbedire al suo «dannato dovere»di seguire la sua «vocazione» politica nelle strade e nellepiazze, dove ha davanti delle persone che gli possono rispon-dere per le rime: non in una aula universitaria, dove gli stu-denti possono soltanto ascoltare e prendere appunti. Lascienza deve contribuire a quel «disincantamento del mondo»
a cui ci ha avviato la modernità, non ad «incantare» le persone.La differenza tra il credente ed il professore universitario deveessere che il primo riconosce la validità dei «presupposti» cri-stiani (tra i quali il miracolo e la rivelazione), il secondo non liriconosce. Anche se è difficile creare una scienza completa-mente «priva di presupposti», bisogna crearla e sforzarsi dicrearla. I metodi sono quelli della ricerca empirica e dell’espe-rimento scientifico. Già nel suo capolavoro del 1904-1905,L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Weber avevasostenuto che il luteranesimo, pur dimostrandosi una religioneavanzata rispetto al cattolicesimo, era da considerarsi arretratorispetto al calvinismo che aveva guidato lo sviluppo econo-mico dei paesi anglosassoni. La condizione inferiore edarcaica rispetto ad essi della Germania era la prova provatadella validità delle sue conclusioni.
La lotta politica si atteggia a un contrasto
tra dei, in cui è impossibile decidere in
maniera assoluta e definitiva quali siano le
divinità buone e quali le divinità malvage
Figuriamoci che cosa gli sarebbe capitato se avesse avuto ache fare con personalità come Giorgio La Pira, il cui unicoobiettivo era «incantare» il mondo facendo perno sulla sua«vocazione» e sui suoi «valori». Molto probabilmente nonsarebbe mai uscito dall’esaurimento nervoso da cui era statocolpito nel 1903 a causa dell’intensità con cui si dedicava aglistudi: o forse sarebbe subito entrato in un altro e finito persempre in manicomio. Qualcosa di analogo, se non di peggio,gli sarebbe toccato in sorte se avesse avuto da combattere coni vari Mario Capanna dell’epoca novecentesca che noiabbiamo faticosamente attraversato, il cui scopo era stabiliz-zare quale fosse il «vero essere», la «vera natura» ed il «verodio» nella storia e nella politica.C’è un altro motivo, conclude Weber, per cui conviene non darealla scienza l’aspetto di un intervento «pratico» nella vita poli-tica: una simile impostazione ed impresa sono sostanzialmenteassurde, in quanto tra i diversi valori che presiedono l’ordina-mento del mondo il contrasto è inconciliabile. La lotta politicasi atteggia a un contrasto tra dei, in cui è impossibile decidere inmaniera assoluta e definitiva quali siano le divinità buone equali le divinità malvage: «Dipende dal proprio atteggiamentorispetto al fine ultimo decidere quale delle due divinità sia il dia-volo o sia dio e per quale delle due divinità propendere». Se lascienza ci insegnerà i metodi di pensare, gli strumenti per distin-

/ / 56 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
guere e la preparazione allo scopo che vogliamo raggiungere,avrà già conseguito un importante obiettivo.
In Italia Weber incontra Gentile e con lui
quell’Antonio Gramsci che secondo le più
recenti ricerche filosofiche è stato uno dei
suoi allievi più fedeli e più misconosciuti
Sebbene le ultime pagine del suo saggio sulla «scienza comeprofessione» si rivolgano direttamente a Gyorgy Lukacs (unodei suoi allievi più stimati ed intelligenti, che però di lì a dueanni sarebbe diventato l’ideologo più importante di Lenin),non è un caso che egli qui si accommiati ironicamente daquelle forze politiche, che in Germania si erano prese il gustodi sostituire la politica con una specie di «cappella privata,arredandola come per gioco con immagini sacre di tutti ipaesi». Il suo discorso era rivolto a quei circoli culturaliquasi-religiosi, particolarmente di matrice cattolica, da cuisarebbe scaturito un personaggio come Carl Schmitt - il suo
saggio sulla «sovranità» a carattere «teologico politico» è del’22 - che era destinato a diventare, di lì a pochi anni, il piùfecondo ideologo di Hitler. Non è un caso che il bersaglio polemico preferito di questidue intellettuali di estrema sinistra e di estrema destra siastato - in occasioni diverse e con il massimo rispetto, ma conuna quasi strabiliante identità di vedute - proprio Weber. Ilprimo lo accusa (in Storia e coscienza di classe, che è ugual-mente del ’22) di avere concepito un concetto di Stato scissodalla realtà, facendosi sfuggire con il suo riferimento alle«norme astratte, basate sul calcolo razionale, che regolano ilsuo funzionamento», quella che era l’essenza, la cosa in sé,di tale Stato. Il secondo gli rimprovera, in un suo lavoro del1950, di aver reso problematica, col suo concetto di «lega-lità» desunto da Kelsen, la «legittimità» della «volontà ple-biscitaria popolare», rimanendo nella sua analisi alla superfi-cie delle cose. Insomma, tutti e due gli ideologi lo mettono sotto processoper non aver penetrato quella sostanza politico-sociale delleistituzioni che sia per i comunisti che per i nazisti era quella
>>> Quis vigilat vigilantes? Che cosaera scritto nella relazione consegnatanel 2009 dal generale dei carabinieriMario Mori al sindaco Gianni Ale-manno, che non appena eletto lo avevaincaricato di indagare sul corpo deivigili urbani di Roma? Come mai l’op-posizione in Campidoglio non chieseche fosse resa pubblica, né di pren-derne visione direttamente? E comun-que, in una città e in quartieri che ivigili certamente non li vedono tutti igiorni, non ne fece l’argomento di unabattaglia politica neppure di bandiera?Come mai i sindacati dei dipendenti delComune di Roma (come di altre ammi-nistrazioni locali) hanno potuto riven-dicare e ottenere integrazioni salariali atitolo di “indennità di effettiva pre-senza”, “indennità per servizio esterno”o per “turno serale (speciale per i vigili)a partire dalle ore 16”? Le camere dellavoro cittadine e i sindacati nazionali
hanno sostenuto queste rivendica-zioni? E che cosa hanno detto e fattoquando sono state informate che que-ste “conquiste” erano state “strappate”alle varie amministrazioni? E i partitilocali e nazionali, in varia misura enatura così all’ascolto e in sintonia conil “mondo del lavoro”, quando anche nesiano venuti a conoscenza, che cosahanno detto e fatto, magari nei consi-gli comunali? Perché i comuni mortaline hanno saputo qualcosa solo quandoil ministero dell’Economia ha impu-gnato la legittimità della spesa che neè derivata per le casse pubbliche?E come mai su tutte queste vicende igiornali cittadini e nazionali, nelle lorocronache romane che negli scorsi mesiabbiamo visto scatenate sulla Pandarossa del sindaco Marino, in questi anninon hanno cercato di sapere di più diquella relazione e non hanno datonotizia di quanto (pur pubblico, perché
quegli accordi sono tali) amministra-zione, sindacati e partiti hanno volutotenere riservato?Queste domande torna a porsi chi hapotuto leggere, sulla Stampa di domenica4 gennaio, l’articolo di Vladimiro Zagre-belsky che invita a non farsi troppe illusionicirca la praticabilità e l’efficacia delle azionipenali (e anche delle sanzioni) comminatesulla base delle risultanze delle più varieindagini amministrative, “quando il feno-meno dell’illegalità e dell’infedeltà è mas-siccio, strutturale”. Sicché non resterebbeche “ripetere quanto da tanti già detto:non c’è salvezza senza etica pubblica,senso civico, senso del servizio pubblico”.Ma se la nostra democrazia non può con-tare sui partiti, sui sindacati e sui media,dovrà (continuare a) contare – e fino aquando? – sui magistrati, la contabilitànazionale e le forze dell’ordine (a parte ivigili dell’Urbe)? (Celestino Spada, mon-doperaio.net, gennaio 2015)

verità dell’essere che per loro era un obiettivo da raggiungereed invece per Weber non era neanche da contemplare. Chivuol vedere un remake di quel dibattito si rilegga le battutedello scontro verbale che si svolse in Italia tra Pietro Ingrao eNorberto Bobbio ai tempi dello sfortunato tentativo craxianodi «governare il cambiamento» attraverso la «granderiforma»: il primo che fu una reincarnazione riuscita diLukacs e Schmitt nello stesso tempo, il secondo che avrebbepotuto reincarnare benissimo Weber, ma non ci riuscì o forsenon lo volle veramente.In Italia Weber incontra Gentile e con lui quell’AntonioGramsci che secondo le più recenti ricerche filosofiche è statouno dei suoi allievi più fedeli e più misconosciuti. Non cipoteva essere, per l’inventore della sociologia moderna, unincontro più disgraziato. Come le analisi di Giuseppe Bede-schi e di Luciano Pellicani (nonché quelle più recenti diDiego Fusaro, e, se vogliamo, le mie) hanno dimostrato inmaniera inoppugnabile, il fondatore dell’Ordine nuovo avevaun concetto di prassi, di volontà, di partito, di filosofia, cheera pari pari quello dell’ideologo di Mussolini: ovvero tuttoil contrario di quello che pensava Weber su tutti questi temi,nonché sulla razionalità scientifica che avrebbe dovuto gui-dare lo Stato a dei fini prestabiliti. Il fatto che alla catarsi comunista di Lukacs si fosse sosti-tuita la catarsi nazista di Schmitt ha giovato alla diffusionedelle sue idee in Germania tanto poco quanto poco il sub-entrare della mistica fascista alla mistica di Lazzari,Labriola e Lelio Basso ha avuto effetti positivi per la pub-blicazione delle sue opere nel nostro paese. Come ebbe adire Terracini ai suoi tempi, nella redazione di Ordinenuovo «non c’era uno di noi che non fosse un gentiliano».La società trascendentale di Gentile aleggiava talmentenelle teste dei comunisti che l’unica cosa che avevanoappreso Gramsci e Lukacs da Weber era che il capo del par-tito doveva essere «carismatico». Che poi questo carismafosse quello di Lenin o di Mussolini, o addirittura di Hitler,poco importava. Tra gli attuali intellettuali del Pd si èaperta una nobile gara tra chi elogia di più e meglio nei suoiscritti non solo Gentile, ma anche Carl Schmitt. Alla Poli-tische theologie si è sostituita, qui da noi, la teologia poli-tica di un Luciano Canfora che elogia Stalin ed altri auto-crati «greci», un giorno si ed uno no, sulle pagine del Cor-riere della Sera. Ancora, nella sua introduzione al Lavorointellettuale come professione, Massimo Cacciari, uno deimassimi ideologi dei moderni post-comunisti, accusaWeber di essere stato un formalista.
Nell’articolo di Capogrossi, a cui ho alluso all’inizio siosserva giustamente che in Italia alla cultura craxiana del«fare» è subentrata la cultura della «virtù». Questa si è sosti-tuita, nei programmi dei partiti di opposizione, alle ideologiecomunista e fascista ormai da tempo crollate, diventando ilmito ed il collante di quell’attesa palingenetica che si espressenell’idea di una nuova partenza: l’inizio della seconda Repub-blica. Egli annota, inoltre, che al posto della tradizionale divi-sione dei poteri dello Stato si è sostituito, a seguito della col-pevole latitanza del potere politico, quello esclusivo dei giu-dici. Ciò che ne è conseguito è stato un ordine politico-socialeche si contraddistingueva non per l’azione riformatrice deigoverni e per il fare, ma per l’impedire di «fare» il «male»,che caratterizza per natura un organismo giudiziario.
Il «morto ordine burocratico» di cui parlava
Weber è il risultato delle riforme di questi anni
Lo si vide bene anche nell’azione che lo Stato condusse controil terrorismo, che fu pertanto esclusivamente penale, e nonun’azione volta a modificare le cause ideologiche e reali che ilterrorismo avevano prodotto. Tuttavia, prosegue pertinente-mente Capogrossi, nessuna trasformazione incisiva dellasocietà è stata mai portata a termine con la mera applicazionedella legge penale. Ma, mi chiedo, la lotta contro il terrorismonon si configurò sempre come una «lotta» weberiana tra «divi-nità», ognuna con la sua diversa «visione del mondo»? Da unaparte c’erano i democristiani che il capitalismo lo avevanoaccettato, ma da esso volevano uscire perché non soddisfacevai loro scrupoli di cattolici; dall’altra c’erano i comunisti, chedel pari il sistema capitalistico l’avevano accettato, ma da essovolevano uscire perché non rispondeva alle loro esigenzemorali; dall’altra ancora c’erano i terroristi, che contestavanoil capitalismo, e volevano uscire da esso con la furia che siaddice agli spiriti religiosi. Non sarebbe stato opportuno che leforze laiche controproponessero alla pura azione militare alter-native ideali e dettate dalla ragione? L’unico tentativo effet-tuale di «ragionare» fu quello di Bettino Craxi, al momento incui voleva trattare con i terroristi per salvare la vita di Moro.Ma fu censurato e sbeffeggiato da comunisti e da democri-stiani perché poco virtuoso. E la lotta ventennale contro Ber-lusconi non fu fatta sempre in nome della virtù, quando sisarebbe dovuto capire che quest’uomo raccoglieva milioni divoti da un elettorato che lo eleggeva a capo del governo nonnecessariamente solo perché tale popolo era formato da satiriassatanati alla ricerca di donne giovani e compiacenti?
/ / 57 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

Dal «fare», conclude Capogrossi, si è passati al «non fare»,per paura di «fare male» e di essere inquisiti e condannati.E dal non fare al semplice e desolante esclusivo «dire». Maquello che è più grave è il carattere di fondo delle nuoveondate legislative, ispirate anch’esse al perseguimentodella «virtù». Perché il disciplinamento della macchinapubblica dominato dall’ossessione del «peccato» si èsostanziato in una legislazione non direttamente mirata alfunzionamento-tipo dell’ordinamento, lasciando spazirepressivi per le eventuali disfunzioni: ma ispirata al crite-rio che tutti gli amministratori sono potenzialmente dei«peccatori», e quindi che il fine primario è distogliere ipeccatori potenziali dal fare il male. Vincoli su vincoli sisono accumulati contro i propri amministratori e la propriaburocrazia e contro la società.
Il «morto ordine burocratico» di cui parlava Weber è il risul-tato delle riforme di questi anni, che rendendo ingovernabileil paese contribuiscono a togliere potere effettivo di inter-vento al governo ed allo stesso Parlamento. Su tutto plana ilsempre più temuto potere giudiziario. Speriamo che dal dire,sotto la spinta imperante della crisi economica, non si tornia passare al «fare»: ma non al «fare» liberaldemocratico diuomini come Bettino Craxi, bensì al «fare» teologico-poli-tico di comunisti e nazi-fascisti o al «fare» di Beppe Grillo,che è tutt’altro che fuori gioco, ed al «fare» (nonché al«dire», se non al «pensare») di tali indirizzi politico-filoso-fici rassomiglia non poco. Robespierre diceva: «La vertù oula terreur!». La frase è già risuonata in Italia e non è esclusoche torni a farsi sentire nelle aule del Parlamento e fuori,nelle piazze.
/ / 58 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

/ / 59 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti
>>>> saggi e dibattiti
Se quantità non fa qualità>>>> Simone Emiliani
I festival cinematografici
Nel giro di due mesi si sono svolti sia la 71° Mostra d’artecinematografica di Venezia sia il 9° Festival internazionale
di Roma. La prima anomalia, tutta italiana, è quella di duegrandi kermesse cinematografiche che si sono svolte a questadistanza ravvicinata: a cui si aggiunge il Torino Film Festival,che si è svolto dal 21 al 29 novembre. Il problema non è solodi quest’anno ma va avanti già da un po’ di tempo. È chiaroche a questa poca distanza di tempo i due eventi vanno ascontrarsi su molti titoli in uscita in questo periodo, dai filmitaliani alle anteprime statunitensi. Cosa che non accade né alFestival di Cannes, in programma a maggio, ne a quello diBerlino, che si svolge tra la prima e la seconda settimana difebbraio. Si è rimproverato al Festival di Venezia di non aver portato alLido pellicole attese come l’ultimo film di Paul Thomas An-derson Inherent Vice, che uscirà in Italia come Vizio di forma,e Gone Girl di David Fincher (in Italia L’amore bugiardo),quest’ultimo invece presente al Festival di Roma ma senza lapresenza del regista e del cast (Ben Affleck e RosamundPike). Al tempo stesso invece coloro che si sono schieratidalla parte del Festival di Venezia hanno voluto sottolineare illavoro di ricerca presente nella competizione ufficiale e l’altaqualità dei film italiani presenti in concorso: Il giovanefavoloso di Mario Martone, Anime nere di Francesco Munzi eHungry Hearts di Saverio Costanzo. Questo dato è certamenteincontestabile. Al tempo stesso però anche a Roma si sonovisti dei buonissimi film italiani a cominciare da Tre tocchi diMarco Risi fino alla rivelazione Fino a qui tutto bene delpisano Roan Johnson, una sorta di “eccebombo toscano” conal centro cinque ex-studenti universitari che stanno per lasciarela casa dove hanno vissuto per diversi anni.Basta la qualità dei film per fare un festival di livello? È utile.ma non basta. Serve anche il rapporto dell’evento col territorioe la risposto del pubblico. E al di là dei numeri di facciata datialla fine del Festival di Venezia, quest’anno il Lido era semprepiù vuoto e desolato, mentre a Roma invece ci sono state pre-senze intermittenti con qualche innalzamento nel fine settimana,
quando l’Auditorium è stato preso d’assalto da giovanissimifan per l’anteprima di #ScrivimiAncora con la presenza di duegiovanissime star, Sam Claflin e Lily Collins.Partiamo dal livello dei film. La terza edizione diretta daAlberto Barbera ha mostrato una qualità a dir poco altalenante.All’ottimo livello della delegazione italiana vanno aggiunti ilviscerale e contestatissimo Pasolini di Abel Ferrara, la folliaantimilitarista di Fires on the Plain del giapponese ShinyaTsukamoto, il cinema vecchia maniera ma ancora d’impattodel russo Andrei Konchalovsky (che con The Postman’s WhiteNights ha vinto il Leone d’argento), la fisicità dirompente diLe dernier coup de marteau di Alix Delaporte, a cui sui puòaggiungere anche il documentario sullo sterminio indonesianoThe Look of Silence di Joshua Oppenheimer. E due filminclusi nella sezione Orizzonti potevano essere tranquillamentein gara: Jackie & Ryan di Ami Canaan Mann (probabilmenteil miglior film di Venezia) e il coreano Hill of Freedom diHong Sang-soo. Ma ricordare soltanto 8 film sui 20 del concorso non è un datoincoraggiante. Soprattutto per la tradizione che dovrebbe avereVenezia. Senza dire che il vincitore del Leone d’oro di que-st’anno, A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence dellosvedese Roy Andersson di improponibile non ha soltanto il

titolo ma è un cinema già vecchio 30 anni fa che si diverte conquadretti grotteschi di dubbio gusto. La critica allineata peròha gridato al capolavoro. Beati loro.Roma è invece un altro caso. Se Alberto Barbera ha potuto la-vorare a Venezia con il totale appoggio del presidente dellaBiennale Paolo Baratta, non si può dire la stessa cosa diMarco Müller a Roma, già osteggiato sin dal suo insediamentonel 2012 e ora a fine mandato. Eppure, come osserva giusta-mente Raffaele Meale su www.quinlan.it, il suo interludio èstato visto “con sospetto da chi gestisce la res publica capitolinafin dall’investitura, ricevuta nel 2012 da Gianni Alemanno eRenata Polverini”. Aggiunge Meale: “Prima che si incappinell’errore di leggere in questo un’opposizione politica e ideo-logica, è giusto ricordare come il festival mülleriano si siasmarcato da subito, con facilità, dagli schematismi piuttostobeceri del centro-destra romano, per muoversi in libertà in di-rezione di una kermesse che rinunciasse almeno in parte altappeto rosso per star non sempre di primaria importanza a fa-
vore invece di una selezione più ricca, in grado di coniugarel’intrattenimento con la ricerca, il cinema ‘popolare’ e l’avan-guardia, il documentario e la finzione”.
Tre festival attaccati sono troppi ma le
soluzioni sembrano lontane
Eppure, nel caos generale, quest’anno Roma è riuscita inparte a unire quelli che sono gli ingredienti fondamentale diun ottimo festival: la sperimentazione, la scoperta e lo spetta-colo. Se l’anno scorso la sintesi più felice era rappresentatodall’unione di eventi come la passerella per Hunger Games ela serata in onore del regista russo scomparso Aleksej JurevičGerman, quest’anno invece si è danzato tra il sempre più sor-prendente Aleksej Fedorchenko di Angels of Revolution e larivelazione indiana di Haider di Vishal Bhardwaj, fino allapotente serie tv The Knick di Stebven Soderbergh per passarealle presenze di star come Kevin Costner, Richard Gere, le
/ / 60 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

masterclass con Tomas Milian e il film di chiusura di Ficarrae Picone, Andiamo a quel paese, bollato dalla stampa tradi-zionale come l’ennesima provocazione mentre in realtà è unfelice esempio di “cinema di parola” del duo comico sicilianoche da una parte guarda alle lezioni di Camillo Mastrocinquee Mario Mattoli con Totò, dall’altra al grottesco di LucianoSalce, dall’altro ancora alla Sicilia di Pietro Germi.Tre festival attaccati sono troppi ma le soluzioni sembranolontane. Certo che un Festival di Venezia così ha un futurosempre più incerto, malgrado l’ottimo giudizio del Corrieredella Sera e di Repubblica che invece hanno ignorato eattaccato il Festival di Roma. Al di là del valore diseguale deifilm, del numero minore di star rispetto a quello che unfestival come Venezia richiederebbe e di grandi anteprimeamericane (eppure per il Lido sono passati negli anni Apollo13, Forrest Gump, Il diavolo veste Prada), si è avuta l’im-pressione di un evento sempre più deserto, che al terzo giornosembrava già finito.
Müller ha provato a trasformare il rospo
in un principe, dando un’idea di festival
troppo internazionale perché potesse
essere recepita dalla politica romana
Certo, c’è la crisi: c’è il fatto che i commercianti del postocontinuano a mantenere prezzi altissimi dando in cambio unaqualità nei servizi molto al di sotto del valore richiesto, oltrealla proverbiale “ospitalità degli abitanti del posto”. Ma c’èanche un evento che ha meno attenzione da parte della stampainternazionale, dove si vedono meno studenti universitari ecinefili, dove quest’anno non c’erano file né per entrare insala né per andare a prendere il caffè. Inoltre c’è da qualcheanno quel buco enorme davanti al Casinò, costato chissàquante migliaia di euro, che sembra Ground Zero a NewYork, e la nuova Sala Darsena certamente egregiamente ram-modernata, ma in cui nelle prime file si sta col naso sotto loschermo e dove, quando si entra le prime volte, sembra di an-dare a far la spesa all’Ikea. Venezia soffre del fatto che non cisia un mercato. Toronto e Telluride hanno preso sempre piùspazio e importanza e molti attesi film statunitensi voglionoandare lì. Ma non si può affrontare il problema girandosi dal-l’altra parte e dire “Qui c’è più qualità e ricerca”.A Roma invece il caso del posto è emblematico. L’Auditoriumè un posto infelice per il cinema. Sarà l’Eden per gli amantidella musica classica, sarà piacevole per il pubblico romano:
ma per gli addetti ai lavori è un luogo soffocante, una speciedi lager, con foto appese del grande cinema italiano chesembra un museo delle cere. Quel posto è stato progettato daRenzo Piano per la musica, non per il cinema. Berlino ha ilcuore del festival collegato a Postdamer Platz, a Torino sisvolge in centro. Il legame col territorio è fondamentale.Roma non ce l’ha. Lo sapeva pure Marco Müller, che haprovato senza successo a decentrarlo. Del resto l’evento èstato partorito male. Veltroni ha creato una specie di mostrodel quale nessuno aveva bisogno, dandogli quell’aria fintamentepopolare ma altamente radical chic (“Roma non è soltanto lacittà de La dolce vita, ma è anche la città di Caro diario”,soleva ripetere l’ex-sindaco della Capitale). Che nel corsodegli anni è stato chiamato festa, poi Gian Luigi Rondi l’havoluto trasformare in un festival scegliendo però gran partedei film del concorso facendo la spesa al Festival di Toronto,poi è ritornato festa malgrado Marco Müller abbia provato atrasformare il rospo in un principe e dando un’idea di unfestival troppo internazionale perché potesse essere recepitadalla politica romana. Che ha subito messo le mani sull’eventoe ha creato il pericoloso precedente in cui sono state spessodelegittimate le scelte artistiche per usare il cinema come pas-serella elettorale.Del resto il cinema in Italia è sempre più in crisi. Il problemanon è il pubblico, ma è come viene recepito, inquadrato e con-siderato rispetto alle altre arti. Il ministro Franceschini, inun’intervista del 3 luglio scorso, ha ridisegnato a modo suo,con invidiabile abilità, le coordinate storiche del cinemaitaliano parlando di una possibile apertura di un museo del ci-nema a Roma: “In Italia - ha sottolineato - abbiamo un bellis-simo museo del cinema a Torino ma è un museo che parla delcinema di tutto il mondo, dai fratelli Lumière a oggi. Credo cisia invece bisogno di un luogo attrattivo anche per i giovani,in cui si racconta la meravigliosa storia del cinema italiano. Eun museo nazionale del cinema italiano non può che essere aCinecittà, luogo dove il nostro cinema è nato”. Peccato checon questa affermazione ha di colpo annullato l’epoca delmuto e il grande kolossal Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone,che aveva influenzato anche David Wark Griffith. OppurePaolo Baratta, Presidente della Biennale, in occasione dellacerimonia di premiazione del 71° Festival di Venezia ha dettoche uno dei Leoni d’oro alla carriera è andato a una “grandesceneggiatrice”. Si, Thelma Schoonmaker è una delle storichecollaboratrici di Martin Scorsese. Peccato che sia una monta-trice. Se dall’alto il cinema viene guardato così, c’è poco dastare allegri.
/ / 61 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / saggi e dibattiti

LIBRERIA INDIRIZZO CITTA’Edicola Gardini snc Via Rizzoli, 1 bis Bologna
Libreria Succa Via Grazia Deledda, 34 Cagliari
Libreria Manzoni Via Manzoni 81/83 Campobasso
Libreria Guida Via Caduti sul lavoro, 41/43 Caserta
Nuova Libreria Bonaccorso srl Via Etnea 20/22 Catania
Libreria De Luca Via A. Herio, 21 Chieti
Edicola Iervese Piazzale Marconi (Stazione FS) Chieti Scalo
La Libreria di Margherita Via Rubino, 42 Formia
Libreria Mondo Operaio Piazza Garibaldi 8 Massa Carrara
Libreria dell’Arco Via D. Ridola, 37 Matera
Libreria Idealbook Via Epomeo, 108 Napoli
Libreria Scarlatti Via Alessandro Scarlatti, 36 Napoli
Libreria Portinaio Via Duca Verdura 4/C Palermo
Edicolasab Contrada Gallitello (area Stazione) Potenza
Libreria all’Arco via Emilia Santo Stefano, 3 Reggio Emilia
Cartolibreria Ponte Sisto Via delle Zoccolette, 25 Roma
Fanucci Piazza Madama, 8 Roma
Edicola De Angelis Piazza della Minerva Roma
Edicola Eredi Sommariva Piazzale di Ponte Milvio, 45 Roma
Libreria Tergeste Piazza Tommaseo, 3 Trieste
Libreria San Marco Via Gaetano Donizetti, 3/a Trieste
Libreria Cueu Piazza Rinascimento, 4 Urbino
Libreria Galla 1880 Corso Palladio, 11 Vicenza
La Rivisteria Via S. Vigilio, 23 Trento
Acquista la rivista in libreria e in edicola

L’edizione postuma dei diari di Antonio Maccanico relativial settennato di Sandro Pertini al Quirinale è stata curata
da Paolo Soddu (contemporaneista a Torino, autore di unabiografia di Ugo La Malfa), e prefati da Eugenio Scalfari, delquale Il Mulino (che li edita) sceglie un breve brano comecifra interpretativa complessiva che appare nel retro di coper-tina: “Non era facile guidare un uomo come Pertini, specie daquando aveva assunto la più alta carica dello Stato, e non erafacile proteggerlo dal suo carattere, dalle decisioni che prendevapiù col cuore che con la sua testa e che attuava immediatamente.Ma Tonino ci riuscì dedicandogli tutto se stesso”1.Seicento pagine ripropongono anni crucialissimi della storiadell’Italia repubblicana. Anni con le radici affondate in tutto ilsecolo, con il disvelamento – ovvio per gli addetti ai lavori,meno per l’opinione pubblica – dei pochi e riservati luoghi incui tutta la classe dirigente italiana, ancora nel pieno della suaprioritaria articolazione nel pluralismo dei partiti, convergenella quotidianità, converge nelle verità, converge nelle fragilità,converge nelle vanità: ma è ancora dedita ad un progetto com-plessivo di evoluzione della incompiuta democrazia italiana,confrontandosi con la chance (che la presidenza Pertini offre)di ricucire lo strappo ormai grave tra istituzioni e cittadini e ditrasformare l’abisso degli anni segnati dal terrorismo in unaopportunità di riscatto e di orgoglio nazionale. Dunque gli anni che vanno dal caso Moro al caso Craxi, cioèdall’esplosione del progetto di unità nazionale causata dall’as-sassinio del leader della Dc (e probabile prossimo presidentedella Repubblica) al rilancio della competizione politica e ideo-logica della regola democratica. Un rilancio gestito soprattuttodai socialisti (dopo e solo per alcuni versi anche in continuità ri-spetto al governo Spadolini), con cui essi vogliono dimostrare lapraticabilità di un disegno di alternativa politica all’egemonia de-mocristiana e di alternativa ideologica all’egemonia dei comunisti. Questi anni fanno i conti con il carattere impulsivo di uno deipochi eroi nazionali di cui il paese dispone (per la sua storia
pregressa e per la sua connotazione adamantina) per costruireuna nuova simbolica istituzionale. Una figura che appartienea profili precedenti rispetto a quelli della classe politica inazione, e che secondo la diaristica del segretario generale delQuirinale è disegnata in un fluire di decisioni utili alla causanazionale grazie soprattutto al raffreddamento esercitato ealla tessitura praticata proprio da lui, che appartiene ad unacultura prossima ma diversa rispetto alla battaglia tripolare diquegli anni tra socialisti, comunisti e democristiani.
Abituati a vedere il protagonismo dei
politici, qui ci si imbatte nel protagonismo
dell'alta struttura amministrativa
È la cultura laico-democratica di un repubblicano lamalfiano:sensibile alla componente politica meridionale con attenzioneviva alla Campania (lui di Avellino come De Mita e conNapoli al centro della sua sensibilità); connesso alla tradizionelaica della finanza italiana espressa da Mediobanca e radicataa Milano (nipote di Adolfo Tino e poi, in anni successivi, luistesso presidente di Mediobanca); in dialogo diretto con ilgruppo dirigente comunista; caso mai prudente con il nuovocorso socialista, ma con la capacità di praticare scambi di pro-fondità con alcune figure chiave di quel corso (a cominciare daGiuliano Amato e da Gianni De Michelis, ma per le cose di go-verno anche Gennaro Acquaviva e per la relazione storica conla componente parlamentare socialista anche Nello Mariani). Una esperienza maturata nel cuore della democrazia parla-mentare (cioè Montecitorio, di cui è per anni segretario gene-rale) e una relazione attenta e prioritaria alle sensibilità diBankitalia (che lo porteranno poi negli anni successivi adessere – divenuto parlamentare a sua volta e impegnato nellapolitica in prima persona e più volte ministro – il più strettocollaboratore di Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Chigi). AMaccanico il presidente dà del lei chiamandolo Tonino: ne ri-spetta la competenza ma non disdegna anche frequenti frizionidi carattere nel trattamento dell’agenda quotidiana.A tutta prima colpisce il carattere dei diari, che la sintesi di
/ / 63 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini
>>>> maccanico e pertini
Simboli e potere>>>> Stefano Rolando
Acquista la rivista in libreria e in edicola
1 A. MACCANICO, Con Pertini al Quirinale. Diari 1978-1985, a cura diP. Soddu, Il Mulino, 2014.

Scalfari già chiarisce (“guidare un uomo come Pertini”). Sequesta è l’ottica della storia di quella lunga vicenda, in quelguidare sta una questione da discutere. Il diario – essendo trasfe-rimento quotidiano di una montagna di relazioni vissute perso-nalmente da Maccanico – mette al centro lui stesso, più che ilpresidente (la cui sfera privata, per esempio, è pressoché assentenelle pagine). Così che – abituati a vedere il protagonismo deipolitici (quello soprattutto consacrato dai media) – qui ci siimbatte nel protagonismo dell’alta struttura amministrativa (cheassume carattere di garanzia tanto per l’amministrazione delloStato che per la politica). La bussola del segretario generalenasce dall’avvertimento, dichiarato nei diari, di forti scricchiolii
della “prima Repubblica” (ma allora tout court “la Repubblica”),considerando come prima responsabilità quella di bilanciare“l’improvvisazione” della politica. Tema che, si comprenderà,giunge fino ad oggi. C’è naturalmente molta Roma, e c’è soprattutto lo Statocome teatro della quotidianità, poche amministrazioni terri-toriali (nel senso di Regioni e Comuni), ma in fondo moltaItalia. Secondo un costume politico italiano diffuso c’è pocaEuropa, e il mondo entra in scena più nel rilievo del cerimonialeche obbliga ad eventi quotidiani che come soggetto dirimentedella politica che pesa – e anche in quegli anni pesò fortemente– sulla politica italiana. L’apparato produttivo e connesso al
/ / 64 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini

mondo del lavoro è pure attore secondario, salvo alcuni suoirappresentanti (gli Agnelli, De Benedetti, Lama) che svolgonocostantemente un ruolo nelle relazioni istituzionali.Le grandi dorsali del settennato di Pertini (il ruolo della memoria,la democrazia pluralista, l’ammirazione per il coraggio nella mi-litanza, il rispetto per il prezzo pagato dai comunisti nell’antifa-scismo, l’attivazione dell’alternativa laica e socialista alla guidadel governo, l’orgoglio italiano in Europa e nel mondo, la causadella pace) appaiono frutto delle priorità che lo stesso Pertiniesprime a partire dalla sua storia personale e dal suo modo diavere rapporti (ruvidi, spesso insofferenti, magari non facili, conmolti accenti di permalosità) con la classe politica del tempo.Maccanico è qui un eccellente adattatore, un alto gestore dellecompatibilità: come lo sono stati Giuliano Amato con Craxi,Gianni Letta con Berlusconi, Riccardo Misasi con De Mita, ecome – verrebbe da dire – Giorgio Napolitano non ha voluto cheavvenisse nel suo doppio mandato al Quirinale. Ma appunto ilprotagonismo oggettivo rappresentato dal segretario generale –che vede, ascolta, parla, propone, accoglie, dispone, insegue, ag-giusta, regola, misura – tende talvolta a confinare quelle prioritàdi intuizioni e di indirizzo in una sorta di scenario generale resopossibile soprattutto a partire dalle condizioni di adattamento.
Declinando il peso qualitativo della politica
italiana il Colle assume il ruolo di equilibratore
generale del sistema
Forse se l’edizione dei diari fosse avvenuta con Antonio Mac-canico ancora vivo – e quindi capace di levigare un prodottodestinato al pubblico e non solo alla sua memoria di ufficio –questo tratto avrebbe potuto subire a sua volta qualche “adatta-mento”, pur dicendoci il curatore che il lavoro di edizione, av-viato su stimolo di Marina Maccanico, ebbe la sua inizialeadesione (e anche sue “preziose indicazioni”). Il curatore con-ferma di essere intervenuto marginalmente sui contenuti, la-sciando un impianto di scrittura che conferma il carattere di unuomo libero, pur ponendoci talvolta domande. Nella non revi-sione globale da parte dell’autore ci stanno quindi nella lorooriginalità anche i giudizi critici di Maccanico che toccanoalcuni aspetti impulsivi del presidente (uno tra tutti sul com-portamento alla morte di Berlinguer, in cui “Pertini ha strafatto”). Un secondo spunto riguarda il rilievo – nei diari – del governoCraxi, che occupa tanto l’avvio di quell’esperienza governativaquanto l’ultimo triennio della presidenza Pertini. Il diario è lariprova della condizione accerchiata di quel governo (conGiorgio La Malfa più attivo dei comunisti e forse anche dei
demitiani nell’iniziativa demolitoria), e quindi della doppiaenergia necessaria da parte del governo per realizzare i suoiobiettivi esterni (e internazionali), dovendo negoziare un con-senso parlamentare dipendente da altri, un consenso di sistemacon pochi mediatori favorevoli, un consenso mediatico cheanche in questo diario si comprende essere fragilissimo. Alla fine chi “tiene” è proprio il presidente: con tutta la suapermalosità e tutta la sua ambivalenza nel rapporto personalecon il leader, cioè con Craxi (pur sempre figlio di VittorioCraxi dallo stesso Pertini nominato prefetto della Liberazionea Como). E qui – a ben vedere – pur con le sue relazioni conambienti velenosi per Craxi e per quella fase di governo,Maccanico si rivela un “adattatore” con forte lealtà istituzionale.Forse coltivando il suo sogno politico, cioè quello della for-mazione di un blocco laico-socialista capace di raggiungerein quella fase storica un quarto dei consensi degli italiani ge-nerando una garanzia di continuità rispetto ai caratteri fragilidella prima Repubblica, sogno che Craxi non coltivò pensandodi poter da solo raggiungere un livello di “garanzia” nel con-senso dell’elettorato (per usare le espressioni che lo stessoMaccanico usò nel colloquio che ebbi con lui in occasionedei 150 anni dell’unità d’Italia2). Un terzo spunto riguarda il Quirinale. Con la fine degli anni’70 esso assume un rilievo sostanziale nella regolazione dellavita politica italiana che non dismetterà negli anni successivi.Si dibatte se ciò sia conforme o dilatatorio rispetto al profilocostituzionale. Ma il dato è che declinando il peso qualitativodella politica italiana – ovvero dei partiti e delle loro assunzionidi responsabilità nei vari gradi dell’ordinamento – il Colleassume il ruolo di equilibratore generale del sistema. Per dueragioni connesse: perché legittimatore e perché connotato dauna cifra di credibilità per l’opinione pubblica più alta diquella dei partiti e dei politici. Questo ruolo si esprime (neltesto di Maccanico) da un lato con i caratteri personali delpresidente che reggono alla prova della credibilità (lo fu alta-mente per Pertini, lo sarà anche in seguito soprattutto conCiampi e Napolitano); ma si esprime anche con quella piùsilenziosa manovra di tessitura del potere (esteso a tantecose, nomine, sostegni, censure, proposte) che è il ”plot”centrale della storia narrata con la penna delle “noterelle”(quella usata anche da Andreotti) con cui Antonio Maccanicoscrive questi diari. Qui c’è qualche disvelamento, propriosulle modalità di esercizio del potere in democrazia, su cui ildibattito resterebbe utilmente aperto anche per l’oggi.
/ / 65 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini
2 Mondoperaio n.1 / 2011.

Piero Craveri, nell’introdurre l’ottavo volume della collana“Gli anni di Craxi”, dedicato al “decisionismo” craxiano,
ha voluto sottolineare il grave ritardo che caratterizza gli studidi storia sulla Repubblica italiana “nel cogliere quanto è dav-vero successo in questi ultimi settant’anni”: nel ricercare cioèle ragioni per cui “l’Italia, avendo raggiunto la soglia didiventare un paese a vocazione industriale, è stata lentamenteriassorbita in una palude di rapporti sociali e politici premo-derni”. Craveri aggiunge che ciò che maggiormente ostacolauna ricerca storica approfondita su questo punto cruciale nonsono le posizioni, tuttora apparentemente prevalenti, dellapolitica, ma l’insieme delle “ragioni istituzionali e burocrati-che, sociali ed economiche che formavano, e tuttora formano,il resistente amalgama della società italiana e che allora (altempo di Craxi, ndr) risultarono insormontabili”1.In questa sottolineatura che Craveri ci offre rispetto allavicenda craxiana nella crisi della prima Repubblica risiede, amio parere, l’utilità grande del volume pubblicato qualchemese fa dal Mulino2 che contiene le pagine del diario cheAntonio Maccanico ha appuntato per molti degli oltre due-mila giorni in cui fu a fianco del Presidente della RepubblicaPertini quale Segretario generale del Quirinale, tra la fine del1978 e la metà del 1985. Giorni spesso duri, ed anche duris-simi, comunque sempre complicati e assai poco agevoli nellavita dell’Italia e della sua politica. Ma anche giorni di grandesperanza e di forte e positiva volontà di cambiamento.Contributi di questo livello ed utilità non se ne trovano moltinella più recente storiografia dedicata al nostro paese: ha benragione Craveri. Se si esclude il diario pubblicato da Giu-seppe Sangiorgi quasi dieci anni fa3, un ricordo sostanzial-
mente veritiero di quello che vide colui che era all’epoca ilcapo ufficio stampa di De Mita, e che copre il tempo dall’av-vio della segreteria (1982) alla presidenza del Consiglio(1989), non c’è molto altro da segnalare, oltre ai due volumidi memorie di Gerardo Bianco ed all’ultimo libro scritto daLelio Lagorio, anch’esso del 2005. Per questa ragione, fra l’altro, l’approfondita “confessionecollettiva” che abbiamo potuto costruire alla FondazioneSocialismo tra il 2011 ed il 2012 utilizzando la memoria e letestimonianze di gran parte del gruppo dirigente del Psi diCraxi, e che poi siamo riusciti a pubblicare nel 2012 in unimpegnativo volume di quasi mille pagine4, assume unagrande importanza, anche ai fini del confronto tra ragioni isti-tuzionali e burocratiche da un lato e sistema economico-sociale dall’altro rispetto alla necessità di costruire una pro-fonda riforma della politica, modificandone le stesse basi fon-dative realizzate quasi settant’anni prima, dopo la tragediadella doppia guerra italiana del 1943/45. Ed a questo fine,ripeto, il diario di Antonio Maccanico è ancora più utile deitesti che ho citato prima, anche se ai miei occhi ha bisogno diessere integrato da una robusta ricerca critica, soprattutto percontestualizzarne la narrazione e chiarire alcuni passaggidelicati. Ma su questo dirò una parola in conclusione.
Le forze e le idee del rinnovamentopromosse ed espresse allora da Craxi edai socialisti erano condannate in partenza
Il punto di maggiore utilità del diario risiede, a mio parere, nelconcorrere a chiarire l’ampiezza e la consistenza delle “forzeistituzionali e burocratiche” cui ho fatto cenno prima nel lorolavoro di contrasto rispetto a coloro che, partendo prevalente-mente dalla base trasparente della rappresentanza democra-tica ed utilizzando il messaggio riformatore derivato da unarivisitazione critica della loro esperienza storica, all’avviodegli anni ’80 intendevano cambiare seriamente il nostrosistema politico ormai bloccato. Per chi ha potuto condividere
/ / 66 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini
>>>> maccanico e pertini
La resistenza di una élite>>>> Gennaro Acquaviva
1 Decisione e processo politico. La lezione del governo Craxi (1983-1987), a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Marsilio, 2014, pag. 13-14.
2 Con Pertini al Quirinale. I diari di Antonio Maccanico, Il Mulino, 2014.3 G. SANGIORGI, Piazza del Gesù. La Democrazia Cristiana negli anni
Ottanta, Mondadori, 2005.4 Il Crollo. Il Psi nella crisi della prima Repubblica, a cura di G. Acqua-
viva e L. Covatta, Marsilio, 2012.

quotidianamente le conseguenze indotte dalla centralità cra-xiana sui meccanismi della politica del tempo, addirittura neimedesimi giorni in cui Antonio Maccanico trascriveva neldiario accadimenti e pensieri suoi, emerge nettissima unaconstatazione: le forze e le idee del rinnovamento promosseed espresse allora da Craxi e dai socialisti erano condannatein partenza, non avrebbero mai potuto vincere la partita con-clusiva rispetto al “resistente amalgama della società ita-liana”. Torno ad utilizzare questa espressione di Craveri perché essadescrive bene l’azione incessante e determinata che illuminaquotidianamente l’opera di Maccanico, come è testimoniatanelle sue note di diario. Non c’è questione di rilievo, manovrao suggestione politica, azione od esercizio di potere, costru-zione, mediazione o rottura di relazioni e di rapporti tra sog-getti politici, burocratici o istituzioni che sfugga al suo occhioavvertito e prontissimo, traducendosi in capacità di gestione edi governo. E nello svolgere questa funzione centrale nelsistema (spessissimo in solitudine), nel collocarsi con imme-diatezza al centro della trama cangiante ed a volte imprevedi-bile della politica e del potere, quasi diventandone l’indispen-sabile e decisivo punto di raccordo, Maccanico dimostra diessere in grado di indirizzare con forza questo suo potere,effettivo e personale, verso un obiettivo costante che, pur seaccetta o subisce variabili, non gli fa mai cambiare la dire-zione di marcia. La sua finalità è innanzitutto quella di bloccare qualsiasi bar-
lume di rinnovamento non controllato, depotenziare ogniforma di aggregazione di interessi coerenti al nuovo, promuo-vere e comunque difendere le forze che garantiscono su ogniversante innanzitutto la stabilità del suo mondo di riferi-mento: che è soprattutto quello dedicato alla conservazionedegli equilibri e dei poteri di fatto esistenti, assunti e fatti pro-pri in toto dall’allora Segretario generale del Quirinale. Questo suo atteggiamento costante emerge in particolare neirapporti con persone ed ambienti della politica che Macca-nico costruisce o utilizza per realizzare il suo disegno stabi-lizzatore e conservativo, diffusamente ricordati e presenti inmolte pagine del diario. Ne faccio una sintesi sommaria.Innanzitutto il suo referente “familiare”, il Partito repubbli-cano, utilizzato spesso come strumento o schermo per opera-zioni di “scambio”, o di copertura o anche di mera verifica oinformazione; in secondo luogo il suo referente principale,obbligatorio e inevitabile, la Dc in quanto “Partito-Stato”:blandito (Andreotti), temuto (il Preambolo), favorito e pro-tetto anche perché ritenuto senza nerbo ma utilizzabile (DeMita); in terzo luogo, e soprattutto, la sua vera “casa” politica,quella dove risiede il suo cuore, un mondo che egli realistica-mente considera politicamente impotente e che quindi puòessere più facilmente orientato dalla sua azione, il Pci di Ber-linguer: amato, consigliato, sostenuto, promosso in ognimodo. Ed infine il suo nemico più vero e pericoloso, perché,pur se minoritario, è il più bravo di tutti: un soggetto che perdi più dimostra di essere autonomo quanto basta per provarea cambiare sul serio l’Italia anche da solo, il Psi di Craxi.
Per Maccanico il tavolo della politica va
monitorato costantemente e mai lasciato
solo, perchè occorre che sia ben indirizzato
Per Maccanico questo tavolo della politica, che allora eraancora incentrato nel sinedrio della “Repubblica dei partiti”,va monitorato costantemente e mai lasciato solo: perchèoccorre che sia ben indirizzato, ma soprattutto reso neutro eininfluente rispetto ai referenti, altolocati e sovradimensio-nati, che sono la sua “stella” ben fissa e immutabile: quellache per Maccanico è l’Italia vera, quella che egli vuol preser-vare e potenziare costantemente perché è il suo mondo. Gliuomini della finanza, innanzitutto; poi i rappresentanti di unacerta cultura accademica (ma ben selezionati); infine, esoprattutto, il nerbo del ceto burocratico romanocentrico, insimbiosi con i vertici di una magistratura pur sempre amica e
/ / 67 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini

rispettosa ma da tenere comunque sotto controllo costante.Strumento principe - per agire, mediare, influenzare, minac-ciare - è la stampa amica e vicina: soprattutto La Repubblica,il rampante e spregiudicato strumento politico che Scalfari haormai messo a punto, giunto ad una simbiosi di utilità reci-proca con i numeri dei comunisti proprio in concomitanzacon gli anni di Pertini al Quirinale, e che Maccanico utilizzalargamente, anche se la spregiudicatezza e i frequenti colpi diteatro del Direttore (ed il suo rapporto “fiduciario” con il Pre-sidente) lo tengono costantemente sul chi vive.C’è infine il punto decisivo, non sempre controllabile e collo-
cabile in questa ragnatela del potere disegnata e attivata dalSegretario generale del Quirinale, ma inevitabilmente al cen-tro del racconto quotidiano di Maccanico: c’è, fisicamente, lostesso Presidente della Repubblica, il socialista Sandro Per-tini, con i suoi umori, gli infiniti colpi di testa, il rischio con-tinuo di gaffe mondiali, la voglia debordante di protagoni-smo. Senza di lui o contro di lui la ragnatela rischia di risul-tare impotente o peggio di lacerarsi; è quindi necessario chela grande popolarità che si è indirizzata verso il Presidente sulfinire degli anni ’70, anche utilizzando abilmente il suo tantospesso costruito anticonformismo, possa essere messa a servi-
/ / 68 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini
>>> L’esempio di Schröder. In diecianni la disoccupazione in Germania èscesa dal 12% al 6,7%. Una buona com-petitività ha favorito le esportazioniconsolidando il bilancio statale. Se peròuno guarda con maggiore attenzionescopre che c'è un risvolto negativo. Peresempio, nello stesso periodo la crescitafrancese è stata superiore a quella tede-sca, ed i molti impieghi che la Germaniaha saputo creare sono tuttavia di tipoprecario. I salari reali sono scesi per il16% della popolazione, con gravi pro-blemi di ineguaglianza. Così si esprimeMarcel Fratzscher, autore di un librointitolato Die Deutschland-Illusion(Hanser, 2014), presidente del Diw(Deutsches Institute für Wirtschaftsfor-schung), con un lungo passato presso laBce e attualmente consigliere del socia-lista Sigmar Gabriel, vice cancelliere eministro dell'economia e dell'energianel governo Merkel.Le sue dichiarazioni sono state raccolte daOdile Benyahia-Kouider per il NouvelObservateur. Qualcuno, continua Fratz-scher, dice che la forte diminuzione demo-grafica causerà grossi problemi all'econo-mia tedesca nei prossimi cinque o diecianni e la crescita economica potrebbequindi diminuire: ma ciò non vuol direnecessariamente un abbassamento dellaprosperità. Ciò che preoccupa Fratzscher èla constatazione che la causa prima delladebolezza sarà data dalla mancanza di
investimenti sia pubblici che privati. Biso-gnerebbe investire almeno dieci miliardi dieuro ogni anno nelle infrastrutture, e que-sto solamente per mantenerle in funzione,non per crearne di nuove. Si è però affer-mata l'dea che bisogna risparmiare e limi-tare le spese. Anche in città che hannoeccedenza di bilancio si preferisce tenere isoldi in cassa. Lo Stato federale, chepotrebbe aiutare i comuni su obiettivi pre-cisi, preferisce utilizzare quei fondi perobiettivi meno produttivi. E’ importanteridurre i debiti, ma, afferma Fratzscher,bisognerebbe farlo quando l'economia è infase di crescita. Se però consideriamo chedal 2008 l'economia tedesca è cresciuta aun tasso dello 0,6% o 0,7%, vuol dire chec'è una situazione di quasi stagnazione. E itedeschi si comportano come se tuttoandasse bene.Nel 2000, con l'unificazione, c'era in Ger-mania molta sfiducia: essa era il malatod'Europa, un paese poco dinamico, cheperò ha iniziato a fare delle riforme, si èconvinto che poteva farcela ed è divenutoil paese più stabile della zona euro. Ma l'ec-cesso di fiducia, sostiene Fratzscher, ci haresi arroganti e ciechi. In realtà la Germaniaha massicciamente utilizzato l'Europa fra il2003 e il 2008. Se ha potuto raddrizzarsi èstato certo grazie alle riforme, ma ancheperché la maggior parte delle sue esporta-zioni andavano verso gli altri paesi dellazona euro, che all'epoca avevano migliorisituazioni economiche. Oggi però avviene il
contrario. La crescita economica tedesca,migliore rispetto a quella degli altri paesieuropei, dovrebbe creare una dinamicapositiva per l'insieme di questi paesi. I tede-schi devono convincersi che stiamo tutti sulmedesimo battello. Il piano Junckerpotrebbe anche avere degli effetti positivi:ma è indispensabile che il governo tedescoporti il proprio mattone per la edificazionedell'edificio.Quanto alla Francia, sembra quasi che cisiano oggi gli stessi problemi che unaquindicina d'anni fa c'erano per la Ger-mania. Oggi Hollande si trova come ilgoverno rosso-verde tedesco di allora:con le spalle al muro. Il governo del socia-lista Schröder ne uscì facendo delleriforme drastiche e coraggiose. Hollande èdi fronte ad una scelta: non fare niente ofare una politica dei piccoli passi e per-derà le prossime elezioni; oppure faredelle riforme in grado di rimettere l'eco-nomia sul giusto binario e allora potrebbeanche vincere nel 2017. Come allora isocialisti tedeschi costrinsero politici esindacati a cambiare mentalità, anche inFrancia occorrerà sacrificare qualche sim-bolo (per esempio le 35 ore), per otteneregli stessi risultati. La credibilità si ottieneattraverso grandi riforme ben visibili e talida cambiare la mentalità comune. Questoè quanto pensa un economista impor-tante come Fratzscher per la Francia: anessuno viene in mente altro? (MatteoMonaco, mondoperaio.net, gennaio 2015)

zio del superiore disegno costruito dall’èlite “illuminata” rap-presentata da Antonio Maccanico, che ormai circonda e blan-disce in ogni modo anche il buon Sandro perchè ha scelto diutilizzarlo spregiudicatamente proprio facendo forza sulnascosto ed inespresso conformismo del Presidente.Perché è avvenuto tutto ciò? Perché un’élite altolocata e dibuona cultura – pur se espressione di un ceto burocratico diprevalente tradizione casalinga – è stata in grado di giocare unruolo di tale importanza nel condizionare il cambiamento e lariforma politica di un grande paese? Chi ha potuto prestareattenzione al lavoro di approfondimento storico-politico cheMondoperaio (con la costanza dei suoi contributi mensili) e laFondazione Socialismo (con la sua elaborazione storica tra-sfusa nei volumi pubblicati nella collana “Gli anni di Craxi”)hanno realizzato in questi ultimi anni ha già una risposta soli-damente fondata. Quello che qui posso aggiungere è ricordare che quella grandeélite burocratica (così vicina anche alla storia personale diTonino Maccanico) che trovò espressione negli anni ’30 e ’40nel gruppo Beneduce e soprattutto nella sua florida “figlio-lanza” – un gruppo ed una tradizione che è arrivata fino a noi,perché arriva fino a Guido Carli – fu decisiva nella ricostru-zione economica, ma anche politica, del nostro paese: perchéebbe l’opportunità (e la fortuna) di avere di fronte a sé, prontia collaborare ma anche a dirigere e a comandare, uomini poli-
tici, partiti, e un vero sistema rappresentativo: De Gasperi edEinaudi, la Dc ed il migliore liberalismo, gli eredi dell’azioni-smo filo-occidentale come il socialismo democratico.
Gli anni ’80 sono per l’Italia l’ultima finestra
possibile per riprendere il filo di questo
destino originario
Questa saggia dirigenza politica del dopoguerra si era esauritain una lunga stagione di governo, pur positiva, ma ormai,negli anni di Maccanico, arrivata al capolinea: senza ricam-bio, perché aveva come inaridito l’idealità originaria e le fonticulturali di alto livello da cui era partita; senza innovazione,perché aveva perso molte delle esperienze comunitarie diforte insediamento sociale e le multiformi reti solidaristichedi uomini e donne che era stata in grado di esprimere. Gli anni’80 sono storicamente, per l’Italia, l’ultima finestra possibileper riprendere il filo di questo destino originario. E Craxi edi nuovi socialisti – un mondo minoritario ma trasversale edanche innovativo, capace di attrarre e vivere il nuovo – rap-presentano l’ultima occasione che viene offerta all’Italia permettere insieme il progresso ormai costruito con un sistema ingrado di governarlo e forse anche di stabilizzarlo. Il mondo di Antonio Maccanico, la realtà di potere e di forzacondizionante così vividamente rappresentata nelle pagine
/ / 69 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini

del suo diario, si oppone a questo disegno, cerca di contra-stare in mille modi il suo ordinato e positivo dispiegarsi,aiuta fortemente quelli che lo vogliono demonizzare, bana-lizzare, sporcare. Questa realtà per di più non ha un disegnoalternativo, ma si abbarbica e cerca di rafforzarsi alleandosicon chi si oppone per disperazione, con chi non vuole o nonpuò cambiare: in primis i comunisti, ormai giunti alla vigiliadel funerale.Le conseguenze di questa azione deleteria le abbiamo tuttiben viste e constatate in questi lunghi trent’anni che ci sepa-rano da quel racconto. Non solo la regressione dello sviluppoe l’allontanamento dalla progressione virtuosa del lavoro edella produzione: ma soprattutto l’immiserimento umano espirituale, l’abbassamento delle virtù civiche e la crescitaesponenziale dell’antipolitica, anticamera tra le maggiori diquella mancanza di speranza nel futuro che è il vero cancrodell’Italia di oggi.Avendolo conosciuto abbastanza bene non ho dubbi sul fattoche Antonio Maccanico non avrebbe desiderato questo infau-sto destino per il proprio paese, che al contrario avrebbevoluto prospero, ordinato e giusto al suo interno, e rispettatodi fronte al mondo intero. Ma questa testimonianza della suavicenda umana che la sorte ci ha consegnato dimostra esau-rientemente che il contrasto e l’opposizione – spesso sotterra-
nea e comunque costantemente praticata – che il suo mondoe lui medesimo espressero nei confronti di coloro che vole-vano superare il blocco del sistema politico, riformandolo edaggiornandolo, contribuirono probabilmente in maniera deci-siva a sconfiggere i riformatori e a far precipitare nel nullismola tradizione politica che si era affermata nel dopoguerra, eche era anche la sua.Un’ultima considerazione. Mi sento di dedicarla a chi lavo-rerà, da storico di professione, su queste carte. Esse vannocontestualizzate ed anche attentamente verificate, ricercandotestimonianze e procedendo ad incroci interpretativi. Possoaccennare a due punti in particolare, di cui ho diretta cono-scenza, che secondo me abbisognano di questo trattamento. Ilprimo è quello della vicenda della P2: delle liste, dei docu-menti, delle azioni propriamente svolte da Maccanico, in pro-prio o per esplicito incarico di Pertini. Su questo c’è sicura-mente da scavare, e troverò modo di scrivere qualcosa iostesso. Il secondo è il “caso” De Michelis - Scalzone, su cui ebbiallora parte direttamente, come ricorda anche Maccaniconel diario. Nel merito ne ho già scritto5. Mi preme peròsottolineare che queste pagine del diario (pag. 509 eseguenti) dimostrano senza ombra di dubbio che la suastesura finale è stata puntigliosamente ricostruita a poste-riori con un’attenzione precisa alle possibili reazioni deiprotagonisti allora in vita: uno spunto che mi fa dubitarenon poco anche dell’autenticità di altre affermazioni con-tenute nel diario.
/ / 70 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / maccanico e pertini
5 Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M.Gervasoni, Marsilio, 2011, pag. 291-294.

Nel momento di avviare questa rubrica di memorie, che hal’ambizione di far rivivere personaggi dimenticati e di dare
un rappresentazione reale di un passato che oggi appare mitico odeplorevole, mi sembra opportuno ricordare le singolari circostanzeche mi spianarono la via per una onorevole carriera di giornalistapolitico. Non sarà inutile il raffronto che ognuno potrà fare tra lavita politica di un tempo e i giorni magri che oggi viviamo.Parlo dei primissimi anni Cinquanta, il primo o il secondo delladecina, quando ancora governava De Gasperi con Saragat. OronzoReale e Villabruna. Era in corso a Montecitorio un verifica di go-verno. Il quadripartito di De Gasperi non era un’oasi felice. DeGasperi si ostinava nell’alleanza con i partiti laici (socialdemo-cratici, repubblicani, liberali) per avere un argine alle pretesedella Chiesa: ma la sinistra del suo partito, con Dossetti e Fanfani,scalpitava per giungere a un governo di soli cattolici. Le verificheerano all’ordine del giorno.Dall’alto della tribuna stampa osservavo l’aula. Proprio sotto dime Giuseppe Dossetti armeggiava con la matita su un fogliobianco. Incuriosito lo seguii. Dossetti disegnava curve in tondo,linee flessuose, semicerchi. Ma che faceva? Non mi parevapossibile, ma ormai non mi potevo sbagliare: Dossetti stavaproprio disegnando un water, uno sciacquone, l’attrezzo principefra gli attrezzi igienici. Poi d’improvviso capii tutto. Dossettiaveva capovolto il foglio e scritto sopra, a stampatello: GABI-NETTO ROVESCIATO.Corsi al mio giornale, l’Avanti!, e scrissi un corsivo di primapagina dal titolo inequivocabile: “Prova generale del governomonocolore”. Il testo era semplice: mentre i vari La Malfa, Vi-gorelli, Reale, Martino, Sforza fanno professione di fedeatlantica per guadagnarsi i galloni da ministro (le verifiche sichiudevano sempre con un voto di fiducia sul Patto Atlantico,linea discriminante tra governo e opposizione), i veri detentoridel potere nella Dc si preparano a mandarli a casa.Al mattino dopo, entrando a Montecitorio, i colleghi mi venneroincontro tutti eccitati. Ma che hai fatto? Hai combinato un casino!
Il governo è a pezzi! L’effetto del corsivo era stato dirompente.Saragat aveva dato le dimissioni, La Malfa urlava nel Transatlanticoche non avrebbe più messo piede al governo, De Gasperi si erachiuso nello studio riservato e non riceveva nessuno. Ci volle piùdi una settimana per arrivare a un chiarimento: ma per me le cosecambiarono subito. Al pomeriggio, in redazione, fui chiamatodal direttore, che allora era Sandro Pertini. Entrai titubante. Pertini non era solo. Erano con lui due perso-naggi che sembravano usciti dalle pagine di un libro di favoleillustrato. Alberto Cianca, il prestigioso direttore de Il Mondoprefascista, la più accreditata rivista liberaldemocratica italiana,sembrava un vecchio travestito da fanciullo: capelli, sopraccigliae baffetti tinti, il viso senza un ruga, ma le mani tremanti e ipiedi divaricati come a cercare un migliore appoggio. All’op-posto, Francesco Fancello, un intellettuale sardo, medico e ro-manziere, che prima di conoscere carcere e confino era statodirettore degli Ospedali riuniti di Roma, sembrava un fanciullotravestito da vecchio: ben portante, totalmente glabro, masegnato dalle rughe e dai capelli bianchi.Cianca e Fancello erano allora direttore e vice-direttore diMilano Sera, un quotidiano che nella città lombarda faceva ilverso al Paese Sera di Roma. Mi riempirono di complimenti,congratulandosi per l’ironia e il fiuto politico; poi Cianca mipropose un bel contratto con il suo giornale. Pertini, che fino aquel momento non sapeva nemmeno che io esistessi, si opposedecisamente: “So io come ricompensarlo”. Difatti, sedutastante, mi affidò l’incarico di corrispondente romano del Lavorodi Genova, anch’esso diretto da lui. Due lavori (fortunatamente simili), due stipendi. Avevo duegiornali sui quali sfogare la mia passione politica, una buonaconsiderazione, una carriera davanti e due stipendi che portaronouna fiammante Topolino C che quando andavo alla direzione delPartito dovevo nascondere a via Vittoria, a via Mario dei Fiori,cioè nei vicoli oltre il Corso: altrimenti mi avrebbero fatto unprocesso. Insomma, la svolta della mia vita: per uno sciacquone.
/ / 71 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / memorie postume
>>>> memorie postume
Gabinetto rovesciato>>>> Franco Gerardi
Prima di lasciarci, nell’aprile scorso, Franco Gerardi lavorava alla redazione di una serie di cammei dedicati ai personaggi conosciuti nella sua lunga carriera di giornalista politico. Da questo numero cominciamo a pubblicarli.

/ / 72 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / memoria
>>>> memoria
Il 5 gennaio si è spento Sergio Ristuccia, figura rara inItalia di intellettuale che dall’interno delle istituzioni sapeva
parlare a un pubblico molto più vasto, e che spendeva la suagrande cultura per progetti di innovazione e di democratizza-zione delle istituzioni. Lui stesso si era definito “un intellettualeche è un professionista generalist, come si direbbe altrove,del mondo istituzionale e amministrativo” (Amministrare egovernare. Governo parlamento amministrazione nella crisidel sistema politico, Officina, 1980, XI). Culturalmente era stato generalist fin dall’inizio, avendocollaborato con Adriano Olivetti dall’età di ventidue anni;e professionalmente lo era diventato attraverso le esperienzedi magistrato della Corte dei conti addetto al controllosugli enti pubblici, di direttore della Fondazione Olivetti,di autore di una gran quantità di scritti sulla finanzapubblica, sulle riforme amministrative, sulla democrazia(comparsi anche su Mondoperaio), nonché di fondatore edirettore dal 1973 di Queste istituzioni, che prosegue daalcuni anni le pubblicazioni online grazie al suo entusiasmoe ai molti giovani che ne sono rimasti contagiati. Esperienze molto varie, come si vede, ma anche frutto discelte di chi preferisce la libertà dell’“osservatore critico”,come pure si definiva, sia alle ansie da cursus honorum ti-piche di tanti suoi colleghi che al culto di altri per l’appar-tenenza partitica. Sergio aveva le capacità del riformatoreintelligente, che abbandonate le declamazioni ideologichecerca la chiave giusta per combinare modernizzazione edemocrazia nella progettazione istituzionale e soprattuttoamministrativa. Non a caso una sua recente opera si intitolaCostruire le istituzioni della democrazia. La lezione diAdriano Olivetti, politico e teorico della politica, Marsilio,2009. Il lascito di Olivetti, a sua volta erede di Carlo Cat-
taneo nella cultura democratica italiana del secolo scorso,era per Sergio motivo di rinnovato impegno in un ambientepolitico e istituzionale solo apparentemente più tranquillodi quello col quale Olivetti aveva dovuto misurarsi. Ora possiamo capire fino a che punto la fine delle guerredi religione in vesti politiche ha fatto riemergere unastruttura sociale profondamente corporativa, che viene dalontano e ostacola tuttora non tanto “le riforme”, quantoogni loro seria attuazione. E come all’epoca della CostituenteOlivetti e Massimo Severo Giannini avevano prospettatol’alternativa di un pluralismo moderno, perché aperto econflittuale, così la scommessa dell’“osservatore critico”Ristuccia consisteva nell’avviare il cantiere delle riformedal lato dei “rami bassi” delle istituzioni, i più vicini allasocietà e al tempo stesso i più impermeabili alle innovazionieffettive: con evidenti saldature, peraltro, con le ipotesiolivettiane. Come quando Ristuccia osserva che la sussidiarietà oriz-zontale riconosciuta in Costituzione dal 2001 “non riguardasoltanto i livelli di governo, ma la capacità delle organiz-zazioni sociali di dare o contribuire a dare risposte allestesse molteplici domande politiche” (Costruire le istituzioni,116); oppure quando nota che la proposta teorica di co-struzione di ordini politici chiamati alla formazione delSenato federale, che era difficilmente accettabile al momentodell’affermarsi dei grandi partiti di massa, oggi “risulteràinaudita nel gran mare di mediocrità della politica” (ivi,118). Questo disincanto non toglie che a Sergio fosserimasto fino all’ultimo il gusto per le iniziative culturali,che ne attesta l’esemplare passione civile. E che i suoilavori restino una miniera di analisi politico-istituzionaliche meritano di venire proseguite.
L’osservatore della democrazia >>>> Cesare Pinelli
Sergio Ristuccia

/ / 73 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
>>>> biblioteca / recensioni
Ambizioso e stimolante è l’ultimo studio di Guido Baglioni,che si presenta con un titolo volutamente e non infon-
datamente “narrativo”: Un racconto del lavoro salariato. Ineffetti si tratta di una lunga cavalcata sull’evoluzione delmondo del lavoro in Italia dai primi anni e dalle speranze deldopoguerra fino alla situazione attuale, con il suo carico di dif-ficoltà e di incertezze. Una cavalcata condotta con vari strumenti,che vanno da quelli utilizzati nelle scienze sociali, ai paradigmimarxisti e alle loro conseguenze, ed ai dettami e alle applicazionidella dottrina sociale della Chiesa: senza disdegnare però la di-mensione autobiografica e l’esperienza diretta, che integra eumanizza questo vasto itinerario (di qui l’allusione al “racconto”). Baglioni, professore emerito di Sociologia presso l’UniversitàBicocca, è più noto come studioso delle relazioni industriali edel fenomeno sindacale, nonché come principale teoricoitaliano della partecipazione dei lavoratori. Per lungo tempoha accompagnato e attraversato le vicende sindacali e in par-ticolare seguito il consolidamento e l’evoluzione della Cisl, dicui è stato, oltre che tra i principali intellettuali di riferimento,anche una figura importante dal punto di vista dell’organizzazionedella cultura e della formazione (da presidente prima delCentro Studi Cisl di Firenze e poi del Cesos, il Centro studinazionale che si occupa di ricerca sociale e sindacale, due trale strutture a lungo più prestigiose del mondo cislino). Ma inquesto caso il sindacato si colloca piuttosto sullo sfondo e avalle della sua analisi, che ruota appunto intorno al lungocammino, dal respiro di quasi settant’anni – e dunque potremmodire pressoché secolare – del lavoro e dei lavoratori nellasocietà italiana. Già qualche anno fa un altro eminente sociologo del lavoro,Aris Accornero, aveva tratteggiato un ritratto del novecento,appunto secondo la sua ricostruzione “il secolo del Lavoro”:con la maiuscola, perché era il secolo che aveva ruotato, condiverse declinazioni, intorno alla “centralità” del lavoro. Ac-cornero, che scriveva a cavallo del nuovo secolo, sottolineavail declino di quel ruolo assorbente. E individuava nuoveinsidie, come la crescente insicurezza legata in special modo
alla diffusione di regimi di impiego temporaneo e precario,insieme però a importanti cambiamenti, come la diffusione –non lineare – di lavori a più alta densità cognitiva. Baglioni va oltre, in quanto si spinge fino a decrittare letendenze in atto nelle contemporanee economie globali, chehanno eroso anche alcuni dei caratteri portanti dei capitalismi‘renani’: quelli che, a partire dalla Germania, sono statiplasmati dalle socialdemocrazie (ma non solo), e sono statipiù orientati verso una conciliazione dinamica tra le ragionidelle imprese e quelle della protezione sociale del lavoro.L’erosione di quei capitalismi, socialmente più avanzati, portacon sé nella fase attuale un ridimensionamento delle posizioniche il lavoro aveva saputo accumulare in passato. Nel confronto con Accornero potremmo dire che Baglioni èpiù ottimista (ma anche meno epico) in relazione al bilanciodel secolo “fordista”: ma nello stesso tempo più disincantatoe forse scettico intorno alle evoluzioni in corso. Ma andiamocon ordine. Dunque questo libro, come ci ricorda l’autore, èdedicato non ai numeri e alle tendenze del mercato del lavoro(aspetti che sono trattati con dovizia di informazioni), ma ai“significati socio-culturali del lavoro salariato”.
La storia che Baglioni ci racconta è comunque la storia di un avanzamento sociale dentro il quale la parola chiave
è “benessere”
La periodizzazione proposta presenta una scansione in trefasi. La prima, quella più descritta con gli occhi della scoperta,attraversa la storia repubblicana per arrivare al suo culminenegli anni settanta, quando il ruolo del lavoro – complici lelotte operaie – trova il pieno riconoscimento sociale e si carat-terizza per un progressivo miglioramento della condizione la-vorativa e degli stessi livelli retributivi: all’inizio più lento,ma successivamente più incalzante, anche come portato delpieno decollo economico.La seconda fase dura fino all’incirca ai primi anni del nuovo
Il lavoro salariato e la sua storia>>>> Mimmo Carrieri
Guido Baglioni

/ / 74 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
secolo, e potrebbe essere definita come il periodo dell’asse-stamento. Quello in cui il lavoro e i lavoratori, nonostantel’esaurimento progressivo della regolazione fordista, nei paesiavanzati e dunque anche in Italia mantengono, sia pure più afatica, una piena cittadinanza sociale.La terza fase è quella che prende corpo a cavallo della crisieconomico-finanziaria del 2008, che fa esplodere contraddizionigià da tempo incubate: è la fase che potremmo definire delripiegamento. In essa nei paesi dell’Europa occidentale, e inspecial modo in Italia, il lavoro vede minacciate le sue acqui-sizioni precedenti: non solo la sua scarsità quantitativa vedel’esclusione o la mortificazione di tanti giovani nel mercatodel lavoro, ma il suo stesso status qualitativo (non solo dunquela condizione materiale di lavoro, ma il suo posto nelle nostresocietà) è sottoposto a tensioni e passi indietro, aggravati dauna maggiore marginalità delle ragioni del lavoro nella sferapubblica.La storia che Baglioni ci racconta è filtrata dalle sue esperienze,dalle elaborazioni degli scienziati sociali che cita, o dalledottrine politiche (socialdemocrazia e marxismo) e dagli in-segnamenti religiosi: come ricordavamo, la dottrina socialedella Chiesa, intesa come fonte di ispirazione per gli attoripolitici e sociali, ma anche per l’elaborazione di numerosi in-tellettuali, fino ai Fanfani, Romani e Mengoni. Ma è comunquela storia di un avanzamento sociale dentro il quale la parolachiave è “benessere”. Il benessere è quello che manca nell’Italiauscita dalla guerra, quando questo viaggio muove i suoi primipassi; il benessere è l’acquisizione principale e il punto diarrivo (oggi spesso difeso con i denti) di quel cambiamentocapace di segnare un riscatto: tanto più rilevante in quantoesteso, almeno per un pezzo consistente di storia, all’insiemedei lavoratori, inclusi gli strati più umili. Infatti il primocuore, più riconoscibile, di questa storia è quello del gruppoemergente negli anni del dopoguerra: il gruppo dei lavoratorioperai, “il gruppo sociale più corposo, ampio e con capacitàdi cambiare o migliorare la loro condizione”, secondo leparole dell’autore.Lo strumento principe per questa promozione sociale genera-lizzata consiste in un metodo che potremmo chiamare percomodità “riformista”: quello che Baglioni descrive come im-pegno per migliorare in modo gradualista, mattone dopomattone, e senza chimere di salti radicali, la condizionelavorativa e le tutele che le si accompagnano.Per questa ragione l’attenzione privilegiata – e la valutazionepositiva – del ragionamento dell’autore si indirizzano alle e-sperienze politiche e sindacali che meglio hanno incarnato e
materializzato questo percorso sociale di miglioramento in-crementale. Quindi da un lato la socialdemocrazia, non solocome approccio ideologico, ma soprattutto come praticapolitica, che ha preso corpo in primo luogo nelle importantidemocrazie del centro e nord Europa e nelle loro realizzazionisociali. Così Baglioni ci ricorda che in effetti “nel secondodopoguerra la socialdemocrazia è la più rilevante e diffusaprospettiva di correzione dell’economia capitalistica sul pianosociale e per la valorizzazione del lavoro”. Da un altro lato, e non casualmente, la valorizzazione delruolo giocato dalla Cisl nel mondo sindacale per fornire unretroterra a questa prospettiva: quello dei modelli pluralistidell’azione sindacale e della concezione associativa dal puntodi vista del profilo organizzativo. Ma anche per innervarla suprecise gambe contrattuali, che al momento attuale si sostanzianonell’obiettivo di rafforzare la contrattazione in azienda, inquanto la “tutela nei luoghi di lavoro dovrebbe essere piùconcreta , profonda e tempestiva rispetto a quella di livelli piùampi”. E nella sfera sindacale, nonostante la dichiarata affinitàcon gli orientamenti cislini, non mancano i riconoscimentirelativi al ruolo utile giocato anche dalle altre principali Con-federazioni (incluso l’abbandono progressivo di posizionidogmatiche da parte della Cgil).
L’idea che il mondo del lavoro avesse nella sostanza risolto brillantemente i suoiprincipali problemi non è infondata, ma è
portata a sottovalutare i gradi di insoddisfazione e di disagio persistenti
nella condizione lavorativa
Dentro questa ricostruzione esiste anche un chiaro contraltare,che anch’esso svolge il ruolo di filo conduttore per così direspeculare: il rigetto per quelle ideologie del riscatto che hannopreso corpo all’interno del mondo comunista, e che hannosempre fatto leva sul non contentarsi del miglioramentograduale, per puntare invece sulla necessità di una trasformazionetanto più radicale quanto spesso indistinta o impraticabile.Anche se Baglioni riconosce la maggiore complessità dellastoria del Pci in Italia, difficilmente racchiudibile sottol’etichetta di uno schematico antagonismo: “La cultura e laprospettiva della politica comunista avevano una profonditàantagonistica ma di fatto componibile con processi e attoripoco o nulla antagonistici”.Questa ricostruzione comunque si compone di una ricchezzadi esempi e di episodi, oltre che di approcci scientifici, di

/ / 75 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
cui non è possibile in questa sede dare conto in tutta la suavarietà.Essa appare anche nel suo insieme convincente: questatraversata verso un miglioramento ragionevole, l’unica prospet-tiva effettivamente praticabile nelle economie capitaliste (etale da esaltare il contrattualismo come fondamento dell’azionesindacale).Sorgono maggiori dubbi sulla cornice costruita intorno alletendenze attuali. Anche a partire probabilmente da una visioneeccessivamente pacificata in relazione al passato (di cui sismarriscono le aspre tensioni e gli approdi irrisolti). L’ideache il mondo del lavoro – grazie alla crescita economica edunque a quella conseguente del benessere – avesse nellasostanza risolto brillantemente i suoi principali problemi nonè infondata, ma è portata a sottovalutare i gradi di insoddisfazionee di disagio persistenti nella condizione lavorativa. E corre ilrischio di essere anche fuorviante politicamente. Infatti il giudizio sulla socialdemocrazia appare distorto daquesta convinzione. Quando Baglioni sostiene che dopo l’etàdell’oro “il cammino della socialdemocrazia diventa meno in-cisivo […] perché buona parte dei suoi obiettivi sono statiraggiunti” sottolinea a ragione i grandi successi del compromessosocialdemocratico (l’arte di “quadrare il cerchio”, secondoDahrendorf). Ma tende a sottovalutare che quei risultati fon-damentali per il lavoro classico – che per comodità chiamiamofordista – non costituiscono la fine della storia. Il lavoro si è trasformato nell’ultimo trentennio, diventando
più discontinuo, ma spesso più ricco nei contenuti, piùeterogeneo e difficile da aggregare, più accidentato e mobilenei percorsi: al punto che Accornero ha proposto di parlare di“lavori” al plurale. E qui la sinistra europea, principalmentequella di ispirazione socialdemocratica, è stata sfidata a trovarenuove chiavi che non ricalcassero semplicemente le ricettedel passato. In questa angolatura deve essere letta la terza viadi Blair e la ricerca di nuovi paradigmi capaci di conciliarecapitalismo e benessere diffuso. Ma non c’è dubbio che questoindirizzo (molto più orientato a lasciar fare al mercato rispettoalla prima socialdemocrazia, che il mercato voleva indirizzarlo),dopo aver suscitato attese e prodotto buoni risultati, si siaesaurito per le sue difficoltà su entrambi i lati: nella capacitàdi garantire una crescita sostenuta, e nella capacità di estenderei benefici sociali a larga parte dei “lavori”. Ecco perché la terza fase di Baglioni è così problematica. Iprincipali attori collettivi – partiti, ed anche sindacati, espressionedel lavoro classico – si sono fin qui dimostrati inadeguati neltrovare politiche efficaci a scala delle diverse facce dei “lavori”contemporanei. E quindi tendono a rappresentare segmentipiù ridotti delle loro società, rivelandosi non all’altezza difornire una bussola (e adeguate protezioni) alla parte piùdebole, economicamente e culturalmente, dei lavoratori. Pocomale se i “lavori”, e quei lavoratori, venissero riscattatiattraverso altre vie, nuove ideologie o nuovi orizzonti riformatori.Ma dal momento che così non è, dobbiamo ritenere che questalunga storia possa continuare, passando però attraverso inno-vazioni rilevanti, se intende giocare un ruolo rilevanteanalogo a quello dei cicli precedenti.
Dobbiamo chiederci se accanto ai fattorioggettivi che relativizzano il peso del lavoronon bisogna mettere di più l’accento sullainadeguatezza soggettiva dei partiti
di sinistra e dei sindacati
Per queste ragioni quello che Baglioni chiama “un buoncammino che si è arrestato”, mentre rende evidenti tutti iproblemi attuali, allo stesso tempo ci interroga sulle potenzialitàdi uno scenario che non è fatto solo di aspetti critici e dideclino inarrestabile. Sono due i punti fermi nel ragionamentodell’autore. Da un lato il deciso miglioramento della condizionemedia dei lavoratori all’interno di questo percorso di lungoperiodo: un bene storico da preservare. Da un altro lato il peggioramento tendenziale cui è espostatanta parte del lavoro: “Una parte dei lavoratori non trova

/ / 76 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
lavoro, svolge mansioni faticose e sgradevoli, non arriva adun decente tenore di vita”. Tra le ragioni che producono un quadro di crescente insicurezzasociale Baglioni cita il rallentamento della crescita (nei paesipiù avanzati), e la prevalenza delle diversità tra i lavoratori, checomporta anche il venir meno di una identità forte e omogenea.Mentre non bisogna sottovalutare, in positivo, l’avvi-cinamentodei paesi emergenti a soglie di maggiore benessere, non c’èdubbio che quelli a noi più vicini, un tempo decisamente piùcaratterizzati da un capitalismo socialmente protettivo, oggistentino a mantenere le loro posizioni (e questo riguarda in par-ticolare l’Italia, uno dei fanalini di coda dei paesi occidentali).In questo ritratto preoccupato, ma anche un po’ sconsolato,Baglioni da un lato mostra la minore capacità di animazionesociale e di costruzione di speranza espresse dai soggetti so-cio-politici del cammino dell’emancipazione del lavoro, daun altro il fatto che la questione del lavoro è diventata meno
“decisiva”. Ma arrivati a questo punto, nel condividere moltedelle analisi e delle valutazioni dell’autore, dobbiamo chiedercise accanto ai fattori oggettivi che relativizzano il peso dellavoro (come l’emergere di altre questioni centrali) non bisognamettere di più l’accento sulla inadeguatezza soggettiva deipartiti di sinistra e dei sindacati. In realtà uno dei punti nodalidi questo deperimento del lavoro deriva a mio avviso anchedal fatto che gli attori tradizionali (partiti di sinistra e sindacati)hanno in mente, e in parte aggregano, un “altro” lavoro,diverso da quello – intelligente, spezzettato e fluido – chepervade le nostre società. Ma questa variabile – le politiche ei risultati prodotti da questi attori – è proprio una delle variabiliprincipali di cui parla Baglioni: la capacità strategica del“lavoro organizzato” che ha tanto contato nei successi delNovecento.Nella fase attuale questa capacità si è rattrappita, pur davanti aproblemi crescenti che vengono dalla condizione lavorativa:nuove insicurezze e segmentazioni maggiori, ma anche domandedi tutele di maggiore qualità ed individualità, che produconouna massa critica di contraddizioni forse più dispersa e mobile,ma certo non meno intensa di quelle precedenti.E dunque, anche se questo aspetto – come rilevato – resta vo-lutamente sullo sfondo del ragionamento di Baglioni, lo dob-biamo necessariamente rimettere al centro, con un interrogativo:esiste ancora un legame chiaro tra sorti del lavoro e delsindacato? O questo legame è saltato, e saranno altri attori adoccuparsi dei nodi materiali e redistributivi (come per esempioha fatto Renzi in Italia con gli 80 euro per i redditi più bassi)?In realtà una interdipendenza tra sorti del lavoro e del sindacatosembra ancora forte: il lavoro è più periferico, perché ilsindacato conta di meno (e perché la sinistra classica se neoccupa di meno). E’ possibile – come dicono alcuni – che isindacati siano condannati ad un declino inarrestabile, edunque bisognerà sempre meno parlare di “Lavoro” comesoggetto unitario, e sempre più di tanti lavoratori, variamenterappresentati. Ma neppure si può escludere che i sindacati, su-perate le attuali incrostazioni conservatrici, siano capaci di unrinnovamento che li riporti – come è successo negli annisessanta e settanta – nel cuore sociale dei problemi del lavoronelle nuove dimensioni che hanno assunto. Molto dunquedipende dall’immaginazione sindacale e dalla capacità diquesti organismi – ancora largamente forti e vitali – dirielaborare e fornire una prospettiva di innovazione alle tanteidentità sociali del lavoro.
G. BAGLIONI, Un racconto del lavoro salariato, Il Mulino, 2014.

/ / 77 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
>>>> biblioteca / recensioni
Un saggio stimolante e arguto ci fornisce il pretesto per darela stura a un dibattito sui massimi sistemi. L’autore, Franco
Buffoni, è un intellettuale eclettico a tutto tondo: poeta fra i piùoriginali dell’ultimo scorcio del Novecento, anglista di chiarafama, traduttore nonché teorico della traduzione letteraria, e,last but not least, cane sciolto della sinistra liberale di ascendenzailluministica. Il suo infatti è un manifesto laico e illuminista chedovrebbe far parte di un’ideale biblioteca liberal-socialista.Buffoni difende appassionatamente quanto di meglio ha partoritola civiltà occidentale: i diritti civili e politici, lo Stato costituzionale,la liberal-democrazia, la tolleranza. Straordinari, per concisione ed efficacia, alcuni passaggi.Ecco come viene demolita la teoria conservatrice secondo laquale Dio ha scolpito nella pietra una legge e un dirittonaturali (di cui il cristianesimo, ovviamente, si ritiene il de-positario): “I figli ‘naturali’ li hanno sempre definiti anche‘bastardi’. Ma che decidano! Questa natura è buona o cattiva?Ovviamente la natura non è né buona né cattiva: la natura èanimale. È ‘destra’ allo stato puro, sorgivo. Parlare di naturacon riferimento all’uomo contemporaneo è come pretenderedi fare indossare un’armatura medievale a un astronauta.Anche nascere con una malattia ereditaria è una cosa naturale,biologica, quando purtroppo accade. L’essere ‘naturale’ noncomporta alcun valore in sé, non significa che si sia ‘normali’.” Buffoni è animato da una intensa passione politica e civile:l’Italia, a suo dire (e io su questo concordo), sarà più libera e piùdemocratica quando avremo leggi moderne e liberali sulla fecon-dazione assistita, sul testamento biologico, sulle adozioni, sullecoppie di fatto, sulle unioni omosessuali. Bisogna anche educarele coscienze alla modernità. Solo una scuola di Stato laica epluralista può scavare solchi profondi. Fin qui tutto bene: il libe-ral-socialista condivide sia l’elogio della ragione laica, sia lapassione per la cultura scientifica. Ma la sua cifra è la ricerca disoluzioni moderate e realistiche. Ecco perché è un laico tollerante(più agnostico che ateo) che non teme di dialogare con i credenti. Ma la visione laica, in certi ambienti della sinistra liberal, de-genera in un laicismo dogmatico e intransigente il cui imprinting
risale alle correnti più radicali dell’Illuminismo. Il laicista –un ateo dichiarato, seguace più di Diderot e di d’Holbach chenon di Kant – affronta il fenomeno religioso in chiave riduttiva:o sociologica (la fede è espressione di società arcaiche), o psi-cologica/freudiana (chi crede in Dio sublima pulsioni psichicheo problemi reconditi). Gli sfugge così una dimensione fonda-mentale dell’animo umano. Il laicista pensa che si può – anzi:che si deve – vivere senza Dio: “Gli abramitici dovrebberoimparare dai loro laici, dai loro atei, ad affrontare la questionedella finitudine senza ricorrre a metafisiche illusorie di so-pravvivenza post mortem, con il loro portato storico difanatismo, intolleranza, coazione a credere, persecuzioni ainon credenti. E spirito di crociata, di herem, di jihad”.
È realistico pretendere che tutte
le società si ispirino, nel più breve tempo
possibile, a un unico modello di laicità
inflessibile?
Soffermiamoci un attimo sulla finitudine umana: come possiamopretendere che tutti gli esseri umani abbandonino il Dio dellereligioni positive? La promessa di una vita ultraterrena, cheanch’io giudico illusoria, è fonte di consolazione per chi inquesto mondo soffre o non riesce ad accettare la propriamorte in termini di fine assoluta. C’è chi ha le forze perfarcela da solo, ricorrendo alla sola ragione; c’è chi ha bisognodella fede, così come la declinano la tradizione giudaico-cristiana e quella islamica. Il laicismo di filiazione illuministica pecca di schematicità:enfatizza il grumo fideistico, tendenzialmente fanatico, cheindubbiamente esiste, ed ignora i diversi stadi di sviluppo incui si trovano le religioni. Intendiamoci: noi occidentali –credenti e laici in egual misura – siamo figli dell’Età deiLumi. I philosophes hanno scritto pagine memorabili nellastoria della nostra civiltà: il loro più grande merito consistenell’aver concepito “una nuova morale razionale e universalebasata sui diritti”, con cui è stato reciso di netto il nesso “tra
Giacobinismo fuori tempo>>>> Edoardo Crisafulli
Franco Buffoni

/ / 78 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
morale e religione come principio fondatore della convivenzacivile”, come scrive Vincenzo Ferrone. Quel nesso era diventatouna camicia di forza per chi aveva imboccato la strada dellamodernità. Se oggi viviamo in società secolari e aperte, che sireggono egregiamente su una morale laica lo dobbiamo so-prattutto agli illuministi. Ma è realistico pretendere che tuttele società si ispirino, nel più breve tempo possibile, a un unicomodello di laicità inflessibile? Un certo tipo di illuministanon si pone questo problema: batte i pugni sul tavolo, epretende che il mondo intero si conformi alle sue aspettative. Il culto della modernità e del progresso è un grande limite.Porta diritto filato al manicheismo: la luce (la ragione) checombatte le tenebre (la religione). Sappiamo che l’Illuminismonon è un movimento unitario. Ma sappiamo anche che ilrazionalismo illuministico non sempre offre chiavi di letturaadeguate della natura umana e del mondo sociale: gli è estraneala coscienza della complessità, tant’è che il suo maggior limiteè l’antistoricismo ingenuo che lo caratterizza. Ecco perchésfocia spesso nella polemica e nella critica astratte. Se vogliamodistricarci in quel ginepraio che è il mondo contemporaneo, ilprimo passo da compiere è sforzarsi di comprenderlo: lereligioni non possono essere espunte con editti o ingiunzioni.Ma, per timore di dover giustificare l’esistente, l’illuministagranitico chiude gli occhi sulla razionalità di ciò che è reale.Preferisce condannare ciò che ripugna alla sua coscienza. Nona caso la cultura illuministica, a cui associamo subito il trattatosulla tolleranza di Voltaire, ha generato anche atteggiamentiintolleranti e faziosi. Un esempio contemporaneo di illuminismointransigente – un po’ spicciolo e spurio, in verità, ma chiarissimonelle sue coordinate culturali – lo si trova nell’ultima OrianaFallaci: gli attacchi feroci all’islam condannato in blocco,senza distinguo, come una religione barbara – riecheggiano icommenti antisemiti di Voltaire. In Buffoni non v’è traccia della rozzezza anti-islamica chetroviamo in La rabbia e l’orgoglio; la sua raffinata sensibilità,che lo sospinge alla ricerca del vero e del giusto, è lontanaanni luce dall’aggressività ipocrita dei teo-con, i quali bran-discono il crocefisso – nel quale, peraltro, non credono – amo’ di clava contro i musulmani. Lui, che è equanime, se laprende in egual modo – e visceralmente – con tutte e tre legrandi religioni abramitiche. E in questo ha ragione: ebraismo,cristianesimo e islam si equivalgono da un punto di vistamorale e politico. Nel male (che lui evidenzia con straordinariaverve critica) e nel bene (che però gli sfugge). Qui, più che la teologia e la filosofia della storia, ci interessala riflessione politica. Chi impoverisce l’analisi storica, restringe
il ventaglio delle opzioni politiche. In altre parole: le posizionipreconcette sono spesso velleitarie o nocive. È senz’altro veroche alcune società islamiche pullulano di religiosi fanatici.Ma in quelle stesse società si levano anche le voci ragionevolidi chi crede nella mediazione e nella convivenza pacifica.Sono quelle dei religiosi moderati, gli alleati naturali dei ri-formisti. Ma il laicista non va a braccetto con personaggi diquella risma: “credente laico” (chi accetta la divisione Stato eChiesa) o “ebreo/cristiano/islamico liberale” (chi è aperto al-l’esegesi modernista dei testi sacri) sono ossimori, per principio.Nessun dato empirico lo convincerà del contrario.
Vi sono credenti nella “mitologia” biblica
o coranica che sono giunti a conclusioni
politiche diametralmente opposte a quelle
degli integralisti
Il problema politico più spinoso dei nostri tempi – il fonda-mentalismo religioso – non si sconfigge con le formule astratte.Soprattutto sperché queste, in genere, confliggono con larealtà. Consideriamo l’equivalenza, posta in termini assiomatici,“metafisica religiosa = crociate e jihad”. Che ebraismo, cri-stianesimo e islam covino pulsioni fondamentaliste è cosa ar-cinota. Del resto la storia è colma di episodi di violenzacompiuti in nome di Dio. Ma è vero che i dogmi religiosisono di per sé – a prescindere dai vari contesti culturali,politici e sociali – il principale carburante dei fondamentalismi?La questione che sta più a cuore a Buffoni è l’intollerabilediscriminazione anti-omosessuale, il pregiudizio omofobico,che lui riconduce al severo monoteismo abramitico. È difficile dargli torto: i testi parlano chiaro. Nell’Antico Te-stamento e nel Corano vi sono passi illiberali che vienenaturale stigmatizzare come primitivi e oscurantisti. Ancoroggi molti vescovi, imam e rabbini condannano l’omosessualità,e ritengono inammissibile la libertà di scelta in ambito etico esessuale. Ma da ciò non consegue che il dogma in quanto taleè sempre anti-modernista. Altrimenti non si spiegherebbequell’evento rivoluzionario, nella storia della Chiesa cattolica,che porta il nome di Concilio Vaticano II. Vi sono minoranzeilluminate in ogni religione abramitica, le quali propongonoletture liberaleggianti, aperte alla modernità, scontrandosi coni tradizionalisti, per i quali la dottrina è immutabile, scolpitanella pietra. Vi sono, insomma, credenti nella “mitologia”biblica o coranica, i quali sono giunti a conclusioni politichediametralmente opposte a quelle degli integralisti. Secondo il rabbinato ortodosso, le donne in sinagoga ci

/ / 79 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
possono stare solo segregate e non possono sfiorare la Torahneppure con un dito; il rabbinato progressista, invece, ammettee anzi incoraggia la figura della donna rabbino. Il cattolicesimocondanna l’omosessualità e rifiuta il sacerdozio femminile, innome di una visione patriarcale e sessista; ma in varieconfessioni protestanti, che pure adottano i testi canonicicristiani più importanti, le donne pastore sono una realtà, ed èammesso il matrimonio omosessuale (è il caso, per stare inItalia, dei Valdesi). L’esegesi ha ricadute politiche chiarissime:i fautori delle interpretazioni letterali sono tradizionalisti ir-riducibili alla modernità (i cattolici integralisti, pre-conciliari;i salafiti e i wahabiti musulmani; gli ebrei ortodossi e ultra-ortodossi); i modernisti, invece, estrapolano dai testi sacri unmessaggio religioso profondo, se necessario a scapito dellalettera. Riconoscono in tal modo che la rivelazione ha vestitopanni storici, è apparsa in società arcaiche, a cui era estraneoil concetto di libertà individuale nel senso odierno. Nelmomento in cui ammetto che i testi religiosi vanno collocatinel tempo in cui furono scritti, gli insegnamenti religiosi nonsono più assoluti. Questa è una bestemmia per i fondamentalisti. In sintesi: solo scavando nell’animo degli abramitici, e analiz-zando le condizioni concrete in cui vivono, troveremo glistrumenti per intervenire in quel magma che è il fanatismo.
Non abbiamo bisogno né dell’ateismo né di un neo-paganesimo:da un punto di vista politico, è più utile incoraggiare leminoranze liberaleggianti in tutti i gruppi religiosi. Il modernismo,nelle mani di persone intelligenti, è un’arma filosofico-politicamicidiale. Il fanatismo nasce come reazione violenta all’irromperedella modernità in società archaiche. Solo politiche graduali,di tipo riformistico, possono sortire effetti durevoli. Convincerei fedeli a considerare mitologici tutti i testi sacri è insensato;la vera sfida è piuttosto quella di favorire l’esegesi modernista.Giacché la fonte dei problemi che stiamo vivendo non è lafede in dogmi irriducibili alla ragione, bensì l’atteggiamentointransigente, fanatico, di un certo tipo di credente. Tra fede epolitica può esserci anche un rapporto sano.
Chi si ferma alla superfice del fenomeno
religioso è costretto a menar fendenti
come un Donchisciotte redivivo
Ma gli illuministi tutti d’un pezzo non se ne danno per inteso:la madre di tutti i problemi sarebbe la religione tout court, sianell’Occidente che altrove. Il monoteismo, “con la suacostrizione a scegliere tra vero e falso”, sarebbe “l’ostacolomaggiore allo scatto antropologico di cui necessita la Sa-

/ / 80 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
piens-sapiens di cultura abramitica”. Qui si parla dunque disradicare le religioni abramitiche, “obsoleti retaggi di antichetradizioni”, nonché focolaio delle peggiori barbarie nel mondocontemporaneo. In questo modo di ragionare si scorge, sottotraccia, il desiderio giacobino di far piazza pulita di tutte le re-ligioni, viste come residui limacciosi di una mentalità arcaicae anti-moderna; palle al piede in quella che dovrebbe essere lamarcia trionfale della modernità. Insomma, fa capolino l’ormaianacronistico, e per molti aspetti fallimentare, ottimismo pro-gressista che ha accomunato illuministi e marxisti. Il gran salto antropologico verso un “Sapiens-sapiens” ra-gionevole, del tutto emancipato dalle pastoie di credenzemitologiche, non è ancora avvenuto, e c’è da dubitare cheavverrà mai. Questa linea di pensiero è problematica proprioperché ritiene che l’ateismo sia la soluzione migliore – lapiù radicale e definitiva – al problema del fondamentalismoreligioso. Se i fanatici uccidono in nome di Dio, bastaeliminare Dio dalla scena. Semplice, no? Il velleitarismonon risolve i problemi, semmai li amplifica. Chi si fermaalla superfice del fenomeno religioso, è costretto a menarfendenti come un Donchisciotte redivivo. Se il monoteismoabramitico, con tutti i suoi dogmi e le sue credenze assurde,è la causa del male, è ovvio che di fronte a noi si staglia uncompito politico sovrumano: come ricondurre alla ragione-volezza almeno tre miliardi di individui sviati e indottrinatidalla fede? È ingenuo pensare che dosi massicce di razionalismopossano far rinsavire società, come quelle arabo-islamiche,
che sono ancora impregnate di religiosità arcaica. Anzichégettarsi a capofitto in una guerra destinata alla sconfitta, nonè forse meglio cercare di ‘urbanizzare’ le religioni, depurandoledalle tossine fondamentaliste? C’è, oltretutto, una obiezione di principio alla propagandaateista: chi si professa riformista non dovrebbe impegnarsiper far sì che le religioni scompaiano, anche se fosse in suopotere farlo. È ragionevole esser contrari all’insegnamentodella religione cattolica nelle scuole di Stato italiane. Ed ègiusto proporre esperti di “storia delle religioni e delle civiltàculturali”, selezionati “tramite concorso pubblico, al postodei docenti di religione scelti dai vescovi”. Lo Stato – in Oc-cidente, nella città secolare – non deve insegnare un credo re-ligioso. Ma uno Stato ateista che educhi alla ‘laicità’ in sensoanti-religioso – come avveniva in Urss, per intenderci –sarebbe altrettanto illiberale di uno Stato cristiano o islamico.Anch’io penso che la Bibbia e il Corano siano testi mitologici,ma non me la sentirei di imporre questa mia visione a chicrede nella verginità della Madonna o nei voli alati delprofeta Maometto. L’educazione religiosa è un compito dellefamiglie, non dello Stato.
Nessuna forma di multiculturalismo può
ignorare i diritti universali dell’uomo
su cui si regge la città secolare e aperta
I due corni del dilemma liberal-socialista, qui, si concilianoperfettamente: in economia vogliamo uno Stato interventista(in questo siamo socialisti); nella sfera morale ed educativa,vogliamo uno Stato neutrale (in questo siamo liberali). Nonsapendo infatti quale sia la verità, chiediamo solo che lo Stato“educatore” si preoccupi di far passare il principio dellatolleranza e della convivenza pacifica tra laici e credenti (ditutte le religioni). Un dialogo aperto tra sostenitori di istanzediverse può innescarsi solo a condizione che tutti abbandoninola pretesa di essere i depositari dell’unica verità. Il confronto èfonte di conflitto, ma gestito civilmente fa crescere e maturare. Detto ciò, nessuna forma di multiculturalismo può ignorare idiritti universali dell’uomo su cui si regge la città secolare eaperta. È giusto dire che dobbiamo instillare nelle menti deicredenti “la tolleranza come il valore laico per eccellenza”.Tolleranza, per il credente, significa dover rispettare sia chipratica una fede diversa dalla sua, sia gli atei dichiarati. E peril laico implica ammettere la possibilità della fede. Ed èproprio qui che casca l’asino. Gli atei militanti sono il cor-rispettivo laico degli integralisti religiosi: hanno le loro verità

/ / 81 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
assolute da imporre. L’unico confronto che abbia senso,secondo loro, è quello che si pone come obiettivo la liberazionedalla religione. Che i credenti rinuncino “alle loro prerogativedogmatiche e sacrali”, e concepiscano le religioni come“eredità culturali”. Solo così sapranno “superare lo stadiodella preghiera e della magia”.Il confronto tra credenti e atei dovrebbe sfociare in un “sano”materialismo filosofico. Il che equivale a dire che il dialogo èprecluso in partenza: in realtà è un monologo. Come dicevo,qui ci interessa il discorso politico: bollare i credenti in toto –inclusi i modernisti – come individui obnubilati da pratichesuperstiziose, nonché equiparare magia e religione, è un’invettiva,non una proposta politica. L’unica soluzione alle guerre di re-ligione è il dialogo interreligioso (e interculturale). Ma ildialogo interreligioso, per gli atei militanti, puzza troppo d’in-censo. Eppure, se vogliamo pacificare il mondo, è imperativocostruire un baluardo contro il fanatismo insieme con i religiosimoderati. Come possono un cattolico liberale o un protestanteilluminato dialogare con chi sostiene che sia “dannoso indurreun bambino a basare la propria etica su una nascita ‘divina’, esulla ‘resurrezione’ di un uomo”? Se infatti quel bambino,crescendo, un giorno rifiuta, “alla luce della ragione, l’impiantoetico basato sui dogmi, è ben difficile che l’ex giovane sia ingrado di configurarsi un’altra etica radicata e profonda”.
Il cristianesimo è anche la religione
che ci ha insegnato la caritas, prima scintilla
dell’ethos egalitario socialista
Lo spaesamento dell’ipotetico ex cristiano sarebbe la fonte ditanto cinismo, opportunismo e ipocrisia che vediamo attornoa noi. Qui abbiamo le premesse intellettuali per una serie diguerre non di religione, ma contro le religioni. Il problema delcristianesimo, più che la divinità di Cristo, è stato storicamentela pretesa di possedere l’unica verità. Nulla salus extraecclesiam. Il dialogo interreligioso ha ammorbidito l’intransi-genza dottrinale d’un tempo. Né regge alla verifica empirical’assunto per cui l’aver creduto in Cristo sarebbe di per sédeleterio. Il cristianesimo, depurato dai dogmi, può ispirareun’etica senza trascendenza. Anch’io, come Buffoni, hoimparato a disancorare la mia visione morale “da incarnazioni,carri di fuoco, cavalli alati, resurrezioni, transustanziazioni,jihad”. Ma cosa mi ha predisposto a recepire l’etica kantiana el’ideale socialista che professo, se non l’educazione cristianache ho ricevuto? Un’educazione religiosa può imprimere unabito mentale intollerante, che permane in chi ha abbandonato
la fede (pensiamo, per esempio, al dogmatismo comunista);ma questo è un problema più del cattolicesimo tradizionalistache non del cristianesimo tout court. L’insegnamento di moltechiese protestanti educa alla tolleranza, allo spirito critico, allibero pensiero.Affinché si possa ragionare sul modo in cui possiamo tirarfuori le potenzialità riformatrici dell’islam, occorre disfarsidel pregiudizio ideologico secondo cui la fede è sempre e co-munque regressiva. Le religioni non sono solo fonte difanatismo. E non mi riferisco all’ovvietà che hanno fatto ger-minare la nostra cultura. Il punto è che hanno lasciato ancheun imprinting indelebile nella nostra vita politica e sociale.L’ebraismo ci fa venire in mente la lapidazione delle adulteree il sessismo; ma è anche la religione che ha affermato ilprincipio della centralità della persona, la quale, secondo laGenesi, è stata creata a immagine e somiglianza di Dio. L’e-braismo è, in certo senso, il primo umanesimo, giacchécondanna ogni idolatria – inclusa quella, pericolosissima, delDio-denaro, come ha scritto Luigino Bruni. Non a caso tra isuoi precetti ha codificato lo shabbat, giorno obbligatorio diriposo, tutela ante litteram del lavoratore. L’islam integralista impone la shariah, che, per certi aspetti, è il-liberale e anti-moderna; eppure la seconda sura coranica contieneil precetto “nessuna costrizione nella fede”. E infatti, nei secolipassati, erano più liberi (e meno perseguitati) i cristiani nelmondo islamico di quanto non lo fossero gli islamici e gli ebreinel mondo cristiano. L’islam è anche la religione che, tra i suoipilastri, ha quello dell’obbligatorietà dell’elemosina; gli islamici,tra l’altro, hanno in gran dispitto la speculazione finanziaria eogni forma di usura: le banche islamiche si ispirano a un codiceetico, non praticano tassi d’interesse esosi, prediligono gli in-vestimenti produttivi e socialmente utili. Il cristianesimo, dal canto suo, ha dato vita ai tribunali del-l’Inquisizione e ha scatenato le prime grandi guerre religiose;ma è anche la religione che ci ha insegnato la caritas, primascintilla dell’ethos egalitario socialista. La caritas, frutto dellacapacità di vedere noi stessi negli altri, contribuì a dissolverel’Impero romano, fondato sul modo di produzione schiavistico.Per i romani, la schiavitù era più che compatibile con la pietaspagana evocata da Buffoni. La caritas, peraltro, è una realtàviva e pulsante ancor oggi: il (benemerito) volontariatocattolico supplisce alle carenze di un Welfare State ansimante.C’è solo da augurarsi che il tracollo delle ideologie politichenon trascini con sé la fede evangelica, quella pura, che è altracosa dal clericalismo conservatore. Tutte queste riflessioni chiamano in causa la lotta millenaria

/ / 82 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
tra Atene e Gerusalemme, tra ragione e fede. Il tema è troppocomplesso per poter essere affrontato esaurientemente inquesta sede. Mi limito ad osservare che Atene, la città secolareche garantisce libertà e autonomia all’individuo, ha comple-tamente soppiantato Gerusalemme, la città sacra che asservival’individuo alla teocrazia. I nemici della modernità, per quantoagguerriti e pericolosi, non potranno cambiare il corso dellastoria occidentale. Le cose, insomma, procedono nella direzione“progressista” auspicata da Buffoni. È per questo che sifatica a capire il senso, oggi, di un illuminismo militante,vecchia maniera. Dire in termini perentori che “il clerico-fas-cismo può e deve essere distrutto” è un po’ come lanciare ungrido di battaglia di fronte a un nemico sconfitto, incapace dicontrattaccare. L’agenda conservatrice di Woytila e Ratzingerè, semplicemente, anacronistica – è l’ultimo colpo di coda diuna Chiesa in profonda crisi, che sta elaborando il lutto per laperdita di un’identità fideistica millenaria.
Viene meno, quindi, una delle giustificazioni ideologiche dellaicismo illuministico: un clericalismo sanguigno e vitale, espres-sione di un cristianesimo sul piede di guerra e capace di vincere.La modernità, in Occidente, è il nuovo senso comune (si pensiall’omofobia, tema caro a Buffoni: ormai anche tra i conservatoriamericani e inglesi prevalgono i liberali contrari allo stigma efavorevoli al matrimonio omosessuale). Tuttavia, anche se Atenepuò già cantare vittoria, gli squilli di tromba sono fuori luogo: ilpercorso verso la modernità, nei prossimi anni, sarà accidentatoe pieno di insidie. Il mondo islamico resiste, tenace, a ogniforma di modernizzazione coatta ed eterodiretta. E la minacciafondamentalista islamica, con l’immigrazione, si è insinuata nelcuore dell’Occidente. La città secolare dovrà esser capace dicontenere la violenza reattiva di chi si batte per un’improbabilerestaurazione del dominio della città sacra.
Anche noi laici dovremmo disfarci della
presunzione di possedere la verità
Occorre dunque distinguere tra l’Occidente, che corre a velocitàfolle sulla strada a senso unico del progresso, e la cultura arabo-islamica (quella che ci interessa più da vicino), che ha erettouna diga contro la modernità. Quello del fanatismo religioso,insomma, è un problema che il mondo occidentale ha superato,nonostante alcune sacche che resistono all’avanzata travolgentedel progresso, e che vive solo di riflesso, allorché questo siscontra con culture fieramente tradizionaliste. L’Occidente si èspinto ben oltre la conquista della laicità, che significa separazionetra Stato e religione: ha perso la cognizione del sacro, e si èquasi del tutto scristianizzato. La strategia politica dei teo-conne è la prova lampante: gli islamisti non hanno bisogno di re-suscitare un “islam culturale” senza Dio, in funzione difensiva,anti-cristiana: sanno benissimo cos’è la fede dei martiri e degliesaltati. I laicisti non colgono la drammaticità di questo passaggioperché pensano, come gli integralisti religiosi, che una societàlaica e secolare implichi la fine di ogni trascendenza.Possiamo sperare che la modernità, camminando con le suegambe, faccia piazza pulita delle mitologie religiose, assomigliandoin questo ai marxisti che attendevano la Gerusalemme terrestreda un processo storico teleologico regolato da ferre leggi;oppure possiamo ingaggiare battaglia per affrettare i tempi incui ci sarà il Regno della libertà laica, al pari dei volontaristiche la rivoluzione proletaria volevano farla scoppiare subito.La storia ci ha insegnato che entrambi i metodi sono sbagliati:il primo è illusorio: svaluta la realtà in cui viviamo in nome diun’idealizzazione (associata, qui sta il paradosso, al finalismo

/ / 83 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / recensioni
tipico del pensiero religioso); il secondo è pericoloso: la filosofiadel tutto e subito puzza di giacobinismo, e tende a portare allaghigliottina, la cui versione più moderna sono i missili intelligenti.La realtà può essere modificata solo in parte, e gradualmente.Bisogna mettere in conto sconfitte e ritirate strategiche.Già Bobbio, riflettendo sul socialismo, ammoniva sul fattoche la storia non è una strada retta e a senso unico. Si ispiravaalla straordinaria lezione di Carlo Rosselli: “Il socialistaliberale [...] non si illude di possedere il segreto dell’avvenire,non si crede depositario della verità ultima, definitiva, inmateria sociale, non china la fronte dinanzi a dogmi di nessunaspecie. Non crede che il regime socialista sarà o si affermerànei secoli per una legge trascendente la volontà degli uomini”.Tutto fa supporre che la società aperta e secolare, ovvero lademocrazia liberale, sarà l’approdo dell’umanità intera, e noice lo auguriamo. Ma non è detto che lo sarà, non almeno nelleforme pure che ha assunto in Occidente. Anche noi laici dovremmo disfarci della presunzione dipossedere la verità. L’elogio del dubbio, dello spirito critico,mal si concilia con l’idea che la ragione sia onnipotente. Un
sano agnosticismo, coniugato con un moderato pessimismoantropologico, sono gli ingredienti filosofici del liberal-so-cialismo. Noi laici abbiamo molto da imparare da quel per-sonaggio straordinario che fu Dietrich Bonhoeffer: uno deipochi teologi protestanti che, in nome della fede cristiana,affrontò il patibolo nazista con dignità assoluta. Rovesciamola sua celebre affermazione, e proviamo a vivere etsi Deusdaretur. Nella consapevolezza che il Sapiens-Sapiens è unguazzabuglio di razionalità e fede, di superstizione e spiritoscientifico, di lucidità e follia. Il riformista è alla costantericerca di una formula che coniughi il desiderabile con ilpossibile. Ben venga dunque un illuminismo “debole”, chenon idolatra la ragione. Non dobbiamo più rincorrere chimere.Si tratta piuttosto di capire l’intima logica che governa lecose di questo mondo, cercando di indirizzarle, per quantopossible, verso esiti ragionevoli, o quantomeno meno di-struttivi. Di più non possiamo – e non dobbiamo – fare.
F. BUFFONI, Laico alfabeto in salsa gay piccante. L’ordine delcreato e le creature disordinate, Transeuropa Edizioni, 2010.

L’attentato alla redazione parigina del settimanale satiricoCharlie Hebdo è la dimostrazione di un errore che co-
involge molte persone. Coinvolge la tendenza Le Pen, chevorrebbe una soluzione tanto netta quanto vaga del problemaislamico. Fintanto che ci vorremo definire delle democraziee vorremo pretenderci diversi rispetto agli Stati dell’anteguerra,non potremo adottare quasi nessuna delle misure che piaccionoalla signora Le Pen e al suo elettorato. Quindi anche tantiemuli di Clint Eastwood, facili pistoleri da scrivania, intellettualimuscolari autori di libercoli da supermercato, possono mettersil’anima in pace e rimettere Carl Schmitt nel cassetto.Coinvolge anche la tendenza “ospitalista” della sinistra mul-ticulturale e deproblematizzata. Quella delle braccia aperte,dell’accoglienza ottusa, in cui umanismo e animalismo sonola stessa cosa, perché sembra pensare che basti riempire lescodelle a tutti per evitare che ci si sbrani. È la sinistra dellevolontarie che vanno in Palestina perché “Israele è un covodi nazisti” e vengono rapite dall’Isis. Anche questa gentesbaglia, credendo che la differenza irriducibile manifestatadagli ambienti dell’integralismo islamico sia assimilabile conuna sorta di amore cristico senza crocifissione.Coinvolge soprattutto i cantastorie dell’Occidente, tantoquelli che sostengono che l’Occidente attaccato è in guerracon gli islamici, quanto quelli che sostengono che l’Occidentesia una società indefinitamente aperta: entrambe, pur opposte,si cullano sull’implicita particolarità (se non superiorità) oc-cidentale e, inevitabilmente, entrambe sono fallimentari. Inrealtà l’unica tendenza ad aver avuto ragione fino in fondo èquella di Charlie Hebdo. L’Occidente, per i suoi intrinseci valori, non può discriminare inalcun modo una cultura diversa, e peggio ancora, se ha a cuore ilconcetto stesso di diritto e la distinzione fra diritto in tempo dipace e diritto in tempo di guerra, non può parlare di “nemici”. Èimpensabile che l’Occidente cominci a parlare di guerra laddovei “nemici” sarebbero i suoi stessi cittadini, com’è il caso degliislamici. Le guerre civili sono state superate e un loro ritorno se-gnerebbe una regressione che farebbe il gioco dei terroristi edegli integralisti. Ma contemporaneamente non si può pretendereche la cultura occidentale si apra a tutto, anche al suo opposto,anche alla minaccia a se stessa. Non può abbassarsi ad accettareusanze che mettono in discussione i propri cardini; non può am-
mettere che la libertà conquistata faticosamente sia sacrificatasull’altare dell’integrazione a ogni costo.La tendenza Hebdo per questo vince: senza aggredire, senzascadere nel nazionalismo, ha rimarcato nella maniera più efficacedi tutte le differenze rispetto a queste minacce anti-occidentali.Ridere di Maometto o del Papa è stato il gesto più occidentale ditutti e allo stesso tempo il più potente: più ancora delle marceper la salvezza della Francia dall’islamizzazione.Il potere della satira, di cui tanto si parlò proprio in Italia inanni passati (e – come sempre, purtroppo – grossolanamente)è eminentemente occidentale: è l’unico prodotto che distinguala nostra cultura da ogni altra. La possibilità di mettere sullostesso piano ogni preteso potere intangibile (religioso politicoo culturale), e il suo contrappunto scatologico o viscerale frapancia e sottopancia, è proprio quel nucleo culturale impre-scindibile che ci ricorda qual è il nostro corredo genetico ecosa non possiamo sacrificare a nessun prezzo. Ridere delpotere ci distingue e funge da anticorpo necessario: chi nonride è un potenziale terrorista. Quindi chi uccide per lapropria fede, per la propria patria, per la propria parte politica,non può dirsi del tutto occidentale.L’evento che si è verificato il 7 gennaio è un punto di nonritorno: non si è bruciato un supermercato o ucciso qualche ope-ratore di Borsa: nemmeno l’uccisione del regista Theo VanGogh o la carneficina di Utøya rivaleggia con questo attentato,perché in nessuno di questi casi è stata messa a repentaglio lalibertà di ridere, che è la quintessenza e contemporaneamente lacondizione primaria della libertà d’espressione. Poter ridere li-beramente è più importante che parlare liberamente perché ol-trepassa molti limiti della semplice espressione, mette in risaltoil lato comico delle cose, il doppiofondo ridicolo del potere. Se ce ne dimentichiamo è finita: su questo, purtroppo,l’Occidente non può transigere e deve reagire, infischiandosenedel quieto vivere: ogni giornale, ogni sito internet, anzichéscusarsi con questa o quella fede, da oggi sarà costretto – sevorrà non essere complice – a salire sulle barricate dellasatira: chiunque voglia ancora dirsi libero dovrà dismettereogni senso di moderazione e mandare a memoria tutte le bar-zellette che troverà sulla religione e sulla morale comune. È ilminimo per commemorare gli undici redattori caduti: impararea ridere di coloro che li hanno uccisi.
/ / 84 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / aporie
>>>> aporie
Le barricate della satira>>>> Antonio Romano

/ / 85 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / schede di lettura
>>>> biblioteca / schede di lettura
Orientarsi senza vento
>>> Danilo Di Matteo
Ricordo che l’espressione le sinistre,al plurale, al tempo della prima
Repubblica era di uso comune e nonapparteneva solo al lessico delle élite.E lo stesso Norberto Bobbio eviden-ziava ogni volta l’articolazione e lacomplessità del concetto di sinistra.Franco Cassano lo tiene ben presente,ma scorge nel confronto fra destra esinistra (al singolare) lo sfondo delletortuose vicende di almeno due secoli,il XIX e il XX. Leggendo con atten-zione, tuttavia, emerge come egli pro-ponga un discorso ben più problem-atico. Se per alcuni il marxismo, comeforza storica reale, sarebbe stato ad-dirittura sepolto già dalla grande guerra,sopravvivendo poi come suggestioneculturale, per i più la linea di divisionesinistra-destra si sarebbe manifestataappieno su scala planetaria durante laguerra fredda. Già: però proprio i tredecenni successivi al secondo conflittomondiale – i “trenta gloriosi” – hannocaratterizzato il Novecento, in parti-colare nell’Occidente europeo, comeil secolo socialdemocratico: lo stessoNovecento che pure è stato contrasseg-nato dalla rivoluzione d’ottobre. La nozione di sinistra, del resto, pre-cede le vicende del movimento op-eraio, facendo irruzione nella storiacon la rivoluzione francese (qui siaprirebbe il discorso sul contributoche alla sua elaborazione diede ilmondo anglosassone), e presumibil-mente continuerà a influenzare gliscenari politici. Per l’autore il conflittofra capitale e lavoro rappresenta l’asse
con il quale a lungo è stato identificatoquello fra destra e sinistra, eppure inrealtà ne costituirebbe solo un aspetto.Come se egli prendesse sul serio lefigure e le vulgate meta-storiche, com-prese quelle sul “verso” della storia esul suo carattere provvidenziale, persituarle nel tempo e circoscriverle,relativizzandole. A onor del vero nemmeno per un istanteil “vento della storia” ha spazzato via,ad esempio, le coordinate geografiche:vicende nazionali, differenze etniche ereligiose, e via discorrendo. Il crollodell’impero sovietico, come è com-prensibile, ha riportato tutto ciò allaribalta, pur se in un contesto profonda-mente mutato, contraddistinto da quel-l’intreccio di fenomeni possenti notocome globalizzazione. “Del resto checosa erano le famose ‘quistioni’ diGramsci (meridionale, vaticana, e poi,sulla scia del suo lavoro, femminile,giovanile, ecc.) se non la scoperta chela strada del conflitto di classe eracostretta ad incrociare lungo il percorsoaltre strade, ad intersecarsi con linee didivisione e soggettività caratterizzateda solidarietà ed ostilità molto diverse?
D’altra parte già negli anni Venti nonappena lo schema generale dell’oppo-sizione classe operaia/capitale provavaad atterrare sul piano della ricognizioneconcreta del terreno, le diverse ‘qui-stioni’ avevano cominciato ad affollarsi,l’una dopo l’altra”. La novità è chefino a qualche lustro fa eravamo abituatia ricondurle tutte, magari con notevoliforzature, alla frattura destra-sinistra,mentre oggi ciò sarebbe impossibile. Cassano insiste molto sull’esigenza didisporre ormai di uno sguardo e di unapproccio largo e globale, e sottolineala dinamicità del mondo odierno: tuttosi muove velocemente e muta. Nel con-tempo, però, ripropone due nozioniclassiche: quelle di egemonia e diblocco sociale. Concetti che sug-geriscono piuttosto un’idea di continuitàe di durata, se non di stasi. Non tuttele “liquidità”, ecco l’argomento addottodall’autore, sono uguali: “Accanto allamobilità dei manager e delle supponentitecnocrazie esiste la mobilità angosciosae talvolta tragica dei migranti […]Nella stessa acqua c’è chi naviga adalta velocità, chi nuota e chi affogasenza pietà”. Come dire: dinanzi alle

/ / 86 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / schede di lettura
ingiustizie e alle diseguaglianze, quellenozioni restano le sole di cui disponia-mo. Viene tuttavia da chiedersi: sarannoancora utili ed efficaci?Subito dopo Cassano pone un temacruciale: quello del merito. E lo fa inmaniera articolata e condivisibile. Spes-so infatti si crede che basti evocareuna parola per affrontare e risolverenella loro complessità i problemi adessa legati. Non è così: “Nulla è piùgiusto che premiare il merito, ricono-scere che le abilità non sono uguali eassegnare responsabilità e ricompensemaggiori a chi è più capace. Ma nullaè più ingiusto che rappresentare comeun trionfo del merito quella dinamicache risucchia nelle aree forti i più co-raggiosi e capaci aumentando in modoesponenziale il divario preesistente erendendo sempre più ineguali i puntidi partenza”.Su un altro tema l’autore sfida i luoghicomuni: la globalizzazione non è statasolo un gioco a somma zero fra capitalee lavoro, gonfiando i profitti e morti-ficando quest’ultimo. Non è stata “unasemplice deviazione del capitalismodalla sua vocazione produttiva verso itavoli da gioco di Wall Street, ma ungioco a somma positiva nel quale,anche grazie alla finanza, sono inter-venuti nuovi giocatori, la cui ascesa,in concorrenza e in conflitto con ivecchi, ha contribuito a colpire e pre-carizzare chi pensava come garantiteper sempre le conquiste dei decenniprecedenti”. A tal riguardo come non ricordare l’e-mergere, nei “trenta gloriosi” anni delsecondo dopoguerra, di bisogni, aspet-tative e diritti crescenti? Non a casoancor oggi una parte significativa dellasinistra prova a difendere le conquistedel passato in nome dei “diritti”. Dinuovo Cassano prova a far scorgere laproblematicità dell’argomento, legata,oltre che alla disponibilità delle risorse,al carattere conflittuale, per così dire,dei diritti stessi. Può accadere infatti,a dispetto dei tentativi di conciliazioneverbale, che non sia affatto facile co-niugare il rispetto dell’ambiente conla salvaguardia dei posti di lavoro, o
la sicurezza con la libertà personale.Dilatare certi spazi può comprimernealtri, promuovere alcune istanze puòpenalizzarne altre. Detto altrimenti: siè spezzato l’incantesimo per il qualenon poteva che esservi continuità fra idiritti civili, politici e sociali (i quali,fecondandosi a vicenda, avrebbero do-vuto garantire “le magnifiche sorti eprogressive”). E se la crisi degli ultimianni ha ridimensionato il mito del“fare da sé” o del “mettersi in proprio”,i più percepiscono che per uscire dalleproprie difficoltà la risposta non puòche essere individualizzata, legata allapropria peculiare situazione, non so-vrapponibile a quella altrui. Tale prevalenza del sentimento del“particulare” è riscontrabile anche inun’altra tendenza, in apparenza assaidiversa: la riproposizione dell’idea diterritorio e di piccola comunità, la ri-vincita, comunque declinata, della di-mensione locale rispetto allo Stato. Alcospetto di fenomeni e di scelte che cisovrastano, l’unica possibilità di con-servare una certa autonomia starebbe“nel ri-radicarsi nei luoghi, rinunziandoad ogni progetto a largo raggio, destinatoa diventare preda di elite sottratte adogni regola e ad ogni sanzione, chedella esaltazione della potenza e delladis-misura fanno il criterio-guida delloro comportamento”. Da qui, ad esempio, l’insistenza sui“beni comuni”. Beni da controllare egestire direttamente, sottraendoli ai luo-
ghi lontani e irraggiungibili dei “poteriforti”. “Ma – ci ricorda l’autore – ladiffidenza nei riguardi dell’astrazionela si paga duramente allorché si scoprela limitatezza proprietaria che accom-pagna questo esercizio comune del con-trollo e della cura. Infatti, se si guardala proprietà comune dall’esterno e congli occhi di altri contesti locali, essaappare come una forma di proprietàprivata che esclude tutti gli altri, nonsolo i grandi interessi, dalla fruizionedel bene. Se l’acqua è un bene comuneglobale, come può appartenere soltantoa quelle comunità nei cui terreni scorrecopiosa?”. La tensione fra inclusione ed esclu-sione, fra “insider” e “outsider”, delresto, sembra essere la cifra del nostrotempo, l’altro volto della crisi dell’u-niversalismo. Crisi dinanzi a cui emer-gono due tentativi di risposta: da unlato si vorrebbero erigere nuovi murie barriere (si pensi ai flussi migratori),dall’altro, in nome di una sorta di uni-versalismo radicale, si vorrebbe abolirepersino l’idea di cittadinanza, vistacome fonte di discriminazione. In en-trambi i casi si tratta di chimere. Piùin generale, cosa resta del nesso framodernità e rivoluzione? Sembra cheesso, nella tarda modernità, non siavenuto meno. La questione è un’altra: prevalgono digran lunga le “rivoluzioni passive” (sipensi a quelle tecnologiche) rispetto aquelle attive. Dinanzi a ciò, come pro-

/ / 87 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / schede di lettura
vare a ridare forza alla politica? Cassanoscrive che non basta un leader, pure in-dispensabile: occorre bensì “una guida,che è molto di più, una cultura fortedel cambiamento, capace di riaprire laporta del futuro”. Già, ma come? Le ri-sposte del libro paiono incerte e un po’fumose. E del resto esso si concludecon la constatazione di aver soprattuttosollevato dei problemi.
Franco Cassano, Senza il vento della storia.La sinistra nell’era del cambiamento, La-terza, pp. 92, € 12.
Viaggio nel Bel Paese
>>> Matteo Lo Presti
“Direttore, è fondamentale che gliadulti credano in noi, se sono
loro a dirci che dobbiamo andare viacome possiamo avere fiducia nel nostrofuturo e nel nostro paese?”: così un gio-vane studente si rivolge a Roberto Na-poletano, direttore del quotidiano Il Sole24 Ore, per richiamarne l’attenzione suldrammatico problema della fuga dellemigliori intelligenze dall’Italia verso piùfortunate opportunità. La testimonianzaè raccolta nel nuovo volume che RobertoNapoletano ha voluto dedicare a tutte lepersone che “soffrono, ma non si arren-dono” in una stagione nella quale civuole molto coraggio a individuare ele-menti di ottimismo nel mare tempestosodi una crisi sociale drammatica.Attraverso un itinerario che da Trentoarriva a Pantelleria, evitando con lucidastrategia piagnistei culturali e denigrazionidella politica, i giovani che Napoletanoaccoglie nella sua galleria di testimoniappaiono più pronti ad affrontare ilfuturo di quanto non lo siano le istituzionisociali ed i loro rappresentanti. Dannoper scontato che il cambiamento di pro-spettiva nella società e nel mondo del
lavoro costituisce un arricchimento; af-fermano che questo avviene in mezzo atante contraddizioni, ma ammettono cheda questo cambiamento strutturale emergela tendenza a valorizzare il confrontocon la pluralità e con la mobilità sociale.Sanno che quanto più rapidamente edestensivamente mutano le basi oggettivedella vita, del lavoro e dell’economia,tanto più si sentiranno capaci di rispon-dere alle sfide della modernità.Nella loro dimensione esistenziale vivonola società mondiale del rischio, un ritornoalle incertezze che scuote la fiducia nelleistituzioni più importanti del mondo in-dustrializzato. Sanno che, sullo sfondodel declino economico, domina la paurache un benessere ritenuto stabile possaaffondare e non riemergere più. Ma gio-cano comunque le proprie chances sulmercato del lavoro, sulla formazionedelle proprie professionalità, per evitaredi farsi travolgere da una concezionedella vita disumana. Tra intelligente utopia e impegnata con-cretezza ecco un’altra testimonianza dioggettivazione della condotta di vitapersonale: “Mi chiamo Stefano, ho 24anni. Ho conseguito una laurea sanitariaa pieni voti che mi consente di lavorarepresso un’azienda biomedicale. Il salarionetto è buono. Non posso lamentarmi.
Ho tanti sogni da realizzare e non mi ar-rendo all’idea che non si possa invertirela rotta. Le mie ali non si toccano, cihanno già provato in molti a spezzarle”.Questi sogni di cui parla il giovane Ste-fano si affacciano sui conflitti che sonouna componente dei continui cambia-menti sempre presenti nello sviluppodella storia del capitalismo globale. Mamolti giovani, fortunatamente, preten-dono di superare il rischio di una ato-mizzazione della società senza tradurloin egoismo utilitaristico collettivo. Molti– e nel libro se ne trovano tracce consi-stenti – si dedicano a interpretazioni eanalisi delle trasformazioni delle regoledemocratiche in direzione di una inte-riorizzazione, alla quale anche Napole-tano aderisce, perché lo spirito della li-bertà possa diventare ospite accettato erisolutivo nella società, magari attraversola dimensione emozionale di una soli-darietà vitale anche in una prospettivareligiosa.Le tensioni sono il nucleo centrale di di-battiti e di contrasti perenni in tutte ledimensioni della creatività umana e dellacostituzione di ogni società. La costanzadi queste contraddizioni costituisce il di-battito perenne che si è sviluppato intornoad esse e forma i modelli della modernitàmultipla sempre in evoluzione. E Roberto

/ / 88 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / biblioteca / schede di lettura
Napoletano, giornalista curioso e pacatonell’illustrarne la bontà, ha un sinceroatteggiamento di sbalordimento. Si avverteche il suo desiderio maggiore sarebbequello di presentare un viaggio nell’Italiadella modernità, ma in un’Italia che vuoleconsiderare anche un “Bel Paese”. FuAntonio Stoppani, sacerdote di Leccoche partecipò alle Cinque giornate diMilano e custode dei cataloghi dellaBiblioteca Ambrosiana, a pubblicarenel 1875 un volume di cui nessuno parlapiù, considerato capolavoro di divulga-zione scientifica sulle bellezze naturalid’Italia e appunto intitolato Il Bel Paese.Al contrario, nelle pagine del viaggioche Napoletano compie nella società ita-liana, nel Bel Paese che sogna di vederetornare a fiorire, il paesaggio è arricchitoda volti di persone di cui i talk-show ra-ramente parlano. Nel libro si naviga inun’Italia nella quale vivono energie vitali,
dai giovani che danno splendore all’in-telligenza creativa agli imprenditori in-novativi che non vogliono rinunciare adavere un ruolo nel ristabilire le condizionidi una più equa distribuzione non tantodelle risorse in sé, quanto dell’accessoalle conoscenze e quindi al benessere.Insiste Napoletano a chiedere un BelPaese, purché vi siano le condizioni percostruire progetti di una Bella Politica. E se della politica nel libro si parla, èchiaro che il riferimento ai labirinti del-l’attualità è assente. Il Bel Paese dellapolitica è esistito nel coraggio eretico diGiuseppe Di Vittorio, nel riformismocattolico di De Gasperi, nella lotta al-l’evasione fiscale di Ezio Vanoni, nellaserietà di Gabriele Pescatore, per ventidueanni presidente della Cassa del Mezzo-giorno, che da “tecnico” fu capace di ri-costruire parte dell’Italia distrutta dallaseconda guerra mondiale.
Di straziante emozione la pagina nellaquale Marina Biagi racconta gli ultimiricordi del marito Marco, giuslavoristadi specchiata laboriosità e onestà, am-mazzato da terroristi nel marzo del2002 in una strada di Bologna. Vienecitato di sfuggita anche Napoleone Co-lajanni, che ebbe con Napoletano unabella amicizia. Autore di un libro, Capi-talismi, compilato pochi mesi prima dimorire, testo di suggestive analisi sul-l’economia internazionale e troppo prestodimenticato, meritava di comparire ancheegli tra i personaggi che hanno dato alpaese tracce per renderlo più civilmentepraticabile. Un modo per onorarlo sarebbequello di potere editare i molti articoliche il burbero senatore comunista avevascritto proprio per il Sole 24 Ore.
Roberto Napoletano, Viaggio in Italia, Riz-zoli, pp.226, euro 17.

Bruxelles - Più che le parole vacue (e imbarazzate) di Junckere Renzi, valgono le immagini. Anche quelle della Merkel e diHollande. Un Consiglio europeo inutile che ha rimandato alfuturo qualsiasi argomento sostanziale. Sulle questioni eco-nomiche ci si penserà tra gennaio e giugno 2015, sulle questionidi politica estera e di sicurezza regnano le divisioni e quindinessuna decisione (tranne le nuove sanzioni alla Russia deciseda Washington). Si chiude così la presidenza italiana con nullain tasca, ma si apre quella della Lettonia, che rischia di dareuna sterzata ancor più atlantista alle posizioni Ue sulla Russia. Sul piano politico si vede una Ue confusa e divisa, su quelloeconomico una Ue che non sa più che fare. Avere approvato la“scatola vuota” del piano Juncker per la crescita non significaproprio nulla. I dettagli, cioè chi paga, restano nel campo delleipotesi. Ma da parte dei media italiani si deve dire, come infattifanno, che Renzi e Juncker sono soddisfatti: il primo perchéavrebbe (non si sa come in concreto) avuto l’approvazione allasua richiesta che gli investimenti siano scorporati dal calcolo suldeficit, e il secondo perché avrebbe incassato l’approvazione diprincipio sul suo piano a debito per la crescita. Si vede chiara,invece, una Ue sempre più piombata e incapace di decidere.Finanche sul famigerato Ttip Juncker ha detto a mezza bocca chesi continua a lavorare nella “convinzione che sarà approvato nel2015” (beato lui che ci crede ancora). Nessuna risposta politica èemersa da questo incontro di grandi leader europei. Si continuanoa raccontare fandonie nella segreta convinzione che la soluzioneai problemi europei verrà da fuori. Russia? Cina? Usa? Questileader europei sono talmente scadenti e insipienti che non si ac-corgono di essere totalmente irrilevanti per il resto del mondo. Mentre il circo dei cantori lirici europei continua a girareattorno al circolatorio Schuman di Bruxelles raccontandofiabe europeiste, Juncker vorrebbe trasformare la sua Com-missione in una power house secondo metodi e sistemi tipicidi una multinazionale: pochi programmi (circa 20 e il resto siaccantona); pochi decisori (4 super commissari che sarebberoriuniti in un gabinetto o cabina di regia); la politica estera e disicurezza nuovamente in mano alla Commissione. Insomma
dal cilindro di Juncker uscirebbe un modello Delors rafforzato.Peccato che, a giudicare dall’espressività dei visi dei leader inconferenza stampa, gli sia stato detto un sonoro no. Tutto qui:l’Europa non esiste e continua ad illudersi di esistere.Non va meglio a livello nazionale e governativo. Nessuno deipaesi europei ha ormai alcuna rilevanza internazionale. La Turchiae la Serbia scelgono rispettivamente Mosca e Pechino. La Libiapeggiora di ora in ora spaccandosi tra fazioni che poi alla fineguardano all’Egitto, non all’Italia. L’Ucraina, quasi congelata peril freddo (e gli accordi dietro le quinte), non nasconde ladisperazione per la mancanza di sostegno concreto da partedell’Ue, e quindi si appoggia malamente a russi e americani.L’Iran e la Russia, che sono oggetto di un’aggressione finanziariasenza precedenti, si piegano ma non si spezzano (anzi, rilancianofieramente guardando allo Sco). I paesi della penisola arabicarestano immobili nella loro Disneyland della repressione wahabitasenza che nessuno, Ue o Usa, dicano più una sola parola inmateria di diritti fondamentali e dignità delle persone. Mentre qualche parlamento e tribunale in Europa si esercitain dichiarazioni di riconoscimento della Palestina o di Hamas(ma da quando i riconoscimenti degli Stati li fanno i parlamentio i tribunali?), Israele fa dichiarazioni infuocate e continua larepressione nei territori cari alla cara stagière che occupa ilposto di Mrs. Pesc. Dulcis in fundo, un paesino europeo dipoco più di un milione di persone, peraltro multietnico al50%, si prende il lusso di arrestare ed espellere un cittadinoeuropeo che di professione è giornalista con il pretesto delsuo filo-russismo, mentre l’Ue è silente. La Grecia e la Spagna,ma anche l’Italia, sono allo stremo sociale e si prospettanocambiamenti di regime indotti dalla rabbia popolare: ma dallaUe arriva solo il monito sul rispetto delle regole e si rimandaqualsiasi decisione ai prossimi mesi. Aggiungiamo che ilcrollo del prezzo del petrolio e del gas, indotto da unapericolosa e miope strategia americana via Arabia Saudita,non farà crollare Russia e Iran ma Ue e Venezuela. D’altraparte, Cuba ha appena capitolato nelle mani yankee proprioper questa ragione.
/ / 89 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante
>>>> quadrante
Il semestre inutile>>>> Paolo Raffone

New York - Il valore dell’euro è sceso al livello più bassodegli ultimi anni, provocando un calo delle borse europee edestando inquietudine per una nuova crisi economica efinanziaria. Il deprezzamento della valuta si verifica in pre-senza di una sostenuta discesa del prezzo del petrolio. Unbasso costo del petrolio, in principio un fatto positivo perconsumatori e industria, suscita il timore che il declino siail sintomo di una domanda debole e il prodromo di un ral-lentamento economico globale. A causa della discesa del costo dell’energia i prezzi al con-sumo nell’unione monetaria europea si sono contratti nelmese di dicembre. Anche se una lieve riduzione non èancora conclamata deflazione (cioè un diffuso e persistentecalo dei prezzi), si consolidano le preoccupazioni per unasituazione debilitante per l’economia. Certo, l’Europapotrebbe anche beneficiare di una combinazione virtuosa dibassi tassi di interesse, petrolio a buon mercato e vantaggiocompetitivo procurato dalla debolezza dell’euro. Tuttavia,prevale la convinzione che i responsabili politici europeicontinuino a sottovalutare la minaccia di una stagnazione dilungo termine del genere di quella che ha afflitto il Giap-pone per due decadi. Lo spettro di un prolungato periodo di deflazione concedeun più ampio margine di manovra a Mario Draghi e rinvi-gorisce la previsione che la Bce interverrà con un vastoprogramma di acquisto di titoli di debito pubblico, comehanno fatto la Riserva federale degli Stati Uniti e la Bancacentrale di Inghilterra negli ultimi anni. Tuttavia permaneinsoluto il conflitto con la Germania, le cui dichiarazioniufficiali rimangono ostili alla prospettiva di un interventoespansivo di politica monetaria, poiché esso potrebbe rive-larsi inefficace e risolversi in un onere netto a carico deicontribuenti.In questo quadro di incertezze, le imminenti elezioni inGrecia concorrono ad accrescere i rischi di turbolenzefinanziarie. Tsipras, anche se ha detto chiaramente che vor-rebbe mantenere la Grecia all’interno dell’unione moneta-
ria europea, ha comunque promesso la ristrutturazione diparte del debito della nazione, la revisione di alcune misuredi austerità e la rinegoziazione dei termini degli accordicon i creditori internazionali che hanno concesso alla Gre-cia l’accesso ai fondi. Se il contagio non pare diffondersiagli altri debiti sovrani, i mercati finanziari rimangono inuno stato di allerta.A molti commentatori pare evidente che le politiche diausterità imposte alla Grecia ne abbiano aggravato e pro-lungato la recessione economica. Se Tsipras sostiene che«l’austerità è irrazionale e distruttiva», e che «per ripagareil debito, è necessaria un’audace ristrutturazione», il comi-tato editoriale del New York Times dichiara che «ulteriorisofferenze non stabilizzeranno la Grecia e non la rende-ranno capace di ripagare il debito». In sostanza non solo laprospettiva di una vittoria elettorale di Syriza non spaventa,ma sembra quasi lo sviluppo necessario di una condizionedi protratta miseria e sofferenza inutilmente inflitte alpopolo greco.Nonostante certe recenti dichiarazioni di intransigenza daparte di Germania e Commissione europea, un qualchecompromesso sul debito greco pare la strada obbligata.Dopo tutto, se la Grecia dovesse tornare alla dracma, ilpaese sarebbe scosso da uno sconvolgimento economicotale che non può permettersi. L’uscita della Grecia dall’u-nione monetaria europea non è una prospettiva desiderabileneanche per la Germania e gli altri paesi creditori, dalmomento che se la Grecia dovesse lasciare l’euro miliardidi euro dei contribuenti andrebbero perduti. Sarebbe politi-camente più agevole negoziare un compromesso con laGrecia (anche se di sostanziale ripudio di parte del debito),e mantenere la finzione che la Grecia ripagherà i suoi debitinel tempo.Mentre non cala l’apprensione per gli sviluppi della situa-zione economica dell’Unione europea, si dispiega unvivace dibattito sulle «cause della condotta russa», pren-dendo a prestito il titolo del celebre articolo di George
/ / 90 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante
>>>> quadrante
Chi ha paura di Putin e Tsipras>>>> Gaetano Bloise

Frost Kennan apparso su Foreign Affairs nel luglio del1947 e divenuto una sorta di manifesto della politica delcontenimento dell’Unione Sovietica. Nel volgere di alcunimesi, l’atteggiamento dei commentatori è passato daitimori per un redivivo imperialismo russo all’annuncio diimminente dissoluzione dell’economia russa e di deposi-zione di Vladimir Putin. Questo repentino mutamento diprospettiva è il portato della recente perdita di valore delrublo che ha gettato la Russia nel disordine economico,monetario e finanziario. Nella tradizionale conferenza di fine anno, Vladimir Putinha promesso la ripresa economica in due anni, nonostantel’incombente recessione, il tracollo del rublo e i crescentitimori di instabilità economica. Il presidente della Federa-zione Russa ha provocatoriamente addossato la responsabi-lità della turbolenza all’Occidente, adombrando l’ipotesi diun obiettivo geopolitico occidentale volto a limitare l’in-fluenza di Mosca. In sostanza, Putin è parso prepararsi adanni di conflitto con l’Occidente, seppure assumendo toni
lievemente più concilianti sulla pace in Ucraina orientale.Poco dopo la conferenza stampa di Putin, Barack Obama havarato un provvedimento che concede alla Casa Bianca ilpotere di comminare ulteriori sanzioni alla Russia e di con-solidare il sostegno militare all’Ucraina, anche se nelledichiarazioni ufficiali il Presidente ha detto che per ora nonha intenzione di utilizzarlo. Dal canto suo il Consiglioeuropeo ha confermato il mantenimento delle sanzioni, e ilsuo nuovo presidente, Donald Tusk, ha espressamentedichiarato che «la sfida odierna più importante è la con-dotta della Russia non soltanto verso l’Ucraina, ma ancheverso l’Unione europea».La Russia di Putin non ha retto alla proiezione di potenza.Al principio della crisi di Crimea era quasi parso che Putinavesse scongiurato le nefaste conseguenze economiche diun’espansione territoriale. La speranza di inarrestabile vit-toria si è� però infranta di fronte alla diminuzione delprezzo del petrolio, un evento esogeno secondo alcuni, esecondo altri indotto dagli Stati Uniti di concerto con l’A-
/ / 91 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante

rabia Saudita. Con la conseguente flessione dei proventi (ilpetrolio incide per quasi i due terzi delle esportazionirusse), l’economia russa è entrata in recessione e i capitalihanno abbandonato la valuta, provocandone il deprezza-mento immediato. Nonostante i rassicuranti propositi difine anno, per tutto il protrarsi del conflitto ucraino difficil-mente Putin riuscirà a persuadere i capitali a tornare in Rus-sia se il corso del petrolio rimane ai livelli correnti.Secondo alcuni commentatori, si profila il collasso dell’in-tero ordine economico e politico delle Russia post-sovie-tica, nonché il declino politico di Vladimir Putin. In questecondizioni, con un minimo esercizio di pressione econo-mica, l’Occidente sarebbe in condizione di influire sulcorso della politica estera (determinando una soluzionedella crisi della Crimea con l’accettazione dell’entratadell’Ucraina nel blocco atlantico), e della politica interna,promuovendo una riforma delle istituzioni politichesecondo i principi liberali occidentali. Questo ottimismonon è però unanime. Altri commentatori avvertono che lapopolazione russa potrebbe accogliere l’appello di Putin eaccettare il fardello dell’austerità economica in difesa diindipendenza e sovranità, ipotesi corroborata da esempistorici di straordinaria resistenza del popolo russo di frontealle avversità. In ogni caso il rapido deterioramento della situazione econo-mica russa stringe Putin in una morsa, e secondo alcuni com-mentatori potrebbe innescare una spirale perversa. Se gli StatiUniti e l’Unione europea intensificano le sanzioni economi-che in queste circostanze di estrema vulnerabilità della Rus-sia, rafforzano la convinzione di Putin sull’esistenza di undisegno occidentale per il cambio di regime, per cui nessunbeneficio può derivargli da eventuali concessioni all’Occi-dente. Dall’altro lato, avendo avuto manifesta evidenza dellafondamentale debolezza della Russia, gli occidentali diven-gono restii a concedere spazi di manovra a Putin. Da ambo leparti, insomma, gli ambiti di negoziato si restringono.Con niente da perdere, il Cremlino potrebbe agire anche inmodo più aggressivo, una involuzione presa in seria consi-derazione su Foreign Affairs e su National Interest, la rivi-sta della scuola realista americana. In questo scenario Putindovrà sopravvivere all’inevitabile contraccolpo politico e ilsolo appello ai sentimenti nazionalisti potrebbe rivelarsiinsufficiente, poiché è probabile che i russi non siano di-sposti a un ritorno permanente alle condizioni di miseriadell’ultimo decennio del secolo passato. Per mantenere ilpotere, Putin dovrà abbandonare ogni parvenza di governo
democratico e di Stato di diritto, e riesumare lo Stato dipolizia del regime sovietico. Non può essere esclusa unarepressione violenta di ogni opposizione interna per l’in-staurazione di un nuovo corso. Se l’analisi prospettata tiene, ne segue un importaterisvolto di politica estera. Bisogna impedire che Putin siincammini lungo un tale percorso, poiché, compiuti i primipassi, diventerà molto più difficile recedere. I governioccidentali devono quindi fare il possibile per convincerloa fare un passo indietro dal baratro, anche se questo signi-fica, come consigliato da Kennan nel 1947, «lasciare lastrada aperta a una condiscendenza non troppo dannosa peril prestigio russo». D’altra parte anche Henry Kissinger, inun’intervista allo Spiegel, ha ammesso che le azioni dellaRussia in Ucraina sono state una reazione (seppure ingiu-stificabile) a un improvvido ampliamento della sfera diinfluenza americana.
/ / 92 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante

Shanghai - L’8 gennaio 2015 si è aperto a Pechino il primoforum interministeriale tra la Cina e la Comunità degli Stati la-tinoamericani e dei Caraibi (Celac), organizzazione costituitanel 2011 con l’obiettivo di consolidare l’integrazione regionalee ridurre l’influenza americana in America Latina, e compostada 33 paesi rappresentanti di 550 milioni di persone, un vastomercato e preziose riserve di idrocarburi. Il forum rappresentaun importante risultato diplomatico della politica estera cinesenel continente americano e un’importante risposta allo storicodisgelo tra Washington ed Avana annunciato da Barack Obamail 17 dicembre scorso. La visita del presidente cinese Xi Jinpingin America Latina a luglio aveva peraltro portato ad un ulterioreconsolidamento delle relazioni con i paesi della regione.
Formalmente il forum aveva l’obiettivo di definire regole eforme per il dialogo interregionale futuro e costituire un si-stema permanente di garanzia per cementare di volta involta il consenso politico necessario ad implementarepolitiche per lo sviluppo. Per quanto riguarda i contenuti, leeconomie regionali hanno da tempo manifestato interessead incrementare il volume degli scambi con la Cina, attiran-done investimenti diretti a sviluppare le economie locali eridurre il livello di dipendenza politica da Washington. LaCina ha già promesso di portare il valore degli investimentia 250 miliardi entro i prossimi dieci anni, e di mirare ad unraddoppio del valore dei commerci bilaterali fino a 500miliardi entro la stessa data: un risultato che sarebbe molto
/ / 93 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante
>>>> quadrante
Il Beijing Consensus>>>> Emanuele Scansani

importante, ma ancora molto lontano dal valore degli scambicon il nord America.Il Celac diventa dunque per la Cina un importante canale di pe-netrazione geopolitica nel backyard americano, aiutando lacrescita di una piattaforma regionale nata con l’obiettivo di in-tegrare gli Stati riducendone la dipendenza dall’orbita nord-americana. Ricalcando un modello di politica estera usato anchenell’Africa subsahariana, la Cina ha partecipato al forum usandoil linguaggio caratteristico delle relazioni estere di Pechino:crescita condivisa, partnership tra eguali e win-win cooperation.Tale linguaggio viene anche accompagnato regolarmente dallaspecificazione che le partnership costruite con la Cina non as-sumeranno mai le forme ingiuste del colonialismo: una retoricache trova facile sostegno in regimi autoritari spesso stigmatizzatidai paesi occidentali. Eppure, gli investimenti diretti cinesivengono effettuati in settori strategici, legati all’estrazione dirisorse o allo sviluppo di infrastrutture idonee alla distribuzionedelle merci cinesi, mentre i finanziamenti vengono preferibilmenteprogrammati con la formula del cash-for-oil. In questa prospettiva,dopo l’apertura storica di Obama a Cuba (membro Celac)soltanto pochi giorni prima, il forum di Pechino acquisivaancora più importanza, costringendo la Cina a dimostrarsipartner alternativo e preferibile a Washington.Tra i maggiori beneficiari figura il Venezuela. Il crollo deiprezzi petroliferi ha infatti incoraggiato il presidente venezuelanoNicolas Maduro a guardare con inesorabile necessità a Pechinoper un prestito in grado di salvare l’economia di Caracas dalrischio di default. Fonti venezuelane, non confermate da Pechino,indicano che Caracas abbia ricevuto un bailout da almeno 20miliardi di dollari per salvare il paese, anche se non è chiaro sesi tratti di un nuovo prestito o di un valore aggregato inclusivodei precedenti finanziamenti. Dal 2007 la Cina ha dato aCaracas prestiti per quasi 50 miliardi di dollari in cambio dipreziose consegne di idrocarburi; secondo l’Agenzia internazionaledell’energia il Venezuela consegna quotidianamente a Pechinoquasi 524,000 barili di greggio e altri derivati, buona parte deiquali contribuiscono al pagamento di prestiti esistenti.Soltanto pochi giorni prima del forum di Pechino la Cina si eralanciata al soccorso dell’economia russa con una dichiarazioneufficiale del ministro degli Esteri Wang Yi e un impegno a so-stenere currency swaps in rubli e yuan per un ammontareiniziale di 25 miliardi di dollari. L’impegno in aiuto dellaRussia, oltre ai prestiti verso l’America Latina, rappresentanoun ulteriore segnale di declino del sistema post-bellico diBretton Woods e un chiaro messaggio che Pechino non intendecontinuare ad accettare un ordinamento economico globale so-
stenuto da Washington e Tokyo. Il 24 ottobre 2014 Pechino hadato vita alla Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib),un’istituzione finanziaria finalizzata a fornire finanziamentidiretti a progetti infrastrutturali tesi a sviluppare un’integrazioneeconomica asiatica alternativa all’ordinamento costruito sullaWorld Bank e la Asian Development Bank (Adb). L’Aiib vedela Cina al suo centro con lo stanziamento in due fasi di unfondo di 100 miliardi di dollari per l’avvio delle operazioni fi-nanziarie. Soltanto le pressioni americane hanno spinto Australiae Corea del Sud a ritirare la loro adesione.Sul fronte europeo, il primo ministro Li Keqiang ha partecipatonei Balcani al terzo meeting dei capi di governo di Cina epaesi dell’Europa centro-orientale tenutosi in Serbia il 15-17dicembre. La regione rappresenta un elemento chiave neirapporti sino-europei, dato il posizionamento geografico e ilpotenziale mercato di sbocco per le merci cinesi: nel 2014l’interscambio commerciale tra la Cina e i paesi della regioneha oltrepassato i 50 miliardi di dollari, in crescita rispettoall’anno precedente. La visita di Li Keqiang, il primo capo digoverno cinese a visitare la regione in quasi trent’anni,coincideva peraltro con la crisi economica russa, alimentandol’impressione che le relazioni delle economie balcaniche versoest debbano spingersi oltre Mosca. Oltre alla firma di unaccordo per la costruzione di una linea ferroviaria ad altavelocità tra Budapest e Belgrado, Li Keqiang ha voluto evi-denziare ai partner balcanici come la Cina voglia investirenella regione per la creazone di una grande tratta marittima eterrestre in grado di connettere velocemente il porto del Pireoai mercati della regione, agendo anche come punto di accessoall’Unione europea. Per raggiungere questo obiettivo Pechinoha promesso la costituzione di un fondo di finanziamentodegli investimenti in loco pari a tre miliardi di dollari.Le infrastrutture d’avanguardia della regione si connetterannoanche a quelle della nuova Via della Seta eurasiatica e del fondo
/ / 94 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante

da 40 miliardi di dollari che è stato annunciato il mese scorsoper sostenere lo sviluppo dei collegamenti ferroviari e stradaliprevisti. Una visita ufficiale di Li in Kazakistan e un incontrocon il collega kazako Karim Massimov a metà dicembre sonorisultati nella firma di ulteriori accordi di cooperazione dalvalore di 14 miliardi, confermando la Cina come suo maggiorepartner commerciale. La condivisione di un enorme confine e laconvergenza di interessi per lo sviluppo della nuova rottaeurasiatica, senza tralasciare le abbondanti riserve energetichekazake e il fabbisogno cinese, porteranno ad un ulteriore avvici-namento non solo energetico e commerciale tra Astana e Pechino,facendo del Kazakistan un partner strategico.Mosca non ha fino ad oggi lamentato conflittualità particolaricon la Cina in Asia Centrale: i piani cinesi, insomma, non sa-rebbero in contraddizione con l’Unione Eurasiatica (Uee)voluta da Mosca. Questa, lanciata il maggio scorso tra Russia,Bielorussia e Kazakistan, ha l’obiettivo di costituire unospazio commerciale e geopolitico senza dogane destinatoanche ad estendersi alle altre quattro repubbliche centrasiatiche.A fare da collante tra le due superpotenze anche il problemadel terrorismo, dopo che l’Isis ha cercato di penetrare iltessuto dei militanti islamici nella Valle del Fergana.Da queste manovre diplomatiche verso l’America Latina,l’Europa centro-orientale e verso l’Asia Centrale, emerge
una formula politica destinata a continuare nel breve e mediotermine, rendendo la Cina il paese leader tra i Brics, dataanche l’influenza negativa del crollo dei prezzi petroliferisull’economia russa. Viene dunque a costituirsi una megasfera di influenza su cui Pechino ripone molta fiducia perpoter incassare sostegno diplomatico a fronte di possibilicrisi internazionali future: da un’escalation nei rapporti conTokyo ad un conflitto - sempre possibile - con Taiwan (dovele ultime elezioni locali hanno assestato un duro colpo alpartito pro-Pechino di governo, innescando un terremotopolitico in seno al Kmt); dalla spinosa disputa territoriale nelMar Cinese Meridionale ad un possibile conflitto con l’India.Un eventuale aumento del grado di coinvolgimento cinesenei mercati obbligazionari europei porterebbe ad un ulterioreavvicinamento a Pechino e ad un approfondirsi delle con-traddizioni nei rapporti commerciali e politici con gli alleatistorici a Washington. Il Beijing Consensus, modello alternativoal Washington Consensus del ventesimo secolo, per certiaspetti fallimentare, continua dunque a riscuotere un successogeneralizzato, e non soltanto tra i paesi in via di sviluppo chene sono i beneficiari principali. Eppure continua a promuovereun modello politico autocratico e di capitalismo di stato cherischia di indebolire lo sviluppo delle istituzioni politiche efinanziarie globali.
/ / 95 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante

Roma - Nella sua ultima nota Gaetano Bloise ci chiama a unariflessione sul tema delle sanzioni: una riflessione peraltromai veramente iniziata, almeno nel vecchio continente, dovequesto strumento di politica internazionale non gode dibuona fama: perchè ingiusto (sono i cittadini innocenti e noni governanti a pagarne il prezzo); perché inadeguato (c’è unaviolazione dell’ordine internazionale e la reazione è molle);perché improprio (si interferisce negli affari interni); e soprat-tutto perché inutile, cioè incapace di modificare i comporta-menti dei reprobi di turno.E però, mentre ci baloccavamo con i nostri ricordi, la realtàinternazionale andava mutando radicalmente sotto i nostriocchi: soprattutto dopo la fine del secolo breve. Così, nell’u-niverso di oggi, le sanzioni sono diventate uno strumentoassai efficace. E precisamente nel senso di cambiare la con-dotta dei “sanzionati”. Il caso più clamoroso quello del Suda-frica: ma ce ne sono molti altri, a partire dall’IranNaturalmente, l’efficacia di uno strumento dipende da chi lo
usa. Dal fatto che nello specifico, scomparsi l’Urss e l’universodella guerra fredda, il “sanzionismo”sia diventato uno dei car-dini della politica estera americana, per il combinato dispostodi elementi presenti nel dna della nazione americana e dellastessa evoluzione del quadro internazionale. Nel dna c’è la“mission”: l’idea di essere chiamati a costruire un mondo - coni suoi valori, le sue regole e, appunto, le sue sanzioni - a propriaimmagine e somiglianza; nell’evoluzione del quadro interna-zionale, una prima fase in cui il sogno sembra avverarsi. In economia c’è il Washington consensus, in politica le guerreumanitarie con l’avallo esplicito o silenzioso dell’Onu. Poiavremo Bush, le guerre unilaterali e il disastro iracheno.Rispetto al quale la linea delle sanzioni sarà un eccellentepiano B. Perché non ha bisogno dell’avallo Onu (mentre puòpiù facilmente coinvolgere l’Europa); perché limita al mas-simo il fattore rischio; perché è raccomandabile nello schemacosti-benefici; e infine perché nel quadro di economie semprepiù globalizzate danneggia, e in modo serio, i paesi colpiti.Sino a spingerli a mutare condotta.Nel caso iraniano, l’evidenza è incontrovertibile. Il suo interogruppo dirigente vuole negoziare con gli Stati Uniti. E sututto. E ciò per arrivare alla fine di sanzioni che, per sua stessaammissione, ne strozzano l’economia. Ma lo è anche nel caso
russo. Prese di distanza dai ribelli. Riconoscimento dellalegittimità del governo di Kiev. Disponibilità a negoziare conquesto. Però, come diceva Stalin buonanima, il successo puòdare le vertigini. Portando a mutare, agli occhi di chi lo pra-tica, la stessa natura del meccanismo sanzionatorio.Per dirla in sintesi, questo non è un più un mezzo ma un finein sé. Uno strumento di punizione, tendenzialmente perma-nente, in cui si colpisce un regime non per quello che ha fatto(colpa specifica) ma per quello che è (colpa esistenziale). E’il ritorno dello schema buoni/cattivi, in cui è dato ai primi - ecioè agli avversari diretti dei cattivi - la possibilità di definirela natura e le intenzioni di questi ultimi. E senza essere mairealmente contraddetti.Così sarà Israele a spiegare al mondo le sinistre intenzioni diTeheran. Così saranno i nazionalisti giapponesi o taiwanesi adenunciare le mene espansioniste di Pechino. Così, nel casoche ci interessa, saranno gli ipernazionalisti di Kiev (e soprat-tutto di Leopoli) a parlare di terza guerra mondiale, a chiederel’entrata immediata nella Nato e - udite udite- l’espulsionedella Russia dall’Onu, bussando per intanto ad armi e quat-trini: armi dagli americani (ben lieti di ottemperare); daglieuropei, quattrini e tanti: da 10 a 15 miliardi subito, per nonandare falliti, in un quadro in cui, diversamente dal passato, èl’Ucraina che ha tutto l’interesse a esacerbare lo scontro.Una valutazione che può essere condivisa oppure no. La cosastraordinaria è che - a quanto Bloise ci riferisce - il temaUcraina (e con esso quello del che fare per risolvere la crisi)sia sostanzialmente assente nel dibattito politico americano.Abbiamo il Colpevole: Putin. Abbiamo le sanzioni: date perscontate. E allora ci si interroga sulla conseguenze. Probabileuna crisi profonda dell’economia russa. Superabile? Insupe-rabile? È da vedere. Ci sarà, allora, il segretamente auspicatoregime change? Del tutto impensabile. Più che probabile,allora, l’irrigidimento dello stesso regime, almeno in politicainterna. Ma cosa può comportare tutto questo in politica inter-nazionale (un tema che meriterebbe la massima attenzione, ameno di pensare che gli americani possano, insieme, dichia-rare guerra all’Isis e darla sul muso a russi, cinesi, iraniani,nordcoreani e quant’altro)? Su questo non ci si interroga, onon ci si interroga a sufficienza. Attendiamo rassicurazioni daBloise. Se non dovessero venire, siamo messi male.
/ / 96 / /
mondoperaio 1/2015 / / / / quadrante
>>>> quadrante
Le eque sanzioni>>>> Alberto Benzoni