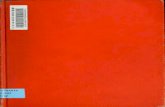Paganini AND ITALIAN enius
Transcript of Paganini AND ITALIAN enius
CDS7903 (DDD)
Paganini AND ITALIAN geniusN I C O L Ò P A G A N I N I ( 1 7 8 2 - 1 8 4 0 )
Capriccio a Violino solo “In cor più non mi sento” M.S.44 - Andante-Presto W P R 03:31“Alla spagnola” W P R 00:34Valtz in A major M.S. 80 W P R O F T H E C R I T I C A L E D I T I O N 01:44Canon Duet No.1 in A major for two violins W P R 01:20Canon Duet No. 2 in B flat major for two violins W P R 01:47Valtz No. 1 in F major W P R 00:45Valtz No. 2 in E major W P R 00:46Valtz No. 3 in A major W P R 00:48Valtz No. 4 in G major W P R 00:51Valtz No. 5 in A major W P R 00:52Caprice d’adieu M.S.68 - Allegro moderato W P R O F T H E C R I T I C A L E D I T I O N 03:20
O N O R I O D E V I T O ( 1 7 9 2 - 1 8 4 4 )3 Variations and Coda on the Neapolitan Folk Song “Io te voglio bene assaje” (1840) W P R 03:54
G I U S E P P E A U S T R I ( 1 8 2 3 - 1 8 8 4 )Caprice Op. 9 No. 1 in G major (1852) - Allegro moderato W P R 01:50
B E R N A R D O F E R R A R A ( 1 8 1 0 - 1 8 8 2 )From 6 Preludes dedicated to the friend Dionigi Torre (1870) 10:02
Prelude No. 3 in G major - "Scherzo and Cantabile" W P R 04:30Prelude No. 5 in D major - "The Stream" W P R 02:23Prelude No. 6 in A major - "Introduction and Scherzo fantastico" W P R 03:09
F E R D I N A N D O G I O R G E T T I ( 1 7 9 6 - 1 8 6 7 )From 6 Preliminary Etudes to Paganini Caprices Op. 28 (1849) 08:54
Etude No. 5 in d minor - "Prelude and Caprice" W P R 02:49Etude No. 2 in A major - Allegro moderato (with 2nd violin) W P R 03:52
01
02
03
04
05
06
10
11
12
13
14
16
17
07
08
09
15
18
Etude No. 6 in D major - Allegro un poco mosso W P R 02:13
C A R L O B I G N A M I ( 1 8 0 8 - 1 8 4 8 )From 12 Violin Caprices (1828) 08:27
Caprice No. 6 in D major - Allegro W P R 03:52Caprice No. 4 in E flat major - Allegro assai W P R 01:47Caprice No. 12 in d minor - Allegro con forza assai W P R 02:48
R U N N I N G T I M E 5 0 : 0 5
M A R C O R O G L I A N O , V I O L I N ( S )
Violin Nicola Bergonzi, Cremona 1790 trusted by Maggini Foundation - Langenthal (Switzerland)Bow: Francois Lupot, Paris 1830 ca.
20
22
19
21
L e opere per violino solo di NicolòPaganini, come documenta il nuovoCatalogo tematico, costituiscono un
corpus a sé stante e rappresentano un aspet-to particolarmente significativo della sua pro-duzione musicale. Tale produzione, che vedeal centro i 24 Capricci op. 1 pubblicati daRicordi nel 1820, comprende composizioni divario carattere e struttura scritte in momentidiversi, quali Inno patriottico M.S. 81, Temavariato M.S. 82 e Sonata a violino solo M.S. 83appartenenti al periodo giovanile (probabil-mente prima del 1805), il Valtz M.S. 80 com-posto probabilmente a Genova nel periodo1803-1805, la Sonata a violino solo M.S. 6(nota anche come Merveille de Paganini)scritta nel periodo lucchese (1805-1809) ealtri brani appartenenti a un periodo successi-vo quali Capriccio a violino solo M.S. 44 del1821 su “In cor più non mi sento”, Capriccioper violino solo M.S. 54, un singolare branovergato su quattro pentagrammi scritto aVienna nel 1828, le variazioni su God SaveThe King M.S. 56 del 1829 e il Caprice d’adieuM.S. 68 del 1833. A questi titoli si aggiungonocomposizioni recentemente ritrovate come leContradanze inglesi M.S. 136 e i Quattro studiM.S. 138, opere appartenenti ad un periodoprecedente ai Capricci op. 1, e alcuni braniqui proposti in questo cd, quali Alla spagnola,2 Duetti in forma di canone e 5 Valtz.
Il Capriccio per violino solo “In cor più non misento” M.S. 44 composto nel 1821, è unbrano pochissimo noto nella stesura autogra-
fa in due movimenti, Andante e Presto, rispet-tivamente il tema variato di Paisiello (scritto sudue pentagrammi per l’effetto arco-pizzicato)e una variazione brillante. Nota è invece laversione tramandata da Carl Guhr (ricostruita“a memoria”) che reca il titolo Introduction etVariations sur le Thème «Nel cor più non misento» pour le violon seul de Nicolo Paganini,contenuta nel suo trattato Über PaganinisKunst die Violine zu spielen (Mainz, B.Schott’s Söhnen, 1829), che comprende,oltre all’Introduzione e al Tema, sette variazio-ni, l’ultima delle quali corrisponde quasi esat-tamente con il Presto della versione in duemovimenti. Per lungo tempo si è pensato chequest’ultima versione fosse una sorta di“prima stesura”, non cogliendo l’originalitàdel brano. L’ Andante è caratterizzato dal temadi Paisiello che si presenta in forma variata,con alcune figurazioni ritmico - melodichediverse rispetto alla “versione” tramandata daGuhr, più articolate e originali. Il Presto checostituisce la variazione, come si è detto corri-sponde alla settima variazione presente inGuhr dove si registrano, anche in questo caso,piccole ma significative differenze.
Alla spagnola, composizione autografa recen-temente ritrovata, è una pagina di breve respi-ro di struttura tripartita (a-b col Da capo) dovenon è difficile scorgere la grandezza del musi-cista genovese anche nelle piccole composi-zioni. Il brano corrisponde parzialmente alMinuetto (Allegretto mosso), parte di violino,del Quartetto n. 12 per violino, viola, violoncel-
5
lo e chitarra (M.S. 39), anch’esso nella tonalitàdi la minore, le cui 32 misure iniziali corrispon-dono sostanzialmente alle 16 battute conritornelli del piccolo brano per violino. Non èimprobabile che Paganini abbia ripreso il branoper svilupparlo e collocarlo in un contesto piùampio ed elaborato come fece, ad esempio, peril Valtz del Cantabile a Minuetto e Valtz (M.S. 126)per violino e chitarra che, notevolmente svilup-pato e ampliato, divenne il Rondò del Quintoconcerto per violino e orchestra (M.S. 78). Ildiverso titolo, e la differente struttura ed ampiez-za (il Minuetto consta di 733 misure), portano aconsiderare Alla spagnola come brano a séstante e non una sorta di “studio preparatorio”.La composizione, ritrovata nel manoscritto auto-grafo «M.S. Cas. 5630» (custodito presso laBiblioteca Casanatense di Roma) comprenden-te tre altri brani completi, documenta una curio-sa abitudine di Paganini: appuntare idee musi-cali (schizzi, abbozzi) ovunque trovasse spazio,su fogli sciolti piuttosto che su carte assemblate,assieme ad altre composizioni di diverso organi-co, come è successo anche per i 5 Valtz, comesi dirà più avanti.
Il Valtz in La maggiore M.S. 80 è una brevecomposizione che curiosamente si trova col-locata all’interno del manoscritto autografodelle 37 Sonate per chitarra M.S. 84. Il brano,di struttura tripartita (a-b col Da capo), nellaprima parte (poi ripresa) è impostato in Lamaggiore ed ha un carattere gioiosamenteestroverso, mentre la parte centrale, in laminore, ha un carattere più dolce ed espressi-
vo. Il Valtz, fra l’altro, corrisponde alla parte diviolino primo del Valzer n. 2 dei Divertimenticarnevaleschi, una serie di musiche perdanze composte per il «Festone deiGiustiniani». Potrebbe quindi trattarsi di unautoimprestito, peraltro non così raro inPaganini.
I 2 duetti in forma di canone per due violini, rap-presentano a tutt’oggi un unicum nella produ-zione musicale di Paganini. Il titolo, mancantenell’autografo, è ricavato dalla struttura dei duebrani che sono realizzati per l’appunto in cano-ne all’unisono. L’organico, non esplicitato nel-l’autografo, non lascia spazio a dubbi: la nota-zione musicale con uso di bicordi e l’indicazione«pizzicato» posta in coda al brano ne chiarisco-no senza incertezze la destinazione strumenta-le. Essi si trovano nello stesso manoscritto auto-grafo che comprende la Canzonetta per canto(sic!) e chitarra (M.S.121) e alcuni schizzi (ottomisure di una «Polacca», e una serie di accordiabbozzati sui quali c’è scritto «Ghiribizzi») estra-nei sia alla Canzonetta sia ai 2 duetti. La man-canza di date e altri riferimenti utili a contestua-lizzarli induce solo a fare ipotesi sui due brani,che potrebbero appartenere al periodo giovani-le di Paganini, quando egli si trasferì a Parma(1795) per studiare con Alessandro Rolla e, suc-cessivamente, con Gasparo Ghiretti, «violoncel-lista di Corte e celebre contrappuntista», con ilquale lo stesso Paganini dichiarò nell’autobio-grafia dettata a Lichtenthal, di aver studiato con-trappunto e di aver scritto sotto di lui «una granquantità di musica istrumentale».
6
I cinque Valtz (il quinto in realtà costituisce laprima stesura del n. 3) per violino, si trovanocuriosamente all’interno dell’autografo deiGhiribizzi per chitarra M.S. 43, una raccolta dipiccole composizioni scritte nel periodo 1819-1820. L’autografo è privo di data, ma visto ilgenere e le caratteristiche musicali, essi si pos-sono collegare, come il ValtzM.S. 80, allo stessoperiodo dei Divertimenti carnevaleschi M.S. 4.Sono brani di breve respiro, di relativo impegnostrumentale ma molto gradevoli, la cui strutturamusicale è semplice e si articola perlopiù informa bipartita (8+8 misure) con ritornelli.
Il Caprice d’adieu ci è noto attraverso l’edizio-ne a stampa dei Six Caprices Caractéristiquespour le Violon op.12 composti da EduardEliason, pubblicati da B. Schott nel 1833, incui il Capriccio di Paganini appare come‘appendice’. Il brano, le cui dimensioni e strut-tura tripartita (a-b-a) compresa tra due ritor-nelli seguono il modello di alcuni dei Capricciop. 1, ha un carattere più leggero e scherzo-so, tecnicamente meno complesso rispetto aquesti ultimi. La scrittura musicale è perlopiùa due parti nelle sezioni ‘a’, mentre nellasezione centrale la notazione si fa più articola-ta e contrastante anche nelle dinamiche dove,fra l’altro, si registrano passaggi tecnici nonproprio semplici (ad es. accordi con trilli nellaparte interna), elementi che certamente ren-dono interessante e degna di attenzione que-sta pagina, forse un po’ troppo trascurata.
Italo Vescovo
Completa il programma del cd una serie dibrani scaturiti dal ‘modello’ paganiniano siaper quanto attiene la forma sia la tecnica sia ilcontenuto e tutti composti da musicisti cheebbero con Paganini contatti diretti ora dinatura lavorativa ora di semplice frequentazio-ne personale. La forma libera del Preludio odel Capriccio o dello Studio, nel quale si celail capriccio, o delle variazioni su tema notosono il repertorio più diffuso nel corsodell’Ottocento tra i virtuosi itineranti. Nella lorosuccessione questi brani permettono di avvi-cinare e comprendere il gusto e l’estetica diquel momento nelle varie scuole d’Italia: dallanapoletana alla milanese passando perFirenze e l’Emilia. Il loro interesse e la loro ori-ginalità consistono dunque non tanto nellatipologia delle articolazioni o delle figurazioniin sé, ma nelle modalità in cui queste sonoapplicate, nelle soluzioni di elaborazione evariazione di volta in volta adottate che tendo-no a emulare, certamente, ma anche a sopra-vanzare il modello, senza dimenticare il belcanto e talvolta anche lasciandosi sedurre dalrichiamo della musica descrittiva.
Onorio De Vito (Arpino 1792 - Napoli 1844), fudocente di violino nel conservatorio napoleta-no, dove riuscì a vivacizzare la didatticacreando una scuola fondata su nuovi metodie tecniche. I 36 Capricci per violino diFederico Fiorillo e i Ventiquattro capricci aguisa di studi di Rode erano il fondamento delsuo insegnamento che si estese negli annianche in altre istituzioni cittadine e nelle città
7
8
limitrofe. In contatto con alcune personalità dispicco della cultura (Masseangeli), è ammira-to da alcuni tra i più noti compositori deltempo: Rossini, Donizetti, Mercadante, Spohr,Lipiński e Paganini appunto, col quale intrec-cia una corrispondenza dal 1819 almeno sinoal 1836. Gli argomenti delle missive sono perlo più legati a piccoli favori, a segnalazioni digiovani violinisti e a consulenze tecnichesoprattutto incentrate sulla qualità delle cordeche per Paganini si rivela spesso un’ossessio-ne. Le Tre variazioni e coda per violino solosul motivo popolare Te voglio bene assaiecomposte a Napoli nel 1840 e conservate siamanoscritte che nell’edizione a stampa a curadi Girard, si inseriscono nel novero dei pezzidi bravura scaturiti da temi conosciuti e rap-presentano la tipologia di brano più presentenel catalogo di De Vito. La prodigiosa abilitàdi esecuzione e la memoria che sembra con-traddistinguessero la sua personalità (si narrache, non avendo potuto recuperare la partitu-ra, abbia trascritto col solo ausilio mnemonicoi Capricci e alcune variazioni di Paganiniascoltati durante un concerto) lo portano aideare brani di alta complessità nei quali alli-nea figurazioni e articolazioni virtuosisticheche in Napoli lo imposero come «uno dei piùincantevoli suonatori che da Tartini abbia maiavuto l’Italia».
Il piacentino Giuseppe Austri, allievo diGiuseppe Jona e di Carlo Bignami, prodigio-so virtuoso di violino, fu docente dal 1855della scuola comunale di musica di
Fiorenzuola, nonché violino a capo dell’or-chestra nelle stagioni liriche al TeatroMunicipale di Piacenza dove concertò operedi Verdi e di Meyerbeer. Ampiamente ammira-to dal pubblico di varie capitali europee(suonò anche a Odessa, Leopoli e SanPietroburgo) per «franchezza d’esecuzioneche tocca l’ardimento, foga nella passioneanimatrice di quell’archetto che imprime aisuoni una irresistibile potenza nei motivi vuoilieti vuoi patetici, volubilità, incomparabilepadronanza del suo strumento, buon gustosquisito nelle composizioni, fluidità e chiarez-za in quelle note sì ben staccate e granite», fuspesso paragonato al «celebre Paganini» ecomunque reputato «uno dei migliori concer-tisti dell’età nostra» (Casamorata sullaGazzetta musicale di Milano nel 1851).
Bernardo Ferrara, formatosi alla scuola delpavese Alessandro Rolla, venne chiamato daPaganini ad occupare il posto di primo violinonell’ambito della riformanda orchestra diParma. Il progetto di riorganizzazione chePaganini intendeva compiere purtroppo nau-fragò anche perché Ferrara dopo pochi mesiabbandonò l’incarico, avendo ricevuto larichiesta di sostituire il suo maestro in conser-vatorio a Milano. Dopo aver tentato senzagrandi riconoscimenti la via del concertismosolistico, il violinista preferì dedicarsi all’attivi-tà orchestrale e didattica compilando ancheopere (metodi e studi) di notevole interesse evalide ancora oggi nell’insegnamento. Se idue Capricci che compongono l’op. 9 di
Austri sono dedicati a Giacomo Costa, illustremaestro di Paganini e Sivori, i Preludi diFerrara sono invece dedicati a un compagnodi studi, a un amico violinista, collega in diver-se accademie: il milanese Dionigi Torre.
Anche Ferdinando Giorgetti fu ammirato perle doti esecutive che manifestò già in teneraetà calcando i palcoscenici europei.Animatore della vita musicale fiorentina e pro-motore della musica strumentale con una par-ticolare attenzione per quella tedesca (da quiil divertente epiteto di tedescone), ebbe mododi entrare in contatto con Paganini al qualededicò anche i Tre gran trii di una difficoltàprogressiva e il Gran trio di una difficoltà parti-colare. I suoi Studi op. 28 sono espressamen-te composti «per servire di esercizio prelimi-nare a quelli di Paganini» e dominati da unelevato virtuosismo, nonché minuziosamente«corredati di tante segnature perché fosserocondotti a quella perfezione di esecuzione,che forma uno dei più bei pregi nelle arti tutte,e che è poi, io credo, essenzialissima nellamusica in ispecie».
Il cremonese Carlo Bignami, passato alla sto-ria come epigono di Paganini, svolse in realtàun ruolo autonomo e molto significativo nel-l’ambito della sua città. Insieme a RuggeroManna e ad altri amici contribuì a rivoluziona-re la vita musicale di Cremona, attuando unrinnovamento radicale dell’orchestra cittadinae dando vita a istituzioni di supporto all’inizia-tiva. Anziché intraprendere la carriera di vir-
tuoso itinerante, Bignami preferì rimanerestanziale, riscuotendo comunque l’ammira-zione della critica – che riconosceva in lui un«suonatore di una robustezza unica: egliriusciva meravigliosamente soprattutto nellaesecuzione della musica brillante e nel gene-re staccato» – e di Paganini stesso, che loesortava a muoversi e a non poltrire, metten-do a frutto i propri talenti. I 12 capricci per vio-lino solo, dedicati al conte Arrivabene, sonotra poche sue opere date alle stampe.
Mariateresa Dellaborra
“Un violinista eccezionale sotto ogni aspetto”(Ruggiero Ricci)
“Rogliano réunit toutes les qualités de l’inter-prète idéal de Paganini” (J. M. Molkhou, Diapason)
“Le sue qualità tecniche e musicali sono assolu-tamente particolari” (Salvatore Accardo)
“Rogliano established a high dramatic stan-dard for the next generation of Paganini follo-wers” (R. Maxham, Fanfare)
“Excellente soliste” (Le Monde de la Musique)
“Da parte sua Rogliano sfoggia un virtuosismobrillante e di grande comunicativa, sorretto dauna tecnica e da un’intonazione sicurissime”(G. Tasso, Giornale della Musica)
9
Questi soltanto alcuni dei commenti più signi-ficativi sulla sua personalità artistica.
Marco Rogliano si laurea con lode alConservatorio S. Cecilia di Roma sotto la guidadi Antonio Salvatore, per poi perfezionarsi conRuggiero Ricci, Riccardo Brengola e SalvatoreAccardo. Nel 1989 il suo debutto internaziona-le come solista, eseguendo il Concerto diSibelius con la Helsingborg SymphonyOrchestra diretta da Ari Rasilainen.I successi conseguiti in importanti concorsiviolinistici e cameristici internazionali, come ilV. Bucchi di Roma, l’ARD di Monaco, Eastand West Artists di New York, lo hanno porta-to a esibirsi presso le più importanti platee delmondo, fra cui la Carnegie Hall di New York,la Grosser Saal della Philharmonie di Berlino,la Herkulessaal di Monaco, la Sala Ciajkovskijdi Mosca, la Casals Hall di Tokyo, la Sala S.Cecilia di Roma, il Teatro S. Carlo di Napoli, ilPoliteama di Palermo collaborando con diret-tori e strumentisti del calibro di L. Shambadal,S. Accardo, T. Ceccherini, E. Dindo, A.Lonquich, A. Lucchesini, I. Turban.Particolarmente impegnato nella valorizzazionedel repertorio violinistico italiano del XIX, XX eXXI sec. la sua discografia contiene numerosePrime assolute di autori quali Paganini, Rolla,Respighi, Zanella e Sciarrino.Già titolare nei Conservatori di Rovigo e Fermo èattualmente docente di Musica da Camera alConservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Ha tenu-to Masterclass in numerosi Conservatori italiani,all’Università Mozarteum di Salisburgo e presso
la Steinway Academy di Verona. Eccezionale ilsuo strumento, un Nicola Bergonzi (Cremona,1790) affidatogli dalla Fondazione Maggini diLangenthal (Svizzera).La sua brillante carriera lo colloca di diritto fra imigliori artisti del panorama musicale contempo-raneo. Non a caso la rivista Amadeus gli ha dedi-cato la copertina e il CD in duo con A. Dindodedicato a Franz Liszt nel bicentenario dellanascita.
“All in all, Rogliano gives us one of the mostimpressive, persuasively interpreted accountsof this almost impossibly challenging music.”(D. Druce, Gramophone)
10
N icolò Paganini’s solo violin works, asdocumented in the new Catalogotematico, are a corpus in its own
right, and a particularly significant aspect ofthe musician’s output. With at its centre the 24Capricci Op. 1 published by Ricordi in 1820,they include pieces of various character andstructure written at different times: Inno patri-ottico M.S. 81, Tema variato M.S. 82 and theSonata a violin solo M.S. 83 are early works(probably dating to before 1805); the ValtzM.S. 80 was probably composed in Genoaaround 1803-1805; the Sonata a violino soloM.S. 6 (also known as Merveille de Paganini)was written during Paganini’s Lucca period(1805-1809); other works date from lateryears, such as the Capriccio a violino soloM.S. 44 on “In cor più non mi sento” from1821, the Capriccio per violino solo M.S. 54, apeculiar work written on four staves in Viennain 1828, the variations on God Save The KingM.S. 56 from 1829, and Caprice d’adieu M.S.68 from 1833. There are, moreover, somerecently rediscovered works: Contradanzeinglesi M.S. 136 and Quattro studi M.S. 138(works written before the Capricci Op. 1), and,included in this programme, Alla spagnola, 2Duetti in forma di canone and 5 Valtz.
The Capriccio per violino solo “In cor più nonmi sento” M.S. 44, composed in 1821, is notvery well known in its autograph version intwo movements, Andante and Presto, featur-ing, respectively, Paisiello’s varied theme(written on two staves for the bow-pizzicato
effect) and a lively variation. Better known isthe version passed on by Carl Guhr (written“from memory”) entitled Introduction etVariations sur le Thème «Nel cor più non misento» pour le violon seul de Nicolo Paganini,found in his treatise Über Paganinis Kunst dieVioline zu spielen (Mainz, B. Schott’s Söhnen,1829), which has, after an introduction andthe theme, seven variations, the last of whichis almost identical to the Presto of the versionin two movements. For a long time, the latterwas thought to be a sort of “first draft” and itsoriginality was not recognized. The Andantepresents Paisiello’s theme in a varied form,with some different rhythmical-melodical figu-rations from those of Guhr’s version, morearticulate and original. The Presto, its onlyvariation, corresponds, as we mentioned, tothe seventh variation of Guhr’s version, onceagain with, however, small but significant dif-ferences.
Alla spagnola, a recently rediscovered auto-graph piece, is a short page structured inthree parts (a-b with Da capo) and shows theGenoese musician’s talent also in minor com-positions. The work partially corresponds tothe violin part of the Minuetto (Allegrettomosso) from the Quartet No. 12 for violin,viola, cello and guitar (M.S. 39), also in Aminor, the initial 32 measures of which aresubstantially the same as the 16 measureswith repeats of this short violin piece.Probably, Paganini reworked the piece anddeveloped it to place it within a wider context,
12
as he did, for example, with the Valtz of theCantabile a Minuetto e Valtz (M.S. 126) for vio-lin and guitar, which, developed and extend-ed, became the Rondò of the Violin ConcertoNo. 5 (M.S. 78). Its different title, structure andbreadth (the Minuetto consists of 733 mea-sures), lead us to consider Alla spagnola apiece in its own right and not a “preparatorystudy”. This composition, which is found inthe autograph manuscript «M.S. Cas. 5630»(of Rome’s Biblioteca Casanatense) togetherwith three other complete compositions, doc-uments a curious habit of Paganini’s, that ofjotting down musical ideas (sketches, drafts)anywhere he could, on loose sheets orassembled ones, together with other compo-sitions for different instruments, as is also thecase of the 5 Valtz, as we shall see further on.
The Valtz in A major M.S. 80 is a short compo-sition curiously found within the autographmanuscripts of the 37 Sonate for guitar M.S. 84.This piece, in three parts (a-b with Da capo),has a lively first part (then repeated) in A major,while the central part, in A minor, is sweet andlyrical. The Valtz, incidentally, corresponds tothe first violin part of the Valzer No. 2 fromDivertimenti carnevaleschi, a series of dancescomposed for the «Festone dei Giustiniani».We could therefore speak of a self-loan – notsuch a rare occurrence in Paganini.
2 duetti in forma di canone for two violins, are,to our current knowledge, unique inPaganini’s output. The title, missing on the
autograph, has been gathered from the struc-ture of the two pieces, which were composedindeed as a unison canon. No instruments arementioned on the autograph, but the musicnotation with the use of double stops and theindication «pizzicato» at the end of the com-position leave no room for doubt. On thesame autograph manuscript we also find theCanzonetta for voice and guitar (M.S.121) andsome sketches (eight measures of a«Polacca», and a series of chords indicated as«Ghiribizzi») that are alien both to theCanzonetta and the 2 duetti. Due to the lack ofdates or other elements useful to contextualizethem, we can only theorize that these twopieces might date from the time when Paganinimoved to Parma (1795) to study withAlessandro Rolla and, later, with GasparoGhiretti, «Court cellist and renowned contra-puntist», with whom Paganini, as stated in theautobiography he dictated to Lichtenthal, stud-ied counterpoint and under whose guidance hewrote «a great quantity of instrumental pieces».
Cinque Valtz for violin (the fifth of which, actu-ally, is the first draft of the third) are foundwithin the autograph manuscript of theGhiribizzi for guitar M.S. 43, a collection ofshort compositions written in the 1819-1820period. Although the autograph is not dated,from the the Ghiribizzi’s music genre andcharacteristics they can be ascribed to thesame period as the Divertimenti carnevaleschiM.S. 4, as can the Valtz M.S. 80. These shortpieces, technically not very demanding but
13
quite pleasant, are simply structured, mainlyin two parts (8+8 measures) with repeats.
Caprice d’adieu is known through the printededition of Eduard Eliason’s Six CapricesCaractéristiques pour le Violon op.12, publishedby B. Schott in 1833, where Paganini’s Capriceappears like an ‘appendix’. The piece’s breadthand three-part structure, (a-b-a) with two repeats,make it similar to the model of some of theCapricci Op. 1, but Caprice d’adieu has a lighter,more playful character and is technically lesscomplex than opus 1. The writing is mostly two-voice in the ‘a’ sections, while in the central sec-tion it becomes more articulate and dynamic,with some technical passages that are not alto-gether simple (for example chords with trills with-in), elements that certainly make this often disre-garded piece interesting and worthy of note.
Italo Vescovo
The CD programme is completed by a seriesof works inspired by the Paganini model asregards to form, technique and content, andcomposed by musicians who were in directcontact with Paganini either for work or per-sonal friendship. The most widespread reper-toire of 19th-century itinerant virtuosos con-sisted of the freely structured Prelude orCaprice, of the Etude that conceals a caprice,or of Variations on a well-known theme. Oneafter the other, these works show us the tasteand aesthetics of that time in the variousschools of Italy, those of Naples, Milan,
Florence and Emilia. Their interest and origi-nality reside not so much in the type of articu-lations or figurations, but in the way they areused, in the developments and variationsadopted each time, which tend to emulate, ofcourse, but also surpass the model, not forgo-ing lyricism and, on occasion, answering thecall of descriptive music.
Onorio De Vito (Arpino, 1792 - Naples, 1844),was a violin teacher at the NaplesConservatory, where he livened up didacticsby founding a school based on new methodsand techniques. He built his teachings onFederico Fiorillo’s 36 Capricci per violino andRode’s 24 Caprices, and his method in timespread to other Neapolitan institutions andneighbouring cities. He was in contact withsome prominent personalities of the culturalmilieu (Masseangeli) and was admired bysome of the most renowned composers of theday: Rossini, Donizetti, Mercadante, Spohr,Lipi ski and, indeed, Paganini, with whom hecorresponded from 1819 to at least 1836. Theletters mostly speak of small favours, recom-mendations of young violinists, and technicaladvice, above all on the quality of strings,which for Paganini often proved to be a trueobsession. Tre variazioni e coda per violinosolo sul motivo popolare Te voglio beneassaie composed in Naples in 1840, whichexists both in manuscript and in the printededition by Girard, fits in the category of bravu-ra pieces based on popular themes, the typeof work of which De Vito’s catalogue mostly
14
consists. With his prodigious technical skillsand memory, which seem to have been histrademark (reportedly, since he could not getthe score, he wrote from memory Paganini’sCaprices and some variations he had heard inconcert), he composed very complex works,with virtuosic figurations and articulations,whereby in Naples he was considered “one ofthe most wonderful performers Italy has everhad since Tartini”.
Born in Piacenza, Giuseppe Austri was a pupilof Giuseppe Jona and Carlo Bignami. A violinvirtuoso, from 1855 he taught at the musicschool of Fiorenzuola; he was, moreover, firstviolin leading the orchestra for the operaticseasons of Piacenza’s Teatro Municipale,where he performed in works by Verdi andMeyerbeer. He was greatly admired by thepublic of various European capitals (he alsoplayed in Odessa, Lviv and St. Petersburg) forhis “frank, almost audacious performing, theheated passion animating his bow, whichgives sounds a compelling power in both joy-ous and doleful melodies, his unpredictability,the incomparable mastery of his instrument,the exquisite good taste of his compositions,the fluidity and clarity of his notes, so verystaccato and strong”; he was often comparedto the “famous Paganini” and considered“one of the best performers of our times”(Casamorata in the Gazzetta musicale diMilano in 1851).
Bernardo Ferrara, who trained at the school of
Alessandro Rolla in Pavia, was summoned byPaganini to occupy the post of first violin inthe soon-to-be restructured orchestra ofParma. Paganini’s reorganization projectunfortunately failed, also due to the fact thatafter a few months Ferrara resigned, havingreceived the offer to replace his teacher at theMilan Conservatory. After trying, withoutmuch success, a career as a solo performer,the violinist opted for orchestral playing andteaching, composing, at the same time, worksof remarkable interest (methods and etudes),still in use today. While the two Capricci ofOp. 9 by Austri are dedicated to GiacomoCosta, renowned teacher of Paganini andSivori, Ferrara’s Preludi are instead bestowedon a fellow student of his, a friend and violin-ist, a partner in several academies: theMilanese Dionigi Torre.
Ferdinando Giorgetti was admired for the tal-ent he revealed as a very young performer onEuropean stages. A protagonist of Florence’smusical life and promoter of instrumentalmusic, especially of the German repertoire(for which he was wittily nicknamed“tedescone”), he had the opportunity to comein contact with Paganini, to whom he dedicat-ed his Tre gran trii di una difficoltà progressivaand Gran trio di una difficoltà particolare. HisStudi Op. 28, specifically composed “as a pre-liminary exercise to Paganini’s” and dominatedby highly virtuosic writing, come scrupulously“furnished with many indications so as to leadto that perfection of performance that is one of
15
the finest qualities in all arts and which, Ibelieve, is most essential especially in music”.
Carlo Bignami, from Cremona, has gonedown in history as an epigon of Paganini, butheld, actually, an independent and very signif-icant role in his city. With Ruggero Manna andsome other friends, he revolutionized themusical life of Cremona, radically renewingthe city orchestra and founding institutions insupport of the initiative. Rather than becomingan itinerant virtuoso, Bignami preferred toremain in Cremona, earning nonetheless thepraise of the critics – who recognized in him“a uniquely strong performer: he was marvel-lous especially in performing virtuosic musicand in the staccato” – and of Paganini himself,who urged him to put his laziness aside andtravel, putting his talents to good use. His 12capricci per violino solo, dedicated to CountArrivabene, are one of the few works of histhat were printed.
Mariateresa Dellaborra(Translated by Daniela Pilarz)
“Un violinista eccezionale sotto ogni aspetto”(Ruggiero Ricci)
“Rogliano réunit toutes les qualités de l’inter-prète idéal de Paganini” (J. M. Molkhou, Diapason)
“Le sue qualità tecniche e musicali sono asso-lutamente particolari” (Salvatore Accardo)
“Rogliano established a high dramatic stan-dard for the next generation of Paganini follow-ers” (R. Maxham, Fanfare)
“Excellente soliste” (Le Monde de la Musique)
“Da parte sua Rogliano sfoggia un virtuosismobrillante e di grande comunicativa, sorretto dauna tecnica e da un’intonazione sicurissime”(G. Tasso, Giornale della Musica)
These are only some of the reviews of MarcoRogliano’s artistic figure.
Marco Rogliano graduated with distinctionfrom Rome’s S. Cecilia Conservatory underthe guidance of Antonio Salvatore, then fur-thered his studies with Ruggiero Ricci,Riccardo Brengola and Salvatore Accardo. In1989 he debuted internationally as a soloistperforming the Concerto by Sibelius with theHelsingborg Symphony Orchestra conductedby Ari Rasilainen.In the wake of his successes in eminent violinand chamber music international competitions
16
– such as the V. Bucchi of Rome, ARD ofMunich, East and West Artists of New York – hehas appeared at the most important venues ofthe world: New York’s Carnegie Hall, theGrosser Saal of Berlin’s Philharmonie, theHerkulessaal of Munich, Ciajkovskij Hall ofMoscow, Casals Hall of Tokyo, S. Cecilia Hallof Rome, Teatro S. Carlo of Naples, Politeamaof Palermo, working with conductors and per-formers such as L. Shambadal, S. Accardo, T.Ceccherini, E. Dindo, A. Lonquich, A.Lucchesini, and I. Turban.Particularly committed to the Italian violinrepertoire of the 19th, 20th and 21st centuries,his discography includes many world pre-mières of authors such as Paganini, Rolla,Respighi, Zanella and Sciarrino.After teaching at the Conservatories of Rovigoand Fermo, he currently holds the chair ofChamber Music at the Conservatory ofPiacenza. Rogliano has held master classesin numerous Italian Conservatories, atSalzburg’s Mozarteum and at the SteinwayAcademy of Verona. He plays on an exception-al instrument, a Nicola Bergonzi datedCremona, 1790 entrusted to him by the MagginiFoundation of Lagenthal (Switzerland).His brilliant career rightfully places himamong the best artists of the current musicscene. The specialized magazine Amadeus,indeed, featured him on its cover and dis-tributed his CD in duo with A. Dindo dedicatedto Franz Liszt on the bicentenary of his birth.
“All in all, Rogliano gives us one of the most
impressive, persuasively interpreted accountsof this almost impossibly challenging music.”(D. Druce, Gramophone)
17
Un particolare ringraziamento al Prof. Italo Vescovo, l'Archivio dell'Accademia Nazionale S. Cecilia, l'Ing. Saeid Golkar,
il Direttore del Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza M. Walter Casali, il Prof. Marco Alpi.
Dedico questo album a mia moglie Rossana Tomassi.
Grateful thanks to Italo Vescovo, the archive of the Accademia Nazionale di S. Cecilia, Saeid Golkar,
the director of the Piacenza Conservatory M. Walter Casali, and Marco Alpi.
I dedicate this recording to my wife Rossana Tomassi.
CDS7903
Dynamic SrlVia Mura Chiappe 39, 16136 Genova - Italytel.+39 010.27.22.884 fax +39 010.21.39.37
[email protected] us at www.dynamic.it
Dynamic operaand classical music