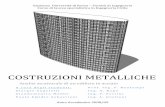oste Italiane S.p.A.- Spedizione in Abbonamento Postale...
Transcript of oste Italiane S.p.A.- Spedizione in Abbonamento Postale...

Post
e Ita
liane
S.p
.A.-
Sped
izion
e in
Abb
onam
ento
Pos
tale
- D.
L.35
3/20
03 (c
onv.
in L
.27/
02/2
004
n°46
) art
.1 co
mm
a 1,
DCB
Rom
a

II copertina

sommario
Mensile dell’Associazione Italia Nostra419 luglio/agosto 2006
Soci onorariPier Fausto Bagatti Valsecchi
Giorgio Luciani
Alessandro Merli
PresidenteCarlo Ripa di Meana
Vice PresidentiMarco Parini
Maurizio Sebastiani
Rossana Bettinelli
Consiglio direttivoMirella Belvisi
Salvatore Ciaravino
Piero Ferretti
Alberto Ferruzzi
Minuccia Fontana
Bruno Giampaoli
Giovanni Losavio
Andrea Malacarne
Antonio Mansi
Raffaele Mazzanti
Franco Medici
Adele Nicoletti
Gherardo Ortalli
Domenico Palezzato
Maria Letizia Panajotti
Marco Piacentino
Giacomo Rech
Maria Teresa Roli
Oreste Rutigliano
Floriano Villa
Giunta
Mirella Belvisi
Alberto Ferruzzi
Maria Letizia Panajotti
Giacomo Rech
Oreste Rutigliano
Collegio dei Revisori dei conti
Luigi Colombo
Andrea Del Sarto
Roberto Giliberti
Collegio dei Probiviri
Giancarlo Bagarotto
Gianluigi Ceruti
Franca Guelfi
Italia Nostra Onlus Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (riconosciuta con D.P.R. 22 VIII-1958, n. 1111)
Italia NostraPubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 1957, n°5683 Sped. A.p., art. 2 c. 20/b45% legge 662/96Filiale di Roma
Direttore ResponsabileCarlo Ripa di Meana
Hanno collaboratoAndrea CostaDafne ColaRoberto ConteGiovanni De PascalisGabriella MecucciIrene Ortis
GraficaGraziosi e Associati sas
StampaI.g.r. Industria graficaRomanasede legale e stabilimentovia Cancelleria 2400040 Cecchina RM
Indirizzario Mauro Di Bartolomeo
SedeVia Nicolò Porpora 2200198 Romatel. 06.8440631fax 06.8844634P.I. 02121101006C.F. 80078410588
e-mail:[email protected]
e-mail redazione:[email protected]
sito internet:http://www.italianostra.org
Adesione a Italia NostraSocio Ordinarioquota annuale euro 31,00quota triennale euro 80,00Socio Familiare: quotaannuale euro 20,00quota triennale euro 50,00Socio Giovane(fino a 18 anni): quotaannuale euro 10,00quota triennale euro 25,00
Socio ordinario studente(fino a 26 anni):quota annuale euro 15,00quota triennale euro 40,00Socio Sostenitore: quotaannuale euro 80,00quota triennale euro 210,00Socio Estero: quota annua-le euro 52,00 Versamenti su c.c.p socin°48008007intestato a Italia Nostra -Romanumero verde: 800 566 177per il rinnovo tramite cartadi credito (dal lunedì alvenerdì, ore 16.00 - 18.00)Per informazioni su abbo-namenti alla rivista per i nonsoci:Servizio abbonativia Nicolò Porpora 2200198 Roma - Tel. 06.84406327
Finito di stampare:
settembre 2006
Il pensiero ufficiale
dell’Associazione sui diversi
argomenti è espresso nell’e-
ditoriale.
Tutti gli altri articoli rappre-
sentano l’opinione dei
rispettivi autori.
Normativa sulla Privacy:
ai sensi del D.L. 196 del
30/06/03 i dati sono raccolti
ai soli fini associativi e gesti-
ti con modalità cartacea ed
elettronica da Italia Nostra.
In qualunque momento Lei
potrà aggiornare i suoi dati
o cancellarli scrivendo ai
nostri uffici di Via Porpora,
22 - 00198 Roma
Foto di copertina:
IL BUSINESS CHE OSCURA IL SOLE
EDITORIALEIl grande raggiroCarlo Ripa di Meana 2Le energie che salveranno il climaDomenico Coiante 5Nucleare, ancora un noDomenico Coiante 14Chi ha paura dell’energia pulitaLeonardo Libero 20Così usciremo dall’era del petrolio Jeremy Leggett 24Macchine contro il paesaggio Oreste Rutiglian 27L’impegno del Cnp Oreste Rutigliano 30Ghigliottine per l’avifauna Stefano Allavena 31DER SPIEGEL 33
IL DELIRIO DEI MULINI A VENTOEuropa Nostra - Attenti a quelle pale 38
DICHIARAZIONIGiuliano Amato, Carlo Rubbia, Giancarlo Galan, Daniele Capezzone,Ernesto Galli della Loggia, Emanuele Sanna, Petrini, Emiliani, La Malfa
TESTIMONIANZERenato Soru, Sardegna 43Pietro Scarpellini, Umbria 45Enzo Cripezzi, Puglia 48Chi boicotta il soleOreste Rutigliano 51Tutti pazzi per il fotovoltaicoGiovanni De Pascalis 52Il sol dell’avvenirePaul Roberts 56Biomasse 60Scandalo assimilate 62Rigassificatori 63
GLOSSARIOUnità di misura dell’energia 64

editoriale
2
Il grande raggiroIl grande raggiro
ono consapevole della novità e della delica-tezza di questo numero del Bollettino di ItaliaNostra che, per la prima volta nella lunga sto-
ria dell’Associazione, cerca di fare il punto sullaquestione energia in Italia.Quando Italia Nostra negli anni cinquanta si costi-tuì, la questione energia non si poneva nelle ri-flessioni prevalenti di quel decennio. L’Italia di-sponeva di una importante quantità di energia rin-novabile prodotta dall’idroelettrico, che allora erauna voce importante nel bilancio energetico italia-no del dopoguerra, e spiccava come primato tra ipaesi che si avviavano all’integrazione europea. Ita-lia Nostra, negli anni sessanta, in particolare conscritti e discorsi del Presidente Giorgio Bassani (Ita-lia da salvare, Einaudi, 2005,pag.20,21,28), sollevòfondate obiezioni paesaggistiche contro l’Impian-to per la conversione del metano liquido in gas nel-la baia di Panigaglia, presso La Spezia, nel 1966, esulla scelta di Porto Tolle per la grande Centraleelettrica nelle valli di Comacchio. Più tardi, nel 1985,convocò una Tavola Rotonda nazionale su: Ener-gia verso il XXI secolo e fu pubblicato un quader-no con il punto di vista dell’associazione (luglio1985). Tutto, però, nel segno della ricerca e dellostudio. Solo trent’anni dopo, nella seconda metàdegli anni ottanta, sotto la pressione drammatica diChernobyl, Italia Nostra, che aveva nel suo Consi-glio Direttivo un eminente fisico, Gianni Mattioli,decise di sostenere l’abbandono del nucleare nelcampo energetico con un Referendum che raccol-se una larga maggioranza. Si veda il BollettinoNr.240 di Italia Nostra (luglio 1986), dal titolo “Fi-ne dell’era nucleare”.Un convegno europeo di Italia NostraOggi la questione dell’energia, anche da parte diuna Associazione come la nostra che opera in prio-rità per la tutela e la conservazione del patrimoniopaesaggistico, artistico e naturale della Nazione, haassunto una tale rilevanza e urgenza da imporci
una riflessione approfondita, a cui Italia Nostra èchiamata a dare seguiti concreti. Difatti, a partiredall’attualità geopolitica internazionale, per poi pas-sare alle mutazioni climatiche, all’incidenza dellescelte energetiche sul territorio e sugli stessi stili divita, per la crescente scarsità di combustibili fossi-li, per i crescenti consumi energetici in ogni ango-lo del pianeta, per la necessità di diversificare geo-graficamente gli approvvigionamenti di combusti-bili fossili, si deve dare inizio, anche nel “nostroorizzonte limitato, ad orientamenti nuovi per beneoperare nel futuro”. È evidente che come Italia No-stra Nazionale dovremo, nel corso del prossimo an-no, organizzare un Incontro Europeo, così comegià proposto dal Comitato Regionale Toscano, permettere su basi salde gli orientamenti di fondo sul-la questione energetica. Questo numero del Bol-lettino ne è l’annuncio e insieme il primo contri-buto.Abbiamo deciso di partire da un capitolo, per il mo-mento minore, quello delle energie rinnovabili. Alquale si collegano, però, le più appassionate spe-ranze nella ricerca e nella sperimentazione. Va det-to che oggi, nel 2006, con le sole energie rinnova-bili, di cui le più tecnologicamente mature, l’eoli-co e il solare, hanno caratteristiche intermittenti, siè ancora lontanissimi dalla soluzione dei maggio-ri problemi, e quindi anche dal raggiungimento deiprimi obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, damolti considerato chimerico. Il Trattato internazio-nale divenuto operativo nel febbraio di quest’an-no, i cui obiettivi possono essere perseguiti a me-dio termine, con maggiore efficacia, rispetto alleattuali possibilità delle rinnovabili, attraverso unastrategia incentrata sulla diffusione a ogni livello diquei programmi tecnologici che permettono di rag-giungere la più alta efficienza energetica, e quindidi ridurre al minimo gli sprechi di energie e di ri-sorse.Nessuna svolta decisiva a breve
Carlo Ripa di Meana S

I limiti ancora oggi insuperabili delle energie rin-novabili di cui è indispensabile tener conto in ognianalisi per evitare che si possa diffondere un’im-prudente attesa di svolte decisive a breve, ci im-pongono, dunque, di classificare il contributo del-le rinnovabili come contributo ancora non decisi-vo nei bilanci energetici. Ciononostante, questo set-tore presenta elementi di estrema attualità su cui,però, dobbiamo portare parole di chiarezza. Ini-ziando con il riconoscere che, come abbiamo giàdetto, è preliminare a ogni ipotesi per le rinnova-bili rivendicare la possibilità concretissima di ra-zionalizzazione, per poter poi dare, appena possi-bile, ali alla produzione crescente del combustibi-le rinnovabile per eccellenza, l’idrogeno, nella suaera futura.Perché il lettore del nostro Bollettino possa orien-tarsi con piena cognizione dei fatti, abbiamo chie-sto al maggiore esperto italiano di energie rinno-vabili, Domenico Coiante, di raccogliere nel me-morandum “Contrastare la crisi climatica” e in unaseconda scheda dedicata al nucleare civile oggi nelmondo, “Nucleare, ancora un no”, la descrizionedelle diverse forme di energie, con i loro pregi e iloro limiti, per fornire al lettore un quadro di rife-rimento aggiornato e problematico. Questo Bol-lettino contiene, inoltre, a mo’ di inserto, ap-profondimenti sulle esperienze in materia di rin-novabili che negli ultimi anni hanno caratterizzatole scelte della Germania, paese guida nel Conti-nente, raccolte dal settimanale Der Spiegel. Il no-stro Bollettino pubblica poi, presentandola in sche-de, una vasta documentazione di base, in partico-lare sulla questione eolica in Italia e sul fotovoltai-co, le due rinnovabili che al momento, seppure conun largo margine di vantaggio per l’eolico, si con-tendono il futuro del rinnovabile nel nostro paese.Nel numero stesso, oltre all’inserto Der Spiegel, èstata raccolta un’ampia documentazione fotografi-ca riferita alla intrusione violenta degli impianti in-dustriali eolici nel paesaggio italiano, con i nomidei comuni dove sono stati realizzati, accompa-gnata da una lunga serie di opinioni, giudizi, com-menti, pareri espressi negli ultimi anni da studiosi,esperti, giornalisti, legislatori e decisori politici.Eolico, ciò che non vaLa tesi centrale di questo numero del Bollettino èche, anche per l’assenza nel nostro paese delle ver-
sioni off-shore dell’eolico industriale e del mini-eo-lico a utilizzazione ridotta e familiare, e nell’attesadi una verifica concreta del progetto di eolico di al-ta quota studiato dall’ingegnere Massimo Ippolito(vedi nota tecnica a pag. ...), l’energia eolica rin-novabile si manifesti in Italia nei suoi impianti in-dustriali con ingombri, peso, altezza, scassi, vied’accesso non mitigabili in relazione alla tutela delpaesaggio. Si può dire che Italia Nostra l’abbia, difatto, già testimoniato nella sua azione quotidianacontrapponendosi in moltissime regioni (Liguria,Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Ca-labria, Sicilia e Sardegna) con Comitati di base con-tro gli impianti annunciati e, purtroppo, in parte giàrealizzati, ricorrendo in ben otto di queste regionia ricorsi amministrativi e giudiziari a tutti i livelli.Questa battaglia, che ha ormai alcuni anni (nel 2002-2003 il nostro Consiglio Nazionale ha approvato treordini del giorno esprimendo crescenti riserve fi-no alla proposta di moratoria nazionale nel 21 mar-zo 2004), ha gradualmente conquistato vasti setto-ri dell’opinione pubblica, ed è riuscita in alcune re-gioni, in particolare in Sardegna, in Puglia, nel Mo-lise e in Basilicata, a ottenere moratorie e riduzio-
3

ni di progetti. Tuttavia, l’assalto affaristico è ripre-so negli ultimi mesi con una virulenza impressio-nante che l’Espresso, con una sua recente inchie-sta riprodotta nelle pagine seguenti, ha descritto inmodo mirabile. In questa contrapposizione ItaliaNostra, e con Italia Nostra il Comitato Nazionaledel Paesaggio, la Coldiretti, Altura, Wilderness,Mountain Wilderness, la LIPU, il Club Alpino Ita-liano, hanno incessantemente denunciato la asso-luta irrilevanza, sia energetica sia a proposito del-le mutazioni climatiche, della scelta eolica. Irrile-vanza già chiarissima oggi, ad un livello di circa1.800 Megawatt di potenza di picco installata, e an-cora egualmente irrilevante anche nell’ipotesi estre-ma (quella sostenuta da Legambiente) di 10.000Megawatt:1.800 Megawatt3,2 miliardi di chilowattora elettrici (1% del fabbi-sogno elettrico italiano, 0,37% del fabbisogno ener-getico totale italiano)circa 2 milioni di tonnellate di gas serra risparmia-ti (0,4% sul totale di circa 500 milioni di tonnella-te)10.000 Megawatt18 miliardi di chilowattora (5,5% del fabbisognoelettrico italiano, 2% del fabbisogno energetico to-tale italiano)circa 11 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate(2,2% sul totale di 500 milioni di tonnellate)Questa è dunque la situazione nei suoi termini rea-li: l’eolico industriale italiano nulla di influente puòrisolvere né sul piano energetico, né per ottenereuna drastica riduzione dei gas a effetto serra. Ri-cordo che il Protocollo di Kyoto ci chiede di ridur-re entro il 2012 del 18% le emissioni a effetto ser-ra, per cui si conferma la natura puramente finan-ziaria e speculativa dell’attuale corsa all’eolico, ba-sata su una catena di generosissimi incentivi fi-nanziari, i “certificati verdi”, in particolare (un mer-cato speciale di azioni corrispondenti a quantità dienergia da fonte rinnovabile, a cui sono forzati igrandi distributori di energia proveniente, invece,da fonte fossile), tali da permettere la remunera-zione dei capitali investiti in soli 3-4 anni.Il business del ventoIn conclusione, riteniamo incomprensibile e con-traddittoria la ormai decennale campagna di pro-mozione dell’Eolico industriale pervicacemente
condotta, con calcolo non innocente, da larga par-te della stampa italiana e sostenuta da Legambien-te con la sua azione quotidiana e con il suo Proto-collo d’intesa con l’Organizzazione degli industrialidel vento, l’ANEV, a cui si è, negli ultimi mesi, ag-giunto con proprio Protocollo il WWF. I promoto-ri dell’eolico sanno benissimo che l’eolico in Italianon risolve nulla, nulla di decisivo. Legambiente egli altri promotori si diano pace: rispetto alle fina-lità esibite a gran voce, il conficcare migliaia di tor-ri eoliche alte tra i 100 e i 140 metri (Vestas, V-80)sui crinali appenninici, in particolare sulle gran-diose montagne dell’Abruzzo e della Calabria, su-gli acrocori affacciati sul mare, sulle distese di uli-veti secolari della penisola salentina, sulle monta-gne, sulle colline e sulle coste di Sardegna e Sici-lia, a ridosso di città d’arte e di monumenti di rile-vanza nazionale e internazionale, nonché nei Par-chi nazionali e nelle aree tutelate di diversa specie:si pensi in Toscana a Scansano, nel cono visivo delCastello di Monte Po (si veda l’articolo di Carlin Pe-trini, lo Specchio – La Stampa, 2-09-2006); in Moli-se a Saepinum (segnalo l’interessantissimo e do-cumentato articolo di Vittorio Emiliani su Airone,luglio 2006); in Puglia a Lecce e a Castel del Mon-te; in Umbria a Perugia e in Val Nerina (si legga iltesto di Pietro Scarpellini, di seguito) rappresente-rebbe nient’altro che l’ultimo scempio del paesag-gio. Uno scempio del paesaggio ed un’aggressio-ne all’ambiente che, se portate alle loro estremeconseguenze, già nell’ipotesi intermedia di 5.000Megawatt di potenza di picco installata corrispon-derebbero, prima di tutto nel Mezzogiorno e nelleIsole, al colpo di grazia a quel che resta della bel-lezza e della riconoscibilità del paesaggio italiano.Puntare sul fotovoltaicoLa tesi di questo numero del nostro Bollettino è chesi debba puntare sul Fotovoltaico. Si può far de-collare sul serio, finalmente, il Fotovoltaico e tuttele altre energie solari. Ridurre drasticamente glisprechi inaccettabili nel campo dei trasporti e del-le abitazioni civili. Puntare sulla cogenerazione dielettricità e calore attraverso centrali di piccola emedia taglia. Utilizzare tutte le altre tecnologie ener-getiche rinnovabili a nostra disposizione: biomas-se, geotermia, mini idroelettrico. Investire infinemassicciamente sull’idrogeno come vettore ener-getico e nel campo degli accumulatori elettrici.
editoriale
4

l protocollo di KyotoIl folto gruppo di scienziati che sotto l’egida del-l’ONU sta studiando dal 1988 le alterazioni del
clima terrestre, ha convenuto che il contributo piùrilevante a questo fenomeno è quello dovuto alleemissioni di carbonio, che si accompagnano alle at-tività umane. In particolare si è rilevato che la com-ponente di maggiore incidenza deriva dalle emis-sioni provenienti dalla crescita esponenziale del con-sumo mondiale di combustibili fossili. Nel 1997 aKyoto la terza Conferenza sul clima globale ha pro-posto un patto tra tutte le nazioni per cercare di por-re rimedio alla crescita abnorme della concentra-zione in atmosfera di anidride carbonica e di altrigas a effetto serra. Il patto, presentato a Kyoto nel-la sua forma definitiva, è stato ratificato da nume-rosi Paesi, tra cui l’Unione Europea e l’Italia con es-sa. Il Protocollo di Kyoto è divenuto operativo nelfebbraio 2006. Nonostante che alcuni importanti pae-si industriali, tra cui primeggiano gli USA e l’Austra-lia, non lo abbiano ancora ratificato, il patto è ormaidivenuto legge internazionale. Dal 2006, i Paesi ade-renti all’ONU sono tenuti al rispetto rigoroso dellaquota di emissioni, che a ciascuno di essi viene as-segnata dal Protocollo. Tale strumento, pur insuffi-ciente a contrastare completamente la crisi climati-
ca, soprattutto perché privo di vincoli nei confrontidelle cosiddette economie emergenti, costituisce co-munque un notevole passo avanti verso l’obiettivodel rispetto dell’ambiente globale, cioè verso il co-siddetto sviluppo sostenibile dell’umanità.
L’impegno di Kyoto per l’ItaliaConsumo energetico annualeIl consumo energetico italiano del 2004 è stato equi-valente a 197,8 milioni di tonnellate di petrolio(Mtep), di cui solo 16,5 Mtep provengono dalle fon-ti rinnovabili endogene e 10 Mtep entrano nel bi-lancio come energia elettrica importata. Quindi, am-mettendo ottimisticamente che tutta l’elettricità im-portata sia esente da emissioni di CO2, rimangonocirca 171,3 Mtep che derivano dai combustibili fos-sili e che, quindi, sono accompagnati da emissionidi gas serra nell’ambiente. Emissioni di anidride carbonica.Secondo l’ENEA, il contributo proveniente dal set-tore dei consumi energetici italiani alle emissionicomplessive di gas serra è stato per il 2004 pari a 477milioni di tonnellate in termini di CO2 equivalente.Pertanto si può concludere che ogni Mtep consu-mato in Italia nel 2004 di provenienza dai combu-stibili fossili è stato accompagnato in media dall’e-
Domenico CoianteFisico nucleare
le rinnovabili
5
I
Le energie chesalveranno il climaLe energie chesalveranno il clima
Domenico Coiante, laureato in fisica, ha lavo-rato all’ENEA come ricercatore e dirigentescientifico dal 1960 al 1997. Dal 1969 al 1975si è occupato di fusione nucleare presso i la-boratori di Frascati. Dal 1975 al 1979 ha lavo-rato al settore della sicurezza nucleare. Dal1979 al 1997 è stato il responsabile nazionaledell’ENEA per il settore delle fonti energetiche
rinnovabili. Autore di numerose pubblicazio-ni scientifiche su riviste sia italiane che stra-niere, ha pubblicato nel 2004, con franco An-geli, il libro: “Le nuove fonti di energia rinno-vabile”. Fa parte del Direttivo nazionale degliAmici della Terra, del Consiglio scientifico diASPO Italia e collabora con il Comitato Nazio-nale del Paesaggio dal 2002.
L’ESPERTO DI ENERGIA PROVENIENTE DALL’ENEA

missione 2,78 milioni di tonnellate di CO2 equiva-lente.Obiettivo del Protocollo di KyotoL’Italia, assieme all’Unione Europea, ha sottoscrittoil Protocollo di Kyoto ed è quindi vincolata all’os-servanza delle norme in esso contenute. L’obiettivodi Kyoto per l’Italia stabilisce che le emissioni deigas serra debbono essere ridotte entro il 2012 del6,5% rispetto al valore del 1990. Per il settore ener-getico italiano il valore di riferimento è posto a 419milioni di tonnellate. Ciò significa che le emissionidel sistema Italia devono scendere da 477 milioni ditonnellate del 2004 a 392 milioni di tonnellate. Dettaglio dell’impegno
Pertanto è necessario ridurre le emissioni annualidi anidride carbonica del nostro sistema energeti-co di 85 milioni di tonnellate nel corso dei prossi-mi 8 anni. Occorre cumulare ogni anno una nuo-va riduzione di 10,6 milioni di tonnellate, per unabbattimento totale al 2012 del 17,8% rispetto al li-vello del 2004. Passando dalle emissioni alle quan-tità di combustibili fossili che le producono, do-vremmo sostituire con energia pulita una quantitàdi 3,8 Mtep all’anno di energia fossile fino a cu-mulare una sostituzione energetica per circa 30Mtep nei prossimi 8 anni. L’uso del verbo al con-dizionale sta ad indicare che il meccanismo buro-cratico del Protocollo di Kyoto permette anche di
le rinnovabili
6

rispettare l’impegno di riduzione delle emissionisenza dover ridurre la quantità di combustibili fos-sili bruciati. Infatti, l’eccesso di emissioni può es-sere azzerato mediante l’acquisto di una corri-spondente quantità di mancate emissioni da partedi un altro Paese che si trovi al di sotto dell’obiet-tivo ad esso assegnato dal Protocollo. Questo mec-canismo di mercato delle emissioni, noto comeemissions trading, è stato messo in moto conte-stualmente all’avvio del Protocollo di Kyoto. Essopermette di acquistare da terzi il diritto ad emette-re gas serra senza effettuare modifiche al sistemadi produzione energetico, ovviamente nei limitidella convenienza economica.
Per mantenere l’impegnoIl ricorso alla costosa prassi delle emissions tradingè da escludere per un paese come l’Italia già pe-santemente indebitato verso l’estero per l’acquistodi energia primaria. Dobbiamo, pertanto, fare ricor-so alle fonti energetiche esenti da emissioni di CO2.Esse sono essenzialmente tre, una virtuale e due ef-fettive: il risparmio energetico, le fonti di energia rin-novabile e il nucleare. Tralasciamo per il momentol’argomento molto delicato e controverso del nu-cleare per motivi che saranno oggetto di uno speci-fico esame in un successivo articolo e poniamo lanostra attenzione sugli altri due argomenti. Di fattosi deve registrare che nell’immediato, per sostituireuna parte dei combustibili fossili, abbiamo a dispo-sizione soltanto il risparmio energetico e le fonti rin-novabili, quali l’idroelettrico, il geotermico, il sola-re termico, il solare termodinamico, il solare foto-voltaico, l’eolico e le biomasse.In definitiva, se non vogliamo aggravare ulterior-mente la bilancia dei pagamenti acquistando, oltreal petrolio, anche i diritti di emissione dall’estero, nonpossiamo fare altro che rivolgerci al risparmio ener-getico e alle fonti rinnovabili. Il contributo comples-sivo da queste fonti deve crescere dai 16.5 Mtep at-tuali di ulteriori 3.8 Mtep all’anno fino ad arrivare acirca 47 Mtep nel 2012. Questo numero potrebbesembrare piccolo, ma se lo paragoniamo alla pro-duzione attuale di energia rinnovabile, si vede im-mediatamente che si tratta di una quantità conside-revole di energia. L’incremento di 3.8 Mtep all’anno,paragonato alla produzione totale di tutte le fonti rin-novabili del 2004, corrisponde ad un tasso annualedi crescita del 23% a partire da subito. Si tratta di untasso enorme, che pone a tutto il settore del rispar-mio e delle fonti rinnovabili una formidabile sfida.La risposta a questa sfida costituisce un argomentomolto dibattuto e spesso molto aggrovigliato sul pia-no logico, soprattutto a causa delle implicazioni ideo-logiche, che, a torto o a ragione, vengono associateal modello di sviluppo sociale a cui far riferimento.Un’altra frequente causa di discussione è poi dovu-ta alla mancanza della chiara percezione tecnica cir-ca lo stato e la consistenza delle varie tecnologie del-le fonti rinnovabili. Infatti, si registra spesso, soprat-tutto negli interventi dei politici, un errore di collo-cazione temporale delle proposte dovuto al fatto che
7

le varie tecnologie in questione si trovano oggi in undiverso stadio di sviluppo. Avviene così che si con-siderino come ormai mature, sia sul piano tecnico,sia su quello economico, alcune tecnologie che inrealtà si trovano ancora distanti dalla maturità. Lepromettenti caratteristiche di sviluppo di tali tecno-logie, del tutto futuribili, vengono scambiate per at-tuali e si considera come acquisibile subito il lorocontributo energetico, altrimenti da collocare nel fu-turo più o meno lontano. In definitiva, un’analisi ac-curata della situazione non può prescindere da un’ar-ticolazione temporale dell’argomento basata sullo
stato effettivo delle diverse tecnologie rinnovabili. Oggi, si possono considerare mature e disponibilisul mercato le tecnologie afferenti all’idroelettrico,al geotermoelettrico, al risparmio energetico, al so-lare termico e all’eolico. Vanno considerate maturesul piano tecnico, ma ancora non completamentecompetitive, le tecnologie delle biomasse (compre-so il settore dei recuperi energetici dai rifiuti). Il so-lare termodinamico, nella situazione climatologicaitaliana, è a poche lunghezze dalla competitività,mentre il solare fotovoltaico, che strategicamenteappare come il più promettente, oggi si trova eco-nomicamente più lontano dalla concorrenzialità.Ad una situazione così articolata corrisponde chia-ramente una risposta altrettanto articolata rispettoalle opzioni praticabili e ai tempi. In altre parole, oc-corrono una serie di provvedimenti che attingano atutta la gamma delle soluzioni disponibili. Questevanno considerate, sia rispetto allo stato presentedella tecnologia, sia rispetto al loro processo evo-lutivo, sia infine, ma non ultimo, rispetto alla lorocompatibilità quantitativa e qualitativa con le altreattività umane presenti sul territorio. In sostanza, lanecessità di contrastare la crisi climatica porta in evi-denza il ricorso alle fonti rinnovabili, ma tale esi-genza deve essere soddisfatta mediante una sele-zione rigorosa delle scelte in modo da salvaguarda-re sia gli aspetti economici, sia i valori territoriali nonstrettamente economici, come quelli collegati allacultura, alla storia e all’estetica dei luoghi.
Interventi immediatiIdroelettrico e geotermoelettricoQueste fonti sono ormai completamente mature. Puressendo state ampiamente utilizzate nel passato inItalia, tuttavia esse sono suscettibili di ulteriori svi-luppi. La quantificazione del loro possibile apportoè però materia di discussione, soprattutto a causadel fatto che entrambe le fonti presentano notevolidifficoltà di accettazione nel territorio a causa del lo-ro impatto ambientale non trascurabile quando il lo-ro impiego debba essere fatto su larga scala (comeè nel caso italiano). Inoltre, proprio perché già ab-bondantemente sfruttato, il loro potenziale energe-tico residuo non si presta a garantire la continuitànel medio e lungo termine della crescita del tasso disostituzione dei fossili, come è richiesto da Kyoto.Pertanto, pur tenendo presente l’esistenza di que-
le rinnovabili
8

ste opzioni, non si procederà qui a quantificare ilpossibile contributo.
Risparmio energeticoSempre nel breve termine, si può ricorrere alle mi-sure di risparmio energetico in tutti i settori di con-sumo, ma soprattutto nel settore dei trasporti, che èresponsabile della quota maggiore di emissioni digas serra, oltre che di numerosi altri tipi d’inquina-mento. Mentre negli altri settori energetici il sistemaproduttivo italiano ha effettuato costantemente neltempo una riduzione dell’intensità energetica, tantoda essere considerato come uno dei migliori al mon-do, il settore dei trasporti ha reagito al miglioramen-to in un modo anomalo. Nel passato, l’aumento ge-nerale dell’efficienza energetica dei motori, associa-to al lungo periodo di stabilità del prezzo del petro-lio, invece di produrre una diminuzione dei consu-mi ha prodotto un aumento della potenza media deimotori del parco degli autoveicoli e di conseguenzail consumo totale è aumentato. L’attuale rapida cre-scita del prezzo del petrolio avrà indubbiamente uneffetto di contenimento, ma questa tendenza sarà for-temente contrastata dalla continua crescita della do-
manda di mobilità. Pertanto, volendo realizzare unaquantità apprezzabile di risparmio energetico, oc-corre guidare il processo di riduzione del consumodegli autoveicoli mediante interventi promozionalie normativi che privilegino gli autoveicoli ad alta ef-ficienza rispetto a quelli dispersivi (vedi i S.U.V.). Atitolo di esempio della quantità di energia che è pos-sibile risparmiare, si può citare il fatto che l’attualetecnologia dei nuovi motori diesel a basso consumoconsentirebbe un risparmio di circa 2.5 Mtep all’an-no qualora essi venissero adottati dall’intero parcodi autovetture circolanti in Italia. Ulteriori riduzioni,per altro tecnicamente possibili, sarebbero di più dif-ficile attuazione. Come si vede le quantità in giocosono confrontabili con la richiesta di riduzione di 3.8Mtep del primo anno, ma i contributi per gli anni suc-cessivi inevitabilmente si andranno ad affievolire.Questo aspetto è comune agli interventi di risparmioenergetico in tutti i settori d’uso dell’energia e di con-seguenza la strada del risparmio energetico, che èsenza dubbio da percorrere in tutti i settori, da solapotrebbe bastare a soddisfare gli obblighi di Kyotoper i primi anni, ma essa non consentirebbe di se-guire nel tempo il processo di riduzione delle emis-
9

sioni fino al 2012 ed oltre.
Solare termicoSi tratta della tecnologia dei collettori solari per il ri-scaldamento dell’acqua per gli usi sanitari. La tec-nologia è ormai matura ed è ampiamente impiega-ta in numerosi altri paesi della U.E., come ad esem-pio in Germania e Austria. Le condizioni di mag-giore insolazione del nostro Paese la rendono an-cor più competitiva soprattutto nel settore civile eresidenziale. Il contributo energetico attuale al bi-lancio italiano è pressoché trascurabile, mentre ilpotenziale praticabile nell’immediato sarebbe in-gente, stimabile in circa 9 Mtep. Esiste pertanto ungrande spazio di crescita.
EolicoTra le fonti rinnovabili produttrici di elettricità, l’eo-lico è la tecnologia che per prima ha raggiunto lacompetitività economica. E’ chiaro che tale econo-micità è un concetto relativo alle condizioni di ven-tosità dei siti d’installazione degli aerogeneratori equesta condizione favorevole, in Italia, si viene atrovare soltanto nelle zone dei crinali appenninici ein alcune zone costiere e montane della Sicilia e del-la Sardegna. Purtroppo queste zone, nella maggio-ranza dei casi, vanno considerate di particolare pre-gio paesaggistico e l’insediamento in esse delle cen-trali eoliche pone gravi problemi di accettabilità ter-ritoriale. Tuttavia, nonostante i contrasti locali e gra-zie soprattutto alla politica governativa di incenti-vazione economica (Certificati Verdi) che permettedi raggiungere un livello di profitto notevole per igestori degli impianti, la potenza eolica installata havisto negli anni recenti una crescita esponenziale.La potenza cumulativa, entrata in funzione in Italia,ha superato i 1700 MW alla fine del 2005. I dati del-la produzione energetica, consolidati nel 2004, dan-no 1,847 TWh annui, corrispondenti ad un rispar-mio di petrolio di 0,406 Mtep. Si tratta indubbiamentedi un contributo più significativo di quello del sola-re termico, ma ancora del tutto insufficiente a ri-spondere agli obblighi di Kyoto. L’ulteriore crescitadel contributo è messa in discussione, da un lato,dai problemi dell’impatto paesaggistico delle cen-trali nei territori sensibili, dall’altro lato, dal limite diaccettazione della rete elettrica al collegamento de-gli impianti eolici, la cui generazione di potenza è
di natura intermittente e casuale. Anche i recenti stu-di più favorevoli effettuati in Danimarca, hanno evi-denziato che tale limite si viene a trovare intorno al20% della potenza attiva in rete nel momento delcollegamento degli impianti eolici. Nella situazioneattuale della rete italiana, la cui stabilità è molto piùcritica di quella danese, come dimostrano speri-mentalmente i vari black out che periodicamente ciaffliggono, si ritiene di poter tollerare al massimouna potenza intermittente pari al 10% di quella atti-va in rete. Ciò corrisponde ad un limite di potenzaintorno ai 5000 MW per le centrali eoliche, cosa cheporterebbe ad un contributo di elettricità di 10 TWh,cioè al risparmio massimo di petrolio di 2,2 Mtep.Quindi, a prescindere dal fatto che 5000 MW eolicicorrisponderebbero all’installazione territoriale dicirca 5000 aerogeneratori da 1 MW nelle zone pae-saggisticamente sensibili, (cioè a quadruplicare ilnumero attuale di aerogeneratori e quindi a qua-
le rinnovabili
10

druplicare l’impegno territoriale e i problemi ad es-so connessi), il contributo energetico ottenibile nonraggiungerebbe nemmeno la sufficienza di un an-no rispetto alle esigenze di Kyoto.
Biomasse e recuperi energeticiL’argomento delle biomasse si presenta in modo du-plice rispetto alla maturità della tecnologia. Infatti,alcune applicazioni energetiche sono da considera-re completamente mature e competitive ed altre an-cora non lo sono, anche se si trovano vicino allacompetitività. L’uso termico delle biomasse da col-tivazioni di piante da legno e dai residui delle lavo-razioni agro-industriali ha ormai raggiunto la com-petitività nelle applicazioni volte al riscaldamentodegli edifici. Il contributo energetico di questo set-tore va ad aggiungersi a quello tradizionale della le-gna da ardere fornendo al presente circa 3 Mtep an-nui al bilancio energetico nazionale. (…) Un’anali-
si del potenziale oggi praticabile mostra che il con-tributo energetico ricavabile dal settore termico edelettrico delle biomasse può arrivare nel breve ter-mine al livello di circa 12 Mtep annui, semplicementeorganizzando meglio le coltivazioni, le tecniche diraccolta e la distribuzione del prodotto. Come si ve-de, l’uso termico ed elettrico delle biomasse costi-tuisce una delle opzioni che può fornire subito unconsistente contributo.
Interventi per il medio termineBiocombustibiliLa coltivazione di piante dai semi oleaginosi e diquelle amidacee e zuccherine permette di produr-re metilestere e alcool, i cosiddetti biocombustibililiquidi, che possono essere usati per alimentare imotori delle autovetture. Questa tecnologia non èancora matura sul piano economico e presenta no-tevoli perplessità dal punto di vista del guadagnonetto di energia (rapporto tra il contenuto energeti-co del prodotto finale e la quantità di energia im-piegata, quindi immessa, nel processo produttivo).Il valore di questo parametro è strettamente colle-gato alle tecniche di coltivazione e alla produttivitàdei terreni, per cui solo in alcuni casi il guadagnoenergetico assume valori decisamente maggiori di1. Nelle situazioni dei migliori terreni agricoli italia-ni il guadagno è appena conveniente, venendosi atrovare intorno al valore 2.Il contributo attuale dei biocombustibili al nostro bi-lancio energetico è di 0,28 Mtep e le analisi di svi-luppo del settore mostrano che esso potrà salire allivello di 0,36 Mtep nel medio termine. In ogni ca-so, quindi, è da escludere che da questo settore pos-sa venire un significativo contributo per le esigenzedi Kyoto.
Solare termoelettricoE’ la tecnologia che produce calore ad alta tempe-ratura ed elettricità mediante la concentrazione del-la radiazione solare con superfici speculari piane oparaboliche. E’ una delle opzioni, che nella situa-zione climatica italiana, non è ancora completamentematura. Questo giudizio sintetico richiederebbe unadettagliata articolazione rispetto alle diverse opzio-ni tecnologiche ancora in competizione (impianti aspecchi piani, impianti con specchi paraboloidi, ecc.)Per il momento soltanto la tecnica dei concentrato-
11

ri paraboloidi cilindrici si è avvicinata alla competi-tività, ma in località dove l’insolazione raggiunge va-lori massimi, come il deserto della California o quel-lo del Negev. La stessa tecnologia, applicata ai sitimigliori italiani, non riesce ancora a raggiungere lecondizioni minime di economicità dovendo scon-tare il notevole differenziale negativo, che esiste neisiti nostrani per l’intensità della radiazione solare.Sono necessari ancora studi e ricerche, come quel-le dell’ENEA del Progetto Archimede, per dimostra-re la possibilità di migliorare le prestazioni tecnichedi affidabilità e di efficienza degli impianti. Per il mo-mento non è possibile ipotizzare, nel breve-mediotermine, alcun contributo energetico rilevante ri-spetto alle esigenze del Protocollo di Kyoto.
Opzioni di lungo termineSolare fotovoltaicoE’ la tecnica che permette la conversione diretta del-la radiazione solare in elettricità sfruttando un ef-fetto fisico presente nei materiali semiconduttori,l’effetto fotovoltaico. Riguardo alla maturità di que-sta tecnologia occorre distinguere l’argomento indue aspetti: quello tecnico e quello economico. Sulpiano tecnico, lo stato attuale della tecnologia deimoduli piani a celle di silicio mono e policristallinoha raggiunto la maturità. A testimonianza di ciò, ba-sta considerare che i prodotti commerciali vengonoformalmente garantiti per 25 anni dalle industrie co-struttrici. Sul piano economico, però, il costo deimoduli è ancora tanto alto da non rendere compe-titiva l’energia elettrica prodotta. Nelle attuali con-dizioni dei prezzi del petrolio a circa 70 $/barile, ilcosto di produzione del chilowattora degli impian-ti fotovoltaici, nelle condizioni di insolazione tipi-che dell’Italia meridionale, è circa 4 volte più alto diquello delle centrali termoelettriche convenzionali.Per contro, si può dimostrare che il potenziale so-lare tecnicamente sfruttabile con questa tecnologiain Italia potrebbe fornire il maggiore contributo ener-getico tra le fonti rinnovabili, mentre sul versantedell’impatto ambientale gli impianti offrono le con-dizioni più favorevoli per l’integrazione nel pae-saggio potendo essere installati in zone industriali(tetti dei capannoni) e/o in quelle paesaggistica-mente non pregiate (terreni degradati in zone aridemarginali). In linea di principio ed in una prospet-tiva di lungo periodo, l’intero fabbisogno energeti-
co nazionale sarebbe alla portata della tecnologiafotovoltaica. A fronte di questa attraente prospetti-va, occorre registrare il continuo miglioramento del-le prestazioni tecniche soprattutto sul versante del-l’aumento dell’efficienza di conversione, con unaconseguente costante diminuzione del costo del chi-lowattora prodotto. Per tale motivo, non è difficileprevedere che, anche grazie alle economie di sca-la, la competitività possa essere raggiunta nel me-dio termine. Ed è proprio in tale prospettiva che sista conducendo a livello mondiale (soprattutto inGermania e Giappone) una intensa campagna d’in-centivazione economica, a cui recentemente si è ac-codata anche l’Italia con il Decreto sul fotovoltaicodetto del Conto Energia. Potremmo pertanto consi-derare, fiduciosi, che un grande contributo energe-tico possa venire dal fotovoltaico, ma, per il mo-mento, ed ancora per qualche tempo, il suo valore,che è oggi di 0,006 Mtep, continuerà ad essere irri-levante ai fini delle esigenze di Kyoto. In ogni caso,occorre poi tenere presente che la fonte fotovoltai-ca soffre del difetto dell’intermittenza casuale della
le rinnovabili
12

generazione e, quindi, tutto ciò che si è detto perl’eolico su tale argomento vale anche per il fotovol-taico. Nell’ipotesi futuribile che venga raggiunta lacompetitività e che la tecnologia si possa diffonde-re su larga scala, la crescita del contributo energeti-co sarà arrestata dal limite tecnico di allacciamentodegli impianti alla rete elettrica. Pertanto esso potràarrivare ad un valore di qualche TWh, all’interno delcontributo ipotizzato di circa 10 TWh (2,2 Mtep) perl’intero settore delle fonti rinnovabili intermittenti.
ConclusioniSommando in sintesi le considerazioni precedenti, siarriva a concludere che risparmio energetico e fontirinnovabili possono fornire la risposta alle esigenzedel Protocollo di Kyoto. Infatti, nell’immediato si puòricorrere alle tecnologie mature, come quelle per in-crementare il risparmio energetico, per aumentare ilcontributo del solare termico, delle biomasse e, conmolte riserve, dell’eolico. Gli interventi di sviluppodell’uso di queste tecnologie potrebbero fornire su-bito il mezzo per la sostituzione dei combustibili fos-
sili nella quantità richiesta dagli impegni urgenti diKyoto per l’Italia (circa 30 Mtep al 2012). La prose-cuzione del percorso di riduzione delle emissioni digas serra, che si sta definendo in sede internaziona-le per il dopo Kyoto, impone un ulteriore incremen-to del contributo delle fonti rinnovabili. Per quantovisto, tale incremento si concilia difficilmente con ilpotenziale praticabile di quelle mature, mentre si èanche evidenziato che l’attesa di contributi consistentida parte delle fonti rinnovabili elettriche viene vani-ficata dal difetto della loro intermittenza. Si può per-tanto prevedere il verificarsi di una situazione di stal-lo, in cui, ad esempio per il fotovoltaico, si ha a di-sposizione, da una parte, un enorme potenziale ener-getico, mentre dall’altra parte il suo sfruttamento ef-fettivo è impedito dai limiti di accettazione del colle-gamento degli impianti con la rete a causa dell’inter-mittenza del loro funzionamento. Il superamento diquesta situazione è possibile con l’introduzione di unadeguato sistema di accumulo dell’energia elettrica,che permetta il dispacciamento della potenza in mo-do differito nel tempo e programmabile secondo leesigenze del carico. In questo modo, l’intero poten-ziale della fonte solare fotovoltaica diverrebbe sfrut-tabile permettendo la sostituzione graduale dei com-bustibili fossili nel bilancio energetico nazionale. Al-lo stato attuale della tecnica esistono alcuni mezzi peraccumulare l’energia elettrica, ad esempio gli accu-mulatori elettrochimici per tempi di accumulo brevie lo stoccaggio di idrogeno prodotto per elettrolisidell’acqua per tempi di accumulo lunghi, anche sta-gionali. Le tecnologie implicate in tali soluzioni sonotutte ampiamente collaudate, ma i costi aggiunti daisistemi di accumulo portano ancora più distante lacompetitività dell’energia rinnovabile. Tuttavia, la con-tinua crescita del prezzo del petrolio e degli altri com-bustibili e la necessità crescente di contrastare i dan-ni prodotti dalla crisi climatica agiscono in modo dariavvicinare questa soluzione alla competitività. Ciòfa si che si possa guardare con fiducia ad una pro-spettiva di lungo periodo in cui l’energia solare pos-sa effettivamente dare il maggior contributo al bilan-cio energetico nazionale. A patto però che si inizi su-bito a sperimentare la tecnologia dei sistemi di accu-mulo. E purtroppo oggi, pur essendo immersi in con-tinue iniziative di promozione delle fonti rinnovabi-li, questo argomento fondamentale per il futuro è qua-si del tutto trascurato.
13

enni sul nucleare nel mondoNel 2005 la potenza elettronucleare nel mon-do era pari a 368.256 MW. Alla stessa data era-
no in costruzione nuove centrali nucleari per ulte-riori 17.566 MW. Le centrali ordinate e quelle pia-nificate per gli ordini erano pari a 44.709 MW, co-sicché il totale della potenza attesa nei prossimi an-ni si dovrebbe portare a 43.0531 MW complessivicon un incremento di circa il 17% rispetto al livel-lo attuale (Fonte: Unione Petrolifera, “StatisticheEconomiche Energetiche e Petrolifere” Novembre2005).Per comprendere meglio il significato di questa sfil-za di numeri, che danno l’impressione di una gran-de crescita degli impianti nucleari, conviene esa-minare la serie storica della produzione di elettri-cità nucleare rapportandola anno per anno al con-sumo mondiale di energia. Utilizzando la fonte già
citata dei dati, otteniamo il seguente andamentostorico: Si può notare che il nucleare ha avuto un’inciden-za fortemente crescente fino alla fine degli anni ’80,quando ha raggiunto la quota del 5.5 % per poi sta-bilizzarsi su un tasso di crescita notevolmente piùbasso. Nell’intero decennio successivo la crescitaè stata di un solo punto. Oggi si deve notare chel’incidenza del nucleare sul consumo mondiale dienergia mostra una tendenza a decrescere. In ef-fetti, anche le analisi previsionali per i prossimi 10anni dell’A.I.E. confermano tale tendenza, ricono-scendo al settore una certa crescita nel tempo intermini assoluti a fronte però di una crescita mol-to più grande dei consumi complessivi di energiadalle altre fonti. Pertanto il nucleare è destinato adavere una sempre minore incidenza nel bilancioenergetico mondiale.
Si possono trovare mol-te ragioni per giustifica-re l’arresto della cresci-ta del nucleare. Quellapiù utilizzata è il disastrodi Chernobyl, che in-dubbiamente ha avutouna grande risonanzapresso l’opinione pub-blica di alcuni paesi, inparticolare in Italia. Mala causa principale del-l’arresto dello svilupponucleare a livello mon-diale è di natura essen-zialmente economica. Sipuò dimostrare che ilcosto di produzione delkWh negli impianti del-le vecchie filiere era no-tevolmente più alto diquello delle centrali ter-
Domenico Coiante Fisico nucleare
le rinnovabili
14
C
Nucleareancora un noNucleareancora un no

moelettriche. Come sispiega allora il grandesviluppo degli anni ’80?La ragione era nel fattoil nucleare poteva be-neficiare delle sovven-zioni governative mili-tari, erogate sotto formadi acquisto garantito delplutonio (questo ele-mento si produce du-rante la fissione dell’u-ranio e si accumula co-me scoria negli elemen-ti di combustibile bru-ciati). La guerra freddarichiedeva la corsa alletestate missilistiche alplutonio e questo giu-stificava le incentivazioni pubbliche USA, erogatetra l’altro anche in altri paesi occidentali sotto for-ma sia di garanzie governative ai finanziamenti pergl’impianti, sia di facilitazioni commerciali per l’ac-quisto del plutonio. In tali condizioni di mercatoassistito l’industria nucleare prosperava. La provadi tutto questo discorso è che, non appena il Pre-sidente Ford privatizzò nel 1976 il settore nuclea-re statunitense, interrompendo l’acquisto militaredel plutonio, gli ordini di nuove centrali furonobloccati. Da allora, nelle condizioni di libero mer-cato, negli USA non furono più ordinate nuove cen-trali a causa della scarsa, o inesistente, redditivitàdell’impresa. L’aumento della potenza installata,pur avvenuto negli anni successivi, era dovuto alcompletamento della costruzione delle centrali or-dinate prima del 1977 (com’è noto, si richiedonoin media 10 anni tra l’ordine e l’entrata in eserci-zio). Da allora, solo in alcuni paesi, nei quali con-tinua ad essere presente l’obiettivo militare (comeFrancia, Inghilterra, Pakistan, India, Israele e re-centemente la Cina) nuove centrali nucleari sonostate prese in considerazione. (…)Ai nostri giorni siamo assistendo ad un tentativodi rilancio del nucleare sulla base dei seguentinuovi elementi di giudizio dichiarati dall’industriadel settore.1. Il prezzo del petrolio è salito ad oltre 70 $/bari-le e con esso è aumentato fortemente anche il prez-
zo del gas naturale. Ciò ha prodotto un forte au-mento del costo del kWh delle centrali termoelet-triche e questo rimette in gioco il nucleare.2. Anche il prezzo dell’uranio è salito notevolmen-te, ma l’incidenza di questo aumento gioca un ruo-lo marginale rispetto alle altre componenti di co-sto. Per converso, si è avuta una revisione tecnicadegli impianti che oggi sono offerti nella versionedi nuova generazione con caratteristiche di effi-cienza, di affidabilità e di sicurezza notevolmentemigliorate, mentre il prezzo si è mantenuto al li-vello della generazione precedente. Il fattore di ca-pacità delle nuove centrali è migliorato passandodalle circa 6500 ore di funzionamento annuale fi-no alle 8000 ore dichiarate negli impianti più re-centi. Ciò ha come conseguenza una proporzio-nale riduzione del costo del kWh. Inoltre, l’espe-rienza acquisita sul campo suggerisce di portare ladurata della vita utile da 30 a 40 anni, con conse-guente ulteriore riduzione dei costi finanziari. 3. Nel 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyo-to, che impone la riduzione delle emissioni di CO2da parte delle centrali termoelettriche dei paesi ade-renti, assegnando a ciascun paese un obiettivo diriduzione da raggiungere per il 2012. Ciò ha datoluogo al meccanismo del commercio dei crediticonnessi con l’emissione di CO2. Sul mercato di ta-li crediti l’emissione evitata di una tonnellata di CO2vale all’incirca 20 euro. Poiché l’energia nucleare
15

non è accompagnata da emissioni di carbonio, ognikWh prodotto consente di evitare in media 0.5 –0.7 kg di CO2. 4. In conclusione, il nucleare viene presentato nel-la nuova veste di fonte pulita ed economicamenteconveniente, in grado di produrre elettricità a uncosto di circa 4 centesimi/euro a kWh, contro i cir-ca 9-10 centesimi delle centrali termoelettriche(prezzo del petrolio a 70 $/barile). Pertanto si con-sidera il nucleare come l’unico mezzo in grado dicombattere efficacemente la crisi climatica, vistasoprattutto l’urgenza presente che non consente diaspettare i tempi di maturazione delle tecnologierinnovabili.
Il nucleare in ItaliaIl referendum del 1987 ha imposto l’uscita dell’Ita-lia dalla produzione di energia nucleare. Da allorala breve stagione del nucleare ha lasciato in ereditàagli italiani il grave problema del trattamento e del-lo smaltimento degli elementi di combustibile bru-ciato e delle scorie radioattive, prodotte negli annidi funzionamento delle centrali. A distanza di cir-ca 20 anni dal referendum, questo problema nonè stato ancora risolto ed è causa di ricorrenti con-tenziosi tra Stato e Comuni, ogni qual volta si ten-ti di localizzare gli impianti di stoccaggio sul terri-torio. Oggi, comunque, per gli stessi motivi sopraelencati, anche in Italia è in corso il tentativo di av-viare un nuovo programma nucleare, attraverso lapianificazione della realizzazione di nuove centra-li della cosiddetta IV generazione. La discussione in corso pone in particolare evi-denza, da parte dei fautori del nucleare, da un la-to, i dichiarati vantaggi economici raggiunti dallatecnologia e, dall’altro, la necessità di rispondereagli impegni nazionali conseguenti all’adesione alProtocollo di Kyoto. In conclusione, i punti di forza portati avanti dallaposizione nuclearista sono essenzialmente tre:1. convenienza economica del chilowattora dellenuove centrali;2. capacità produttiva pronta ed adeguata in rispostaall’esigenza ambientale del Protocollo di Kyoto;3. maggiori garanzie di sicurezza dei nuovi impianticontro il rischio di rilascio ambientale di radioatti-vità in caso d’incidente.
Alcune considerazioni in merito1. La convenienza economica dei nuovi impiantiL’idea che si possa aumentare la capacità di produ-zione da 6500 a 8000 ore annuali equivalenti e con-temporaneamente la vita operativa da 30 a 40 anni,ha più il senso di una scommessa che quello dellarealtà. Infatti tale ipotesi si basa sostanzialmente sul-la estrapolazione dei dati di esercizio attuali in unottica molto ottimistica. Il buon senso tecnico, in-vece, non autorizza affatto tale valutazione. Infatti,una centrale nucleare sul piano impiantistico è mol-to più vicina ad una termoelettrica convenzionaleche a una idroelettrica (che ha vita più lunga). Lasostanziale affinità impiantistica tra nucleare e ter-moelettrico, fino ad oggi, si è tradotta sul piano del-l’affidabilità dell’esercizio nell’uguaglianza dei fat-tori di capacità. E’ cosa nota che una centrale ter-moelettrica raggiunge le 6500-6600 ore di funzio-namento all’anno e gli impianti nucleari fino a po-chi anni fa erano anch’essi attestati (con fatica) suquesto valore medio, come confermano tutte le sta-tistiche di esercizio. In ogni caso, se per una cen-
le rinnovabili
16

trale termoelettrica si riesce ad andare oltre le 6600ore con enorme difficoltà, appare discutibile cheuna centrale nucleare, la cui parte impiantistica èmolto più complessa e quindi soggetta a maggioreesigenza di manutenzione e a una maggiore pro-babilità di guasti, possa realizzare 8000 ore mediedi funzionamento nell’arco della vita utile. Per lostesso motivo, appare eccessiva la valutazione di 40anni della durata della centrale nucleare. In con-clusione, se vengono meno le 8000 ore e i 40 annidi durata, il dato dichiarato di 4 centesimi di europer kWh fa sorgere seri dubbi di credibilità. Può es-sere allora lecito sospettare che il kWh nucleare nonsia ancora competitivo con quello convenzionale,nonostante l’attuale alto prezzo dei combustibili fos-sili. La conferma di questa affermazione può esse-re facilmente trovata nel fatto che il programma dirilancio del nucleare statunitense, proposto dal Di-partimento per l’Energia nel 2005, stenta a decolla-re nonostante che esso goda dell’erogazione di unaincentivazione governativa di 1.8 centesimi di $ perkWh prodotto.
Infine, un’ulteriore serio dubbio circa la competi-tività economica sorge dal fatto che i conti mostra-ti sottovalutano ampiamente l’incidenza del costodi smantellamento degli impianti a fine vita opera-tiva e del trattamento del combustibile bruciato etrascurano completamente il costo della colloca-zione in discarica protetta per centinaia d’anni deirifiuti radioattivi a lunga vita, da lasciare in ereditàalle future generazioni.
2. La risposta adeguata alle esigenze di KyotoCome è noto, la complessità dell’iter burocraticoamministrativo per l’autorizzazione, sia della faseesecutiva di cantiere, porta ad un tempo di realiz-zazione (dall’ordine all’entrata in esercizio) di cir-ca 10 anni. Pertanto, anche partendo nel 2007, nonpotremmo avere le nuove centrali in esercizio pri-ma del 2017, cioè ben al di là della prima scaden-za di Kyoto del 2012. Inoltre, assieme alle centralidovremmo importare anche i tecnici operatori de-gli impianti, perché quelli esistenti in Italia sonoandati, come chi scrive queste note, da tempo inpensione. Per formare una classe di tecnici nuclearipreparati ci vollero più di 15 anni negli anni ‘50 edaltrettanti ci vorrebbero ora. Quindi la risposta nonè pronta, anche se potrebbe essere adeguata in ter-mini quantitativi.Occorre poi sottolineare i seguenti fatti 1 - in Italia non esistono giacimenti d’uranio sfrut-tabili a basso costo e che, quindi, si riproporrebbela dipendenza dall’estero per l’approvvigionamen-to del combustibile; 2 - tutte le analisi circa le risorse di uranio econo-micamente sfruttabili mostrano il loro probabileesaurimento entro i prossimi quaranta anni, e ciòmantenendo l’attuale numero di reattori in funzio-ne nel mondo. Ora, è chiaro che il rilancio mon-diale del nucleare avrebbe come conseguenza l’au-mento massiccio del numero dei reattori. Ciò, a suavolta, porterebbe ad una impennata nei consumidi uranio e, quindi, ad una notevole riduzione deltempo di esaurimento della disponibilità d’uranio,almeno di quello estraibile ai bassi costi attuali. Per-tanto, dobbiamo concludere che la risposta alla esi-genza di sostituire il petrolio ed il gas naturale perfar fronte alla crisi climatica non potrà venire dalnucleare, ma richiederà comunque una soluzionemolto più articolata sul piano delle possibili op-
17

zioni alternative.
3. Le garanzie di maggiore sicurezzaIndubbiamente le centrali nucleari della IV gene-razione possiedono un maggior numero di dispo-sitivi di sicurezza attivi e passivi, che rendono me-no probabile il cosiddetto massimo incidente, lafusione del nocciolo. Se però ci si prendesse la bri-ga di chiedere agli ingegneri nucleari il calcoloquantitativo del miglioramento della probabilità,ci si sentirebbe rispondere con notevole vaghez-za che l’aggiunta di un sistema di sicurezza nonpuò che produrre un miglioramento della situa-zione. Quindi le nuove centrali sono più sicure,punto e basta. La ragione di questa risposta risie-de nel fatto che la complessità degli impianti e del-le logiche di funzionamento, la numerosità deicomponenti e dei sistemi, non permette, nemme-no con i moderni calcolatori, di effettuare il cal-colo a priori dell’affidabilità complessiva. Si fa ri-corso, allora, all’esperienza di esercizio dell’inte-ro parco impianti, dicendo che se complessiva-mente si sono avuti solo tre o quattro incidenti gra-vi nell’arco dei passati 40 anni su un numero com-plessivo di reattori di molte centinaia, la probabi-lità d’incidente per ogni singolo reattore è dell’or-dine di 1 su un milione all’anno. Possiamo quindistare tranquilli, perché nessuna altra attività uma-
na possiede un rischio così basso. La debolezza diquesto ragionamento sta in un solo punto: la na-tura differente del rischio che si corre. Se non siconsidera questo aspetto, si commette l’errore lo-gico di paragonare, per così dire, fagioli con pa-tate. La natura del rischio radioattivo è completa-mente differente da quella di qualsiasi altra attivitàumana. Si faccia, in proposito, mente locale sul-l’incidente nucleare di Chernobyl, dove si è avutala fusione del nocciolo. Sono morte subito decinedi persone nel raggio di qualche km. Nella zonacircostante, alcune centinaia di persone sono de-cedute subito dopo l’incidente a causa del cancroe, in una zona ancora più ampia, altre continuanoa subire gli effetti dell’esposizione alla ricaduta del-le polveri e alla contaminazione del terreno conuna incidenza percentuale anomala della morta-lità per tumore. L’area immediatamente interessa-ta dalle ricadute radioattive è stata di centinaia dikm2 e la nube radioattiva, che si è sollevata ad al-ta quota, ha percorso migliaia di km arrivando acontaminare il suolo fino alla Finlandia. L’Italia èstata soltanto sfiorata da un lembo della nube. Lamaggiore incidenza delle ricadute di polveri ra-dioattive si è verificata sul settore di Nord-Est, do-ve l’allarme è stato di particolare intensità. Se og-gi si facessero in Italia le misurazioni della ra-dioattività ambientale, si troverebbe che la quan-
le rinnovabili
18

tità di cesio 137, emanato da Chernobyl ed anco-ra presente nel nostro territorio, è in quantità su-periore alla metà del valore che a suo tempo misein grande allarme il nostro Paese. Infatti, il cesio137 ha un tempo di decadimento lungo, che pro-duce un dimezzamento in circa 30 anni e ne sonopassati solo 20 dall’incidente. In altri termini, an-cora oggi, stiamo mangiando le verdure contenentila radioattività di Chernobyl: un po’ diminuita, maancora in notevole quantità. Ciò significa che glieffetti nocivi sulla nostra salute di un incidente nu-cleare, che si è verificato 20 anni fa e a migliaia dikm di distanza, sono ancora in corso di realizza-zione. Si potrebbe proseguire ulteriormente su que-sta linea andando ad esaminare i rilasci di altri ele-menti a lunga vita radioattiva, che hanno conta-minato tutta la zona della centrale e quella limi-trofa. Si potrebbe pure tentare un calcolo delleenormi spese necessarie per effettuare una boni-fica del territorio, peraltro ancora incompleta. Sipotrebbero anche analizzare gli effetti genetici del-la esposizione radioattiva anomala subita dai mi-lioni di esseri umani, animali e piante. Ma qui cifermiamo, poiché riteniamo che le poche consi-derazioni fin qui svolte diano un’idea sufficientedel significato che ha la differente natura del ri-schio nucleare rispetto agli altri rischi. In conclusione, la specificità qualitativa del rischio
nucleare non ne permette la valutazione quantita-tiva sulla base della sola probabilità d’incidente. Levalutazioni di questo tipo hanno tutte una base lo-gica errata e portano ad un giudizio di merito cheha poco riscontro con la realtà. ConclusioniA questo punto occorre porsi una domanda: “Vistala necessità di contrastare la crisi climatica e consi-derati gli argomenti precedenti, è possibile per l’I-talia continuare a fare a meno del nucleare?” La ri-sposta è positiva ed è stata già anticipata nell’arti-colo precedente (Contrastare la crisi climatica), nelquale si è esaminata la reale possibilità di sostitui-re i combustibili fossili con il ricorso alle varie fon-ti rinnovabili e al risparmio energetico in un pro-cesso strategico realistico, che tenda allo svilupposostenibile del Paese.I fautori del nucleare danno ovviamente la rispo-sta contraria, portando le argomentazioni che ab-biamo discusso in precedenza. In ogni caso, a pre-scindere dalla questione economica, nessuno di lo-ro è ancora riuscito a dimostrare la “normalità” delrischio nucleare. Aggiungendo a questo le preoc-cupanti problematiche connesse alle scorie ra-dioattive, che il nucleare lascia in eredità per tem-pi geologici, c’è da porsi seriamente la domanda seil gioco di riproporre oggi il nucleare in Italia val-ga realmente la candela.
19

Le fonti di energia sono apoliticheMolte persone, chissà perché, considerano adesempio il nucleare “di destra” e le fonti rin-
no-vabili “di sinistra”. I fatti dicono che, fra i paesinuclearizzati, ce ne sono stati e ce ne sono sia didemocrazia liberale sia comunisti e che i paesi piùavanzati nel fotovoltaico (in seguito, FV) oggi so-no Giappone, Germania, USA e Spagna, tutti di de-mocrazia liberale, mentre la Cina, comunista, 5 an-ni fa produceva solo l’1% dei materiali FV mondiali,oggi ne produce il 20% e conta di aumentare del400 % la propria capacità produttiva entro cinqueanni. Inoltre il governatore repubblicano della Ca-lifornia ha varato un piano da 2,9 milioni di dolla-ri per dotare quello Stato di una potenza installataFV di 3.000 MegaWatt entro il 2017 e l’Amministra-zione Bush ha previsto di aumentare da 59,9 mi-lioni di dollari del 2006 a 139 milioni di dollari per
il 2007 gli investimenti in ricerca e sviluppo per ilFV.
Il problema energia si pone anche a volerignorare l’ambienteNel 2003 il petrolio costava 29 dollari al barile, og-gi costa intorno ai 73. Di pari passo sono aumen-tati i prezzi delle altre fonti convenzionali di ener-gia, compreso il prezzo dell’uranio, che è passatoda 7 dollari la libbra (2001) ai 40 attuali. Il fatto èche i beni non illimitati, come le fonti non rinno-vabili, sono soggetti ad esaurirsi. E il petrolio sta (ostarebbe) in questi anni attraversando il suo “pic-co”, cioè il momento in cui se ne è estratto metà diquello estraibile sul pianeta senza troppi problemi.Da quel momento in poi il suo prezzo potrà sol-tanto aumentare: a meno che i consumi globali di-minuiscano allo stesso ritmo della disponibilità. Ma
i consumi stanno inve-ce aumentando.
I confronti Rimanendo sull’esem-pio della fonte solare -che è la rinnovabile piùabbondante nel Paesedel Sole e dalla quale èrealistico voler trarreuna quota significativadel fabbisogno elet-tri-co nazionale (teorica-mente, anche l’interofabbisogno) - alla finedel 2004 la capacità pro-duttiva annua di cellefotovoltaiche dell’Italia(dati IEA) era di 7,9 Me-gaWatt, la capacità del-la piccola e nordica Nor-vegia di 10,7 MegaWatt
Leonardo Libero
le rinnovabili
20
L
Chi ha pauradelle’energia pulitaChi ha pauradelle’energia pulita

e quello della nucleariz-zatissima Francia di 30MegaWatt. Meglio del-l’Italia erano poi l’Au-stralia con 35,6 Me-gaWatt, la Spagna con81, gli USA con 138, laGermania con 198, e ilGiappone, primo almondo, con 604 Mega-Watt/anno. Per di più,fra il 2003 e il 2004 la ri-chiesta mondiale di cel-le fotovoltaiche è schiz-zata da 750 a oltre 1.200MegaWatt (+ 60%). Que-sto ha determinato unaimprevista ca-renzamondiale di silicio “so-lar grade”; cioè del ma-teriale semilavorato, lacui produzione non sipuò aumentare in pochigiorni né in pochi mesi,anche il silicio è uno de-gli elementi più diffusisulla Terra. Di tale ca-renza hanno più soffer-to, già nel 2004, i paesiche, come l’Italia, hanno poca o nulla produzionenazionale. I responsabili del ritardo italiano e il grande scan-dalo delle “assimilate” alle rinnovabili.Anzitutto è responsabile l’Enel, che quando era mo-nopolista ha sempre ostacolato l’uso delle “nuove”fonti rinnovabili da parte di altri (ma senza realiz-zare alcunchè di serio da parte sua). Una tenden-za che aveva (ed ha) nel dna e che ha esercitato: a)- in base a una norma insensata della naziona-lizzazione elettrica, che vietava l’autoproduzionecon impianti superiori ai 3 kW (in pratica, la vieta-va del tutto); b)- arrogandosi un potere normativo sugli impian-ti fotovoltaici che nessuna legge gli aveva mai as-segnato: la sola legge vigente in materia, la186/1968, riserva quel potere soltanto al CEI (Co-mitato Elettrotecnico Italiano)c)- grazie anche a questo, esercitando ogni sorta di
resistenze passive, durate decenni e sulle quali sipotrebbe scrivere un libro;d)- imponendo per il “Programma Tetti Fotovoltai-ci” (anno 2000) condizioni a proprio esclu-sivo van-taggio economico e tali per cui gli impianti doveva-no essere il meno potenti possibile, anziché il con-trario come sarebbe stato nell’interesse del paese. Un colmo vergognoso lo ha raggiunto facendosicogliere a fare “la cresta” sulle spese di al-laccia-mento. Il 6 agosto 2001 l’Autorità per l’Energia gliha infatti “ordinato” di “porre fine a comportamentilesivi del diritto di allacciamento alla rete elettricadei nuovi impianti di produzione”. Era risultato cheesso imponeva spese talvolta anche quattro voltesuperiori al costo effettivo dell’operazione; spese,lamentava l’Autorità, “tali da scoraggiare l’avvìo dinuove produzioni, in particolare di piccola taglia,alimentate prevalentemente con fonti rinnovabilidi energia”.
21

Poi sono responsabili anche i Governi dell’iniziodegli anni Novanta, governi che con-Legge 9/91 ela delibera 6/92 del Comitato Interministeriale Prez-zi - detta “Cip6” - hanno i-stituito i sovrapprezzielettrici “A3”, dichiarandoli a sostegno delle fontirinnovabili. Peccato però che, nella legge e nelladelibera, alla parola “rinnovabili” essi abbiano ag-giunto “e assi-milate”, senza fissare criteri chiari perchiarire il significato della “assimilabilità” di unafonte alle rinnovabili. Per cui fra le “assimilate” èpoi stato fatto passare di tutto e soprattutto scartidi raffineria petrolifera e rifiuti non biodegradabilie sono le aziende che li usano per produrre elet-tricità a percepire la maggior parte dell’enorme get-tito di quei balzelli. Una sostanziale distrazione difondi pubblici stimata in una cifra complessiva pa-ri a 60.000 miliardi di Lire (equivalente a 2,5 casiParmalat) dalla X^ Commissione della Camera, ilcui Presidente, Bruno Tabacci, ha definito quei so-vrapprezzi “Una tassa occulta in favore dei petro-lieri”. Si consideri ad esempio che, solo nel 2004,per superpagare elettricità Cip6 di fonte “assimila-ta”, cioè “sporca”, lo Stato ha sborsato 3.511,4 mi-lioni di euro “Cip6”. Con i quali si sarebbero potu-ti acquistare al prezzo di 7.000 euro per kW (cioècarissimi per un tale quantitativo) ben(3.511.400.000 : 7.000) = circa 500mila impianti FVda 1 kW connessi a rete, regalarli a chiunque li vo-lesse e portare così in un solo anno l’Italia – che afine 2003 a-veva appena 26 MegaWatt di potenzainstallata FV – al terzo posto nel mondo a quel ri-
guar-do (a fine 2004, ilGiappone ne aveva po-co più di un milione diMegaWatt, la Germania794mila, gli USA 365mi-la). Per fortuna – e perobiettivo merito di Go-verno e Parlamento –l’articolo 15, n. 1, lette-ra f) della Legge 62 - 18aprile 2005 esclude ognipossibilità di rinnovodelle convenzioni per“assimilate Cip6”. Lequali però hanno am-piezza temporale di 15anni, per lo più stipula-
te nel 1992 e scadranno quindi non prima del 2007.Perciò solo a partire da tale anno lo Stato disporràdi fondi adeguati a sostenere seriamente l’utilizzodelle fonti rinnovabili anche nel nostro paese.
A che punto siamoPer il fotovoltaico, il 28 luglio 2005 l’allora Ministrodelle Attività produttive Scajola ha e-manato un de-creto che ha istituito anche in Italia il sovvenzio-namento del Fotovoltaico “in conto energia”; cioèil sistema di incentivazione risultato il più efficacein numerosi paesi e particolarmente in Germania.In poche parole, il proprietario di un generatoreFV versa in rete l’elettricità prodotta, che gli vienepagata a una tariffa incentivante circa tripla di quel-la corrente, ma egli paga invece a tariffa correntel’elettricità che preleva dalla rete. Purtroppo i bu-rocrati estensori del decreto lo avevano non soloscritto in burocratese, ma anche inzeppato di com-plicazioni inutili e vere stupidaggini. Inoltre vi era-no stati previsti limiti di potenza totale installata tal-mente bassi (100 MegaWatt subito e 300 totali al2015) che erano stati già raggiunti nella prima set-timana di vigenza del decreto. Di fronte alle criti-che degli operatori, il Ministro aveva disposto l’e-manazione di un nuovo decreto. La nuova bozzadel quale però aumentava sì i limiti di potenza in-stallata (500 MegaWatt subito e 1000 al 2015), maper altri versi peggiorava il primo decreto anzichémigliorarlo: i burocrati avevano colpito ancora. Perinciso, che al Ministero Attività Produttive qualcu-
le rinnovabili
22

no “remi contro” al FV è molto più di un sospetto;anche perché quel qualcuno si è sempre così “espo-sto” (evviva la sincerità!) che una importante rivi-sta europea ne ha perfino pubblicato il nome, enon una sola volta. Comunque il secondo decreto,che era un lungo elenco di modifiche da apporta-re al primo, è stato discusso alla Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio, l’ultima Conferenza previstaprima delle elezioni del 9 aprile; e per fortuna inquella occasione è stato trovato un accettabile ac-cordo fra le parti, perchè diversamente il settore sa-rebbe rimasto bloccato almeno fino a estate inol-trata. Infine, si pensi che già al 31 marzo 2006 ledomande di allacciamento pervenute al GRTN era-no corrispondenti ad una potenza complessiva 1,6volte superiore a quei 1.000 MegaWatt totali teori-camente da raggiungere solo nel 2015 !!! In con-clusione, il risultato dell’integrazione fra i due de-creti è un malloppo di difficile lettura, ma col pre-gio innegabile di esistere. La situazione è, a questopunto, di grande incertezza circa il futuro. E’ per-ciò urgente che il nuovo Esecutivo riesamini, o me-glio, riscriva l’intero sistema di incentivazione del-l’energia fotovoltaica; per stabilire con certezza leprospettive della crescita nei prossimi anni; per ra-gioni di comprensibilità e per depurarlo delle for-malità inutili che comporta. E, per prime, di quasitutte le prescrizioni tecniche; perché nel caso delsovvenzionamento “in conto energia” – diversa-mente che per quello “in conto capitale” – a chi loeroga non deve interessare la qualità dell’impian-to, ma solo la quantità di energia che esso versa inrete. Quello è infatti uno dei criteri seguiti dalla leg-ge tedesca EEG, alla quale, per i brillanti risultatiottenuti, tutti dicono di volersi ispirare. Per le altre “nuove fonti rinnovabili”, sempre nel-l’ambito dei piccoli impianti a dimensio-ne non in-dustriale, il 13 febbraio 2006 l’Autorità per l’Ener-gia Elettrica e il Gas ha approvato un provvedi-mento per lo “scambio sul posto” di energia elet-trica prodotta da impianti ali-mentati da fonti rin-novabili (eolica, idrica, etc.) di potenza fino a 20kW. In poche parole, il proprietario di un genera-tore elettrico da fonte rinnovabile può versare inrete l’energia pro-dotta, che deve essere contabi-lizzata dalla società distributrice elettrica a scontodelle bollette future o dei futuri consumi (quindicon una contabilizzazione a tariffa corrente). C’è
da spe-rare che questo sia il primo passo verso ilsovvenzionamento “in conto energia” di tutte lefonti rinnovabili, sia pure con tariffe differenziatesecondo la fonte, come giustamente prevede la ci-tata legge tedesca EEG. Resta poi sempre vigente il meccanismo dei “cer-tificati verdi”: che obbliga i grandi produttori e ven-ditori di elettricità ad acquistare una quantità dienergia elettrica prodotta da fonte rinnovabile pa-ri ad una quota di circa il 3 per cento (in aumentoprogressivo) sul totale da loro trattato. Quote chevengono “certificate” e scambiate, a prezzi non cer-to modesti, attraverso la cosiddetta “borsa elettri-ca”, da cui, appunto, il termine di “certificati ver-di”. Ma questo riguarda la produzione di elettricitàa scala industriale e non la produzione “familiare”diffusa. Devo però precisare che personalmentenon apprezzo molto, almeno sul piano morale, icertificati verdi (né i certificati bianchi), che consi-dero scappatoie attraverso le quali chi se lo puòpermettere può comprarsi, nel vero senso, licenzadi inquinare.Alla metà di giugno, il nuovo Ministro dello Svi-luppo Economico (già delle Attività Produt-tive: nelcambiare il nome – ma solo il nome - alle cose sia-mo imbattibili !), onorevole Bersani, ha presentatoun Disegno di Legge sull’Energia che all’articolo 2si propone di promuovere lo sviluppo delle fontirinnovabili, ma di esse cita espressamente soltan-to “il solare termico” (ottima cosa, ma perché il fo-tovoltaico no ?) e “i carburanti di origine vegeta-le”; i quali, per inciso, sono ritenuti dagli esperti ilsistema meno efficiente e meno ripagante con cuiutilizzare una certa superficie di territorio per pro-durre energia. All’articolo 6, inoltre, il DdL Bersaniabroga gli articoli 15,16 e 17 della Legge 62/2005.Non conosco gli articoli 16 e 17, ma il 15, come inprecedenza ho accennato, è quello che escludeogni possibilità di rinnovo per le convenzioni perfonti “assimilate Cip6”. E’ perciò evidente che la suaabrogazione ridarebbe a certi produttori di elettri-cità da fonti “sporche” la possibilità di intascare isoldi fatti pagare ai cittadini per favorire e soste-nere quelle “pulite”. Sono convinto che questa par-ticolare conseguenza sia sfuggita al Ministro. Nonsono invece altrettanto sicuro, dati molti precedenti,che essa sia sfuggita anche a chi ha materialmenteredatto quel Disegno di Legge.
23

e tecnologie rinnovabili possono essere con-siderate genericamente tecnologie solari, poi-ché quasi tutte sfruttano, in modo diretto o
indiretto, la luce che investe il pianeta. (...) L'inte-ro processo di sfruttamento e commercializzazio-ne di queste tecnologie può essere definito “sola-rizzazione”, e le tecnologie stesse sono dette rin-novabili in quanto saranno potenzialmente in gra-do di generare energia finché la luce del sole con-tinuerà ad investire la Terra: in tal senso sono daconsiderarsi inesauribili. (...)Uno dei più famosi scienziati della Shell, MarionKing Hubbert, era giunto a queste conclusioni giàmolto tempo fa: “La nostra cultura non è in gradodi affrontare una stabilizzazione o un declino ener-getico, eppure dovrà suo malgrado imparare a far-lo”, dichiarò una volta. “Dobbiamo cambiare rottae puntare verso una condizione di stabilità, in cui
il rischio di una catastrofe sia ridotto al minimo. E'necessario cercare altre fonti di energia. Ne esisteuna sola sufficientemente grande. Non costa nullae non si esaurirà per almeno un altro miliardo dianni: il sole.”Agli inizi del mio periodo di attivismo ambientali-sta, nel 1989, quando io e i miei colleghi sostene-vamo a gran voce che le fonti rinnovabili poteva-no soppiantare i combustibili fossili e alimentare ilmondo intero, gli esperti di energia e i politici li-quidarono il nostro pensiero come ingenuo e uto-pistico. Oggi, a quasi vent'anni di distanza, quellostesso punto di vista è ormai ampiamente condivi-so da tutte le istituzioni politiche, perlomeno in Eu-ropa. In un rapporto pubblicato dal governo bri-tannico nel 2003 si legge la seguente conclusione:“Sarebbe fattibile, sia sul piano tecnologico sia suquello economico, ridurre gradualmente, fino a un
totale azzeramento, leemissioni nocive perl'atmosfera. Basterebbeutilizzare l'energia inmodo più efficiente esviluppare sistemi ener-getici a ridotta emissio-ne di carbonio”. Fra letecnologie a bassa emis-sione oggi disponibili, ildocumento pone parti-colare enfasi sulle fontirinnovabili e i sistemi aidrogeno, più che sulnucleare. Quanto all'e-nergia solare, il rappor-to conclude: Sarebbe ingrado, da sola, di sod-disfare l'intero fabbiso-gno mondiale sfruttan-do appena l'uno percento del terreno attual-
Questo brano è trattodal libro “Fine corsa.Sopravviverà la specieumana alla fine delpetrolio?”, editoEinaudi, 2006
Jeramy Leggett
le rinnovabili
24
L
Così usciremodall’era del petrolioCosì usciremodall’era del petrolio

mente adibito all'agricoltura”. Il primo ministro TonyBlair pronunciò queste stesse parole nel suo di-scorso di presentazione del Libro bianco sull'ener-gia del governo britannico. Io ero seduto in primafila ad ascoltarlo, e per un attimo fui tentato di al-zarmi in piedi e gridare: “E allora mi spiega perchénon investite in quel campo, come fanno i tedeschie i giapponesi?”Nell'ambito delle istituzioni locali è possibile tro-vare alcuni piccoli esempi di ciò che andrebbe fat-to su scala nazionale, o meglio ancora internazio-nale. Prendiamo la cittadina di Woking, nel Surrey.Nel suo piccolo, il consiglio circoscrizionale ha at-tuato, a partire dal 1990, un taglio delle emissionidi anidride carbonica pari al settantasetta per cen-to – più di tre quarti del totale – migliorando l'effi-cienza energetica e impiegando un sistema ibridoa idrogeno, con l'installazione di una rete elettricaprivata, impianti di cogenerazione termoelettrica(funzionanti principalmente con gas naturale, main parte anche con biomasse), pannelli fotovoltai-ci, dispositivi a pile a combustibile e refrigeratoriad assorbimento. Ho avuto modo di visitare di per-sona quest'oasi felice, accompagnato dal respon-sabile locale per l'energia, Allan Jones, il quale miha mostrato con comprensibile orgoglio le abita-zioni e gli altri edifici della cittadina, trasformati inveri e proprio microcosmi energeticamente auto-nomi. Se la rete elettrica nazionale smettesse persempre di funzionare, gli abitanti di Woking conti-nuerebbero ad avere luce e riscaldamento. Le tec-
nologie funzionano in perfetta armonia. Le unità dicogenerazione termoelettrica producono il riscal-damento necessario in inverno, e subentrano aipannelli fotovoltaici quando questi non sono in gra-do di fornire sufficiente energia elettrica. La Grea-ter London Authority ha recentemente ingaggiatoAllan Jones per replicare l'impresa a Londra. Okay,amico, ha detto il sindaco, sei riuscito a farlo in unacittadina di ottantamila anime. Ora provaci in unametropoli di otto milioni di abitanti.(...)Alla luce delle potenzialità offerte dalle fonti rin-novabili e dai sistemi per migliorare l'efficienza ela capacità di conservazione dell'energia, quali con-clusioni possiamo trarre circa la tempistica neces-saria per completare il processo di solarizzazione?Amory Lovins afferma che la sostituzione del com-bustibile primario e di altre tecnologie richiede nor-malmente una cinquantina d'anni. Un dato piutto-sto sconfortante, che tuttavia si riferisce al passag-gio legno-carbone-petrolio/gas e all'avvento delleferrovie e dell'elettricità. La diffusione dell'idroge-no, data la possibilità di operare un'innovazione suscala ridotta, avverrebbe in tempi più rapidi, ov-vero nell'arco di circa venticinque o trent'anni. C'èla possibilità che le cose si muovano più in fretta?Ma certo. Prendiamo l'automobile. Nel 1900 il mez-zo di trasporto predominante era il cavallo. Quan-do le prime autovetture fecero la loro comparsa fu-rono a lungo oggetto di scherno. Erano costose,lente e inaffidabili, inoltre mancava un'adeguata re-te stradale su cui farle viaggiare. Poi Henry Ford
25

iniziò a produrle su scala industriale, abbattendo icosti, e parallelemente fece pressione sul governoaffinché fossero costruite strade più idonee. Nel1900, negli Stati Uniti, circolavano ottomila auto-mobili, ma già nel 1912 il loro numero era salito anovecentomila! Nell'arco di appena un decenniola loro presenza si era diffusa a macchia d'olio.Riprendiamo, per un momento, il monito che losceicco Yamani rivolse agli altri ministri del petro-lio nel 1981, quando dichiarò che i paesi dell'Oc-cidente, spinti dall'yumento del prezzo del greg-gio, sarebbero stati in grado di trovare fonti di ener-gia alternative nel giro di un decennio. Ebbene,dopo vent'anni di ricerche, possiamo dire che quel-l'obbiettivo è ormai a portata di mano? La riluttan-za a proseguire sulla strada della dipendenza dalpetrolio d'oltreoceano, scaturita dagli eventi dell'11settembre 2001, ha senz'altro contribuito ad ac-crescere l'interesse verso le energie rinnovabili re-peribili in patria. La corsa allo sviluppo di tecno-logie alternative e di nuovi sistemi di conserva-zione dell'energia si sta diffondendo sempre piùrapidamente in molte nazioni del mondo. Grandiaziende del calibro di Sharp, Sanyo, RWE e Gene-ral Electric hanno recentemente iniziato a investi-re cifre considerevoli nel campo della solarizza-zione. Le priorità sociali e individuali si stanno con-centrando sempre di più nell'ambito dell'energia.Un crescente numero di investitori privati sta spo-stando la propria sfera di interesse dal settore del
petrolio a quello delle fonti rinnovabili, nel tenta-tivo di placare le proprie preoccupazioni per lesorti dell'ambiente. Attualmente, oltre un dollarosu dieci viene destinato a fondi di investimento acarattere ecologico. (...) Di recente gli abitanti diSan Francisco hanno votato a favore di una riso-luzione che prevedeva lo stanziamento di centomilioni di dollari, e di altre ingenti somme in fu-turo, per finanziare l'installazione di impianti aenergia solare ed eolica. Nel Regno Unito quaran-ta istituzioni locali hanno già provveduto a infor-mare le società di costruzione che in futuro gli ap-palti edilizi saranno subordinati alla garanzia chealmeno il dieci per cento dell'energia impiegatanei cantieri sia prodotta mediante fonti rinnovabi-li. Il mercato delle tecnologie alternative, per quan-to ancora circoscritto, sta crescendo con una rapi-dità sbalorditiva e gode di investimenti sempre piùconsistenti. Del resto, questo settore annoveraun'intera famiglia di tecnologie “dirompenti”, co-me lo sono state l'introduzione del motore a com-bustione interna (motore a scoppio), che ha se-gnato la fine del mercato dei cavalli, e la nascitadei microcomputer, che hanno soppiantato le unitàcentrali di elaborazione. Queste nuove realtà si ap-prestano a invadere un mercato del valore di quat-tromila miliardi di dollari, che abbraccia il settoredei servizi energetici e quello delle costruzioni.Oggigiorno, pochi altri campi sono in grado di of-frire un simile potenziale di crescita.
le rinnovabili
26

’impattoLe grandi torri eoliche, per la collocazione suicrinali, per l’altezza, per la composizione in
serie, introducono nel territorio scenari assoluta-mente inusuali, che irrompono – con la forza del-le loro gigantesche dimensioni- nella visione pae-saggistica. Grandi macchine, potenti, dominanti,sempre in movimento. Le più grandi mai costruitedall’uomo. Gli ultimi progetti sfiorano i 130 metri,pari all’altezza della cupola di S. Pietro.
Chi le conosce, o le vive quotidianamente da vici-no, dichiara inquietudine e turbamento nel vede-re i luoghi familiari della propria vita radicalmentemutati e sconvolti in tempi brevissimi.Il movimento perenne, in aggiunta alla grandez-za, determina per lo sguardo una attrazione ine-ludibile.La sensazione di un implacabile dominio delle mac-chine sull’uomo, sembra ora estendersi fin nei luo-ghi che sembravano dedicati per sempre alla bel-lezza ed alla serenità delle campagne e dei monti.L’impatto, colpisce alla radice i valori del paesag-gio, in maniera irreversibile ed immitigabile, perciò stesso che nella ricerca del vento gli apparatidevono svettare su tutto, diventando il punto fo-cale di ogni visione..Territori visti solo ieri, liberi nei campi , nei crinalie negli orizzonti, dopo il conficcamento delle im-mani palificazioni, sono oggi di fatto estromessi dal-l’elenco delle bellezze naturali e paesistiche del no-stro paese.Un paese di piccola taglia , lungo e stretto , densa-mente abitato, percorso ovunque da strade e co-stellato di borghi, torri, castelli, abbazie, aree ar-cheologiche .Dove ogni luogo ed ogni monumento dialoga conun universo di luoghi e siti circostanti storici e na-turali.Dove il contesto paesaggistico è valore irrinun-ciabile di ogni monumento isolato nelle campagnee nei versanti dei monti .Dove l’alterazione del pae-saggio porta con sé la banalizzazione dei tesori cul-turali storici architettonici ed archeologici.
Un mutamento epocaleDopo le grandi, caotiche e mal riuscite periferie cheassediano le città storiche; dopo lo sparpagliamentoirresponsabile di capannoni e villette per le cam-pagne ( un tempo magnifiche) delle aree metro-politane; dopo la distruzione di migliaia di chilo-
Oreste Rutigliano
eolico
27
L
Macchine controil paesaggioMacchine controil paesaggio

metri di coste, ecco ora una nuova piaga ad af-fliggere il nostro paese.Una nuova forma di speculazione edilizia.L’accaparramento, sotto la spinta di interessi mi-liardari dei luoghi più ventosi, fuori da ogni seriavalutazione di impatto ambientale. Terreni acqui-siti a quattro soldi sulle cime dei monti e nelle cam-pagne più riposte, più conservate e più autentiche.Con regalie a Comuni indifesi, in una sorta di nuo-va colonizzazione, non a caso guidata da lobby in-dustriali del Nord Europa, ben inserite nella Co-munità Europea. Esse si giovano, paradossalmen-te, della benevolenza di vasti settori del mondo am-bientalista , che per mancanza di cultura del pae-saggio, non sanno distinguere i luoghi del globoterraqueo, adatti o meno ad accogliere questa tec-nologia.I progetti, in verità dissennati, di installare 10.000MegaWatt di eolico (vedi proposta Legambiente)con migliaia e migliaia di torri distribuite in granparte del Mezzogiorno e in estesissime aree ap-penniniche, isolane e prealpine preannunciano una
dequalificazione generale nel paesaggio italiano.In insanabile contraddizione con i programmi, levocazioni e le aspettative sulle quali da tempo la-vorano le comunità agricole e le loro organizza-zioni per fare di questa ultima grande riserva delpaesaggio storico e naturale, una risorsa capacetrattenere gli abitanti che le presidiano e fornire po-sti di lavoro nella accoglienza rurale, nel turismoambientale e culturale.Nella divisione internazionale del lavoro di ridu-zione dei gas serra nessuno ci obbliga a sceglierel’eolico e neppure vi sono imperiose ragioni di or-dine temporale ed economicistico.Ancora una volta per avventatezza e per avidità sitrascurano le nostre risorse a vantaggio di altri, dipochi, e di estranei:- il sole, per farne la nostra industria energetica,senza ricadute dannose- il paesaggio, per riequilibrare la nostra economiacon beni di qualità e da altri irriproducibili, con-servandolo e restaurandolo nei suoi più originalicaratteri.
eolico
28
L’impatto potenziale di questo progetto potrebbe es-sere così grande da costituire la base per una rivolu-zione energetica di portata globale. Si può dedurre chesopra l’Europa passa un flusso di vento che media-mente ha una potenza pari a 100.000 centrali nuclea-ri. Come si può fare per andare a sfruttare questa gran-de energia totalmente rinnovabile, rappresentata dalvento in altitudine? Il progetto KiteGen ha l'obiettivodi dimostrare la possibilità di controllare in modo au-tomatico gli aquiloni di potenza (power kites) allo sco-po di generare energia elettrica da fonte eolica. I powerkites sono aquiloni, o meglio, profili alari con una su-perficie di alcune decine di metri quadrati. Sono ma-novrabili da terra con una coppia di funi, che consen-te di controllarne la direzione di volo e l'assetto rispettoal vento. In presenza di venti tesi, un singolo profiloalare è in grado di esercitare una forza di trazione chepuò arrivare ad alcune centinaia di kiloNewton, navi-gando a velocità che possono superare gli 80m/s. Ilprodotto forza per velocità potrebbe testimoniare l’or-
dine di grandezza della potenza implicata, siamo nel-l’ordine di decine di MW, ma i calcoli necessari per ot-tenere i valori precisi di potenza sfruttabile sono piùcomplessi. Il KiteGen può essere immaginato come unaturbina orizzontale saldamente vincolata al suolo, co-stituita da una struttura di supporto centrale che sor-reggere i bracci tramite una tensostruttura. La giostraviene messa in rotazione proprio grazie al vento, chetrascina in quota gli aquiloni. Il corpo centrale rotanteè anche il generatore elettrico, esso contiene gli arga-ni automatici per le coppie di cavi di guida/potenzadegli aquiloni, lunghi oltre 1000 metri. A regime, tuttigli aquiloni sono in volo guidato con precisione nellospazio aereo, la buona efficienza dei profili alari con-sente anche una navigazione parzialmente controven-to. KiteGen è una macchina che produce energia inmodo proporzionale alla sua dimensione.
Massimo Ippolitoingegnere Sequoia automation di Chieri (TO)
Progetto Kite Gen, come sfruttare il vento in altitudine

29
Il grande business costituito dall’eolico, con tanto di in-teressi delle grandi famiglie del capitalismo italiano datempo scese in campo, è ben documentato da due lun-ghi articoli apparsi sul numero dell’Espresso del 3 ago-sto. Da questi abbiamo estratto i dati più significativi.
“Vuole raddoppiare la sua produzione eolica in Italia l’E-nel, che ha appena messo in funzione un parco eolicoda 54 Mw in Sardegna, punta al raddoppio nel segmentoper il 2010 e va a caccia di affari anche in Francia e inSpagna, con il portafoglio gonfio di 2,3 miliardi di euro.Per la conquista di Enertad, una piccola società di ener-gia eolica.. è scesa in campo la Eg dei Garrone (già inJoint venture nel settore con gli spagnoli di Acciona),impegnandosi in una partita che vede come antagoni-sta la Alerion di Giuseppe Garofano (con soci eccellen-ti come Alfio Marchini). Nell’eolico hanno investito i Mo-ratti con la Sardeolica; la Api dei Brachetti Peretti, cheha acquistato un impianto di uno storico developer pu-gliese, Filippo Sanseverino e ora vuole incrementare; s’èlanciato il gruppo Falck, che sogna di operare su unadorsale del vento dall’Inghilterra all’Italia sino al Maroccoe anche il gruppo De Benedetti con Sogenia, la sua so-cietà per la produzione elettrica. Le spagnole Endesa eIberdrola hanno già iniziato lo shopping da noi e han-no opzionato centrali in costruzione in Basilicata e Ca-la bria dalla Gamesa, secondo gruppo continentale nel-
la produzione di torri e pale. Il gigante assicurativo te-desco Allianz ha comprato una centrale da 72 Mw in Si-cilia.... E come operatore eolico italiano si è appena piaz-zato il fondo irlandese Trinergy: ha infatti rilevato la pro-prietà di gran parte degli impianti eolici in portafoglioIvpc, la società dell’avvocato avellinese Oreste Vigorito,il re dell’eolico made in Italy, più grande di Enel e Edi-son messe insieme...”L’Espresso passa poi a spiegare il perchè di un così ra-pido sviluppo.“Il segreto dei mulini a vento sta nel fatto che sono allaportata di tutti. La “fiche” per puntare sulla roulette del-l’eolico può essere di due-tre milioni (uno a megawatt):un impianto modesto sì ma molto diffuso nella realtà: Efarseli dare da una banca non sarà difficile considerandoche l’eolico è fortemente incentivato. Gode cioè di duevantaggi: Primo: l’energia prodotta ha diritto di proprietàe di ritiro obbligatorio da parte del Gestore della rete. Se-condo: il suo prezzo è quello di mercato, come per gli al-tri produttori, ma ha una remunerazione extra, il certifi-cato verde. In cifre questo fa dell’eolico un kilowattora dilusso: sui 17,8 centesimi riconosciuti al suo produttore,solo 7 rispecchiano la quotazione di Borsa. Il resto, cioè10, 8 centesimi, sono garantiti dal certificato verde. In to-tale questo fa sì che il business eolico, che ha fatturatol’anno scorso 340 milioni di euro, ne abbia incassati 193,e quindi più della metà, a titolo di incentivo...”
Dalle Torri un fiume di denaro

sì all’eolico nelle aree industriali, no dove de-turpa”: Con questo slogan il Comitato Naziona-le del Paesaggio ha disgelato il carattere pesan-
temente industriale delle torri eoliche, che con la inef-fabile dizione di “parchi eolici” stavano e stanno in-vadendo le aree naturalistiche, ambientali delle areeinterne, alterando per sempre il paesaggio agrosilvo-pastorale.Il Comitato nasce nel 2001, fondato da Carlo Ripa diMeana ed altri pochi preveggenti ambientalisti, edamici del paesaggio italiano. Aderiscono progressivamente personaggi ed asso-ciazioni tra cui il CTS, Pro Natura, Mountain Wildr-ness, Altura, associazione per la protezione dei rapa-ci, Associazione italiana per la wilderness, MovimentoAzzurro, Ambiente e Vita, GAIA Animali e Ambien-te, LAC, Legaanticaccia;poi danno sostegno e contenuti di azione forte e vi-gorosa i rappresentanti regionali del WWF delle Mar-che, Umbria, Molise e Sicilia e della LIPU Puglia e Mo-lise, ed infine la commissione del CAI dell’Italia cen-trale e meridionale. E naturalmente tanti esponenti diItalia Nostra con l’intento primario di difendere i be-ni paesaggistici.
Il CNP ha riassunto la sua battaglia in poche propo-sizioni, dopo aver assunto dal mondo scientifico in-dipendente tutte le necessarie informazioni.
Le rinnovabili intermittenti adibite alla produzione dienergia elettrica rivestono carattere complementare,e non possono essere immesse in rete in proporzio-ni superiori al 10-15% della potenza installata, penail black out della rete di distribuzione, e non potran-no quindi incidere per più del 2-2,50% nel risparmiosul totale dei combustibili fossili consumati in Italia(nel solo 2004 i consumi sono aumentati del 2,8%).
Le centrali eoliche, per le gigantesche strutture checomportano e per la necessità di essere installate sul-
le cime dei monti, sui crinali, o in zone comunquesommitali, sono intrinsecamente non mitigabili, noninseribili nella particolarità del paesaggio italiano, equindi irrimediabilmente deturpanti.
Le centrali eoliche sui passi, sui crinali e sulle prate-rie d’altura mettono inoltre in pericolo l’avifauna stan-ziale e di passo.La allontanano e mettono a rischio di estinzione al-cune delle più importanti specie di rapaci (la velocitàperiferica delle pale di 90 metri di diametro supera i250 Km. all’ora).
Le centrali eoliche portano l’urbanizzazione ad altaquota, quanto e più ferocemente degli impianti sciisti-ci, consumando l territorio connettivo della rete biolo-gica, con il sacrificio di segmenti di ecosistemi di ele-vatissimo valore biologico, estremamente vulnerabili.
Le rinnovabili vanno comunque ed in ogni caso rea-lizzate ed incentivate, anche con sacrifici economicidei cittadini e consumatori, ma secondo la vocazio-ne e le caratteristiche territoriali di ciascun paese, inuna sorta di equa e razionale distribuzione mondia-le dei compiti nell’abbattimento dei gas serra.
Scartando dunque in Italia, anche per scarsità di ven-to (1850 ore l’anno), l’eolico industriale, e privile-giando invece biomasse, fotovoltaico e solare ter-modinamico (progetto Rubbia) in grado di consenti-re anche all’Italia, paese del sole, di inserirsi strategi-camente nella produzione di rinnovabili in vista del-la produzione pulita del vettore energetico idrogeno.
Inconcepibile dunque la corsa all’eolico, nella in-gannevole affermazione di adempiere a Kyoto, per icui obiettivi gli investimenti, come comincia final-mente ad affiorare, dovrebbero essere concentrati sul-la efficienza energetica di motori, elettrodomestici,edifici e stabilimenti di produzione.
Oreste Rutigliano
eolico
30
“
L’impegno del Comitatodel paesaggioL’impegno del Comitatodel paesaggio

e localizzazioni predilette degli impianti sono,per la ventosità, i crinali montano-collinari del-l’Appennino e le grandi isole. La realizzazione
delle centrali e delle opere ad esse accessorie ha co-me primo, più vistoso effetto la devastazione irrever-sibile dei valori paesaggistici e panoramici. Tale im-patto viene notevolmente amplificato dal fatto che gliimpianti, progettati separatamente, vengono poi spes-so aggregati in aree di confine tra più comuni. Unesempio drammatico in tal senso è rappresentato dal-la Valle del Fortore, al confine tra le regioni Campa-nia, Puglia e Molise, dove diverse amministrazionihanno imprudentemente consentito l’installazione diassai numerose pale eoliche, cosicché oggi i crinali ditutto il comprensorio ospitano oltre 600 torri. L’effet-to visivo e prospettico da qualsiasi punto si osservi lavallata è tale che l’intero aspetto dei luoghi risulta pe-
santemente trasformatoe ciò, unitamente alla ru-morosità delle pale, fadecadere in modo defi-nitivo qualsiasi valenzaturistica del territorio. Atale proposito si eviden-zia che alcuni recentiprogetti dovrebbero in-teressare le ultime costerocciose ancora intatte,come ad esempio quel-le del Salento. Una situa-zione analoga a quelladella Valle del Fortore sista venendo a creare inprovincia di Chieti, neicomuni di CastiglioneMesser Marino, Schiavid’Abruzzo ed altri vicini.Alla devastazione delpaesaggio si accompa-gna il grave danno arre-
cato all’ambiente naturale, nelle sue varie compo-nenti. Spesso le aree scelte per la realizzazione degliimpianti costituiscono habitat di elevato pregio natu-ralistico, che in molti casi, proprio per il loro valoreambientale di importanza spesso non solo regionalema nazionale ed internazionale, ricadono in aree pro-tette dalla legislazione interna (Parchi nazionali e re-gionali, riserve naturali) o in Siti d’Importanza Co-munitaria, o in entrambe le situazioni. I progetti chesi stanno proponendo non tengono in nessun contoi principi di conservazione acquisiti in questi ultimidecenni nel nostro Paese e in Europa e che hannotrovato espressione giuridica in fondamentali normenazionali come la legge quadro sulle aree protetten.394 del 1991, nella cosiddetta legge Galasso su vin-coli e piani paesistici, oggi convertita nel D.L. 490 del1999, nonché nelle relative leggi regionali in materia.I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ospitano spe-cie animali e habitat minacciati meritevoli di misurespeciali di tutela. Per tale motivo sono riconosciuti dirilevanza europea sulla base di convenzioni interna-zionali e di norme comunitarie coma la Direttiva92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e se-minaturali, della flora e della fauna selvatiche), rece-pita in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e laDirettiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli sel-vatici), recepita in Italia con la legge n.157 del 1992.Le suddette Direttive prevedono l’istituzione di una re-te europea di aree protette denominata NATURA 2000e i siti individuati ai fini della loro inclusione, furono asuo tempo individuati dalle Regioni sulla base di studinaturalistici appositamente condotti. Oggi, parados-salmente, molte Amministrazioni pubbliche avvallanoed autorizzano la distruzione dei beni naturalistici daloro stesse inventariati. Nel quadro della tutela dellearee protette è fonte di notevole preoccupazione il Pro-tocollo d’intesa “L’energia dei Parchi” firmato il 27 feb-braio 2001 da Enel, Ministero dell’Ambiente – ServizioConservazione della Natura, Legambiente e Federa-zione Italiana Parchi e Riserve Naturali, che favorisce
Stefano Allavena
eolico
31
L
Ghogliottineper l’avifaunaGhogliottineper l’avifauna

ed incentiva lo sfruttamento, nelle aree protette, dellefonti di energia rinnovabile ovverosia il vento e quin-di le centrali eoliche, vista la situazione italiana di qua-si monopolio dell’eolico rispetto alle altre forme di ener-gia rinnovabile. Il Protocollo costituisce inoltre un pe-ricoloso precedente, un alibi, per quanti al di fuori del-la aree protette vorranno realizzare centrali eoliche inaree naturalisticamente di pregio.In sostanza, la presenza di decine e centinaia di torrieoliche di grandi dimensioni, con pale in movimen-to di giorno e di notte, esercita un pesante impattosulla fauna. Le zone individuate per le centrali sonoper lo più molto importanti per numerose specie dirapaci sia come zone di caccia sia come punti di con-centrazione durante le migrazioni. E’ noto e docu-mentato il rischio diretto per gli uccelli rapaci costi-tuito dalle pale dei generatori oltre che dal degradoambientale generale connesso. Quasi tutte le speciedi rapaci italiani sono incluse nell’allegato I della Di-rettiva 79/409/CEE, che comprende le specie parti-colarmente meritevoli di tutela per le quali gli Statimembri sono tenuto all’adozione di misure specialidi conservazione dei loro habitat di vita per “… ga-rantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette spe-cie nelle loro aree di distribuzione”. La realizzazionedelle centrali eoliche in tali ambienti costituirebbequindi un’evidente infrazione a precisi obblighi co-munitari. Negli Stati Uniti varie ricerche scientifichetestimoniano come la presenza dei generatori in areecritiche costituisca un forte fattore di minaccia per laconservazione di molte specie di rapaci. In partico-lare uno studio condotto in un’area della Californiaha verificato che il 38% della mortalità dell’aquila rea-le era dovuto all’impatto con le turbine eoliche. Con-siderando l’impatto con gli elettrodotti, il cui svilup-po si presuppone sia proporzionato all’energia pro-dotta, tale percentuale di mortalità sale al 54%. Da unaltro studio più recente effettuato nelle medesime lo-calità risulta che in soli undici mesi sono stati uccisi,a causa delle collisioni con pale eoliche, 139 esem-plari di uccelli rapaci, tra cui 74 poiane e 5 aquile rea-li. E’ evidente che l’aquila reale, come molte altre spe-cie di rapaci già rari in Italia poiché minacciati da mol-teplici altri fattori, difficilmente potrebbe sopravvive-re nelle zone interessate dagli impianti eolici. Poichéquesti sono progettati di preferenza proprio negli ul-timi territorio dove sopravvivono aquile reali, aquiledel Monelli, avvoltoi, nibbi reali, gufi reali e altri ra-
paci reali, intere popolazioni di uccelli da preda po-trebbero subire un ulteriore e forse definitivo tracol-lo vanificando così il lavoro di decenni nella battagliaper la loro salvaguardia. Ancora più minacciati degliadulti risultano essere i giovani da poco involati danidi ed ancora poco esperti nel volo. Il rischio di col-lisione con le pale sarebbe inoltre elevato per gli uc-celli migratori soprattutto durante il passaggio not-turno ed in condizioni di nebbia.Va messo in evidenza come le ricadute negative coin-volgerebbero l’intera comunità animale sia a causadegli effetti indotti sulla vegetazione e quindi sulla di-sponibilità delle risorse alimentari, sia a causa dellamortalità diretta a carico dei rapaci che svolgono unindispensabile ruolo di controllo ecologico, sia a cau-sa di fattori indotti come il disturbo e il bracconaggiofavoriti dalla nuova viabilità. Anche i pipistrelli, par-ticolarmente utili per la loro dieta insettivora, verreb-bero falcidiati dal movimento delle pale.In conclusione:1. Le centrali eoliche sono veri e propri impianti in-dustriali, e pertanto già in quanto tali la loro ubica-zione in aree ambientalmente pregevoli risulta del tut-to incompatibile con la vocazione spiccatamente na-turalistica di questi territori, caratterizzate inoltre dalfatto che, essendo per lo più realizzate in aree remo-te, comportano la costruzione di infrastrutture di ser-vizio, come strade e linee elettriche, che ne accre-scono il già notevole impatto sull’ambiente e sulle suevarie componenti.2. Non è accettabile che, come invece è diventata pras-si usuale, la localizzazione e la dimensione degli im-pianti vengano decise solo in base a contrattazioni trale ditte produttrici ed i comuni interessati, che spes-so svendono per pochi soldi i valori ambientali piùsignificativi dei loro territori. 3. E’ necessario che il Ministero dell’Ambiente e gli al-tri enti coinvolti ritirino il Protocollo d’intesa “L’ener-gia dei Parchi”, firmato nel febbraio 2001, che ha ef-fetti diretti ed indiretti molto dannosi nei confrontidella salvaguardia degli ultimi ambienti naturali delnostro Paese.4. Vi è un alto livello di disinformazione in meritoalle centrali eoliche vista da molti, anche titolari diresponsabilità decisionali, come a basso impattoambientale. Occorre quindi un’attenta opera di sen-sibilizzazione e di informazione in merito alla si-tuazione reale.
eolico
32

el marzo del 2004 esce in Germania unainchiesta sulla questione eolica sul più au-torevole e diffuso settimanale europeo :"
Der Spiegel ".In Germania già nel 2004 l'eolico è al culminedella sua espansione con più di 15.000 torri at-tive sul territorio, all'avanguardia nel mondo perproduzione ed installazione. Riferimento edesempio per gli " ambientalisti scientifici".Una inchiesta insospettabile di un organo distampa assai vicino alla maggioranza rosso-ver-de che governava nel 2004.Una inchiesta di 18 pagine, clamorosa per le af-fermazioni iconoclaste gia dalla copertina. Do-lorosa se riferita agli effetti sulla realtà socialeed ambientale dettagliatamente raccontati e de-nunciati.
"Dal sogno di una energia ecologica alla deva-stazione del paesaggio","Inghiottiti miliardi di sovvenzioni, ma l'utilita'per l'ambiente pare sia statamolto limitata",e nel cuore del racconto parole profetiche e pe-santi sulle quali sembra impossibile che i nostrigovernanti non abbiano voluto riflettere.Le dice il poeta e scrittore Botho Straub, collabo-ratore abituale di Der Spiegel:"Nessuna fase di industrializzazione ha deter-minato una deturpazione del paesaggio comequesto conficcamento e sprangamento del pa-norama creato dalle torri eoliche, che distrug-gono non solo gli spazi esistenziali, ma anche ipiù profondi spazi della memoria".
Dell'inchiesta di Der Spiegel sulla Stampa italia-na non un accenno, non una parola.
Italia Nostra lo ha tradotto integralmente per chivoglia farsi un idea dell'eolico sulla base delle
esperienze del paese che più ha investito in que-sta tecnologia.
Inchiesta di Der Spiegel... Fino alla fine dell’anno scorso sono sorti in tut-to il paese ben 15.387 mulini a vento; entro il 2010l’utilizzazione dell’energia eolica dovrebbe addi-rittura raddoppiarsi. A questo punto alla protestacontro l’energia nucleare si è sostituito un movi-mento contro l’energia eolica. Si sono formatecentinaia di iniziative popolari e si chiamano “An-ti-vento” o “Bufera anti-eolica” e si oppongono,dal Brandeburgo alla Selva Nera, al rumore ed aldeturpamento del paesaggio.“Si tratta dell’orrore più spaventoso dalla guerradei trent’anni”, dice Hans-Joachim Mengel. Perquesto motivo il Professore berlinese di ScienzePolitiche ha fondato nel Brandeburgo l’iniziativa“Salvate la Uckermark!”. Nelle ultime elezioni delConsiglio provinciale della Provincia della Ucker-mark, Mengel ha ottenuto la maggioranza relati-va dei voti grazie a questa iniziativa.Il fatto che proprio i difensori dell’ambiente e delpaesaggio si oppongano alla visione dei Verdi diuna politica energetica a tutela del clima non èprivo di una certa ironia. Ma tali contestazionirientrano nel conto generale e vengono liquida-te dai funzionari di vertice dei Verdi come “ro-mantiche”.In fin dei conti, così dicono i fautori dell’energiaeolica, la questione di fondo riguarda la riduzio-ni delle emissioni di CO2, una fonte di energiapulita inesauribile e la creazione di nuovi posti dilavoro. Ma è proprio vero? O non si tratta piutto-sto, qualora si proseguisse con un ulteriore in-cremento di energia eolica, di un investimentosocioeconomico sbagliato che inghiotte miliardi?Che cancella posti di lavoro più che crearli? Chedovrebbe essere immediatamente bloccato o perlo meno fortemente ridotto? Per i rosso-verdi l’i-
eolico
33
N
Il delirio dei mulini a ventoIl delirio dei mulini a vento

stituzione dell’energia eolica, 13 anni dopo cheil governo di Helmut Kohl ne iniziò la promo-zione, è più che altro un progetto di prestigio,uno dei pochi che abbia trovato consenso una-nime nelle loro stesse file. (…)(...)Finora il Governo osanna la riuscita riduzio-ne di CO2, ma per il resto teme un bilancio fina-le controverso del proprio progetto eolico. Restada chiarire:- Quali sono i costi per l’economia nazionale te-desca? - Quali sono le conseguenze per il mercato dellavoro e la competitività dell’industria?- Da dove trarranno energia i tedeschi in futuro,
se l’energia nucleare e le sovvenzioni per il car-bone sono troppo pericolose o troppo care e leriserve mondiali di gas e di petrolio si riduconosempre più? - Esiste, a lunga scadenza, un’alternativa al ven-to, oltre all’energia solare ed idroelettrica?- Ma soprattutto: il vento ed il sole sono effettiva-mente in grado di coprire il fabbisogno futuro dienergia o si tratta di una bella, costosa illusione?
I campioni del mondo di asparagi Oggi in Germania esistono più mulini a vento chein qualsiasi altro paese. E anche più contestazio-ni che in qualsiasi altro Paese. Da una parte ci so-
eolico
34

no i produttori, i gestori ed il Ministroper l’Ambiente Trittin. Loro ne voglio-no sempre di più, più alti, più potenti:festeggiano la loro vittoria come ungrande successo. “La Germania è cam-pione del mondo per l’energia eolica“,esulta il Ministro. Dall’altra parte si è for-mata una coalizione multicolore e con-traddittoria. E’ costituita sia da ecologi-sti sia dalle lobbies del nucleare e delcarbone dei grandi gruppi dell’industriaenergetica, ma soprattutto è costituitada tutti quegli abitanti delle zone inte-ressate che si sentono letteralmente ac-cerchiati dai “parchi di mulini a vento“,dalle “fattorie di mulini a vento“ dalle“zone eoliche in allestimento”.Sono persone come Sonja Dollery di El-lierode, nella zona vicina all’Harz. Daquando sono stati progettati i mulini avento sulle colline vicine, la pace delpaese è finita. Tra sostenitori ed oppo-sitori dell’energia eolica volano parolegrosse. Nove proprietari di terreni po-trebbero guadagnarci con i mulini a ven-to, ma “400 persone devono soffrire”.La donna è disperata. “Si ha quasi pau-ra di andare in strada“, dice la signora Dollery.Così, tanto per cominciare, su e giù attraverso tan-ti Comuni una volta sereni, c’è ora aspra litigio-sità. Da una parte ci sono i cittadini che non be-neficiano della pioggia di denaro delle sovven-zioni e coloro che si sono costruiti la casetta, lacui proprietà è diventata improvvisamente in-vendibile a causa dei giganteschi mulini a vento.Dall’altra parte ci sono i gestori dei mulini a ven-to, spesso notabili locali, come dirigenti di latte-rie in pensione, direttori di banca o politici co-munali, associati a quei contadini i cui terreni ser-vono per l’istallazione dei mulini a vento. Dietroc’è sempre uno dei grandi produttori di mulini avento, come ad esempio la Plambeck Neue Ener-gie AG di Cuxhaven. Per far sì che i Comuni ap-provino la progettazione, si offrono agli stessi per-centuali di partecipazione. Si usa anche far arri-vare ai Comuni recalcitranti denaro sottobancotramite fondazioni o donazioni. Così arriva l’ap-provazione. Anche gli imprenditori agricoli, che
non di rado hanno l’acqua alla gola, riescono condifficoltà a resistere alle offerte dei gestori. In fon-do per una istallazione con dieci torri riescono adaffittare – per via della distanza minima necessa-ria tra le torri – ben 45 ettari di terreno. A secon-da dell’abilità con cui viene condotta la trattativa,i proprietari dei terreni possono guadagnare da1.000 fino a 20.000 euro per anno e per mulino;il tutto per lo più per una durata contrattuale di20 anni. Il che è di più di quanto rendano alcuneaziende. In tal modo si è venuta a determinareuna associazione contadina di interessi: denarocontro paesaggio. Da un’idea idilliaca di verde ènata un’industria verde.(...)Resistere? Non serve a niente. “Lo Stato, nel-l’impegno di ridurre le emissioni di CO2, non puòlimitarsi a fare appello alla ragionevolezza di tut-ti gli interessati..” si legge nel verbale della sedu-ta della Commissione Edilizia federale, in data 19giugno 1996, “..deve fare di tutto, affinché ven-gano rimossi gli ostacoli allo sfruttamento delle
35

fonti energetiche rinnovabili..“. Anche questo in-tento è riuscito. Per i proprietari di mulini a ven-to è iniziata così un’epoca d’oro. Soltanto negliultimi quattro anni il numero degli impianti si èraddoppiato, giungendo ad oltre 15.000 unità.E pare che debba andare avanti così. Denaro cen’è a sufficienza, in quanto lo Stato promuovel’incremento dell’energia eolica su vari fronti con-temporaneamente: attraverso prezzi fissi ed un’ac-quisto garantito dell’elettricità prodotta. (...)
La lotta contro i mulini a ventoLe conseguenze di una così dissennata promo-zione si possono constatare ad esempio nellaUckermark. La Provincia al nord di Berlino è co-perta di mulini a vento come nessun’altra regio-ne della Repubblica. Già sono stati costruiti 223impianti, altri 280 sono già in fase di progetta-zione esecutiva. Taluni paesi sono letteralmenteaccerchiati da parchi di mulini a vento.“Nessuna fase di industrializzazione ha determi-nato una deturpazione del paesaggio così bruta-le, come questo conficcamento e sprangamentodi orizzonti creato dai mulini a vento” ha senten-ziato recentemente Botho Strauß, in un saggio suDER SPIEGEL. Il poeta possiede da oltre dieci an-ni una casa nella Uckermark. Secondo lui, l’e-nergia eolica distrugge “non soltanto spazi esi-stenziali, ma anche i più profondi spazi della me-moria”, come ha scritto.Come si sia giunti a tanto è una storia di grandiimmagini visionarie e di ancor più grandi delu-sioni. Ha a che fare con la speranza della regio-ne di ottenere sviluppo e posti di lavoro. Con ven-ditori di vento e politici comunali non all’altezzadella situazione, che ne hanno fatto una questio-ne di avidità e di corruzione. Ed ha anche a chefare con la crescente protesta di cittadini, chedapprima lottano e poi sono costretti ad ammet-tere la loro impotenza di fronte ad una industriadel vento giuridicamente privilegiata e sovven-zionata generosamente dallo Stato. Questa storiapotrebbe ripetersi in tutta la Germania.All’inizio i fronti erano chiaramente definiti. Dauna parte c’erano gli investitori, che avevano vi-sto nella strutturalmente povera Uckermark unazona ideale per i loro mulini a vento. E sono sta-ti accolti con entusiasmo: i contadini ottennero
vantaggiosi contratti d’affitto per il loro terrenodagli scarsi raccolti e i Comuni dalle magre fi-nanze trovarono finalmente una prospettiva dientrate fiscali. Dall’altra parte c’era Hans-JoachimMengel, professore di Scienze Politiche alla FreieUniversität Berlin. Quello che lo aveva affascina-to qui era il fatto che i paesani “non erano cam-biati quasi per nulla dall’epoca di Federico il Gran-de”. Per questo egli, fin dall’inizio, ha protestatocontro i moderni mulini a vento. Ma la cosa noninteressava nessuno. Quando il Professore, alto,con il suo ampio mantello di loden ed i capelliarruffati, andava predicando per il Paese di “in-teressi contraddittori nel processo decisionale de-mocratico”, lo prendevano in giro come il “DonChichotte della Uckermark“. L’energia eolica sem-brava loro una benedizione. Per questo motivole Province Uckermark e Barnin decisero, dopoquattro anni di consultazioni, nell’ottobre 2000,un “piano parziale di sfruttamento di energia eo-lica“. Ma è andata diversamente. Quando i pro-prietari di mulini a vento costruirono con grandevelocità i loro impianti nelle zone destinate, quan-do ne costruirono 15 a Neuenfeld, poi 39 aFalkenwalde, poi 57 a Schönemark, allora gli abi-tanti della Uckermark riconobbero cosa regalavaloro quel “piano parziale“: torri per i mulini a ven-to in tutte le direzioni, veri e propri grattacieli,che modificano l’orizzonte. Persino di notte, quan-do lampeggiano le luci rosse di segnalazione: èil cosiddetto effetto discoteca. Progressivamentel’umore andò deprimendosi. E fu allora che il DonChichotte della Uckermark, con la sua tanto de-risa lotta contro i mulini a vento, si trasformò inun vero e proprio eroe popolare. Alle elezioni co-munali dello scorso autunno Mengel ha ottenutopiù voti dei candidati di vertice della CDU, dellaSPD e della PDS. Il suo movimento popolare “Sal-vate la Uckermark“ è anche riuscito ad entrare nelConsiglio.I fronti si sono pertanto modificati. Contro gli in-vestitori vi sono ora ampie parti della popolazio-ne. Il clima è avvelenato. Tra le due parti agisco-no i Comuni, per lo più impotenti ed alle presecon una cosa più grande di loro.(...) Se proprionon possono evitare i mostri orrendi, molti Co-muni vorrebbero almeno trarne un qualche pro-fitto. A tale scopo i gestori delle installazioni di
eolico
36

mulini a vento hanno sviluppato dei modelli con-trattuali fantasiosi, che dovrebbero ripristinare labenevolenza dei Comuni e spesso fanno sorgereil sospetto della corruzione. Ad esempio, da uncosiddetto contratto di permesso, il Comune diUckerland dovrebbe trarre il suo profitto: secon-do la bozza di contratto, in questo caso l’investi-tore paga un “corrispettivo di permesso“, per la“co-utilizzazione delle strade comunali“, che inrealtà dovrebbe essere ovvia, ovvero il “permes-so di spostamento e gestione di cavi“. Vantaggioper il Comune: 180.000 euro subito e altri 44.000euro l’anno successivamente. In cambio l’inve-stitore ottiene la sua istallazione di mulini a ven-to e può addirittura procedere alla proposta dimodifica del Piano regolatore. “Una vendita di di-ritti di sovranità non può esistere“ dice l’avvoca-to di Gottinga Patrick Habor, che rappresenta nu-merosi abitanti vicini agli impianti e Comuni. Piùbrillanti ancora dei colleghi dell’Uckerland si so-no dimostrati i politici locali della vicina Luckow-Petershagen, quando si è trattato della costruzio-ne di una nuova centrale di mulini a vento con25 impianti. Essi fondarono una “AssociazionePaese-Mulini”; contemporaneamente la presi-denza venne per praticità assunta dal sindaco Do-nata Oppelt. Scopo dell’associazione è la “pro-mozione del senso di unità di patria”. Ed in effettine passano di interessi importanti: gli associatidovrebbero incassare dall’investitore una cifra chearriva a 750.000 euro per la costruzione di nuoviimpianti di energia eolica; questo è quanto è scrit-to nella bozza di un “contratto di assegnazione”.La cura dell’orto politico avviene in modo analo-go un po’ dappertutto, quando si tratta della co-struzione di nuove installazioni di mulini a ven-to. Investitori e Comuni hanno da tempo creatoin tutto il paese un multiforme arsenale di accor-di fantasiosi per il comune tornaconto. Genero-se erogazioni di denaro ai Vigili del fuoco vo-lontari sono un altro mezzo niente male, così co-me le somme in contanti direttamente ai cittadi-ni: da 50 fino a 100 euro di premio sono stati de-cisi ad esempio in un piccolo paese dell’Eifel pernascite, matrimoni o lauree; il denaro viene pre-levato da un fondo di promozione del proprieta-rio dei mulini a vento. Altrove gli investitori con-feriscono oltre 400.000 euro al Comune per la
“piantagione di alberi”. Accade anche che paghi-no prontamente “penalità contrattuali” a cinquecifre, per non aver rispettato, certo per puro ca-so, le scadenze contrattuali per un paio di gior-ni.Soltanto raramente accordi sospetti sono docu-mentati così bene come nel caso di un Comunedella Germania del Nord: i suoi rappresentantihanno stipulato nel 1996 un contratto di dona-zione con autentica notarile con la locale Wind-park GmbH, che, secondo il parere dell’avvoca-to amministrativista di Amburgo Rüdiger Nebel-sieck, configura la fattispecie di reato del lucropresunto. (...)
37

ubblichiamo di seguito la dichiarazione di Eu-ropa Nostra su l’eolico1. In riferimento ai propri statuti, Europa Nostras’impegna a proteggere e a valorizzare il paesag-
gio in tutti i suoi aspetti (mobile ed immobile, costruitoe naturale) e nel significato più vasto di paesaggio cul-turale.2. Il Consiglio riconosce pienamente e condivide le gran-di preoccupazioni internazionali riguardo i cambiamen-ti climatici, come notoriamente denunciati nel Protocol-lo di Kyoto, come pure il dovere di ogni paese di porrein essere ed implementare una politica energetica chetenga conto di queste preoccupazioni. Il Consiglio in-tende anche prendere in considerazione gli effetti e gliimpatti di ogni forma di produzione energetica rinnova-bile sul paesaggio.3. Il Consiglio incoraggia a seguire una politica dell’e-nergia globale, che riguardi sia i problemi legati alla ri-chiesta che quelli legati alla produzione. Nel trattare iproblemi legati alla produzione, tutte le forme di ener-gia debbono essere prese in considerazione, e le sceltedebbono riflettere la volontà di conseguire una riduzio-ne delle emissioni di gas ad effetto serra, in particolaredella CO2.4. In numerosi paesi le politiche dell’energia non ten-gono sufficientemente conto delle questioni legate al ri-sparmio energetico.5. Vanno inoltre massimizzati gli sforzi affinché tutte lefonti di energia rinnovabile siano promosse.Considerazioni specifiche sull’eolico6. Sebbene il Consiglio sia favorevole ad incoraggiarel’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, compreso l’eo-lico, considera che gli aerogeneratori eolici devono es-sere eretti solo nei luoghi appropriati.7. In numerosi paesi europei un’importanza smisurata èstata accordata all’eolico, sulla terraferma come in mareaperto. I governi hanno accordato generose sovvenzio-ni; hanno indebolito le misure e le regole a salvaguar-dia del paesaggio e omesso di effettuare un’analisi equi-librata dei suoi vantaggi in rapporto ai suoi inconvenienti.In varie e molteplici aree d’Europa porzioni di splendi-di territori sono oggi dominati da gruppi di torri eoliche,dalle dimensioni sempre più grandi, ciascuno dei qualirappresenta una piccola centrale elettrica. Di conse-
guenza il paesaggio appare industrializzato ed il nostropatrimonio naturale fortemente compromesso.8. In numerosi paesi europei, nell’ambito del processodecisionale relativo alla realizzazione di impianti eolici,l’impatto sociale, economico, turistico e storico di code-sti impianti non è stato sufficientemente considerato, nétanto meno l’impatto sulla fauna e sul paesaggio. 9. A questo riguardo, il Consiglio considera che i pro-cessi decisionali delle autorità pubbliche legati alla rea-lizzazione di torri eoliche, e di gruppi eolici, dovrebbeincludere la consultazione di tutte le parti coinvolte e do-vrebbe essere fondata sulla comprensione del caratteree del valore del paesaggio locale, e per ogni progetto,tenere conto delle seguenti questioni:a) l’impatto sulla comunità locale;b) un’analisi precisa ed obiettiva della riduzione delleemissioni di gas ad effetto serra da attribuire all’eolico;c) l’impatto visivo sulla qualità del paesaggio locale, te-nendo conto del fatto che le torre eoliche attuali attira-no sempre di più l’attenzione, considerate le loro di-mensioni (già oltrepassano i 100 metri e continuano acrescere) e l’ubicazione in siti esposti e visibili;d) i danni supplementari arrecati al paesaggio, agli ha-bitat vulnerabili,
ai corsi d’acqua e ad altri fattori ambientali, durante lafase di edificazione, comprese la costruzione delle vie diaccesso, l’allargamento delle reti elettriche, l’aumentonumerico dei piloni e dei generatori finalizzati alla tra-sformazione e al trasporto dell’elettricità;e) in che misura il ripristino dello stato originale del sitopuò essere o meno garantito al concludersi della vita pro-duttiva della torre eolica;f) la prossimità e l’impatto sui siti e sui paesaggi protet-ti a livello locale, regionale, nazionale ed internaziona-le;g) l’impatto sulle comunità locali degli infrasuoni, del-l’intercettazione della luce (ombra intermittente) e dellaperdita di valore degli immobili;h) la valutazione della possibilità di ricorrere ad altre fon-ti energetiche – generalmente il gas metano – quando sipreveda che gli impianti eolici abbiano scarsa produtti-vità (il che avviene spesso), con il conseguente effettosui costi di produzione e sulla pretesa riduzione dei gasad effetto serra.
eolico
38
P
Tutti i dubbidi Europa NostraTutti i dubbidi Europa Nostra

Arrivare al sito archeologico di Saepinum in pri-mavera, al tramonto, è stata una delle emozio-ni della vita. (…) Da qualche tempo però sono ben più gravi leminacce che si addensano su questo autenticogioiello dell'età romana, studiato e recuperatoda Adriano La Regina quando era soprinten-dente archeologico in Abruzzo e Molise. Invece di tenersi caro questo antico patrimo-nio, si pensa di circondarlo di cose che po-tranno soltanto guastare il bel paesaggio che locirconda. La montagna e l'alta collina della ver-de Valle del Tammaro, in cui è adagiata Saepi-num è, infatti, minacciata dalla installazione ditrenta torri per l'energia eolica, alte 120 metril'una, su un crinale ben visibile, per la lun-ghezza di quattro chilometri. (…) Contro que-sto modello di sviluppo vecchio e pesante sisono opposte Italia nostra, il Wwf e numerosicomuni. Un primo risultato è stato ottenuto: una mora-toria per le pale di Saepinum fino a quando ilConsiglio regionale non con i resti avrà appro-vato il piano energetico (250 torri eoliche inluogo delle 900 preventivate). Ma le forze politiche in Regione si equilibranonei prò e contro, e quindi la vigilanza deve con-tinuare. (…) Possibile che il paesaggio agrario, che si sposabenissimo col patrimonio dei centri storici e
dell'archeologia, debba essere soltanto consi-derato come territorio in attesa di speculazio-ne edilizia o comunque di sfruttamento inten-sivo e improprio?
Da Airone, n. 304, agosto 2006
Vittorio Emilianigiornalista, scrittore, ex Direttore de “Il Messaggero”
dichiarazioni
39
È il nemico dell’archeologiaÈ il nemico dell’archeologia
Ma via, le pale sono una schifezza, che in unapaese con poco vento ne metti dieci e c'è n'è unasola che gira... Allora, uno le può dire queste co-se oppure ha offeso qualche Santo Graal e i San-ti Graal non si possono offendere? Questo non si-gnifica essere contro le energie rinnovabili, masanto iddio, io sono favorevolissimo! Però, allo-ra, energie rinnovabili di cui si vinca la intermit-tenza e che vengano acquisite accumulandole il
più possibile... Altrimenti, io, francamente, l'ideadi riempirmi di pale eoliche in questo modo...non la trovo accattivante... ecco, mi scuso con ipalisti, ma non la trovo accattivante. Insomma,discutiamone laicamente, senza forzature ideo-logiche...
dall’intervento al convegno degli “Amici della Terra”, luglio 2005
Giuliano AmatoMinistro degli Interni
Quelle pale sono troppo brutteQuelle pale sono troppo brutte

Fa ancora bella mostra di sé, all’ingresso di tan-ti comuni d’Italia, un cartello con la scritta “co-mune denuclearizzato”. Si trattava, da parte della giunta comunale, di farsapere, con quel cartello, che essa era schieratacontro “gli armamenti”, le basi missilistiche, i de-positi di testate nucleari, di cui quei guerrafon-dai della Nato avrebbero voluto coprire il BelPaese: che la giunta era schierata insomma dal-la parte della “pace”, nella versione che di essae dei suoi presupposti dava allora la propagan-da filosovietica. E infatti la stragrande maggioranza dei comuni“denuclearizzati” erano comuni governati dagiunte di sinistra. le quali, tanto sensibili un tem-po ai pericoli del nucleare, non sembrano mini-mamente sensibili, invece, oggi, ai pericoli rap-presentati dagli impianti per la produzione dienergia eolica che hanno cominciato a infestareil loro territorio. Parliamo forse del massimo attentato in corso alnostro paesaggio e che ha, proprio per ciò, atti-
rato le ire sacrosante di un neo costituito Comi-tato nazionale del paesaggio, presieduto da Car-lo Ripa di Meana. (…) Le torri eoliche oggi esi-stenti in Italia sono più di mille e cinquecento,ma già è agli atti la richiesta di costruire nel pros-simo futuro la bellezza di 502 nuove centrali (cen-trali, non singole torri) dalla Sicilia alla Basilica-ta, dalla Puglia all’Umbria alla Sardegna… Insomma, una vera e propria immensa distesa ditralicci disseminati in quasi tutti i luoghi più pit-toreschi d’Italia. Ecco come in Italia un ecologismo di maniera,assurto a scialbo luogo comune buonista, divie-ne nella realtà l’alibi per consentire a chi di do-vere di guadagnare un bel po’ di quattrini squar-tando montagne, distruggendo pianori, alteran-do paesaggi prestigiosi...
tratto dall’editoriale del Corriere del 6 maggio 2004
Salvaguardiamo il paesaggio ma non commettia-mo nuovi errori. 'Lo dico con pacatezza ma conprofonda convinzione - aggiunge -; fonti energeti-che cosiddette alternative vanno certamente cer-cate, studiate, applicate per il bene della qualitàdella vita e dell'economia ma questo non implicaun ulteriore degrado del paesaggio. Mi è difficileaccettare ancora oggi - aggiunge Galan - la visionedegli enormi piloni o tralicci che, nel trasportareenergia elettrica, offendono i valori paesaggistici dimolte aree del Veneto figuriamoci cosa diverreb-bero i paesaggi veneti con la comparsa delle gi-gantesche torri con pale e rotori installate per pro-durre energia pulita, che può essere prodotta tran-quillamente con altri mezzi e soprattutto causandoaltri impatti paesaggistici e ambientali.
da una dichiarazione apparsa sull’agenzia Ansa
dichiarazioni
40
Galli Della Loggiastorico ed editorialista
Giancarlo GalanPresidente RegioneVeneto
Il più grande attentato contro il paesaggioIl più grande attentato contro il paesaggio
Usiamo altre energie rinnovabiliUsiamo altre energie rinnovabili

41
Per quanto le si voglia chiamare "fattorie del ven-to", gli impianti eolici sono impianti industriali atutti gli effetti, quelli delle ultime generazioni conaltezze complessive ben superiori ai 100 me-tri…L'energia eolica è intermittente ed impreve-dibile. Su oltre 8000 ore annue in Italia le ore uti-lizzabili dalle torri (con vento tra 4 e 22 metri alsecondo) sono non superiori alle 2000.; inoltrel'intermittenza obbliga a mantenere centrali tra-dizionali sostegno...Se l'obiettivo è quello di pro-durre con il vento il 3,5% dell’elettricità e quindi1'1,2% dell'energia totale consumata dal sistemaItalia (nel limite dei 5000 MW installabili da fonterinnovabile intermittente), al fine di ridurre le emis-sioni nocive dell' 1,5%, l'installazione di oltre 5000-
6000 torri eoliche produrrebbe un risparmio irri-sorio… Gli impatti sul paesaggio italiano, costituzional-mente tutelato, sarebbero abnormi: gli impiantieolici vanno infatti installati sui crinali di monta-gna o in aree costiere di notevole pregio, qualiquelle della Sardegna, della Sicilia, della Campa-nia, della Calabria o della Puglia, distruggendo inmodo indelebile i caratteri culturali, agricoli, turi-stici e paesaggistici del nostro Paese, con una de-qualificazione di intere province e con costi eco-nomici ed ambientali incalcolabili…
dall’ordine del giorno presentato da Giorgio La Malfa al Senato
Giorgio La MalfaParlamentare di centrodestra
Molti danni e poca energiaMolti danni e poca energia
Meglio sarebbe incentivare le aziende agricole a do-tarsi di tecnologie che ne possano coprire le ne-cessità energetiche in modo pulito e sostenibile, conuna distribuzione capillare utile alla campagna e ingrado di contribuire ai fabbisogni della collettività.Una selva di torri bianche alte oltre cento metri -moderni mulini a vento - appoggiate in mezzo ai fi-lari di sangiovese sulle morbide coline dove nasceil Morellino di Scansano sono compatibili con il pae-saggio di un territorio dalla spiccata vocazione agri-cola? In Toscana, il progetto di una centrale eolicache dovrebbe vedere la luce tra breve ha innesca-to in questi mesi una dura polemica tra associazio-ni ambientaliste (schierate stavolta su fronti oppo-sti), cittadini, vignaioli ed enti locali. Le grosse pa-le che ruotano in cielo non inquinano, anzi produ-
cono energia pulita, ma per i vignaioli la compati-bilità con il paesaggio è un problema concreto. Giu-sto o sbagliato che sia, ogni bottiglia ha un potereevocativo, richiama luoghi, volti di uomini, saperiantichi, gesti rituali e non possiamo negare che l'im-magine del terroir di provenienza ha un peso nontrascurabile nel determinare il valore di un vino.Non è una questione facile da dirimere, stretti tra lanecessità di aumentare l'energia rinnovabile e il do-vere di preservare da nuovi scempi il martoriatopaesaggio italiano con i tesori che custodisce. (...)Mi pare comunque condivisibile l'idea di non insi-stere su impianti ciclopici che sono invasivi e nonrisolvono il problema.
tratto da “Specchio”, La Stampa
Carlo Petrinigiornalista, fondatore del movimento Slow Food
Giù le mani dai filari del MorellinoGiù le mani dai filari del Morellino

dichiarazioni
42
Una inedita emergenza ambientale incombe sulpatrimonio naturale della Sardegna e per quan-to possa apparire paradossale stavolta il perico-lo arriva travestito da energia pulita. Nel breve spazio di due anni sono state presen-tate al competente Servizio istanze autorizzati-ve per 88 Parchi eolici per un totale di 2.814 ae-rogeneratori. Questi giganteschi impianti industriali, con tor-ri d’acciaio più alte della cupola del Vaticano eciascuna del peso di centinaia di tonnellate, sa-ranno spalmati in tutto il territorio regionale e
in particolare sui crinali delle montagne e nei si-ti di maggiore visibilità. Questo spaventoso disegno è spinto con mezzimolto efficaci dalle lobbies e dalle imprese checontrollano in Italia e in Europa il libero mer-cato dell’energia elettrica e si contendono l’ac-caparramento dei cosiddetti certificati verdi perottemperare alle direttive comunitarie e al pro-tocollo di Kyoto. Se questi interventi dovessero andare in portola Sardegna avrebbe la più alta concentrazioneal mondo di torri eoliche.
Emanuele SannaParlamentare deiDemocratici di Sinistra
La Sardegna la regione più colpitaLa Sardegna la regione più colpita
Numerosi sono gli articoli e le opinioni apparsi inquesti giorni sulla stampa a proposito delle ipoteti-che opportunità mancate in merito alla produzionedi energia da fonte eolica. Si aprono fronti oppostie le argomentazioni sono spesso originate da pe-santi equivoci. Energia e potenza sono due concettidiversi e non vanno confusi. Si fa quindi un serioerrore quando si scambia la potenza nominale deinuovi impianti eolici con l’energia annuale prodot-ta, dimenticando che la frazione del tempo in cuil’eolico è operativo è solamente dell’ordine del 20%.Pertanto, il progetto per la realizzazione di 3.000MWatt di cui si è parlato recentemente sul "Corrie-re", da attuarsi in cinque anni (circa 1.500 turbinedi 100 metri di altezza), produrrebbe l’1,7% e nonil 7% dell’elettricità nazionale. Esso farebbe rispar-miare solamente 2 e non 8 milioni di tonnellate an-nue di CO2. Alla quotazione per tonnellata di 20 eu-ro/t, il costo risparmiato con 3.000 MWatt eolici sa-
rebbe di circa 30 milioni/annui, da confrontarsi conle quote, pari a circa 2 miliardi/anno, che l’Italia do-vrebbe acquistare all’estero qualora dovesse riscat-tare un eccesso di 100 milioni di tonnellate annuedi CO2. Va notato infatti che il contributo di CO2dall’elettrico è circa del 25% e che quindi i maggio-ri contributi provengono da altre fonti, in primis daitrasporti. Concludendo, il contestato progetto eoli-co da 3.000 MWatt coprirebbe solamente 0,43% del-le emissioni italiane di CO2. Una piccola goccia nelvasto mare! Più che mai si avverte in questo mo-mento la necessità di un piano coerente e rigoroso,per l’installazione di sistemi carbon-free [impiantiper la produzione di energia senza emissione di ani-dride carbonica, n.d.r.], che chiarisca come fare fron-te all’insieme delle conseguenze degli accordi diKyoto, che abbiamo consapevolmente sottoscritto.
dal Corriere della Sera dell’ 8 settembre 2005
Carlo RubbiaFisico nucleare, premioNobel per la fisica
Sul risparmio energetico errori e bugieSul risparmio energetico errori e bugie

a terra non si vende e per quanto possa sem-brare banale, per quanto possa sembrare naif,per quanto possa sembrare strano, oltre certi
limiti la terra non si vende. E' diverso se a gestirela nostra terra, promuoverla, accompagnarla versoil futuro siamo noi, con la nostra testa, con la no-stra cultura, con la volontà di continuare a viverci,a crescere i nostri figli, piuttosto che qualcuno chearriva qui, magari con l'orizzonte temporale di un
fondo di investimento che ha per statuto l'obbligodi liquidare i sui fondi entro cinque anni. Noi vo-gliamo questa terra bellissima, fantastica, vogliamoarricchire la nostra giornata di questo ambiente esentiamo come arricchimento della nostra giorna-ta non averla sciupata, non averla sfruttata e nonaverla distrutta. (…) L'ambiente non può più esse-re visto come uno dei tanti ostacoli che ogni tantoci capitano nel mondo degli affari, ma deve esserevisto come la risorsa importantissima di tutta la Sar-degna e che va vista nel suo insieme, nella sua in-terezza.(…) Occorre fare un salto di qualità (…)partendo dal presupposto che l'ambiente è la ga-ranzia del nostro futuro, di una crescita sana ed or-dinata, di uno sviluppo libero in Sardegna.(…)Io francamente oggi sono quasi più preoccupatodella pale eoliche che delle nuove costruzioni lun-go le coste. Visto che abbiamo iniziato a parlare diinganni ed imbrogli, di fole, andiamo avanti conquesto termine. Questo è l'inganno totale per laSardegna, quello dell'eolico, questo è l'inganno de-finitivo per quei creduloni dei sardi che fanno fin-ta di credere che l'eolico porti lavoro o porti ric-chezza per la Sardegna. E contro un niente di la-voro ed una miseria di piccoli soldi per i piccoli co-muni che hanno difficoltà ad andare avanti, a pa-gare l'illuminazione pubblica, questi, di certo, nonriescono a resistere a chi gli offre 300 milioni di li-re all'anno, oltre all'inganno dei posti di lavoro. Unsindaco è arrivato anche a dire che in questa ma-niera di svilupperà anche il turismo nel suo terri-torio perché la gente andrà a vedere le pale eoli-che. Ebbene, verrà distrutto definitivamente il pae-saggio delle zone interne della Sardegna. Per unpiatto di lenticchie stiamo regalando, distruggen-do per sempre, il paesaggio della Sardegna. Tuttoquesto con un meccanismo semplicissimo, ma in-fernale, Arrivano di soppiatto, zitti zitti. Prima van-no dai proprietari delle cime delle colline, che ora-mai incassano poco dall'agricoltura, hanno i loro
Renato SoruPresidente della Giuntaregionale sarda
il caso
43
L
La Sardegna rovinataper un piatto di lenticchieLa Sardegna rovinataper un piatto di lenticchie

problemi. Arriva qualcuno che gli dice ti do 30 mi-lioni per il tuo cucuzzolo. A loro sembra un rega-lo. Vanno da uno, da due, da tre, da quattro: alla fi-ne ci sono 50 famiglie che sono interessate e cia-scuna prende i suoi 30 milioni. Ebbene, diventanouna forma di pressione davanti a qualsiasi poverosindaco. Immaginate un sindaco di un piccolo co-mune che possa dire a 50 famiglie: no, sapete chec'è? Non vogliamo rovinare il paesaggio e per cuii 30 milioni non vi arriveranno! In questa manierainsidiosa, prima occupano la testa della gente edin questa maniera fanno poi cadere la volontà diqualsiasi sindaco a fronte di una legislazione re-gionale inesistente. Se comprendiamo bene il va-lore dell'ambiente, probabilmente in Sardegna bi-sognerebbe fare una legge, semplice semplice, chedice: le pale eoliche, i mostri di 140 metri sulle ci-me delle nostre colline non sono compatibili conil paesaggio della Sardegna! (…)
Il paesaggio è importante, servono regole più se-vere sulle coste, occorre pianificare e programma-re il nostro ambiente non in termini di anni, ma in
termini di decenni, in termini di generazioni. (…)Se oggi, per assurdo, le nostre coste fossero disa-bitate, in realtà non saremo più poveri, saremo piùricchi. Questa nostra Isola sarebbe non meno fa-mosa, ma più famosa. Una specie di paradiso ter-restre in mezzo all'Europa, a meno di un'ora di vo-lo dalle città più ricche, in una zona sicura lontanada terrorismo e difficoltà politiche. E avrebbe lapossibilità di costruire il suo sviluppo ex novo, inmaniera grandiosa. Questo per dire “stiamo atten-ti” non tutto quello che è costruito, non tutto quel-lo che è “valorizzato” è un valore in più, anzi, è unvalore in meno. E stiamo attenti due volte, perchéil mondo sta andando verso una modifica dei va-lori di scambio e l'ambiente ha sempre più valorerispetto alle altre cose. Quindi, svendere l'ambien-te oggi è doppiamente da stolti. Il valore dell'am-biente continua a crescere nel mondo contempo-raneo rispetto alle altre cose, svenderlo oggi è undelitto contro l'ambiente, ma anche una sciocchezzaeconomica.Dichiarazione a margine di un incontro con leassociazioni ambientaliste sarde
il caso
44

l dibattito sull’energia eolica continua a tur-bare i sonni dei nostri amministratori anche inqueste agitate vacanze estive, mentre le pole-
miche si intrecciano sulla stampa quotidiana.Un caso molto significativo è emerso di recentenei due comuni di San Venanzo e di Orvieto, e neè stata data notizia sulla stampa locale.Una grossa impresa ha proposto d’installare sulmonte Piatto, proprio al confine fra i due Comu-ni interessati, quattro o cinque torri alte comples-sivamente cento metri, cui vanno aggiunti, perquanto riguarda l’impatto ambientale, gli ingom-bri di uno o più elettrodotti, nonchè quelli neces-sari per le modifiche stradali operate sui declivi,nel vivo della montagna. Le proposte avanzate agliuffici competenti dai gestori dell’iniziativa pre-sentano, a quanto si dice, aspetti convenienti dalpunto di vista economico, anche se i vantaggi fi-nanziari sembrano riguardare più le casse comu-nali che non il benessere e l’utile dei cittadini.
A rivelare la dimensione dell’intero “affaire” è sta-to un consigliere della Comunità Montana e delConsiglio Comunale di Orvieto, Giancarlo Imba-stoni, che ha espresso i propri dubbi sulla oppor-tunità dell’iniziativa...Le aziende produttrici, ovvero i gestori, offrono aicomuni una cifra annuale dai 15 ai 20mila europer Mw, che corrisponde più o meno ad una sin-gola torre, quindi dai 50 ai 60mila al Comune diOrvieto e da 15 a 20 mila a quello di San Venan-zo. Imbastoni osserva che un impianto di tali di-mensioni “sarebbe visibile a 300 gradi dal cir-condario, cioè dal Palazzo Comunale di Orvietocome dal Subasio, dall’Alfina come dal Cimino..nitidissimo per decine e decine di chilometri”. Econclude, secondo me molto giustamente, che “aprescindere dai siti deturpabili o meno, l’affaredell’eolico, al pari delle discariche, non può es-sere lasciato in mano alle amministrazioni locali,innanzitutto per evitare che ognuno dei 92 comuni
Pietro ScarpelliniStorico dell’arte, ItaliaNostra – Sezione Perugia
il caso
45
I
Perugia,di nuovo minacciataPerugia,di nuovo minacciata

dell’Umbria piazzi la sua torre e addio cuore ver-de d’Italia”.Intanto sono sorti, nei comuni interessati, comi-tati civici di difesa del paesaggio e dell’ambiente,segno che le popolazioni non restano passive difronte allo sconvolgimento dei loro panorami. Po-chi giorni addietro l’Associazione Cosmo, col suopresidente Vincenzo Fagioli, riunitasi a San Ve-nanzo e a Prodo, si è pronunciata drasticamentecontro una manomissione che porterà solo di-struzione in uno scenario finora incontaminato.E qualcosa di analogo si sta verificando anche al-trove, per esempio, è sorta ad Umbertide l’asso-ciazione “Amici di Monte Acuto e di Monte Coro-na”, presieduta dall’ingegner Renzo Renzini, con-traria all’istallazione di pale eoliche...Senonchè la pressione per dar corso all’eolico,sempre e a tutti i costi, è semplicemente spaven-tosa. Alcuni comuni l’hanno già adottato formal-mente, come quello di San Giustino, dove il Con-siglio ha all’unanimità approvato la convenzionecon la società privata Ater, per impiantare, in lo-calità Montaccio, presso Bocca Trabaria, per 12macchine per produrre 20 Mw in grado di dareenergia al 30-40 per cento dell’intera Alta Valle DelTevere...
...Come contentino finale la società si impegna sind’ora a scegliere, per il personale di gestione, prio-ritariamente gli operatori locali, promette altresìdi coinvolgere, nell’esecuzione del lavoro, in-nanzitutto le imprese del luogo.Tali allettanti condizioni sono evidentemente riu-scite a far breccia presso varie altre amministra-zioni comunali, e, a quanto pare, anche presso ilComune di Perugia.A questo proposito debbo ancora una volta ri-cordare che, nel gennaio 2004, il vice sindaco Sil-vano Rometti, intervenendo circa le possibilità diinstallare una catena di autogeneratori sul crina-le del Monte Tezio (tra l’altro parco naturale) ave-va correttamente concluso che, nel caso specifi-co, bisognava privilegiare “le primarie e priorita-rie esigenze di tutela dei valori paesistici ed am-bientali”. Ma ora il suo successore, ed attuale vi-cesindaco, Nilo Arcudi, non sembra affatto affat-to pensarla come lui.Difatti presentando una nuova società da costi-tuirsi entro la fine dell’anno e che si occuperà diproduzione energetica tramite fonti rinnovabili,dichiara di voler di nuovo discutere “di pale peril vento da installare eventualmente su Monte Te-zio, dato che questo sembra l’unico sito adatto del
il caso
46

territorio”...... La morale del discorso è chiara. Quando ci so-no di mezzo tanti soldi e tanti interessi, i buonipropositi vanno a farsi benedire, e la tanto strom-bazzata difesa del paesaggio e dell’ambiente, di-
venta uno slogan vuoto, ovverosia lettera morta.Quello che è più desolante, in un quadro nel qua-le gli affari dominano ed il commercio e la spe-culazione determinano le scelte, in barba a tutti iprincipi consacrati, è il sostanziale connubio fradestra e sinistra. Pecunia non olet. In questa si-tuazione dispiace che autorevoli associazioni qua-li Legambiente e Wwf si siano dichiarate per scel-te che non possono essere generalizzate. Altret-tanto si dica a proposito di alcuni importanti gior-nalisti come Antonio Cianciullo e Giovanni Va-lentini, che insistono a battere la strada dell’eoli-co come toccasans necessario sempre e ovunque.Rimane così solo Italia Nostra a difendere nei ca-si concreti, la realtà umana e storica di queste no-stre montagne.Se l’eolico può andar bene in zone piatte e defi-late, in qualche area delle Puglie o della Campa-nia, o, meglio ancora, come è stato proposto, inmezzo al mare, non va bene per gli Appennini.Per perseguire un bene, ad ogni buon conto, li-mitato, rischiamo di alterare drasticamente una ri-sorsa di valore incalcolabile e di incalcolabile ri-chiamo turistico.
L’integrale di questo articolo è apparso su “Il Giornale dell’Umbria”
47
Egregio Sindaco,ATG, che come operatore turistico ha visto areerovinate da imprenditori in tutto il mondo, vi in-vita a considerare attentamente le implicazioni chel’erezione di schiere di generatori di energia eoli-ca, all’interno o in zone adiacenti a Parchi Nazio-nali o Regionali nelle vostre aree, potrebbe com-portare.L’Umbria è rinomata per la sua bellezza ed è perquesto che persone da tutto il mondo vengono avisitarla. Il turismo crea posti di lavoro in questazona e fin tanto che essa resterà intatta ciò conti-nuerà a sussistere e l’Umbria resterà prosperosa. Molte comunità montane non sono fortunate co-me la vostra. Voi avete Parchi nazionali e regio-nali eccezionali per bellezza naturale, che creano
e creeranno ricchezza per l’eternità. Volete vera-mente buttare tutto questo? Il turismo è come l’ac-qua: si da sempre per scontato che ci sia. Sola-mente quando non c’è la gente soffre. Forse i generatori di energia eolica porteranno unpo’ di ricchezza ad alcune persone oggi, ma il lo-ro costo futuro sarà di centinaia di posti di lavo-ro, miliardi di euro, famiglie verranno divise dal-la ricerca del lavoro altrove. Avete considerato sevale la pena di pagare questo prezzo?
Distinti salutiChristopher Whimney, Managing Director
Lettera da Operatore turistico inglese al sindacodi Norcia Alberto Naticchioni a maggio del 2002
Le torri cacceranno i turisti da Norcia

n Puglia la vertenza eolica si apriva a fine anni‘90 tra i Monti Dauni (Foggia) e il Beneventano,con l’insediamento improvvisato delle prime de-
cine di torri eoliche, lasciando presagire il poten-ziale disastro che un percorso così deregolamen-tato avrebbe potuto generare su vasta scala. Nel ‘99la LIPU intraprendeva i primi atti formali nei con-fronti degli enti locali, chiedendo informazioni, ve-rifica degli impatti e un confronto per affrontare ilfenomeno. Richieste inascoltate. In pochi anni laproliferazione di centrali eoliche industriali avreb-be assunto i connotati di un dilagare “selvaggio”determinando un vero e proprio sacco ambienta-le. Oggi vaste aree dei Monti Dauni hanno perso ilvolto tipico di aree rurali e agro-pastorali per as-sumere quello industriale, con oltre 500 torri eoli-che, nuove strade, elettrodotti, cantieri, trasportipesanti, cabine e stazioni elettriche, giganteschiplinti di cemento ancorati fino a 20 m di profon-dità. Ma il consuntivo potrebbe diventare anche piùpesante.Senza alcuna procedura di valutazione, fino al 2002sui Monti Dauni furono insediate le “prime” 377torri eoliche. In seguito gli incentivi alla produzio-ne rinnovabile, soprattutto quella eolica (certifica-ti verdi) insieme ad una totale deregulation nor-mativa, hanno determinato un “assalto alla dili-
genza” sul territorio. La costruzione degli impiantiè stata incentivata ed alimentata perfino con con-tributi pubblici a fondo perduto (legge 488, gra-duatoria 2003) riconoscendo ben 53 milioni di eu-ro di finanziamenti pubblici a vari progetti, ancorprima che fossero autorizzati. Con interessi eco-nomici esasperati le società eoliche avviavano in-numerevoli accordi per realizzare gli impianti afronte di modeste royalties per i Comuni e i priva-ti disponibili ad ospitare i piloni eolici. Seguivanole “Linee guida per la realizzazione di impianti eo-lici nella regione Puglia” varate a marzo 2004, al-l’indomani di iniziative pubbliche promosse da LI-PU, Italia Nostra e Comitato Nazionale del Paesag-gio, che in realtà chiedevano una moratoria sui pro-getti. Moratoria subito approvata dal nuovo Go-verno regionale di Niki Vendola, sebbene validaper i soli progetti presentati per l’autorizzazionedopo il maggio 2005, e fino alla redazione del Pia-no Energetico Regionale Ambientale (i cui studierano rimasti colpevolmente per anni nei cassetti).Le linee guida hanno rappresentato uno strumento
di valutazione tanto importante quanto disatteso.Sebbene il provvedimento non imponesse, incre-dibilmente, l’esclusione dalle aree più critiche, an-che le prescrizioni in esso contenute sono state di-sattese persino dove avevano carattere imperativo...
Enzo Cripezzi
eolico
48
I
MinacciateMurgia e SalernoMinacciateMurgia e Salerno

In materia di valutazione ambientale occorre sot-tolineare che in Puglia non è mai stato introdottoun obbligo, per gli impianti eolici industriali, a sot-toporsi a procedura di VIA. Si è preferito ricorrereal ben più banale screening ambientale, rispetto alquale il progetto può essere approvato con le sem-plici valutazioni di istruttori e dirigenti. Ben 377 torri, per 220 MW di picco, sono stati rea-lizzati senza alcuna procedura già al 2002, mentrealtri 41 impianti, con 572 torri per 685 MW, sonostati licenziati direttamente con parere positivo al-lo screening, senza quindi essere sottoposti a VIA.Complessivamente si hanno 1049 torri per 1093 MWdi potenza di picco (!!!) che ad oggi risultano conparere ambientale positivo o già realizzate. Per al-cuni di questi progetti l’ultima speranza di diniegoè riposta nelle attestazioni di compatibilità pae-saggistica ai sensi del PUTT.Questo solo per quanto concerne il “collo di botti-glia” dell’autorizzazione regionale. Sul piano co-munale i progetti e le convenzioni stilate abbrac-ciano la stragrande maggioranza dei Comuni pu-gliesi!! E’ quindi opportuno analizzare un altro ele-mento: la pressoché totale assenza di evidenza pub-blica. La procedura di VIA garantisce la pubblica-zione sul BUR Puglia e su un quotidiano del pro-getto, con la possibilità, da parte di chiunque, dipresentare delle “osservazioni”. La procedura discreening, invece, limita questa propaganda al so-lo albo pretorio comunale. In tal modo si è garan-tita una trattativa “riservata” tra sindaci e società sen-za che fosse promossa l’informazione al pubblicosu un territorio coerente con le “dimensioni” deiprogetti. Amministrazioni capaci di proclami per larealizzazione di un marciapiedi, hanno approvatosenza coinvolgimento popolare mega progetti eo-lici, tamponando con tardive assemblee pubblichesolo alla luce di manifestazioni di dissenso popola-re. Con grave improvvisazione l’amministrazione diTroia ha approvato ben 280 torri eoliche sul pro-prio territorio. Senza alcuna concertazione quelladi Alberona ne autorizzava circa 60, oltre alle 60 giàesistenti. E cosi Faeto, Rocchetta, Roseto, Accadia,S.Agata... Emblematico anche il caso di Minervino,dove sulla Murgia plurivincolata sono previste cir-ca 300 torri: è in atto un braccio di ferro tra alcuneassociazioni ambientaliste e la “dote” di pareri am-bientali incredibilmente - o meglio illegittimamen-
te - positivi con cui i progetti sono approdati alleconferenze di autorizzazione unica.Impropriamente l’impatto dell’eolico viene spessocircoscritto alla mera occupazione fisica delle ope-re. In realtà esso comporta un assoggettamento ter-
49

ritoriale – in particolare per l’impatto paesaggisti-co – su area vasta, e a tal proposito non si può nonsottolineare l’assurda banalità con cui i progetti so-no stati redatti e colpevolmente valutati. Sul pianonaturalistico, riferendosi a parametri emersi da stu-di sull’argomento, si calcola che le circa 500 torrieoliche installate negli ultimi anni sui monti Dau-ni abbiano indotto un impatto su un’area com-plessiva tra 10.000 e 40.000 ha. Di fatto si è cosi re-gistrata la graduale scomparsa di quasi tutte le cop-pie nidificanti di Nibbio reale nel comprensorio inoggetto. Sul piano paesaggistico, la modifica terri-toriale ad opera di tali manufatti, assolutamentefuori scala (tra i 70 e i 110 metri di altezza) e collo-cati in posizioni ovviamente dominanti, ha costi-tuito un profondo detrattore per la percezione del-la ruralità e della tipicità dei luoghi, condizionan-do aspettative turistiche nelle sue molteplici forme.Sul piano sociale l’assenza di perequazione ha in-dotto il decadimento del valore immobiliare per leproprietà contigue agli impianti a vantaggio di po-chi privati. Sul piano urbanistico si è registrata l’am-putazione tutt’ora in corso delle aree di maggiorpregio, dei SIC e dei futuri Parchi regionali dei Mon-ti Dauni, il cui iter politico istituzionale è stato gra-vemente compromesso dalle amministrazioni lo-cali, preoccupate di favorire i progetti eolici concui introitare comodi guadagni. Anche l’introdu-zione di altre forme di pianificazione (PIT, PTCP,istituti faunistico-venatori, assetti urbanistici, retedei tratturi, ecc) rischia di essere vanificata per l’in-
congruenza con le nuove, non previste, alterazio-ni territoriali..Da quanto accennato emerge chiara l’esigenza diuna forte cautela rispetto all’opzione eolica nel suocomplesso. Non senza trascurare l’opportunità diun “risanamento” di situazioni stridenti nell’ambitodella futura pianificazione territoriale ed energeti-ca. Corpose “osservazioni” sono state espresse daun cartello di associazioni nell’ambito del processoconcertativo per la stesura del PEAR , ormai in di-rittura d’arrivo. In esso sono riposte aspettative peruna Puglia più rispettosa del proprio territorio.ULTIM'ORA:A fine giugno la Regione Puglia ha varato il nuovoRegolamento per la realizzazione di impianti eoli-ci: un provvedimento in chiaroscuro con aspettideludenti. Esclude ZPS, SIC, Aree protette, aree Ae B del PUTT regionale, siti archelogici, zone Ram-sar dalla possibilità di impiantarvi torri eoliche. In-troduce il Piano Regolatore per Insediamenti Eoli-ci di cui devono dotarsi preventivamente i Comu-ni che intendano ospitare centrali eoliche. Intro-duce parametri di controllo della concentrazionedi torri rispetto al territorio comunale. Il tutto è peròdepotenziato a causa di fasce di rispetto inconsi-stenti (massimo 200 metri) dagli ambiti tutelati, dal-l'assenza di importanti aree non contemplate (IBA,altre zone umide o naturali, aree C e D del PUTT,linee di costa...), da un indice del parametro di con-trollo troppo elevato, ecc. Inoltre manca ancoral'obbligo della VIA.
eolico
50

ome in Germania, anche in Italia, abbiamoconcesso per il fotovoltaico il conto energia(nessun contributo in conto capitale, ma il pa-
gamento di 0,45 euro a Kwh, in grado di ammor-tizzare l’impianto in 8-10 anni, fornendo una ren-dita per il capitale investito dell’8%). In seguito a ciò sono giunte in totale, a marzo 2006,richieste strabilianti per 1300 MW di fotovoltaico,
ma il Ministero delle At-tività produttive ha con-cesso la copertura fi-nanziaria solo per 85MW.Intanto la Californiaprodurrà, con nuovi sta-bilimenti, per impegnopolitico del Governato-re Schwarzenegger,1000 MW di fotovoltai-co all’anno (in largaparte da esportare). Siarriverà così a installa-re, nella sola California,entro 10 anni, un milio-ne di tetti fotovoltaici,per una potenza pari a3000 MW.In un recente numerodella rivista Le Scienze,dedicato ad una inchie-sta sul solare (n.453 –maggio 2006), nelleconclusioni si scrive:“dopo il conto energial’Italia si è data l’obietti-vo poco ambizioso di1000 MW per l’anno2015. Mentre per quel-l’epoca in Germania sa-ranno installati qualco-
sa come 15.000-20.000 MW di pannelli”Perché accade questo? E’ evidente: la lobby eolicacontinua a tenere sotto il proprio giogo il fotovol-taico, per annettersi integralmente la quota tecni-camente ammissibile di energia rinnovabile che èpossibile immettere nella rete di distribuzione elet-trica nazionale. Si vuole che al fotovoltaico sia ri-servata una posizione di nicchia, ove non dia fa-stidio.Una vergogna: poiché si consente alla tecnologiaeolica, estranea alle vocazioni del Paese e terribil-mente impattante su paesaggio e ambiente, didiffondersi nei territori più delicati, irrinunciabilericchezza del paese. La partita viene giocata su pa-rametri esclusivamente economicistici. Tradendo,peraltro, le stesse leggi delle scienze economichepiù avanzate, che impongono di valutare i costiesterni, quelli pagati dall’intera collettività. Si in-travede il disegno nascosto di mantenere l’interaproduzione dell’energia rinnovabile, nelle mani del-la grande industria, piuttosto che dei cittadini, del-le famiglie e dei piccoli imprenditori.Questo in prospettiva del giorno in cui, con la pos-sibilità di accumulare l’energia rinnovabile inter-mittente attraverso l’idrogeno o con nuove batte-rie o comunque con nuove tecnologie, si possa do-minare il campo con l’eolico senza la concorrenzadel fotovoltaico. Già oggi si osserva una strategiain atto in questo senso. Come mai, infatti, si tenta-no, fin da subito, operazioni sconsiderate e provo-catorie di insediamenti industriali eolici ai danni diParchi nazionali (Aspromonte, Pollino, Cilento, Mur-gie, Abruzzo, etc.), di aree monumentali illustri ofamose (Fossanova, Saepinum, Castel del Monte,castello di Montepo a Scansano, etc.) e di città d’ar-te, come Perugia, Agnone, la stessa Gubbio etc.? Si procede in questa direzione con l’intento di sfon-dare ogni resistenza, per ottenere con l’assuefa-zione ai wind monster il campo libero ad una espan-sione senza limiti su tutto il territorio italiano.
Oreste Rutigliano
fotovoltaico
51
C
Chi boicottail soleChi boicottail sole

he cosa accomuna Giappone, Germania, Sta-ti Uniti d’America, Australia? Semplice, gli in-vestimenti nel settore della produzione di
energia solare. All’appello manca ancora l’Italia, co-me mai? Negli USA il fotovoltaico è il settore che haregistrato la maggiore espansione negli ultimi anni.Lo Stato di punta si conferma la California, fra glistati più attivi nelle politiche a favore dell’ambien-te. Qui il Governatore Arnold Schwarzenegger hafirmato un programma per la promozione, con fi-nanziamenti pubblici, di 3000 MegaWatt fotovoltai-ci in 10 anni, e gli esperti stimano quindi che per il2006 ci sarà un netto miglioramento delle cifre ri-spetto ai risultati del 2005. Ma veniamo alla situa-zione complessiva mondiale. Nel 2005 sono statiistallati 1.727 MegaWatt fotovoltaici, contro i 1.200MW del 2004. L'Europa guida la classifica delle areecon la maggior crescita nel settore, con un trend su-periore perfino a quello del Giappone, leader mon-diale del fotovoltaico. L'area nipponica mantienecomunque il primato mondiale, con 833MW di cel-le fotovoltaiche e una crescita del 33% rispetto al2004. La produzione dei Paesi europei ammonta a452 MW, con un +44%, mentre gli Stati Uniti hannoregistrato una crescita del 10%. Tra i produttori, ilnumero uno mondiale è ancora una volta la giap-ponese Sharp, leader nella produzione di celle fo-tovoltaiche. Nel 2005 Sharp ha registrato un balzodel 32% e si è nuovamente assicurata, per il sestoanno consecutivo, la vetta del podio. Avanza anchel’industria fotovoltaica cinese. In questo contesto larealtà italiana, incredibilmente, resta marginale. Inrealtà, anche in Italia si sono affermate importan-tissime novità, come vedremo.In tutto il mondo alla fine del 2005 si è raggiuntauna potenza installata complessiva pari ad oltre4.500 MegaWatt. Sia il Giappone che la Germaniahanno raggiunto e superato i 1.500 MegaWatt cia-scuno, installando, ciascuno dei due paesi, nel so-lo anno 2005, impianti fotovoltaici per circa 500
MW. Alla fine del 2004 in Italia si è raggiunta unapotenza Fotovoltaica installata complessiva pari acirca 30 MW. Nel 2004 in Italia sono stati installati5 MW… Costo di un impianto fotovoltaico di po-tenza pari a un chilowatt: in Italia 5.500 euro circa,in Giappone meno di 5.000 euro. Ore annue di pro-duzione alla potenza nominale (cioè, produzioneeffettiva annua di chilowattora elettrici per ciascunchilowatt installato): nel Sud d’Italia e nelle Isole:1500 / 1600 ; a Roma: 1.400; in Pianura padana:1.150; in Germania: 900/1000. Gli impianti Foto-voltaici sono produttivi sicuramente per almeno 30anni (anche se la produttività decresce lentamen-te con il passare degli anni). La garanzia legale co-pre una durata di 20 anni. Fotovoltaico: la grande speranza italiana. I vantaggi del Fotovoltaico rispetto alle altre fontirinnovabiliL’energia Fotovoltaica è una fonte inesauribile dienergia pura, disponibile per tutti, prodotta nellostesso luogo di consumo e integrabile nel contestourbano. Gli innumerevoli aspetti positivi rendonoquesta tecnologia probabilmente la più interessan-te tra tutte le rinnovabili. L’elevato costo iniziale rap-presenta l’unico inconveniente, se confrontato coni costi di generazione elettrica da combustibili fos-sili, ma se si tiene conto degli indubbi benefici am-bientali la valutazione economica complessiva nonpuò che diventare positiva. Grazie ad una decisa po-litica di sostegno della domanda e contemporanea-mente di stimolo della ricerca è possibile tuttavia ri-muovere anche quest’ultima barriera e sfruttare apieno tutti i vantaggi che il Fotovoltaico presenta an-che rispetto ad altre fonti rinnovabili di energia. 1 In tutto il mondo L’Italia è conosciuta come “ilPaese del sole”. Non possiamo dire lo stesso per ilvento.2 L’energia solare fotovoltaica non fa rumore né haparti in movimento.3 Non ha un impatto visivo negativo e non detur-
Giovanni De Pascalis
la svolta
52
C
Tutti pazziper il fotovoltaicoTutti pazziper il fotovoltaico

pa l’ambiente, anzi i moduli FotoVoltaici si presta-no molto bene per l’integrazione architettonica (siveda, per esempio, Norman Foster: www.foste-randpartners.com)4 Gli edifici che incorporano elementi Fotovoltai-ci trasmettono un’immagine positiva, legata alla cu-ra per l’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 5 La tecnologia FV non ha bisogno di aree dedica-te, in quanto sfrutta superfici che altrimenti rimar-rebbero inutilizzate (es. tetti, pensiline, facciate diedifici). Nel caso di installazione su tetti piani puòessere quasi invisibile.6 L’energia elettrica viene generata direttamente nelpunto di consumo o molto vicino ad esso, evitan-do quindi perdite dovute al trasporto ed ai cambidi tensione. Pertanto la generazione diffusa di mol-ti piccoli impianti Fotovoltaici riduce i carichi sul-la rete elettrica. 7 Ciascun impianto ha durata di vita superiore a 30anni. 8 Ha costi di manutenzione inferiori a tutte le altrefonti energetiche (rinnovabili e non) in quanto tec-nologia a stato solido e priva di parti in movimento.9 Il cittadino diventa protagonista in quanto pro-duttore in proprio, e pertanto consuma energia inmaniera più consapevole. Diversi studi hanno di-mostrato una marcata riduzione del consumo tota-le di energia elettrica nelle case dotate di sistemisolari Fotovoltaici.Il conto energia triplica. Con il nuovo decreto sipassa da 100 MW a 300 MW, privilegiati i piccoliimpianti.Il 7 dicembre scorso, il Ministro delle Attività Pro-duttive, Claudio Scajola, , di concerto con il mini-stro dell’Ambiente, Altero Matteoli, ha firmato ilnuovo decreto sugli incentivi per l'istallazione de-gli impianti fotovoltaici. Il conto energia passa da100 MW a 300 MW e privilegerà con ben 220 MWle richieste dei piccoli impianti fotovoltaici prove-nienti da condomini, famiglie e piccole imprese.Il provvedimento amplia la potenza incentivabileportandola da 100 a 300 MW, di cui 220 MW desti-nati ai piccoli impianti e 80 MW ai grandi. Ulterio-re novità apportata dal decreto è l’incremento da300 a 500 MW della potenza fotovoltaica da instal-lare entro il 2006. Di questi, 100 MW andranno acoprire le richieste per piccoli impianti (tra 1 e 50KW) provenienti da utenti, condomini e piccole im-
prese e 60 MW quelle delle grandi imprese per gliimpianti fotovoltaica di potenza superiore (tra 50 e1000 kW). I restanti 140 MW sono allocati con tran-che annuali per un Max di 60 MW ogni anno. Il nuo-vo decreto modifica anche l'obiettivo finale incre-mentando la potenza fotovoltaica installata in Ita-lia entro il 2015 a 500 MW… Il "conto energia" fo-tovoltaico è stato introdotto nel settembre scorsodopo un'attesa di quasi due anni. Il nuovo sistemaha sostituito il precedente meccanismo del contri-buto all'acquisto con quello del contributo sull'e-nergia effettivamente prodotta dai pannelli solari evenduta alla rete elettrica nazionale. La tariffa in-centivante prevista – per una durata di venti anni– è compresa tra 0,45 e 0,49 euro per ogni kWhprodotto, a seconda della taglia dell’impianto (com-presa tra 1 e 1000 kW). Inizialmente il decreto delconto energia prevedeva un fondo per soli 100 MW.Il grande interesse ha subito fatto prevedere chetale quota sarebbe stata abbondantemente supe-rata in breve tempo. E così è avvenuto. Dopo 60giorni il fondo di 100 MW del conto energia era giàesaurito.Il boom del fotovoltaico (strepitosi risultati per ilconto energia)(Fonte: Energie Alternative n. 4, Suppl. alla Staffet-ta Quotidiana n. 69/2006)Continua il successo del fotovoltaico in Italia ad unritmo che neanche gli esperti del settore avevanopreventivato. Il numero di domande d'ammissionealle tariffe incentivanti sta crescendo ad un ritmoesponenziale. Era partito con un numero conside-revole al 30 settembre 2005 (3.671 domande percomplessive 121 MW), era raddoppiato al 31 di-cembre (8.144 domande per 222 MW ) e ha rag-giunto valori incredibili al 31 marzo 2006 (più di14.000 domande per una potenza totale stimata in500 MW). Il confronto con la Germania, dove nelprimo anno d'applicazione del sistema d'incenti-vazione in conto energia si erano installati 37 MWd'impianti, è nettamente a favore dell'Italia. Consi-derando che gli impianti con potenza inferiore a 20kW devono essere completati entro 12 mesi dallacomunicazione dell'ammissione alle tariffe incen-tivanti da parte del GRTN, si può prevedere che nel2006 saranno installati almeno 100 MW. Quali lemotivazioni di questo successo? La lunga attesa perl'approvazione del sistema d'incentivazione in con-
53

to energia, il livello delle tariffe sicuramente in-centivanti e superiori a quelle della Germania, ilgrande interesse verso questa applicazione da par-te dei cittadini e delle industrie, evidenziato daicontinui richiami in giornali, riviste e programmitelevisivi, la disponibilità di risorse finanziarie chenon trovavano adeguati canali d'investimento a bas-so rischio, la sensibilità del GRTN nel rendere fa-cilmente accessibile la procedura d'ammissione al-le tariffe, la risposta immediata degli operatori delsettore alle esigenze del mercato sono fra i fattoripiù importanti che hanno contribuito a questa af-fermazione. In questo quadro idilliaco rimangonoalcuni aspetti critici che possono influire sull'ulte-riore sviluppo del FV. Il più rilevante è la capacità
dei produttori mondiali di moduli a soddisfare ladomanda del mercato italiano, tenendo anche con-to della concomitante crescita dei mercati tedeschi(500 MW nel 2005), e spagnolo (800 MW nel pri-mo anno di applicazione) che aveva già trovato im-preparati i produttori della materia prima, i lingot-ti di silicio. Un confronto fra gli utilizzatori del mer-cato italiano e i maggiori produttori mondiali chesi svolgerà a Vicenza in occasione del SolarExpo2006 dovrebbe fornire una risposta esauriente aquesto dilemma. Altro aspetto critico è il limite del-la potenza installabile annualmente a partire dal2006 (85 MW). Se confermato dalla prossima legi-slatura, creerebbe un fenomeno di stop and go eun rallentamento del processo di sviluppo appena
la svolta
54

iniziato. La semplificazione delle procedure buro-cratiche per la costruzione degli impianti, già at-tuata dal MAP con il chiarimento dell'errore mate-riale dell'articolo 12 del D.Lgs 387, potrebbe tro-vare ostacoli inutili nell'applicazione a livello re-gionale. Ultimo problema, decisamente negativo,la recente concentrazione di furti di moduli FV giàinstallati avvenuti in Sicilia (4 ad Alcamo e 1 a Ra-gusa) e in Calabria (2 impianti). Le regioni meri-dionali non sembra si rendano conto dell'enormeopportunità in termini di creazione di posti di la-voro rappresentata dal FotoVoltaico e dovrebberoattivarsi per scongiurare con l'aiuto delle forze del-l'ordine il ripetersi di questo fenomeno criminale.In conclusione, si può affermare che la totale mo-
dularità degli impianti fotovoltaici – il costo so-stanzialmente è sempre lo stesso, sia che si tratti dicentinaia di Megawatt sia che si tratti di 50 Chilowatt– che consente agevolmente di installare impiantidi piccola taglia, da uno a poche decine di Chi-lowatt, configura l’energia fotovoltaica come la tec-nologia energetica più “democratica” in assoluto. Quella che effettivamente rende possibile la gene-razione di elettricità ad ogni famiglia o piccolo im-prenditore, nel modo più semplice e più diffusonel territorio. Situazione opposta, quindi, rispetto ai giganteschiaerogeneratori industriali. Con i quali multinazio-nali e grandi imprese monopolizzano ancora unavolta la ricchezza energetica.
55

uello che presentiamo di seguito, è unostralcio del libro “Dopo il petrolio”, edi-to da Einaudi
(…) Nel sud della Germania, a qualche chilometrodal confine con la Francia, nel bel mezzo della cam-pagna coltivata a vite, il turista appassionato di tec-nologie può dedicare una giornata alla visita guida-ta di Friburgo, prima “città solare” del mondo. Stan-do comodamente seduti in un pulmino, si vedonola stazione ferroviaria alimentata a energia solare,villette a schiera ad alta efficienza energetica, innu-merevoli impianti fotovoltaici montati sui tetti e, sul-la sommità di una collina, il famosissimo Heliotrop,un edificio high-tech che gira su se stesso per se-guire il percorso del sole – il tutto mentre la guida(nel mio caso un ragazzo magro e allampanato dinome Jurgen) spiega come Friburgo abbia dato vi-
ta al movimento ambientalista tedesco quasi trent’an-ni fa. Alla periferia della città, su uno splendido cam-pus fiancheggiato dagli alberi, Jurgen ferma il pul-mino di fronte a un’armoniosa struttura in vetro epannelli fotovoltaici. E’ l’Istituto Fraunhofer per l’E-nergia Solare, tra i principali centri europei di ricer-ca e sviluppo e all’avanguardia della rivoluzione so-lare. Ogni giorno, diverse centinaia dei migliori scien-ziati, ingegneri e tecnici del mondo si riuniscono quiper lavorare alla soluzione che permetterà finalmenteall’energia solare di sviluppare tutto il proprio po-tenziale. Uno dei progetti attualmente in corso è lacostruzione di una cella fotovoltaica di terza gene-razione che produrrà una quantità di energia dop-pia rispetto a qualsiasi cella fotovoltaica oggi sul mer-cato. “Di tutte le energie rinnovabili, quella solareha il potenziale maggiore, – spiega Joachim Luther,
l’effervescente direttoredel centro. – E la ragio-ne è semplice: l’energiasolare è ovunque”.Per gli entusiasti comeLuther, l’energia solareè la strada da percorre-re per arrivare a un’eco-nomia energetica nuo-va. L’energia solare èabbondante. Non emet-te anidride carbonica néaltri gas. Produce anchela forma di energia piùutilizzata – l’elettricità –il che la rende la tecno-logia “pulita” ideale peril settore elettrico, at-tualmente tra i principaliproduttori di CO2 e al-tre emissioni. Poiché l’e-nergia solare funzionasu qualsiasi scala, dai
Paul Roberts
la svolta
56
Q
Il Sol dell’avvenireIl Sol dell’avvenire

tetti delle case di Fri-burgo a distese di chilo-metri di celle fotovoltai-che nel deserto delMojave in California, es-sa getta le basi per un si-stema energetico vera-mente decentralizzato,in cui la produzione dielettricità viene gestita alivello locale, o addirit-tura individuale, anzichéattraverso aziende elet-triche pubbliche o pri-vate e complicati e co-stosi elettrodotti.Ma l’aspetto più impor-tante è forse che l’energia solare è l’unica tecnolo-gia esistente non basata sugli idrocarburi che ab-bia una qualche speranza di soddisfare il fabbiso-gno previsto di volumi enormi di nuova elettricitàsenza carbonio – nell’ordine di molte migliaia dimiliardi di chilowattora – entro il 2050. L’energiaidroelettrica, per esempio ha un potenziale di cre-scita piuttosto limitato. L’energia solare, invece, èlimitata solo dalla quantità di luce solare e dalla su-perficie disponibile: in teoria, la luce solare che il-lumina l’uno per cento della superficie delle terreemerse del pianeta basterebbe già per produrre l’e-nergia necessaria per rifornire tutto il mondo in-dustrializzato. “Quella solare è l’unica tecnologia che potrebbefornire 28 milioni di Megawatt di energia pulita en-tro il 2050 senza la minima fatica”, insiste John Tur-ner, esperto di energie alternative presso la Natio-nal Renewable Energy Laboratory di Golden, in Co-lorado. “Per meglio dire, non c’è nulla che ci im-pedisca di muoverci sin d’ora in quella direzione,se non i costi molto elevati”.L’energia solare si scontra con due ostacoli: quellodei costi proibitivi e una reputazione talmente com-promessa da un’esperienza negativa negli anni Set-tanta che, malgrado i passi avanti compiuti di re-cente, molti attori del business energetico ritengo-no che questa tecnologia non abbia nessun futuro.Trent’anni fa, all’apice della crisi energetica, i go-verni occidentali scommisero che l’energia solarepotesse liberare le rispettive economie industriali
dalla dipendenza dal petrolio arabo. Finanziaronoquindi la ricerca e introdussero sgravi fiscali; i pro-prietari di abitazioni che producevano energia elet-trica in sovrappiù con i nuovi sistemi fotovoltaicipotevano venderla alle utilities, che erano obbli-gate per legge ad acquistarla. Con la prospettiva diun mercato dell’energia solare, si fecero avanti leaziende commerciali. La maggior parte delle com-pagnie petrolifere, incluse Exxon, Arco e Mobil, in-vestì ingenti capitali nell’energia solare, garanten-do così al Big Oil una presenza sul mercato dell’e-nergia solare, qualora avesse preso piede.Ai primi degli anni Novanta, tuttavia, il boom del-l’energia solare si era già sgonfiato. Malgrado in-vestimenti per oltre tre milioni di dollari, i ricerca-tori non riuscirono mai a migliorare le prestazionidella cella fotovoltaica così come avrebbero volu-to. Le migliori celle sul mercato avevano livelli diefficienza di appena il 10 per cento – il che signifi-ca che solo un decimo dell’energia solare assorbi-ta dalla cella veniva trasformato in elettricità utiliz-zabile. Avevano anche altri punti deboli. I costi diproduzione delle celle fotovoltaiche, costruite conil silicio, rimanevano altissimi, ma il problema piùgrave è che l’energia solare è intermittente: vienea mancare di notte e nelle giornate nuvolose. (…)A metà degli anni Novanta molti addetti ai lavori ri-tenevano che l’energia solare fosse ormai finita inun vicolo cieco.In realtà il settore era prossimo a un nuovo boom.Nel 1995 il Giappone, che ha tariffe elettriche tra le
57

più alte al mondo, annunciò un ambizioso pro-gramma per sovvenzionare e installare milioni dicelle fotovoltaiche sui tetti delle case. Due anni do-po i Verdi – da poco al governo della Germania –riuscirono a far approvare dal Parlamento tedescouna legge simile. Stimolato da queste iniziative, ilmercato mondiale dell’energia solare cominciò acrescere: il Giappone installò 25.000 impianti do-mestici nel solo 2002; tra il 1995 e il 2002 il nume-ro di impianti fotovoltaici installati ogni anno pas-sò da 80 a 500 MegaWatt di potenza totale. Oggi il solare cresce a un ritmo del 30-40 per cen-to l’anno – alla stessa velocità dei telefoni cellularinel periodo della massima diffusione – e il settorene ha preso buona nota. BP e Shell hanno effettuatonuovi importanti investimenti nel solare e aziendeelettroniche giapponesi come Sharp, Kyocera eSanyo si contendono la leadership del mercato.Com’era prevedibile, con l’aumento dei volumi, ilsolare è diventato più abbordabile. Ogni volta chele vendite raddoppiano, i costi scendono di un 10per cento, mentre le innovazioni introdotte nellaprogettazione e nei materiali migliorano nettamentel’efficienza. [Negli ultimi 8 anni il prezzo di un chi-lowatt di celle fotovoltaiche è sceso da 9.000 a 5.000euro, n.d.r.] Alcune aziende stanno creando unnuovo sottilissimo “film” fotovoltaico da applicaresui lati degli edifici per trasformare edifici interi,grattacieli e stadi in generatori solari. L’IstitutoFraunhofer sta lavorando a dispositivi di nuova ge-
nerazione, una cella fo-tovoltaica “multistrato”la cui efficienza teoricaè del 40 per cento, circail doppio di quelle at-tualmente sul mercato.L’aumento dell’efficien-za, associato alla dimi-nuzione dei costi, stamigliorando costante-mente la competitivitàdel solare. La tecnologiaper lo sfruttamento del-l’energia solare “costaancora quattro volte dipiù del nucleare e trevolte di più del gas na-turale”, dice Paul May-
cock, ex responsabile della divisione solare del Di-partimento all’Energia e ora direttore della rivistaspecializzata “PV Energy”. Ma, insiste Maycock, lagenerazione di tecnologie fotovoltaiche che con-sentirà di ridurre i costi equiparandoli a quelli delgas naturale “è già in laboratorio e sarà certamen-te pronta entro il 2010”. Secondo uno studio con-dotto dalla società energetica europea Rwe, viste econsiderate le crescenti economie di scala, il sola-re si sta avvicinando con grande rapidità a un co-sto del capitale di un dollaro per watt di potenzainstallata [1.000 euro per chilowatt installato, con-tro i 5.000 euro di oggi, n.d.r.] il che, in paesi conun clima soleggiato e tassi di interesse bassi, de-termina una tariffa di circa otto centesimi di dolla-ro per chilowattora. “Sono tariffe che possono com-petere con il gas”, dice Maycock, il quale ritieneche il divario di costo restante possa essere colmatoda un semplice aumento dei volumi di vendita.“Non sto parlando di qualche nuova scoperta tec-nica, ma solo di economie di scala. E così si scopreche la tecnologia fotovoltaica è molto vicina ai va-lori economici del gas naturale…”Joachim Luther, dell’Istituto Fraunhofer, è piena-mente d’accordo. Se le tendenze attuali si confer-meranno, l’energia solare potrà diventare redditi-zia entro il 2008 – senza sovvenzioni governative– in quelle regioni dove il sole splende per granparte dell’anno, come il Mediterraneo, il MedioOriente e il Sudovest degli Stati Uniti…
la svolta
58

(ANSA) - BARI, 12 GIU - ''Non posso che accoglie-re questo progetto con grande entusiasmo e farmigarante che le procedure amministrative e autoriz-zative, benche' rigorose, saranno spedite, rapide,perche' si possa davvero guadagnare la concretez-za di quello che appare un sogno'': lo ha detto ilpresidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, alquale e' stato consegnato oggi pomeriggio il pro-getto per la realizzazione a Brindisi della centralefotovoltaica piu' grande d' Europa. Il progetto pre-vede la realizzazione, entro tre anni, di una cen-trale di produzione di energia elettrica da fonti rin-novabili mediante campi fotovoltaici di 11 me-gawatt. Sorgera' nell' area dell' ex petrolchimico diBrindisi su una superficie di 84.343 metri quadratie produrra' una energia annuale di 15,12 gigawattorari. Partner scientifico e tecnologico saranno leUniversita'. L' area e' attualmente sottoposta a se-
questro probatorio da parte della procura della Re-pubblica di Brindisi per questioni ambientali. Il ca-pitale da investire previsto e' di 85 milioni di euro,totalmente fondi privati con la possibilita' di otte-nere fino a un 20% di incentivi con investimentocon leggi regionali e nazionali, mentre il resto saràun project financing. La centrale prevede una oc-cupazione iniziale di 16 persone e, a regime, di 50unita'. Iniziative collaterali saranno una scuola diformazione sulle energie rinnovabili rivolta allepubbliche amministrazioni, un polo di eccellenzaper la ricerca e lo sviluppo dello sfruttamento dell'energia solare, in collaborazione con l'universita'di Lecce e col Politecnico di Bari, un centro di for-mazione per progettisti, installatori e manutentoridi impianti solari, convenzioni con università edenti di ricerca per potenziare le capacità tecnolo-giche della Regione Puglia.
scheda
59
A Brindisi la centrale più grande d’EuropaA Brindisi la centrale più grande d’Europa
In Italia le fonti rinnovabili, e soprattutto la solare, su-biscono da sempre un pesante ostruzionismo, rima-sto inspiegabile fino al 6 novembre 2003. Quel gior-no la X^ Commissione della Camera dei deputati de-nunciò le dimensioni dell’osso che certi signori delpetrolio e dei rifiuti tengono fra i denti dal 1991: al-meno 2 miliardi di euro l’anno di fondi pubblici “Cip6”,spremuti ai cittadini col pretesto delle fonti rinnova-bili. In pratica, i rifiuti delle lavorazioni petrolifere so-no stati fatti passare per fonti energetiche “assimila-bili alle rinnovabili” e come tali sono stati accorpatialle fonti rinnovabili vere: sole, vento, biomasse, geo-termia, ecc. In altre parole, anche se l’aggettivo “assi-milabili” è non poco ambiguo, sostanzialmente si èfatto credere alla stragrande maggioranza dei cittadi-ni che si trattasse di finanziare fonti rinnovabili, quin-di non inquinanti, mentre, in realtà, quello che è ac-caduto è che uno dei segmenti della filiera del petro-lio si è pappato per 13 anni la maggior parte dei sol-di pubblici (e certamente non pochi soldi!) che do-vevano invece andare a finanziare l’energia rinnova-bile alternativa ai combustibili fossili!! La Banca Sarasin di Basilea, governata ovviamenteda economisti, non da asceti, indica l’energia sola-re come uno dei più promettenti settori di investi-mento; e aggiunge che un milione di dollari inve-stiti nel fotovoltaico creano 17 posti di lavoro sta-
bili, contro i soli 1,5 che ne creano se investiti nelpetrolio. La tabella qui accanto dà la misura del dan-no che “l’affare Cip6” ha procurato. Essa è un’ela-borazione degli ultimi dati IEA – International EnergyAgency – su venti paesi industrializzati. Ne emergeil grave ritardo dell’Italia nel campo dell’energia so-lare fotovoltaica rispetto a tanti altri paesi del mon-do che hanno certamente meno sole di noi.
Watt di solare fotovoltaico per abitante e potenzatotale fotovoltaica installata a fine 2003:
1 - Giappone: 6,74 859,6 MegaWatt2 - Germania: 4,97 410,3 MegaWatt3 - Svizzera: 2,88 19,5 MegaWatt4 - Olanda: 2,83 26,3 MegaWatt5 - Australia: 2,29 45,6 MegaWatt6 - Austria: 2,05 10,3 MegaWatt7 - Norvegia: 1,44 6,4 MegaWatt8 - Stati Uniti: 0,94 212,2 MegaWatt9 - Spagna: 0,68 20,2 MegaWatt
10 - Finlandia: 0,66 3,1 MegaWatt11 - Italia: 0,45 22,0 MegaWatt12 - Svezia: 0,40 3,3 MegaWatt13 - Canada: 0,37 10,0 MegaWatt14 - Francia: 0,35 17,2 MegaWatt15 - Danimarca: 0,35 1,6 MegaWatt(…)Da “Tuttoscienze - La Stampa” del 10 novembre 2004
Solare, Finlandia batte ItaliaSolare, Finlandia batte Italia

'utilizzo delle biomasse vegetali - o anche ani-mali - per produrre energia - rientra nel piùvasto insieme delle tecnologie energetiche rin-
novabili solari. Facciamo qui riferimento, in parti-colare, ai vegetali. In che modo le piante utilizza-no l’energia del sole? Il processo è ben noto: la ra-diazione solare viene assorbita dalle piante ed uti-lizzata, attraverso un processo chimico-fisico chia-mato fotosintesi, per produrre energia vitale. A spe-se dell'energia solare, la pianta assorbe l'anidridecarbonica dell'aria e la combina con l'acqua pro-veniente dalle radici per formare i carboidrati. L'os-sigeno, per altri versi elemento prezioso per la vi-ta, in questa reazione rappresenta il prodotto discarto. Ma quanta energia possiamo ottenere dallepiante? Dalla combustione completa di un chilo-grammo di sostanza vegetale secca si liberano cir-ca 4500 chilocalorie di energia termica. Ai fini pra-
tici, tenendo conto delle inevitabili perdite di ca-lore, il potere calorifico netto può essere conside-rato pari a circa 4000 chilocalorie per kg.Esistono due modalità fondamentali per ricavareenergia dalle biomasse. La prima è quella di bru-ciare la biomassa (ciò che avviene con la legna daardere). La seconda è quella costituita dalla pro-duzione di biocombustibili. Vediamo dunque piùin dettaglio quanta energia si può ricavare dallacombustione di biomassa vegetale essiccata.Resa energetica per le principali piante legnoseadatte al clima europeo:pioppo, eucalipto e robinia:circa 6-7 tep (tonnellate equivalenti petrolio) perettaro di coltura;salice o canna comune:circa 8-9 tep per ettaro di coltura. Nel caso di combustione delle biomasse in centra-
li per la produzione dienergia elettrica, si haun costo del chilowat-tora prodotto pari a cir-ca 10 centesimi, più al-to quindi rispetto al co-sto del chilowattora pro-dotto da petrolio o dacarbone, che è pari acirca 5-6 centesimi.Questo differenziale dicosto risulterebbe am-piamente recuperabilese venissero contabiliz-zati i benefici ambienta-li collegati all’assenza diincremento di gas a ef-fetto serra in atmosfera. Passiamo ora al capito-lo dei biocombustibili.A questo proposito, alfine di selezionare tra
Domenico Coiante
dossier
60
L
Biomassela rinnovabile più anticaBiomassela rinnovabile più antica

tutte le opzioni quelle più utili per la produzionedi biocombustibili, occorre fare riferimento ad unimportantissimo parametro: il fattore di guadagnoenergetico, EY, (Energy Yeld) definito come il rap-porto tra l'energia lorda ottenibile al termine delprocesso di coltivazione per ettaro, detto anche out-put energetico, e la spesa energetica effettuata perettaro nell'intero periodo della coltivazione, dellapreparazione del terreno, della semina, ecc. fino alraccolto. Considerando tutte le implicazioni, nonsolo strettamente energetiche ma anche economi-che, la soglia di interesse va fissata ad un valore delEY pari almeno a 2. Assumendo questo valore co-me criterio di scelta, si verifica che le colture piùinteressanti ai fini della produzione di biocombu-stibili sono le seguenti:Resa energetica (EY) per le diverse colture:Colza tra 2 e 3Mais tra 2,4 e 4,4Barbabietola da zucchero tra 3,5 e 4,5Sorgo zuccherino tra 5 e 7 [da: Domenico Coiante, Le nuove fonti di energiarinnovabile]
In particolare, la quantità di bioetanolo ricavabile,in Europa, dalle colture più interessanti è la se-guente:Mais: 2,6 tonnellate per ettaroBarbabietola da zucchero: 3,0 tonnellate per ettaro(nonostante il sorgo zuccherino mostri caratteristi-che più vantaggiose, esso non è stato preso in con-siderazione perché si tratta di una coltura ancoraallo stato sperimentale)[da: Domenico Coiante, Le nuove fonti di energiarinnovabile]
ConclusioniAnche se la produzione industriale di energia ter-mica e di combustibili liquidi dalle biomasse si tro-va ancora in una fase giovanile, essa tuttavia puòessere considerata come la più sicura ed affidabiletecnologia di sfruttamento della fonte solare, dalmomento che si collega senza interruzione alla piùantica e consolidata tecnologia solare, l’agricoltu-ra. E’ un dato di fatto che, oggi, senza considerarel’apporto prezioso sotto forma di alimenti, le bio-masse convenzionali contribuiscono al bilancioenergetico mondiale per una quota rilevante, si-
tuata intorno al 12%. Le nuove tecniche di coltiva-zione industriale, specificatamente sviluppate perla produzione di bioenergia, possono far aumen-tare significativamente questo contributo ed il pro-cesso è già in corso. Lo sfruttamento dei cosiddet-ti suoli marginali promette di fornire enormi baci-ni di raccolta di biomasse, che in teoria potrebbe-ro portare ad un rilevante contributo. Tuttavia, sulversante economico, il bilancio dei costi di produ-zione della bioenergia mostra come l’impresa in-dustriale sia conveniente soltanto in condizioni dibuona produttività dei terreni. Tali condizioni pur-troppo portano ad escludere gran parte dei terrenimarginali e di conseguenza ad impegnare per lecoltivazioni energetiche suoli fertili adatti all’agri-coltura tradizionale. Visto l’incremento demografi-co mondiale, l’occupazione di questi terreni con lecoltivazioni bioenergetiche entra in aperto conflit-to con la necessità impellente di incrementare laproduzione di alimenti. Nella pratica, pertanto, ilcontributo energetico mondiale conseguibile conle nuove tecnologie delle biomasse (e con il recu-pero degli scarti dell’agricoltura tradizionale) po-trà spostare di poco il valore del contributo odier-no sopra ricordato.
61

Il sistema di finanziamento degli incentivi econo-mici alle nuove fonti di energia rinnovabile (sola-re, eolico, biomasse, ecc.) non grava sul bilanciodello Stato. Il costo dell’incentivazione viene co-perto con la tariffa A3 della bolletta elettrica, che èstata appunto prevista per finanziare la “costruzio-ne di impianti di produzione di energia elettrica dafonti rinnovabili”. Tale onere pesa per circa il 3 percento sulla bolletta elettrica pagata da famiglie edimprese. Senonché nel 1991 le risorse legate alla“Tariffa A3” sono state estese, con l’articolo 22 del-la legge n. 9/1991, ad una categoria ibrida definita“fonti rinnovabili o assimilate ai sensi della nor-mativa vigente” senza che una normativa vigenteeffettivamente esistesse e limitandosi a rinviare alComitato interministeriale la definizione delle “con-dizioni tecniche generali per l’ammissibilità”. Que-sta anomalia, che genera un sistema di comunica-zioni false e fuorvianti verso il consumatore, è sta-ta fortemente stigmatizzata dal Presidente dellaCommissione X della Camera durante il suo inter-vento del 6 novembre 2003: “Ad oggi non esistenon solo alcun elenco plausibile delle fonti assi-milate, ma neanche una chiara definizione dei cri-teri che consentono l’ammissibilità;” ha enunciato
in quella occasione l’on. Bruno Tabacci: “Si sa so-lo che vige un regime cosiddetto CIP 6 che garan-tisce allo stesso modo alle fonti rinnovabili e a chiricicla i rifiuti non biodegradabili – ma anche in lar-ga misura semplici scarti petroliferi di raffineria –una tariffa molto al di sopra dei valori di mercatodell’energia prodotta. Mentre, tuttavia, il CIP 6 re-lativo alle rinnovabili può giustificarsi con esigen-ze di tutela dell’ambiente e di sviluppo di nuovetecnologie mature in quei settori, si chiede a qua-le titolo possa essere imposta ai cittadini una tassaocculta stimata pari, per l’intera operazione CIP 6,a 30 miliardi di Euro in 15 anni (2 miliardi/anno),circa 60.000 miliardi di lire, per finanziare, per lamaggior parte, energia da combustibili fossili…?!!Le stesse fonti rinnovabili sono state in qualche mi-sura fagocitate dalle fonti assimilate e, in conside-razione dei rapporti di forza, non si può non pren-dere atto che ormai i ruoli si sono invertiti, tantoche si potrebbe dire, con un gioco di parole, chesono le rinnovabili ad essere assimilabili alle assi-milate.” Il risultato di questa situazione scandalosaè che dal 1991 ad oggi almeno l’ottanta per centodei contributi pubblici alle energie rinnovabili e as-similate è andato alle sole assimilate. Vale a dire, inlarga parte, all’industria petrolifera. Questa ha ri-cevuto, dal 1991 ad oggi, tra i 20 e i 25 miliardi dieuro, soldi che avrebbero invece dovuto finanzia-re il decollo dell’energia solare in Italia…!!! Per lerinnovabili vere, solare, eolico, biomasse, sono ri-maste solo le briciole. Sono considerati impianti ali-mentati da fonti assimilate quelli in cogenerazio-ne; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi discarico e altre forme di energia recuperata in im-pianti a combustibile fossile; quelli che usano gliscarti di lavorazione (ad esempio di raffineria) equelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo dagiacimenti minori isolati. In realtà, proprio al termine della scorsa legislatu-ra, l’allora ministro delle Attività produttive Scaio-la emanò un decreto in cui è stabilito che le con-venzioni di finanziamento delle “assimilate”, nel-l’ambito del CIP6, non possono essere rinnovateuna volta giunte a scadenza (la gran parte scadràtra 2006 e 2007). Questo significherebbe liberare,a beneficio delle vere fonti rinnovabili, enormi ri-sorse economiche. Qual è, però, la posizione delnuovo Governo? E in particolare del nuovo mini-stro Bersani? Fino ad oggi non è del tutto chiaro…
scheda
62
Il grande scandalo delle “assimilate”Il grande scandalo delle “assimilate”

Come ricordato nell’Editoriale di questo numero,Italia Nostra nel 1966, per iniziativa del suo Presi-dente Giorgio Bassani, contrastò la costruzione nel-la Baia di Panigaglia di un impianto per la conver-sione del metano liquido in gas, “in nome di By-ron, Shelley e Lawrence per la salvezza del Golfodei Poeti di La Spezia. Ma invano”, notò Bassaniamaramente: “Ci sono guerre – e la nostra, in prodella civiltà, della cultura, e della ragione, è una diquelle – le quali richiedono, per essere vinte allafine, molte sconfitte dolorose.” Nel 1996 Italia Nostra, insieme al WWF e contro laSnam, l’Enel e Legambiente, si impegnò a fondoper impedire la costruzione di un gigantesco ri-gassificatore nel Porto di Monfalcone, di fronte alCarso e a fianco di Trieste. Si tenne un referendumil 29 settembre e il Comitato per il No, guidato daCarlo Ripa di Meana, Gaetano Benedetto, LucianoGiorgi e Paolo Ghersina, ottenne una schiacciantevittoria. Nel 2004-2005-2006 Italia Nostra con il suoConsiglio Regionale della Puglia e l’impegno per-sonale di Nerina Scarascia Vivarelli Mugnozza, si èbattuta contro il rigassificatore previsto all’internodel Porto di Brindisi. Italia Nostra per il futuro, come è sua regola, si espri-merà caso per caso sulle nuove ipotesi di rigassifi-catori che il Governo sta mettendo a punto, con unnumero da definire tra i sei e i dodici siti. Riportiamo brani di un articolo scritto il 5 settembre
2006 per il Giornale dal Professor Franco Battaglia:“A differenza del mercato del petrolio e del carbo-ne, che è un mercato globale, quello del gas è unmercato intercontinentale: per due euro al barile lepetroliere vanno da un capo all’altro del mondo, econ uguale facilità si trasporta il carbone. I gasdotti,invece, operano, principalmente, sulla terraferma.L’unico modo pratico di trasportare il gas per naveè di liquefarlo, il che significa portarlo, e mantener-lo, a temperature inferiori a 160° sotto lo zero. Ber-sani ha dichiarato che “si fa in tutto il mondo e maisono successi incidenti”. Uno laureato in filosofia hail diritto di ignorare la differenza tra kilowatt e ki-lowattora, ma non il significato della parola “mai”.Venti ottobre 1944, Cleveland, Ohio: a causa di unaperdita di gas naturale liquefatto nel sistema di chiu-sura, un’esplosione causa 130 morti. Dieci febbraio1973, ancora negli Stati Uniti, a Staten Island: un’e-splosione durante lavori di manutenzione ad un im-pianto di gas naturale liquefatto uccide 40 persone.19 gennaio 2004, Algeria: un’esplosione di gas na-turale liquefatto uccide 30 persone.(...) Bersani sostiene che l’Italia ha bisogno di unamezza dozzina di siti ove impiantare i rigassificatorie accogliere le navi che trasportano il gas naturale li-quefatto. Non sarebbe male informarlo che in tutti gliStati Uniti di siffatti siti ce ne sono solo 4: a Everett,nel Massachusetts, a Cove Point, in Maryland, a ElliottIsland, in Georgia, e a Lake Charles in Louisiana”.
dossier
63
I rigassificatori, scelta caso per casoI rigassificatori, scelta caso per caso

scheda
Unità di misura dell’EnergiaUnità di misura dell’Energia
64
Distinzione tra potenza e flusso di energiaParlando di energia si deve fare una fondamentale di-stinzione tra potenza, intesa come teorica capacità dicompiere un lavoro, a prescindere dalla durata neltempo di questo lavoro (può anche essere conside-rato come dato di energia dispiegata in un singoloistante) e flusso di energia nel tempo, cioè potenzatrasformata in atto, quindi energia che realizza real-mente un determinato lavoro nell’arco di un deter-minato tempo. In altre parole, nel concetto di “flussodi energia” o “lavoro” il riferimento a un dato perio-do di tempo è indispensabile: sarebbe infatti impos-sibile quantificare un flusso di energia – o un deter-minato lavoro - senza indicare il periodo di tempo nelquale quel flusso energetico, ovvero quel lavoro, si èdispiegato in modo continuo e stabile. Unità di misura della potenzaLa potenza quantifica la capacità massima di lavorodi una macchina o la capacità massima di erogazionedi energia nel caso si tratti di macchina produttrice dienergia (esempio: turbina elettrica). Il Watt (W) è l’u-nità di misura base della potenza elettrica [Tutti co-nosciamo le lampadine da 25 o 50 Watt]; il kiloWatt(kW) equivale a 1000 Watt, il MegaWatt (MW) equi-vale a 1000 kiloWatt [Un aerogeneratore ha normal-mente una potenza tra 0,8 e 2 MegaWatt, cioè tra 800e 2000 kW]Unità di misura del flusso di energia L’unità di misura fondamentale dell’energia elettrica(intesa come flusso o lavoro) è il chilowatt’ora, ovve-ro: kWh; 1 kWh (kilowatt/ora) = 1.000 Wh; 1 MWh(MegaWatt/ora) = 1.000 kWh; 1 GWh (GigaWatt/ora)= 1.000 MegaWatt/ora; 1 TWh (TeraWatt/ora) = 1.000GigaWatt/oraTEP, tonnellata equivalente petrolioUnità di misura universale dell’energia. Fa riferimen-to all’energia complessiva che si può ottenere (teori-camente) bruciando una tonnellata di petrolio. Perconvenzione, si stabilisce: 1 TEP = 11.700 kWh [at-tenzione: nella realtà l’efficienza energetica delle cen-trali termoelettriche a petrolio è intorno al 38 per cen-to. Nella realtà, da una tonnellata di petrolio si rica-vano non 11.700 kWh, bensì meno della metà]Un TEP corrisponde, teoricamente, a 7,33 barili di pe-trolio. 1 barile di petrolio = 159 litri di petrolio. Il consumo energetico totale del sistema Italia è paria circa 200 milioni di TEP all’anno.Ripartizione delle fonti energetiche nel mondoPetrolio: 35,4 %Carbone: 23
%Gas metano: 21,5 %Biomasse (soprattutto legno): 10
%Nucleare: 5
%Idroelettrico: 4,2 %Altre rinnovabili: 0,6 %Ripartizione delle fonti energetiche in ItaliaPetrolio: 43,0 %Gas metano: 34,6 %Carbone: 8,5 %Idroelettrico: 6,0 %Importazioni di energia elettrica: 5,4 %Legname: 1,7 % Altre rinnovabili 0,8 %(Geo, eolico, altre biomasse): Ripartizione del consumo di energia tra i diversi macro-settoriPer energia primaria si intende la somma di tutti i ti-pi e quantità di energia disponibili - in entrata - nel si-stema paese. Il suo consumo è così ripartito: generazione di ener-gia elettrica e importazioni: circa 37,5 %trasporti: circa 30 %riscaldamento civile: circa 20 %bunkeraggi e utilizzi diretti industriali ed agricoli:
circa 12,5 %Ripartizione del consumo di combustibili fossiliQuesto dato è quello che più interessa al fine di una va-lutazione del ruolo che possono giocare le energie rin-novabili al fine di ridurre il consumo nazionale di com-bustibili fossili e di conseguenza l’emissione di gas ser-ra. Infatti, a consumo energetico generale invariato, adogni aumento della quantità di energia prodotta da fon-te rinnovabile si otterrà di diminuire di una corrispon-dente quota il consumo di combustibili fossili. Questaè la ripartizione:il 36% per trasporto di persone e di merci con auto-veicoli, aerei, navi e treni a trazione non elettrica; il25% per produrre energia elettrica; il 24% per il ri-scaldamento civile; il 15% per i consumi diretti del-l’industria e dell’agricoltura e i bunkeraggi. Il consumo totale di elettricità in Italia corrisponde acirca 330 miliardi di kWh, quindi 330 TeraWatt/ora(TWh) all’anno. In Italia si ottiene l’elettricità dalle se-guenti fonti: 16% con centrali idroelettriche; 1,3 % concentrali geotermiche; 1 % con impianti a biomasse;0,8 % con impianti eolici; 14,5 % importazioni da Fran-cia, Svizzera, Austria e Slovenia; il 66,4 % restante èprodotto in Italia con i combustibili fossili.In Italia l’emissione totale di gas a effetto serra, in lar-ghissima parte anidride carbonica (CO2), ha raggiuntouna dimensione pari a circa 500 milioni di tonnella-te. Di queste solo il 25% circa proviene dalle centralitermoelettriche per la produzione di elettricità da pe-trolio, gas naturale e carbone.

III copertina

IV copertina