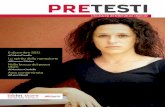Occasioni di letteratura digitaledrm.ebook.telecomitalia.com/free/Pretesti-2012-Numero2.pdf · Il...
Transcript of Occasioni di letteratura digitaledrm.ebook.telecomitalia.com/free/Pretesti-2012-Numero2.pdf · Il...
| Febbraio 2012pretesti1
L'acquedotto di Cerviadi Gene Gnocchi
L'incantesimo di Dickens di Edoardo Rialti
Il miracolo della parola di Marek Halter
Messico e nuvoledi Gianni Biondillo
Occasioni di letteratura digitale
pretesti
Febbraio 2012 • Numero 2
| Febbraio 2012pretesti3
Sono trascorsi duecento anni dalla nascita di Charles Dickens e Alessandro Mari propone un romanzo digitale a puntate. Roberto Saviano riscuote uno straordinario successo con un racconto ebook. Sono passati più di cinquecento anni dall’invenzione della stampa e nel 2015 si celebreranno i quarant’anni dal primo Olivetti da tavolo con floppy disk incorporato. Nel valutare la contrazione del tempo di impatto di una nuova tecnologia sicuramente bisognerà tenere presente che, affinché il romanzo si affermasse, sarebbero dovuti passare almeno tre secoli dall’invenzione della stampa a caratteri mobili, mentre nel mondo contemporaneo invece bastano poco meno di quarant’anni dall’invenzione di un elaboratore da tavolo alla formazione di una nuova letteratura. Che già mostra in nuce quanto potrà essere radioso il suo futuro. Si attende infatti un’esplosione del mercato degli ebook. Ma ci si dimentica che il successo economico è dato dalla risposta adeguata a un bisogno reale. Come potranno affermarsi nuovi canali di intrattenimento se non si adegueranno i messaggi da trasmettere?Gene Gnocchi si misura allora con la scrittura digitale e dal mondo dello spettacolo e del teatro traghetta una simpatia amara e un dolore inaspettato. Il suo racconto è forte come un pugno nello stomaco e la storia appare veloce e intensa nella mente di chi la legge tra una fermata e l’altra del metrò. Gianni Biondillo ci fa sognare il Messico e con Edoardo Rialti viaggeremo nei sogni di Dickens. Con Il cabalista di Praga scopriremo invece il destino del figlio di un tipografo, l’autore Marek Halter: sarà bestseller?Roberto Dessì e Daniela De Pasquale per Il mondo dell’ebook fanno luce sui nuovi mezzi e le fortune tecnologiche della letteratura tra social reading e feuilleton. In Buona la prima Francesco Baucia ricorda un capolavoro della letteratura fantastica curato da Carlo Fruttero (recentemente scomparso) e Sergio Solmi per Einaudi mentre con Lorenzo Coveri dell’Accademia della Crusca entreremo nei testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2012. Sulla punta della lingua celebra così chi già da tempo è stato costretto a confrontarsi con il cambio delle tecnologie per la diffusione dei propri contenuti. In Anima del mondo e in Alta cucina sentiremo Berlino e mangeremo New York.“Entertainment” dicono gli inglesi, e “intrattenimento” possiamo tradurre in italiano: ecco quello che da sempre cercano gli uomini, in ogni forma. Risiede qui la forza della letteratura, nella risposta a questa domanda di “compagnia” che da sempre abita la solitudine dell’umanità. Per questo sogniamo, per questo viviamo, per questo amiamo.
Buoni PreTesti a tutti.Roberto Murgia
Editoriale
| Febbraio 2012pretesti4
32-34Buona la primaLe meraviglie del possibile (1959)di Francesco Baucia35-37Sulla punta della linguaL'italiano canterinodi Lorenzo Coveri38-40Anima del mondoLa città invisibiledi Luca Bisin41-44Alta cucina A Roman Punch in New Yorkdi Francesco Baucia45 Recensioni
46Appuntamenti
47 Tweets / Bookbugs
RubRIChETEsTI
05-07RaccontoL'acquedotto di Cerviadi Gene Gnocchi8-13SaggioL'incantesimo di Dickensdi Edoardo Rialti14-18AnticipazioneIl miracolo della parola di Marek Halter 19-23Racconto Messico e Nuvoledi Gianni Biondillo
IL MONDO DELL’EBOOk
24-27Quattro passi nel fenomeno del social readingdi Roberto Dessì28-31Feuilleton 2.0:il nuovo formato del libro è l'ebook in progressdi Daniela De Pasquale
Indice
| Febbraio 2012pretesti6
na settimana fa ho tentato il suicidio. Erano le 19,30 e sono salito in cima all'acquedotto di Cervia a circa ventisette metri d'altez
za, anzi a ventiquattro, perché proprio sotto c'è il perlinato della pizzeria "L'origano", un perlinato abusivo, non ancora sanato. Era una giornata fredda e umida, se ben ricordo era il giorno che avevano trovato Antonio Di Pietro schiacciato dal suo trattore a Montenero di Bisaccia, forse aveva cercato di dissodare un calanco troppo scosceso, e se ne sono accorti perché non aveva ancora ‒ erano quasi le 18 ‒ rilasciato nessuna dichiarazione contro il malaffare. L'avevano trovato proprio sotto il trattore, in maniche di camicia, sotto il peso, come succede sempre ai morti da trattore. Ricordo anche che nessuno aveva pensato all'omicidio, neanche l'Italia dei Valori tranne Donadi che, testuali parole, "aspettava le risultanze del rapporto della polizia anche se a un primo esame gli interrogativi erano parecchi". Comunque sia io ero lì per tentare il suicidio dall'acquedotto di Cervia; in quel momento, in quel preciso momento non sapevo neanche che Di Pietro era rimasto schiacciato sotto il suo trattore perdendo la vita. L'ho saputo dopo, quando è finito tutto.
Sono stato sull'acquedotto di Cervia per quasi otto ore. Siccome non ho minacciato di buttarmi per avere del lavoro o per delle pene amorose, ma per una normalissima crisi esistenziale che mi ha portato a concludere che non volevo più niente dalla vita, una ventina, forse diciotto persone sono salite, e per cercare di convincermi a non buttarmi sul perlinato della pizzeria "L'origano" mi hanno dovuto parlare di quanto sia bello vivere e di quante cose belle potesse anco
ra riservarmi l'esistenza. Io avevo spiegato fin da subito che mi buttavo di sotto perché non mi interessava più niente del mondo, non vedevo nessuna luce, solo buio più altro buio e ancora buio, e i giorni mi passavano via lentissimi e non aspettavo niente. Ma tutti questi non se ne sono dati per inteso e ognuno a turno si è sentito in dovere di dirmi che la vita doveva essere vissuta tutta fino all'ultimo giorno, e anche se io gli rispondevo che per me l'ultimo giorno era quello, loro hanno insistito tutti così tanto
che sono rimasto ad ascoltarli. È arrivato anche uno con un cappotto scuro, uno magrino senza occhiali che per convincermi a non farla finita mi ha detto che se mi fossi buttato avrei perso i benefici del ridursi della spinta inflattiva e i vantaggi che sarebbero venuti dalla manovra bis e
U
Io mi sono ricordato in quel momento che
quando ero felice mangiavo dei biscotti, oppure andavo al Gran
sasso con un mio amico che ha le chiavi
del telescopio del Gran sasso
| Febbraio 2012pretesti7
dalle liberalizzazioni, oltre al fatto che con gli sgravi fiscali e gli incentivi alle aziende sarebbero ripartiti i consumi, anche non tenendo aperti i negozi tutta la notte. Io mi sono ricordato in quel momento che quando ero felice mangiavo dei biscotti, oppure andavo al Gran Sasso con un mio amico che ha le chiavi del telescopio del Gran Sasso. Arrivavamo lì, finito l'orario di lavoro, entravamo in questo salone dove c'era l'enorme aggeggio e mettevamo fuori fuoco le lenti del telescopio per fare un scherzo, così che la mattina dopo arrivavano gli astrofisici, puntavano il telescopio, che so, su Marte o su Plutone o su Saturno e li vedevano tutti sfuocati; così dovevano chiamare il tecnico, che era un nostro amico ‒ uno che lavorava all'Euronics di Chieti e che montava anche le lavatrici e le lavastoviglie, e non era sempre disponibile ‒ e lui ci dava la percentuale. Così il telescopio del Gran Sasso stava fuori fuoco anche due o tre giorni e si era tutti, dico tutti in Italia,
ignari delle cose che succedevano su Plutone o Saturno o Marte, sapendo poi che là ne succedevano di tutti i colori. Ecco, quando la gente saliva sull'acquedotto di Cervia e mi parlava, io ascoltavo un po' poi mi venivano in mente questi momenti che non torneranno più. Così, ridisceso anche l'ultimo che era venuto su per convincermi, si è formato in cima all'acquedotto un bel silenzio rotondo, pieno, lo stesso silenzio di poche notti piene di grilli che cantano tutti insieme e dopo un po' smettono per rifiatare, e in quel momento si sente solo il respiro assente dei grilli. Era venuto dunque un silenzio ottuso, senza speranza, pieno di silenzi singoli confluenti in quell'unico grande, un bel silenzio buono per decidere.Così mi sono lanciato e posso dire che dopo non c'è niente, neanche il rimpianto di non esserci più. Non c'è paradiso, non c'è l'inferno, non c'è il purgatorio, e questo ve lo voglio dire: tutte le volte che ricevete posta dall'aldilà, diffidate. •
Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, è autore di Una lieve imprecisione (Garzanti 1991), Stati di famiglia (Einaudi 1993), Il signor Leprotti è sensibile (Einaudi 1995), La casa di chi (Il Melangolo 1996, insieme a Mauro Bellei), Sistemazione provvisoria del buio (Einaudi 2001), Sai che la Ventura dal vivo è quasi il doppio? (Einaudi 2002) e Il mondo senza un filo di grasso (Bompiani 2004). Il suo ultimo libro L'invenzione del balcone (Bompiani 2011) è disponibile in ebook da Biblet.
Gene Gnocchi
Disponibile su www.biblet.it
| Febbraio 2012pretesti8
saggio
di Edoardo Rialti
L'INCANTESIMO DI DICKENSProdigi e portenti dell'esistenza quotidiana nei capolavori del maestro inglese
v
| Febbraio 2012pretesti9
n mezzo a quel gran mare spumeggiante d'allegria che è Il circolo Pickwick, con le sue farse e le sue avventure picaresche, dove, come nel
Don Chisciotte, la ridicola goffaggine dei protagonisti si carica pagina dopo pagina d'un aureola di gioiosa santità, d'un tratto il lettore si trova esposto alla gelida corrente di un racconto del tutto diverso, e rabbrividisce: si racconta la storia di una famigliola imprigionata per debiti. La madre ed il bambino muoiono di stenti, e l'uomo rimane solo. Ed ecco che il narratore fa un passo avanti, come incapace a trattenersi dal ribadire qualcosa di decisivo: “Non sa, chi definisce freddamente la morte dei poveri come una benefica liberazione dal dolore per chi se ne va, e una provvidenziale diminuzione delle spese per chi gli sopravvive, non sa, dicevo, quale sia l'angoscia di questi lutti. Uno sguardo affettuoso e premuroso scambiato in silenzio quando tutti hanno distolto freddamente il loro, la sicurezza di aver conservato la simpatia e l'affetto di un essere umano quando tutti ci hanno voltato le spalle, sono un'àncora, un sostegno, un conforto nella più profonda afflizione, e nessuna ricchezza può comprarli, nessuna potenza può renderli obbligatori”.Tanta parte della forza artistica di Dickens costituisce proprio una vasta cassa di risonanza a quel “non sa”: la sua forza nell'additare ancora e ancora la glaciale indifferenza di chi (come lo Scrooge che vedrebbe di buon grado la morte dei senza tetto, se questo può abbassare l'eccesso di popolazione) riposa nello stato attuale delle cose, ben disposto a conservarlo se ciò comporta il proprio benessere e la propria sicurezza, ma anche dell'altrettanto gelida astrazione
dei cosiddetti riformatori sociali, così innamorati delle proprie buone intenzioni e dal proprio amore per l'umanità intera per lasciarsi davvero commuovere e coinvolgere dalle vite di coloro che incontrano. Se Manzoni ci ha regalato Donna Prassede e il suo stolido moralismo, i romanzi di Dickens pullulano di figure simili, la cui apparente benevolenza si è fatta indistinguibile dalla crudeltà. Basti pensare al grottesco ritratto in Casa desolata della Signora Pardiggle, che si pavoneggia nel presentare alle amiche i figli che ha coinvolto a forza nelle sue attività benefiche: “Egbert, il maggiore (dodici anni), è il ragazzino che spedì tutto quello che aveva in tasca, ossia cinque scellini e tre pence, agli Indiani Tockahoopo. Oswald, il secondogenito (dieci anni e mezzo) è il bam
I
| Febbraio 2012pretesti10
bino che ha donato due scellini e nove pence al monumento dei Grandi Frammenti Nazionali. Francis, il terzo (nove), uno scellino, sei pence e mezzo; Felix, il quarto (sette) otto pence alle Vedove Decrepite; Alfred, il più giovane (cinque anni) si è iscritto di sua volontà nelle Alleanze Infantili della Gioia, e ha giurato di non far mai uso di tabacco in vita sua”. Il laconico commento della voce narrante è che “non avevamo mai visto bambini così scontenti”. La signora trascina le ospiti in una delle sue ronde nei quartieri poveri, entrando in una casa dove il marito ha da poco battuto la moglie e che all'ingresso della pia donna le vomita addosso bestemmie e volgarità: “Se ho letto il libretto che mi avete lasciato? No, non ho letto il libretto che mi avete lasciato”, sbotta esasperato, ma la donna non demorde: “prese un buon libro, come fosse la mazza di una guardia, e dichiarò in arresto tutta la famiglia. Intendo naturalmente in arresto religioso; ma in realtà così fece, come se fosse un inesorabile poliziotto morale pronto a trasportarla tutta in guardina”. Non si potrebbe immaginare una distanza più abissale di questo totale scarto di immedesimazione. Certo, ciò che manca ai miserabili è anche un alleviarsi delle indigenze (quel “Ne vorrei ancora, signore” di Oliver Twist) ma dentro e oltre tale bisogno, prima e aldilà di qualsiasi riforma, è proprio la mancanza di quello “sguardo premuroso” ciò che strazia
più a fondo. Lo sa bene lo Smike di Nicho-las Nickelby, lo zoppo che tutti ritengono un idiota buono solo per le staffilate del sadico Squeers; lo afferma chiaramente il galeotto Magwitch, sorpreso dal Pip di Grandi spe-ranze ad aggirarsi braccato nelle fetide paludi. Non occorre molto, alle persone come lui, per raccontare la propria storia: “In prigione e fuori, in prigione e fuori, in prigione e fuori. Ecco fatto... Per quel che ricordo, non ci fu mai anima viva che guardasse il giovane Abel Magwitch, con quel poco che
aveva dentro di lui e su di lui, se non con paura o per cacciarlo via o per arrestarlo”. Ma l'arte di Dickens ci rammenta che tale ferita è possibile in qualsiasi contesto e condizione; si può essere sommamente ricchi e potenti, invidiati e temuti, eppure soffrire la stessa fondamentale mancanza, come testimonia la Signorina Havisham di
Grandi speranze che ha trasformato i propri beni favolosi in un museo delle cere, raggelato al giorno, all'ora e al momento preciso in cui il suo promesso sposo l'aveva abbandonata per profitto. Ed è ciò che, con un sorprendente colpo di scena, Dickens fa vivere al lettore nelle ultime ore di vita perfino del perfido Fagin: l'ebreo criminale che strisciava come una vipera e aveva rapito e acconsentito alla morte di Oliver, al momento del processo finale ci viene presentato inerme dinanzi a una foresta di occhi ostili, e sull'ombra dell'untuoso malvivente
"Fermati, tu che leggi, e medita per un
momento sulla lunga catena di bronzo e
d'oro, di spine o di fiori, che mai ti avrebbe
soggiogato se in un solo memorabile
giorno non si fosse formato e chiuso il
primo anello"
| Febbraio 2012pretesti11
si sovrappone quella di un altro Ebreo processato nella riprovazione generale, mille e ottocento anni prima.Ma quello sguardo, di cui Dickens esprime la mancanza in una così vasta gamma di sfumature e conseguenze, è anche l'unica forza, l'unico “incantesimo” capace di ribaltare qualsiasi situazione, qualsiasi percorso, gettando una luce diversa su ciò che pareva determinato senza speranza.Jill Kriegel la definì “la paradossale combinazione in Dickens di una critica insistente dell'ordine sociale ed una persistente fede nell'individuo”. Dickens era convinto che “così accade a tutti gli esseri umani. Cercate col pensiero di eliminare un dato giorno speciale della vostra vita e pensate a come diverso potrebbe esser stato il suo corso! Fermati, tu che leggi, e medita per un momento sulla lunga catena di bronzo e d'oro, di spine o di fiori, che mai ti avrebbe soggiogato se in un solo memorabile giorno non si fosse formato e chiuso il primo anello”. E le sue opere traboccano non solo di momenti in cui, in silenzio o con clamore, si forgiano le ferree catene dell'odio e della solitudine, ma anche di come basti un solo istante nel quale si faccia strada uno sguardo di vera, reale compassione e commozione, per
schiudere una possibilità del tutto diversa, un “salto” che non è appunto determinato dalla “quantità” dei vantaggi elargibili, ma dalla “qualità” della disposizione di chi decide di coinvolgere la sua vita con quella dell'altro. In Casa desolata la Signora Pardiggle, col suo sermoneggiare, non si sofferma davvero a guardare chi le sta intorno, ma l'amica che ha trascinato con sé si accosta in
silenzio alla donna battuta e si accorge che costei stringe al seno un bambino morto: “la compassione, la pura bontà con la quale si curvò piangendo per poi mettere la sua mano su quella della madre” hanno un solo effetto, per cui “la donna dapprima la fissò stupita, e poi scoppiò in lacrime”. Non si è potuto fare niente, eppure tutto è cambiato, e
persino il marito violento e bestemmiatore “si era alzato, continuando a fumare la pipa con aria di sfida, ma in silenzio”. Un simile sguardo si fa largo in qualsiasi situazione, ed è possibile non solo a eroi limpidi e cavallereschi come il giovane Nicklebly che ritorce su Squeers la frusta con cui questi flagellava Smike o la dignitosa e silenziosa bontà del fabbro Joe che in Grandi speranze è pronto a scomparire pur di non far sfigurare l'amico Pip nella sua nuova vita da gran signore, ma traluce anche nelle eccentriche
Dickens coi suoi romanzi e personaggi ci ha ricordato la divina dignità per cui “tutti gli uomini sono tragici, e tutti gli
uomini sono comici”
| Febbraio 2012pretesti12
bizzarrie della zia Betsy in David Copperfield e nella compassione con cui la prostituta Nell cerca di aiutare Oliver Twist, ma anche nell'affetto che il tenebroso Steerforth ha sempre conservato per David Copperfield, fin da quando lo proteggeva a scuola, e persino nel contorto affetto con cui Fagin ha accolto lo stesso Oliver, insegnandogli a rubare perché è l'unica arma con cui crede si possa sopravvivere in un mondo di belve feroci. È lo sguardo che Pip rivolge al forzato Magwitch mentre lo trascinano via in catene, senza sapere che quell'occhiata ne cambierà per sempre l'esistenza, ed è sempre così che il ragazzo alla fine guarderà anche alla infernale Signorina Havisham, cogliendone tutta la segreta miseria: “al vederla così con i capelli bianchi e il volto distrutto in ginocchio ai miei piedi, fui scosso da un brivido che mi penetrò fino alle ossa. Le scongiurai di alzarsi e le tesi le mani”. Tutto può restare quantitativamente immutato, eppure si è aperta la breccia di un mondo nuovo, e lo storpio Smike, alla domanda se abbia una casa da qualche parte, può ribattere a Nicholas Nickelby che “La mia casa sei tu.” È così che una pietra di selce, sgradevole e gelido come una pioggia invernale, come lo strozzino Scrooge, che scopre di aver già addosso le invisibili catene dell'inferno, può vederle spezzarsi per la pietà che il suo cuore rivolge in silenzio al figlio malato del suo dipendente, prima ancora di poter fare alcunché per migliorarne la sorte. Per il critico Anthony Esolen in Dickens sono proprio i bambini a essere spesso “gli araldi” di questo mondo diverso, sebbene sia “facile per il cinico spazzar via la resa dickensiana dei bambini come sentimentalismo. Ma i cinici hanno poco
da insegnarci sulla profondità di qualsiasi cosa, figuriamoci dei bambini”. La loro unica forza sta nella possibilità di risvegliare in chi li incontra il riconoscimento della propria medesima indigenza, esistenziale e non sociale. Ma questa commozione in Dickens è ben lontana dall'essere solo tragica, e ancor più distante dall'essere seriosa. Come ha notato quello che resta il suo critico migliore, G.K. Chesterton, Dickens coi suoi romanzi e personaggi ci ha ricordato la divina dignità per cui “tutti gli uomini sono tragici, e tutti gli uomini sono comici”. La stessa commossa attenzione, che può dare speranza alla circostanza più dolorosa, è all'origine della inesauribile simpatia
Il circolo Pickwick
| Febbraio 2012pretesti13
con cui Dickens si rivolge a qualsiasi tipo umano, come dinanzi a un evento unico e irripetibile nella sua immensità; ecco, per Chesterton, “la lezione conclusiva e più profonda di Dickens: è nella nostra vita di tutti i giorni che dobbiamo guardare in cerca di portenti e di prodigi”, giacché questo è in effetti “il vero vangelo di Dickens, le inesauribili opportunità offerte dalla libertà e dalla varietà dell'uomo. A paragone con una vita simile, tutta la cosa pubblica, tutta la fama, tutta la sapienza è per sua natura un affare rattrappito, freddo e piccolo”.Ecco perché, secondo Mario Praz, egli risulta secondo solo a Shakespeare nel tratteggiare una galleria di personaggi così vasti e indimenticabili (Micawber e la sua inesauribile riserva di allegria, Picwick e Sam Weller, la zia Betsy o l'attorucolo Crummles...), che il lettore lascia a libro concluso con l'affetto e la nostalgia che si riserva ad un amico, o a un parente conosciuto da
sempre, e caro persino nei suoi difetti e nei suoi tic; C.S. Lewis ha definito Dickens il cantore di quello che i Greci chiamavano storghé, l'affetto, parola che nell'originale antico è tutt'altro che sdolcinata, e possiede anzi una strana forza: solo l'affetto può sorridere senza sarcasmo, godendo, per così dire, dell'altro, proprio perché capace di vedere dentro di lui, cogliendo qualcosa del “cuore del suo mistero”, come notava l'Amleto di Shakespeare. Per Chesterton “c'è il grand'uomo che fa sentire tutti piccoli. Ma l'uomo davvero grande è colui che fa sentire grande ciascuno” e Dickens è stato grande proprio in tal senso: lo sguardo agognato dal prigioniero in Pickwick è anzitutto lo sguardo dell'autore stesso, che attraverso i suoi personaggi raggiunge e contagia i lettori, palesando ancora una volta la dignità dell'esistenza quotidiana, donandoci occhi rinnovati a cogliere la grandezza di chi ci sta attorno, e perfino di noi stessi. •
Edoardo Rialti insegna Letteratura presso l'Istituto teologico di Assisi. È collaboratore del quotidiano "Il Foglio". Studioso e traduttore di letteratura inglese, ha curato opere di C.S. Lewis, M.D. O' Brien, T. Howard, G.K. Chesterton per Rizzoli, Marietti, San Paolo. Ha pubblicato per Cantagalli L'uomo che ride, biografia letteraria di G.K. Chesterton che raccoglie il ciclo di articoli "Chestertoniana" comparsi settimanalmente su "Il Foglio". Ha curato nel 2011 il volume Una gioia antica e nuova. Scritti su Charles Dickens e la letteratura di G.K. Chesterton (Marietti).
Edoardo Rialti
| Febbraio 2012pretesti14
Pubblichiamo, in esclusiva per i lettori di PreTesti, un brano tratto dalle prime pagine del roman-zo di Marek Halter Il cabalista di Praga (Newton Compton) in libreria e in ebook in questi giorni.
i chiamo David Gans. Sono nato a Lippstadt, in Vestfalia, nell’anno 1541 del calendario cristiano, ovvero l’an no
5301 dalla creazione del mondo per opera dell’Onni potente, sempre sia lodato. Sono morto a Praga, settan tadue anni più tardi. Nel vecchio cimitero ebraico una lapide por
ta il mio nome. Sopra i sei bracci dello scudo di Davide è incisa un’oca. Due piccoli segni, scavati nella roccia, che parlano della mia vita. In tempi remoti, quello scudo, quella stella a sei bracci, era l’emblema degli ebrei di Praga prima ancora di divenire quello di un popolo intero. Oggi nessuno sa che io fui il primo a inciderla accanto al mio nome. Un oblio che ha una ragion d’essere. I sei bracci così perfetti – il triangolo sulla cima che si rispecchia in uno uguale alla base – avevano per me ancor più valore del ricordo di Salomone. In quei
Anticipazione
Praga 1600. Il racconto di un segreto millenario tra storia e leggenda
di Marek Halter
M
IL MIRACOLO DELLA PAROLA
| Febbraio 2012pretesti15
tratti rivelavo la passione e il pia cere della mia vita, la purezza infinita della geometria, capace di tracciare, nel cuore della scienza astronomica, il cammino del Padreterno.E l’oca, allo stesso modo, apparteneva solo a me. Non era certo l’uccello più grazioso o coraggioso del Creato, bisogna ammetterlo.Ciò nonostante, portiamo lo stesso nome: gans [Gans significa "oca" sia in tedesco che in yiddish]. A lungo questo fatto mi è bastato per convincermi che ero de stinato a spiccare il volo nel mondo, senza sperare tutta via di regnarvi come un’aquila.In effetti, le aquile le ho frequentate da vicino. Si chiamavano Galileo Galilei, Giordano Bruno, Giovanni Keplero, Tycho Brahe, Isaac Luria, e la più immensa, il re dei saggi e prodigio della mia generazione: il rabbino Judah Loew ben Bezalel, Gran Rabbino di Poznań e di Praga, colui che noi tutti chiamiamo MaHaRaL.La grandezza del loro spirito fu per me, loro discepolo appassionato, una costante lezione di umiltà e al tempo stesso una manifestazione straordinaria della realizzazio ne dell’opera dell’Onnipotente. Perché nessuna bellezza di spirito si compie senza accostarsi alla volontà del Pa dreterno.Devo ammetterlo: a volte, il volo di quei mae stri era così elevato, di un’intelligenza così ardente, da rendermi cieco. Mi sono fatto prendere dall’illusione di potermi elevare
alla loro altezza. Il tempo mi ha richiamato alle mie proporzioni. Ho appreso la misura di ciò che devo loro e dell’apertura delle mie ali. Sono diventato, per così dire, un veicola
tore dei loro pensieri. Un corriere della loro grandezza, alla quale tutta la mia vita fu ed è ancora dedicata.Forse per questo la brava gente di Praga ha fatto incidere sulla lapide del mio trapasso, sotto i due simboli della mia vita, queste parole altisonanti: "qui giace héasid morenu david gans, baal zemach david [Il giusto pio rabbino David Gans, autore dello Ze-mach David]".La frase suona bene. An
cora oggi riesce a solleticare la mia vanità. Quella della modestia è una dura scuola. Non basta una vita per apprenderla e non passa giorno senza che io mi ci dedichi...Ah! Sento che la tua pazienza e la tua intelligenza, let tore, iniziano a vacillare. Ti chiedi se colui che parla in queste pagine sia vivo o morto. Questo Gans che dice di essere polvere tra la polvere, oca nel vasto cortile del Padreterno, e che fa discorsi come un vivo mentre da quattrocento lunghi anni il suo corpo è tornato a essere argilla tra l’argilla!Eppure, è così. Il mio corpo non esiste più e la mia parola è viva.L’Onnipotente ci ha concesso il mondo come lo ve diamo. Noi crediamo di riconoscervi l’unica verità. Ci ha donato la materia. Noi conferiamo a essa il potere di un inizio e di
Disponibile su www.biblet.it
| Febbraio 2012pretesti16
una fine. Ciechi e presuntuosi, ecco cosa siamo. Ed è perché non si sono accontentati di quest’il lusione che i nostri maestri, il MaHaRaL, Tycho Brahe, il grande Keplero e pochi altri, hanno raggiunto quel fir mamento della Conoscenza che si nega ai comuni esseri umani.Per quel che riguarda me, David Gans, in verità Dio solo sa quando sparirò, poiché abito la Sua dimora, e la Sua dimora è quella del Verbo. Sin dal primo respiro dell’uomo, va così: la parola è la scintilla vitale dell’es sere.
Certo, donne, uomini, bambini o anziani, noi siamo parole di carne, movimenti di carne, vite ed emozioni di carne. E il tempo che le attraversa sfugge e, passando, le logora. Riduce la più sublime delle materie, la pelle di seta e l’incarnato di rosa, a un granello di polvere che il respiro di un bambino basta a disperdere.Ma il Verbo sì che è immortale. Non viene sopraffat to dalla furia, non si lascia ridurre in frantumi da alcun maglio. Nessun rogo, neanche tra quelli più insensati di quei secoli pieni di violenze, l’ha consumato. È giunto con lo spirito dell’uomo, non con la sua car
ne. E mai, mai sin dal primo giorno, ha taciuto. Ecco: niente si crea al di fuori del Verbo, tutto soccom be in sua presenza. Coloro che lo ignorano sono deboli; grandi coloro che sanno inchinarsi di fronte a tale po tere. Esseri umani, semplici esseri umani, noi crediamo che solo la carne generi la carne. Cecità, ignoranza! Il re spiro, i battiti di un cuore colmo di sangue sono anch’es si il frutto delle parole che il Padreterno ha messo nelle nostre bocche. Oh lettori, lo sento, molti di voi mostrano già il sorriso dell’incredulità! Permettetemi, prima di lanciarmi nella nostra grande storia comune, di narrarvi un piccolo epi sodio, e, prima di entrare nel pie
no della festa, accenna re insieme a voi amici un passo di danza. Il Talmud (Sanhedrin 65b) racconta che rabbi Chanina e rabbi Oshaya conducevano una vita ritirata e di studio. Durante le veglie dello shabbat, perdevano ogni cognizione della realtà studiando fino alla nausea i rotoli del Sefer Yetsirah, il Libro della Creazione. Ben presto, le ve glie dello shabbat non bastarono più alla loro passione. Dedicarono a essa i giorni comuni. Poi le notti comuni. Leggevano, imparavano, meditavano senza tregua. Can cellando dalla propria coscienza il peso delle loro carni e ossa, consideravano solo l’esilità della propria istruzio ne. Se dormivano o dedicavano un anche minimo tem po allo svago, dovevano moltiplicare gli sforzi in seguito. Non si
sin dal primo respiro dell’uomo, va così:
la parola è la scintilla vitale dell’es sere
| Febbraio 2012pretesti17
rendevano conto che l’esilità del loro corpo era ben più grave di quella del loro sapere. La fame iniziò a sfinirli. La pelle del viso e del collo era ridotta a una pergamena più ruvida delle pagine del Sefer Yetsirah. Le loro rughe divennero profonde come un sentiero trac ciato nel deserto. Ancora uno shabbat, e la vita li avreb be abbandonati. Ma né l’uno, né l’altro aveva la forza di andare in cerca di cibo. Rabbi Chanina dichiarò: «L’Onnipotente ha detto: “Ho messo le Mie parole nella tua bocca”. Le parole che esco no da labbra pure generano la Vita. Ho fame, devo am metterlo. Cosa rischiamo a creare un vitello con le nostre parole, che sono il Verbo dell’Eterno, se non scoprire quanta purezza vi sia nelle nostre labbra?». Rabbi Oshaya rispose: «La nostra stupidità e la nostra punizione stanno proprio nel fatto di non averci pensato prima!».Tutti e due, con una sola voce, pronunciarono le parole necessarie. Ed ecco: un vitello di tre anni, dal pelo folto e lo sguardo stupito, si erse di fronte a loro.Rabbi Oshaya e rabbi Chanina, anche se era ciò che speravano, restarono di stucco. Malgrado la loro grande debolezza, si alzarono e si avvicinarono al vitello, che sta va tranquillo. Gli toccarono il collo, i fianchi, la groppa. Tutto era reale e squisitamente commestibi
le. Il grande sapere della Cabala li avrebbe saziati. Si presero il tempo di un banchetto.Questa storia l’ho letta tanto tempo fa. Mi faceva sorri dere come ne sorridete voi, lettori. Ci credevo solo in parte.Pensavo che fosse una cosa impossibile nel
nostro mondo, più simile a ciò che i retori greci chiamavano parabola: parole con la forza di un’im magine. Parole che all’apparenza racchiudono solo l’om bra del proprio potere.Ignoravo che la volontà dell’Eterno mi avrebbe presto reso testimone di un prodigio ancor più stupefacente, una prova del potere talmente forte del Verbo che
ancor oggi il suo mistero m’incute timore. Un miracolo che ha dato una direzione e un senso a tutta la mia esistenza e che l’ha resa quello che è oggi: l’eternità della parola, che è anche la nostra memoria e la nostra vita futura.Un essere fatto di parole, ecco cos’è oramai David Gans.Alcuni uomini possono sentirsi orgogliosi della pro pria scoperta, della propria creazione. La mia unica fie rezza è la vastità della mia memoria. Io sono il testimone. Il messaggero e il mezzo del ricordo. Porto su di me la grandezza degli altri e a volte faccio in modo che non sprofondi nella vostra indifferenza...
Il MahaRaL era giunto al prodigio dei prodigi.
Aveva eretto la scala che unisce la Terra al Cielo.
Che sgomen to, che terrore!
| Febbraio 2012pretesti18
Marek Halter è nato a Varsavia nel 1936. La madre era una poetessa yiddish e il padre un tipografo. Nel 1940 fugge dal ghetto di Varsavia e trova rifugio in Ucraina, dove una pattuglia di soldati sovietici lo arresta e lo trasferisce a Mosca. Il suo romanzo Abraham, pubblicato in Francia nel 1983, ottiene il premio Livre Inter e resta per otto settimane nella lista dei bestseller stilata dal "New York Times". Nel 1994 realizza il film I giusti, che apre nel 1995 il Festival del Cinema di Berlino.Il cabalista di Praga è disponibile in eBook da Biblet.
Ogni giorno mi sembra abbastanza duro da essere l’ultimo, ma poi si leva l’alba successiva e le mie palpebre si schiudono, indicandomi che la mia missione non è anco ra compiuta.
golem !Ecco la parola e il fuoco della mia esistenza!Ecco il mistero che ha fatto di me il gilgul, la metamor fosi, questo ebreo errante senz’altra dimora che la paro la, che va e viene in mezzo a voi, invisibile in mezzo alla folla e tuttavia presente nella vostra memoria di secoli, qualunque siano le vostre credenze, le vostre paure e le vostre conoscenze.Ecco cosa è successo quel giorno di gennaio del 1600 nel cortile della yeshiva del mio mae stro il MaHaRaL, luce d’Israele, sia benedetto il suo nome. Quel giorno, sì, la potenza di Dio si è mostrata nel potere dell’uomo.Il MaHaRaL era giunto al prodigio dei prodigi. Aveva eretto la scala che unisce la Terra al Cielo. Che sgomen to, che terrore!Quale inaudito sapere!
E, in seguito, le schiere vollero seguirlo unicamente per accaparrarsi la sua conoscenza.Le schiere dell’innocenza e dell’orgoglio. Le legioni del Male, soprattutto.Invano, invano si sono consacrati al mistero del Go lem. Mai con successo. Nessuno, dopo il rabbi Loew, il mio Maestro, ha saputo risalire la scala di Giacobbe, quella che unisce la Terra al Cielo.Nessuno è stato in grado di penetrare così a fondo nel le parole, nelle lettere e nella saggezza della Cabala. Gli sforzi non sono mancati. Mentre sterminava gli ebrei, Hitler, in eterno sia maledetto il suo nome, ci pro vò. Che amara ironia! Per lo meno, temendo un simile prodigio, le truppe na ziste non osarono distruggere l’imponente statua del cre atore del Golem che veglia sul ghetto di Praga. E poco tempo dopo nemmeno i russi si arrischiarono a farlo. Ma ora basta. Ne sapete abbastanza perché possa rac contarvi la vera storia del Golem, io, David Gans, che fui testimone di questa stupefacente avventura.•
Marek Halter
© 2012 Newton Compton editori s.r.l.Traduzione dal francese di Federica Romano.
Disponibile su www.biblet.it
| Febbraio 2012pretesti
Città del Messico vivono gli angeli. È quello che penso quando guardo Ana Maria, che è venuta a prendermi all'aeroporto. Ana
Maria è una scrittrice messicana, l'ho conosciuta a Gijon, durante la Semana Negra, ed è subito nata fra noi quella curiosa solidarietà fra scrittori errabondi. Lei ora mi fa salire su un taxi e mi racconta della sua città, che ama appassionatamente, dello stesso amore che ritrovo nelle parole che spendo per la mia città, così tanto bistrattata dall'immaginario collettivo, Milano.Non che Città del Messico sia da meno.A chiunque dicessi qual era la meta del mio viaggio vedevo gli occhi sbarrarsi: non prendere i taxi per strada, mi dicevano, non bere nulla col ghiaccio, vai in giro con una mascherina, non prendere la metropolitana, non mangiare nulla dalle bancarelle improvvisate per strada, muoviti circospetto, attento alle rapine. La cosa più inverosimile che mi è stata detta sembra persino divertente tanto è assurda: Città del Messico è così inquinata che gli uccelli di passo cadono a terra tramortiti! Racconto alla spicciolata queste cose a Ana Maria che sorride, anche se vedo un velo di amarezza nei suoi occhi. Ovviamente io non credo a nulla di
tutto ciò. È semplicemente una questione di buon senso: chi di noi prenderebbe un taxi abusivo a Milano? Chi salirebbe su un mezzo pubblico con un fascio di cartamoneta che gli spunta dalla tasca della camicia? Chi si aggirerebbe di notte nei vicoli bui della città?Sono un animale metropolitano, le città non mi spaventano, basta entrare in risonanza col battito del cuore urbano e il resto viene da solo. In fondo viaggiare è anche questo: fare a pezzi i luoghi comuni che ci portiamo dentro, smantellare i pregiudizi. Dunque nei pochi giorni che ho vissuto a Città del Messico (perché sì, io vivo le città, non le visito e basta) ho cercato di fare tutto quello che mi era stato sconsigliato. Grazie anche
ad Ana Maria, che, depositati i bagagli in albergo, mi porta subito verso lo Zocalo, l'enorme piazza prospiciente la Cattedrale cittadina. Enorme anch'essa. Tutto è enorme a Città del Messico. Tutto ha una dimensione quasi favolistica: Avenida des Insurgentes, per capirci, la strada che taglia da sottinsù la città, è lunga 42 chilometri. È come partire da Milano e arrivare a Como e restare sem
pre nella stessa città. Neppure sanno quanti abitanti faccia, Città del Messico. C'è chi dice venti milioni, chi trenta. Metà della
20
A
sono un animale metropolitano, le città
non mi spaventano, basta entrare in risonanza col battito del cuore urbano e il resto viene da solo
| Febbraio 2012pretesti
popolazione italiana concentrata in un unico agglomerato urbano. Sono le persone, il numero sterminato di persone, ovunque, che mi colpisce di più: per strada, nei bar, in metropolitana, nei parchi. Sembrano scaturire dalla terra, piovere dal cielo. Sono dappertutto. Nel frattempo saltiamo sopra un pesero, uno dei trabiccoli che portano verso il centro (“non prendere i mezzi pubblici!”). Sono sul Paseo de la Reforma, attraversiamo la Zona Rosa ‒ un quartiere inizio Novecento, dal gusto europeo ‒ fermandoci
ogni tanto al richiamo di chi vuole salire. Non ci sono fermate stabilite, il mezzo non ha neppure un numero di riconoscimento. Si sale e si scende quando si vuole, o quando si può. Io butto gli occhi fuori dal finestrino e mi faccio puro sguardo. I palazzi crescono di altezza, diventano grattacieli. La città pulsa di vita, sembra un misto fra Berlino e Napoli. Ma è una semplificazione del mio cervello. Sto cercando, con i modelli urbani che conosco, quelli europei, un senso a questa città, ma comprendo che Città del Messico è qualcos'altro. È un po' come il figlio di due genitori, che per quanto ci si ossessioni a ritrovare il sorriso del padre
europeo o il taglio d'occhi della madre india, lui, di suo, il bambino cresciuto, la città enorme, è qualcos'altro di autonomo e indipendente.Ci fermiamo all'Alameda Central – lo storico parco del centro città, quello dipinto dal meraviglioso murales di Diego Rivera – a comprare un po' di chicharones da una bancarella abusiva (“non comprare nulla per strada!”), li mangio goloso, come un bimbo ad una fiera. Poi, più avanti è la volta di un tacos alla carne. Ana Maria ci aggiunge un po' di guacamole, una salsa piccante all'avocado. In prossimità della cattedrale è la volta del dolce: polpa di platano glassata. Bene, se la maledizione di Montezuma non mi colpisce ora, penso, non mi colpirà mai più. La voce del povero Montezuma, invece, la sento soffrire nelle pietre degli scavi archeologici a due passi dalla cattedrale. L'ultimo regnante atzeco accolse con tutti gli onori Cortés, mostrando la sua città con orgoglio, pochi anni dopo non ne rimase più nulla. O quasi. Ché la storia non si può cancellare mai per davvero. Soprattutto quando ha saputo dare luce a civiltà così complesse. È quello che penso andando con Jorge, il mio nuovo angelo custode, il giorno appresso, verso Teotihuacàn. Mi mostra una foto, Jorge: è gualcita, in bianco e nero, mostra una valle con dei curiosi montarozzi erbosi, alcuni bassi, altri più prominenti, alle loro spalle le vette dei vulcani innevati. Ecco com'era Teotihuacàn un secolo fa. Nessuno sapeva che là sotto, ricoperta dalla polvere della storia, dormivano la Piràmide de la Luna, la Piràmide del Sol, la Calle de los Muertos. Ci arriviamo in macchina e ad ogni rilievo vagamente conico penso che là sotto potrebbe assopirsi chissà quale al
21
| Febbraio 2012pretesti
tro gioiello millenario. Ma prima beviamo un tequila (“un”, non “una”. Il tequila è maschile in Messico) da Jesus. Niente sale nell'incavo fra pollice e indice, mi dicono, è roba da gringos. Poi Jesus mi mostra tutta la procedura: dopo aver riempito alcuni bicchierini, taglia in spicchi alcuni frutti di lime, e li spolvera di sale. Infine addenta lo spicchio salato e risparmiandone la buccia, a bocca piena, ingolla il tequila, d'un fiato. Io, di mio, avevo già assaggiato il liquore e mi sembrava abbastanza forte, ma non oso contraddirlo. Ripeto l'intera operazione, da buon scolaretto che vuole la lode dal suo maestro. Strappo la polpa dell'agrume salato e la faccio seguire dal bicchierino di tequila, che in bocca cambia radicalmente sapore. Il mio palato assiste a una reazione chimica misteriosa, mi sento come una
ampolla di un alchimista che mescola gli ingredienti alla ricerca di una pozione magica. Al terzo tequila Jorge mi rammenta le ragioni del mio viaggio. Lascio dispiaciuto Jesus per inerpicarmi verso la cima della Piràmide del Sol. E finalmente in cima, mentre attendo che il battito del cuore rallenti dopo la fatica della salita, sotto un sole caldo e asciutto, una brezza lieve che raffresca le membra, lì, mentre osservo la valle come sul precipizio di un burrone, nella mia perfetta solitudine, mi rendo conto di essere davvero felice.Nei giorni a seguire girerò spesso da solo la città, e spesso incontrerò persone che portano con sé una storia, un mondo da raccontare: come Rafael, artigiano dell'argento, che sotto i miei occhi ha inciso il volto di un guerriero atzeco con una precisione
22
| Febbraio 2012pretesti23
degna dei monili che ho ammirato al meraviglioso museo Antropologico, come la piccola india che mi ha venduto i due pon-chos che ho acquistato per le mie bambine in uno degli infiniti mercati abusivi della città, come Clara della Libreria Morgana, che vende solo libri in italiano (che cosa curiosa ritrovarsi dall'altra parte dell'oceano), come Leonardo, che nel parco di Chapultepec – enorme e bellissimo – mi ha raccontato del suo amore per l'Italia, cercando però poi di vendermi un trattamento per lucidare le scarpe (e inutile è stato mostrargli le scarpe da ginnastica ai piedi. “Possibile che un uomo non abbia delle scarpe di cuoio a casa?” sembrava pensare...). Ho girato per le undici linee metropolitane (“non prendere la metro!”), mangiando quello che capitava (“non entrare in locali sconosciuti”) e soprattutto ho camminato continuamente, per chilometri e chilometri – San Angel, Coyacàn, Tacubaya, Polanco – come un
folle, quasi cercassi di misurarla tutta, conscio che era come cercare di contenere in un bicchiere l'oceano. Ci vorrebbe un'intera esistenza per raccontarla tutta questa città. Ché ovunque fossi c'erano persone, facce, corpi, vita che brulicava.Ovunque fossi, ciò che vedevo, ciò che non vedo più da anni in Italia, era il popolo. Da noi, ormai, c'è solo “la gente”, qui, il popolo gremisce ancora le piazze, riempie i parchi, scambia, lavora, corre, sosta, ride, canta, soffre; si distende nelle strade della città, se ne impossessa, la ammanta come fosse un unico drappo multicolore cucito con pazienza dalle sapienti mani artigiane delle donne di questo paese. Questo penso mentre sotto di me scorre la città che si perde a vista d'occhio. Ho visto il popolo, penso, mentre l'aereo mi riporta verso casa. Anche se mi sembra, con una punta di tristezza, che in realtà la stia lasciando, casa mia. •
Gianni Biondillo è nato a Milano, dove vive, nel 1966. Architetto, ha pubblicato saggi su Figini e Pollini, Giovanni Michelucci, Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi, Elio Vittorini. Fa parte della redazione di Nazione Indiana. Ha scritto numerosi romanzi tra cui, più recente, I materiali del killer, una nuova indagine della serie che ha per protagonista l'ispettore Ferraro e che è stato vincitore del premio Giorgio Scerbanenco 2011 come miglior romanzo noir italiano del Courmayeur Noir in Festival.
Gianni Biondillo
Ovunque fossi, ciò che vedevo, ciò che non vedo più da anni in Italia, era il popolo.
Da noi, ormai, c'è solo “la gente”
| Febbraio 2012pretesti24
Il mondo dell’ebook
di Roberto Dessì
QUATTRO PASSINEL FENOMENODEL SOCIAL READINGI libri, da sempre fulcro di conversazioni e scambi d’idee, amplificano il loro raggio d’azione grazie ai social network. Da Twitter a Pottermore, ecco i circoli letterari nell’era del web 2.0.
| Febbraio 2012pretesti25
osa c’è di più sociale di un libro? Quante amicizie, amori, discussioni e idee sono nate attorno a una storia ben scritta? Quan
ti volumi abbiamo visto passare di mano, sottolineati o annotati qua e là su margini fino ad allora immacolati? E ora i terribili eBook vorrebbero portarci via questa magia, ingabbiandola in fredde sequenze binarie? Non sia mai. Il libro si evolve, ma la sua anima è immortale. Parafrasando Shakespeare, cambia la materia di cui sono fatti, ma non i sogni che contengono, divenuti liquidi e condivisibili in tempo reale grazie ai social network, declinati nel so-cial reading. Tredici semplici lettere che al loro interno nascondono un intero universo, gravitante attorno ai libri e alla Rete, popolato di avatar virtuali dietro i quali si celano lettori, scrittori, case editrici e addetti ai lavori, che trovano in Rete un fertile terreno di discussione. Nell’era Avanti Web 2.0, per entrare in contatto con un autore o si assisteva alla presentazione del suo ultimo romanzo ‒ cercando di agganciarlo nella pausa aperitivo ‒ o gli si scriveva un’email, attendendo speranzosi una risposta. Oggi è sufficiente fare un giro tra i social network, ed ecco spuntare come funghi scampoli della quotidianità di chi, fino a poco tempo prima, era un’irraggiungibile
icona letteraria. Twitter è l’emblema dell’anima socialletteraria della Rete. Il servizio di microblogging, ormai celebre anche nel nostro Paese, offre a tante penne più o meno celebri un rifugio e un podio da cui arringare i propri follower, a patto di rimanere entro il limite dei 140 caratteri. Tra i più social Paulo Coelho, che dispensa benedizioni virtuali e pillole dei suoi celebri aforismi, Patricia Cornwell, che cinguetta per sé e per il proprio alter ego letterario Kay Scarpetta, e William Gibson, papà del cyberpunk e non a caso appassionato di in
novazioni tecnologiche. Rimanendo nei patri confini, ecco tra i tanti Alessandro Baricco (che posta solo in spagnolo) , Michela Murgia (che a volte lo fa anche in sardo),
Twitter offre a tante penne più o meno
celebri un rifugio e un podio da cui arringare i
propri follower, a patto di rimanere entro il limite di
140 caratteri
C
| Febbraio 2012pretesti26
v
Roberto Saviano e Beppe Severgnini, attivissimi twittatori. La cosa fantastica dei social network è che sanno essere democratici, dando a tutti le stesse chance di successo. Chi è celebre offline non ha difficoltà a farsi degli amici online, ma anche quando si è semisconosciuti, con un po’ di tattica e pazienza si può mettere in vetrina e vender bene il proprio brand. John Locke e Aman-da Hocking, entrambi nel club dei “milionari” dell’eBook, hanno costruito le loro fortune usando i social network come ufficio stampa e marketing. Tralasciando gli aspetti voyeuristici del Web, il social reading è tale quando crea un rapporto paritario e orizzontale tra lettori. Condivisione è la parola chiave, che si tratti di una generica recensione sul libro appena letto, o si vada nel dettaglio annotando e integrando note a margine sull’eBook. Senza tirare in ballo l’osannato duo FacebookTwitter, l’universo sociale dei libri ‒ digitali e non ‒ comincia da Anobii, capostipite dei book social network. Qui si può dar sfogo alle proprie frustrate aspirazioni di critici letterari, rendendo partecipi gli altri iscritti del proprio entusiasmo per la lettura appena conclusa, o spulciare le opinioni dei propri contatti e trovare così ispirazione per il prossimo titolo da acquistare. Parlando di scaffali non si può non citare GoodReads, che emula – in salsa sociale – il meccanismo
di suggerimento dei libri usato da Amazon. Qui però basta votare venti libri per far sì che il sistema intuisca i più adatti al nostro gusto, e ce li segnali. Se poi oltre ad un libro volete cercare anche una dolce metà con cui leggerlo accoccolati sotto le coperte, potete rivolgervi a Alikewise. A metà tra il social network e l’agenzia matrimoniale, il sito offre un singolare modo per conoscere l’anima gemella: l’affinità di preferenze letterarie. Si aggiungono sul profilo i titoli letti, qualche informazione personale, una bella foto e… si attende che il sistema selezioni per noi dei potenziali partner con i quali, se non altro, non si litigherà sui libri da acquistare.Per la categoria degli impazienti, che non sanno resistere alla foga del commento e leggono l’eBook annotandolo immediatamente con le proprie impressioni, ecco un social network che parla italiano, con spiccato accento sabaudo: su Bookliners ogni appunto si trasforma in una discussione, ogni sottolineatura in un momento di confronto, aggregando gli utenti non più sul libro ma sulla singola frase, rendendo la narrazione teoricamente infinita. Gli spagnoli di 24 Symbols strizzano invece l’occhio ai bulimici della lettura, e offrono una piattaforma dalla quale leggere e commentare a sazietà. Un’integrazione tra recensio
Condivisione è la parola chiave, che si tratti di una generica recensione sul libro appena letto, o si vada nel dettaglio annotando e integrando note a margine sugli ebook
| Febbraio 2012pretesti27
v
ne e commento in tempo reale è quella di BookGlutton, che ambisce a raccogliere l’eredità dei circoli letterari al grido di “books are conversation”, slogan di cluetrainiana memoria: annotazioni e commenti avvengono all’interno di cerchie di contatti talvolta aperte a tutti, in altre più selettive. Rasenta la genialità (o la follia?) uno degli ultimi arrivati: Small Demons. Così come del maiale non si butta via nulla, anche il libro può essere “tagliato” e catalogato per gruppi musicali, celebrità, prodotti e brand citati nella narrazione, collegati e incrociati con altre letture per creare e tracciare sorprendenti percorsi tematici.
Fin qui i social network sui libri. Che dire invece dei libri che diventano social network? Esiste un solo caso, ma merita una categorizzazione a sé: Pottermore è il rifugio virtuale di migliaia di aspiranti maghette e maghetti fan di Harry Potter e offre, oltre alla possibilità di leggere in esclusiva gli eBook della fortunata creatura di J.K. Rowling, un’immersiva esperienza di role play tra i corridoi della Scuola di Hogwarts. Non temano, comunque, i nostalgici del profumo di carta, né gli apocalittici che predicano un futuro privo di relazioni sociali vis à vis. Il passo da virtuale e reale è breve, tanto quanto quello da libro a eBook. •
J.K. Rowling
| Febbraio 2012pretesti28
v
ew York 1841. La nave in arrivo da Londra fu assalita da una folla che chiedeva: “Ma Nell è ancora viva?”. Il più impazien
te andò incontro alla nave con una barchetta di fortuna. Poco importava se Nell Trent era una bambina di carta e inchiostro. I lettori americani non potevano aspettare un’ora di più per conoscere la sua sorte, nell’ultimo episodio de La bottega dell’antiquario, storia pubblicata a puntate sul giornale Master Humphrey's Clock dall’autoreeditore Charles Dickens. E racconta ancora la critica letteraria Paola Colaiacomo che Dickens ricevette molte lettere dai suoi lettori perché non facesse morire Nell e altrettante proteste dopo la lettura della sua triste sorte. Emerge in questo racconto la forza dirompente del feuilleton, forma letteraria
in voga nella Francia e nell’Inghilterra di fine Ottocento, nata da pure logiche commerciali ma rivelatasi un potente diffusore di cultura popolare e letteratura di massa.
Nel 1836 émilie de Girardin fondò La Presse, quotidiano low cost che ambiva a fidelizzare un ampio pubblico. Ripensando a due casi di successo, il feuilleton di LouisFrançois Bertin di fine Settecento ‒ un insieme di rubriche di critica teatrale allegato al Jounal des débats ‒ e la pubblicazione su un giornale di Honoré de Balzac di alcuni capitoli del suo libro per creare interesse e attesa, de Girardin decise di dedicare lo spazio che
altri giornali riservavano alla critica letteraria alla pubblicazione di romanzi a puntate. Nacque così il feuilleton (foglio, pagina di libro), conosciuto anche come romanzo d’appendice (perché pubblicato in ultima o
Feuilleton 2.0:il nuovo formato del libro è l'eBook in progressun viaggio letterario nel tempo, dai romanzi a puntate dell’Ottocento alle nuove forme narrative seriali in formato digitale, in compagnia di Charles Dickens
Il mondo dell’ebook
di Daniela De Pasquale
N
| Febbraio 2012pretesti29 v
v
penultima pagina), da non considerare solo come letteratura di serie B, dal momento che ha dato vita a grandi classici. Tre su tutti: I tre moschettieri (Alexandre Dumas), I misteri di Parigi (Eugène Sue) e Le avventure di Pinocchio (Carlo Collodi).L’idea fu rivoluzionaria e con effetti a lungo termine: nella seconda metà del XIX secolo la cultura era un lusso e non esistevano altri mezzi di informazione se non i giornali. La borghesia leggeva le storie a puntate per svagarsi, le fasce più povere e meno istruite avevano finalmente accesso facile ed economico alla lettura. In Italia, per lo storico Michele Giocondi fino alla Grande Guerra un bestseller era un libro che in cinque anni vendeva 10.000 copie, col fascismo si salì a 20.000. I romanzi d’appendice potevano superare quota 100.000, forte segnale dell’alfabetizzazione del Paese.Certamente l’iniezione di serialità crea dipendenza dalle storie, ma quali sono gli ingredienti magici del siero che trasformava tutti in lettori e che oggi vorremmo tanto riscoprire, visti i 723mila lettori italiani persi nel 2011, secondo l’ISTAT? Per Aldo Grasso sono quattro: l’oleografia, la presenza di stereotipi riconoscibili che permettono al lettore di identificarsi col personaggio per trarne gratificazione; la contrapposizione eroe positivo/eroe negativo e bene/male, in cui i valori borghesi sono perfettamente codificati e difesi con il riscatto finale e il trionfo dei primi sui secondi. Infine l’agnizione, il colpo di scena: una rivelazione improvvisa che determina una svolta decisiva nella vicenda.Caratteristiche superbamente e lucidamente mixate nella serialità televisiva americana, tanto che per lo stesso Grasso oggi l’e
ducazione sentimentale degli adolescenti non si forma più con la grande narrativa ottocentesca ma con i teen-drama. A supporto di questa tesi, alcuni critici hanno definito l’autore della serie The Sopranos David Chase come il Charles Dickens di oggi. Per Jonathan Franzen, le serie tv “stanno rimpiazzando il bisogno che veniva soddisfatto da un certo tipo di realismo del XIX secolo. Quando leggi Dickens ottieni gli stessi effetti narrativi”. In realtà, prima di soap-opera e fiction con mafiosi, dottori e
casalinghe, a ereditare le strategie narrative del feuilleton sono stati i fotoromanzi e i fumetti, i radiodrammi e il cinema. E il pensiero torna ancora a Dickens e alla sua incredibile modernità, perché, sostiene John Bowen ‒ tra i suoi massimi studiosi ‒ “è facile da adattare per la tv, il cinema e il teatro e usa tutte le strategie moderne di pubblicità per far conoscere i suoi libri. È multimediale”. E non aveva Facebook. Oggi, grazie alla tecnologia, i meccanismi della serialità si ripresentano in nuove forme letterarie: sul web e sui blog si moltiplicano i romanzi a puntate e alcune aziende stanno realizzando storie a episodi per
Oggi, grazie alla tecnologia, gli stilemi della narrazione seriale tipici del feuilleton dell’Ottocento si ripresentano in nuove forme letterarie sul web e altre piattaforme, coinvolgendo anche gli ebook
| Febbraio 2012pretesti30
vv
v
nuove piattaforme, sull’onda del successo dei keitai shosetsu, i romanzi giapponesi per cellulare scaricabili da iTunes una puntata al giorno. E, naturalmente, arriviamo agli eBook. Il processo di convergenza fonde
più media, compaiono nuovi device e le storie non sono più un semplice travaso da un formato all’altro, ma fluidi narrativi che si adattano ai nuovi contenitori. D’altra parte il leit motiv di queste settimane, dopo “If Book Then”, incontro internazionale dedicato al futuro del libro, è proprio la necessità di innovare per costruire nuovi modelli di ricavi e nuove logiche di funzionamento per l'editoria. Lo sa bene Alessandro Mari, che ha abbracciato il nuovo progetto di Feltrinelli aggiungendo un significativo tassello al concetto di social writer. Banduna è stato il primo titolo della collana Zoom interamente digitale: un eBook a puntate settimanali da € 0,99 con prima uscita gratuita. Lo sforzo creativo autoriale è alto, il racconto ha un ritmo sincopato e ogni capitolo deve raggiungere un cliffhanger, quel
la pausa narrativa con cui sul più bello si conclude l’episodio, lasciando il lettore con l’impaziente curiosità di scoprire cosa succederà nel successivo. Tra un’uscita e l’altra, c’è il tempo di dialogare con i lettori su
un sito creato ad hoc, per ricevere feedback immediati da inserire “nella centrifuga dell’immaginazione” e, come un attore di teatro che sente l’umore della sala, decidere l’evoluzione della narrazione. Banduna non è dunque una storia già scritta e distribuita un capitolo per volta, ma un eBook in progress. Ci sono poi altri esempi di offerta di contenuti digitali a rate. L’azienda BookRiff offre un servizio di DJ letterario: smembra gli eBook in capitoli vendibili singolarmente, e permette di creare nuovi eBookcompilation assemblando testi di diversi autori. DripRead è un’applicazione che suddivide eBook e altri file in piccole parti, inviandone una ogni giorno tramite email. Nell’attesa che altre aziende italiane si lancino in progetti di questo tipo, sul territorio nazionale arriva Chichili Agency, editore tedesco
banduna, l’eBook a puntate di Alessandro Mari nella collana Zoom di Feltrinelli, non è una storia già scritta e distribuita
un capitolo per volta, ma un ebook in progress, che si evolve con l’interazione dei lettori
| Febbraio 2012pretesti31
v
La serialità può essere considerata un valido terreno di esplorazione per una nuova concezione di letteratura prêt-à-porter al costo di un caffè
che vanta il maggior numero di vendita di eBook in Germania e già nelle classifiche di Amazon.it con l’horror seriale Chills. La sua mission è stare al passo con un lettore moderno hitech e sempre in movimento: chi legge in metropolitana probabilmente è un lettore forte che non vuole rinunciare alla lettura durante i suoi spostamenti. L’offerta è quindi un libro digitale di massimo trenta pagine, da leggere in quindici minuti e dal prezzo contenuto. Anche Banduna ha un limite di battute tra le 23 e le 26mila a puntata, l'equivalente di circa mezz'ora di lettura. L’idea di presentare contenuti, non necessariamente seriali, per tempo di lettura non è nuova, basti pensare allo store EmmaBooks o al sito giornalistico Longreads, focalizzato su forme di long journalism godibili proprio su tablet e eReader. Aggiungendo il fattore prezzo al tempo di lettura, il pensiero vola ai Kindle Single che Amazon ha lanciato oltre un anno fa: racconti low cost
di 1030mila caratteri, lunghezza “perfetta per buttar giù una singola idea geniale, ben sviluppata argomentata e illustrata”. La stessa collana Zoom di Feltrinelli contiene singoli racconti delle sue firme di punta, estratti da raccolte già pubblicate o inediti digitali. La tecnologia riduce le barriere d’accesso alla pubblicazione dei contenuti tanto che, per David Houle, oggi si pubblicano più libri in una settimana che in tutto il 1950. La serialità può essere allora considerata un valido terreno di esplorazione per una nuova concezione di letteratura prêtàporter al costo di un caffè: per l’editore 2.0 è un nuovo modello di business; per lo scrittore 2.0 è una nuova sfida creativa; per il lettore 2.0 è un nuovo prodotto economico che si inserisce nel flusso veloce delle sue giornate, e lo aiuta ad acquisire familiarità con nuovi dispositivi e nuovi modi di concepire l’oggettolibro.•
32 | Febbraio 2012pretesti
essuno è al sicuro, nessuno si salva, la nostra civiltà è fragilissima e può crollare in ogni momento”: chi negli ultimi mesi, leggendo le notizie economiche e politiche, non ha sussurrato tra sé frasi di questo genere? Chi, pensando al sistema della finanza globale che sembra strangolare i destini di nazioni e individui,
non lo ha immaginato come una sorta di mostro fantascientifico? La frase che abbiamo citato qui in apertura è di Carlo Fruttero, che la scrisse con negli occhi le immagini dell'attentato alle Twin Towers. Nel testo da cui è estrapolata, lo scrittore torinese meditava sulla capacità della science-fiction di essere “profetica” nel senso più alto, ossia di mettere la mente
di Francesco Baucia
“N
buona la primastorie di libri ed edizioni
32
(1959)
" LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE"
A CURA DI SERGIO SOLMI E CARLO FRUTTERO
33 | Febbraio 2012pretesti
dell'uomo in assonanza con il proprio tempo per coglierne quelle linee direttrici che conducono al domani. Una missione, inoltre, quasi filosofica, se come diceva Hegel la filosofia è "apprendere il proprio tempo con il pensiero". Su questa scia, si potrebbe tentare una definizione della fantascienza dicendo che essa è "apprendere il proprio tempo con la fantasia". I mondi possibili e i futuri immaginari che questo genere eleva a proprio orizzonte sono infatti solo un modo trasfigurato per parlare di noi, della nostra vita attuale e di ciò che le può accadere da un momento all'altro.Tra i molti meriti letterari ed editoriali che vanno ascritti a Carlo Fruttero, morto di recente a 85 anni nella sua casa di Castiglione della Pescaia, c'è senza dubbio quello di aver promosso instancabilmente la diffusione della science-fic-tion in Italia. Lo ha fatto in due modi: dirigendo dal 1961 al 1986 (per un lungo periodo anche in coppia con Franco Lucentini) la mitica collana mondadoriana Urania e prima ancora curando a quattro mani con Sergio Solmi l'antologia di fantascienza Le meraviglie del possibile, apparsa per Einaudi nel 1959. L'intento che soggiaceva a questa operazione editoriale era quello di porre sotto l'egida severa e autorevole dello Struzzo un genere di narrativa che veniva
considerato perlopiù come di puro intrattenimento, in un periodo in cui l'engagement della letteratura era visto come una priorità assoluta. A questa nobilitazione del genere contribuiva in modo decisivo la dotta introduzione al volume firmata da Solmi, in cui tra l'altro si indicavano i lontani ascendenti della fantascienza addirittura in Platone e Luciano di Samosata. Ma ai lettori sarebbe bastato addentrarsi nelle pagine dei racconti collezionati nel libro per convincersi,
anche senza articolate arringhe, dell'assoluta nobiltà di quei testi. Perché sfogliando le pagine si sarebbero imbattuti nel distillato dell'arte dei maestri del genere, partendo dal precursore H.G. Wells per arrivare agli "assi" Ray Bradbury, Philip K. Dick, Isaac Asimov e Robert Heinlein.L'idea programmatica del libro, indica Solmi nell'introduzione, è di mostrare attraverso la narrativa come dopo le numerose crisi filosofiche e religiose della modernità alla sola scienza è ancora possi
bile nel presente "riaprire le porte del Meraviglioso, che l'uomo aveva chiuse da un pezzo". Leggendo i racconti dell'antologia, però, ci si accorge che forse la vista di quel Meraviglioso nuovamente dischiuso è insostenibile, presaga com'è di scenari foschi i quali non fanno che ripetere in ingegnose
33
34
v
pretesti| Febbraio 2012
variazioni le oscurità della storia passata. Una vena rigogliosa di pessimismo serpeggia nelle pagine di molti racconti, insinuando più di un sospetto sulle "magnifiche sorti e progressive" che la scienza sembra spalancare all'umanità. Così, i naufraghi sul piovoso pianeta Venere del racconto Pioggia senza fine di Bradbury ci appaiono come soldati sull'orlo della follia nella giungla vietnamita; la riscoperta capacità dell'umanità futura di contare senza calcolatrici viene piegata a fini bellici in Nove volte sette di Asimov; l'utilizzo di robot umanoidi con obiettivi spionistici scardina l'affidamento nell'amicizia e negli affetti in Impostore di Philip K. Dick; e la volontà di serafici monaci tibetani di calcolare tutti i possibili nomi di Dio attraverso un supercomputer nasconde il desiderio di causare la fine del mondo, nel racconto I nove miliardi di nomi di Dio di Arthur C. Clarke. Ma il capolavoro assoluto della raccolta è forse il racconto più breve, il fulminante Sentinella di Fredric Brown, lungo una pagina scarsa. Vi leggiamo i pensieri di un soldato di trincea in una guerra intergalattica, lontano cinquantamila anni luce dalla sua patria e piegato alle dinamiche di un conflitto che non comprende. Si trova a compiere quello che è richiesto a ogni buon soldato, ossia uccidere una di quelle schifose creature nemiche contro cui combatte. Ma l'identità della sua vittima non è così
scontata come il lettore sarebbe portato a pensare fin dalle prime righe, e non la riveliamo qui per consentire a chi vorrà cimentarsi con Le meraviglie del possibile di godersi in pieno la sorpresa. Basti indicare però che, in consonanza con i suoi "colleghi", l'autore suggerisce che la Storia, e anche la fantaStoria, obbedisce alla solita eterna logica di prevaricazione e violenza, da qualunque prospettiva la si guardi.
In un intervento di qualche mese fa su "TuttoLibri" della Stampa, Tullio Avoledo (l'autore italiano che si è cimentato con più successo nel genere fantascientifico) ha scritto che leggere testi di science-fiction può alimentare la fiducia nel futuro. Di primo acchito sembrerebbe difficile affermarlo visto l'orizzonte oscuro che tracciano numerosi racconti dell'antologia di Solmi e Fruttero. Ma guardando
le cose da un altro versante, ci accorgiamo che in fondo ha perfettamente ragione. Se i maestriveggenti della fantascienza hanno molte volte espresso vaticini così cupi è per farci comprendere che il futuro è davvero nelle nostre mani, che la fantasia è tutt'uno con la libertà, e che possiamo inventare sul serio un avvenire differente da quello che gli istinti del genere umano sembrano invariabilmente suggerire. Ci ribadiscono che il "mondo migliore" è alla nostra portata, al pari dei molti altri possibili. E poi c'è chi dice che la fantascienza non è engagée…
34
| Febbraio 2012pretesti35
L'ITALIANO CANTERINOdi Lorenzo Coveri
he italiano è quello della canzone? Che rapporti (di dare e di avere) vi sono tra la lingua usata nei testi delle canzoni e quella
di tutti i giorni? È possibile tracciare una storia linguistica della canzone italiana? Sono interrogativi che si può porre tanto l’appassionato di musica leggera, magari in procinto di seguire, come ogni anno, di questa stagione, il Festival di Sanremo (nato nel 1951 e oggi diventato più un evento televisivo che una gara di canzoni), quanto il linguista, che ormai da qualche decennio ha sdoganato il fenomeno, se non altro per il suo rilievo sociale, culturale, economico nel paese del Bel canto.Prima di tutto occorre sgomberare il terreno da un equivoco: il testo della canzone non ha, salvo rarissimi casi, una propria autonomia; esiste solo in quanto è destinato ad essere messo in musica, è al servizio della struttura musicale (la cosiddetta mascheri-na), e non viceversa. E ciò dovrebbe essere sufficiente a smentire chi voglia considerare la canzone come poesia (la quale esaurisce in sé tutti i sensi, mentre il testo canzo
nettistico ha bisogno di quell’“aggiunta di senso” che sono le note), i cantautori come i “nuovi poeti” da antologizzare (ma è credibile che essi contribuiscano ad instillare un certo gusto della poesia nelle giovani generazioni). Se è vero che le parole delle canzoni sono “parole per musica”, è dunque conseguente che la lingua italiana (adatta alla melodia, meno adatta dell’inglese e del francese al ritmo) venga piegata alle esigenze musicali. Altrimenti, come si spiegherebbero, in fine di verso, tanti monosillabi (te, me, io), tante parole tronche, magari in verbi al futuro (vivrò, lavorerò, piangerò, in Io vivrò di Battisti e Mogol, ma anche in Francesco De Gregori, La donna cannone), tante zeppe (e sai, e poi), tante inversioni sintattiche (“e all’improvviso venivo / dal vento rapito”, Nel blu, dipinto di blu di Modugno e Migliacci)? Questo vale certamente per la canzone cosiddetta ancien régime del primo secolo unitario, con le sue radici nel melodramma e nella grande tradizione napoletana, fino alla svolta interpretativa rappresentata, nel 1958, dal teatrale “volo” di Domenico Modugno a Sanremo. Le cose cambiano a partire dagli anni Sessanta (e poi, più marcatamente, Settanta), con la nascita del fenomeno (tipicamente italiano, ma con modelli Oltralpe e Oltreoceano) dei cantautori, che per la prima volta riuniscono in sé le figure, prima distinte,
sulla punta della lingua Come parliamo, come scriviamo
Rubrica a curadell’Accademia della Crusca
C
| Febbraio 2012pretesti36
dell’autore del testo (il paroliere, l’artigiano delle parole), del musicista, dell’interprete. Anche il linguaggio, prima desueto e retorico (“Signorinella pallida / dolce dirimpettaia del quinto piano”, Signorinella, di Bovio e Valente, 1931) si abbassa decisamente di tono, diventa dimesso, più vicino all’italiano quotidiano (“Mi sono innamorato di te / perché / non avevo niente da
fare”, Mi sono innamorato di te, di Tenco), se non altro confrontandosi con l’evoluzione del linguaggio poetico e anche con una più ampia diffusione dell’italiano, cui proprio la canzone avrà, almeno in parte, contribuito. Dagli anni Ottanta in avanti la canzone italiana conosce una grande varietà di generi (accanto alla canzone d’autore, il rock, il pop, il rap), tra i quali ha particolare rilievo il recupero del dialetto (in funzione lirica, come nel grande esempio di Fabrizio De André; in funzione polemica e ideologica, come nelle posse). Tale compresenza di ge
neri, di forme e di modelli (e di tipo di pubblico) è la chiave della situazione attuale. Basta leggere (ma non senza, per le ragioni che si sono dette, ascoltarli in musica) i testi di Sanremo 2012 per averne conferma. Qui, accanto a moduli tipici della vecchia canzonetta (“Io non voglio amare / solo libertà / sono chiusa a chiave / e ci resterò / so di farmi male / male non mi fa”, Respirare,
interpretata da Gigi D’Alessio e Loredana Berté; “baci come spine, sulla bocca mia”, Sei tu, dei Matia Bazar; “Se un giorno tu / tornassi da me / dicendo che”, Per sempre, Nina Zilli; ma sparsi qua e là un po’ in tutti i testi), troviamo esempi ed echi dell’esperienza cantautorale (“Un pallone rubato / è dovuto passare / dalla noia di un prato all’inglese / a un asfalto che fu Garibaldi a donare, / dalle scarpe di Messi / alle scarpe ignoranti, / a una rabbia calciata di punta che lo / fa volare più in alto dei santi”, Un pallone, di Samuele Bersani; “Seguo l’imma
| Febbraio 2012pretesti37
v
ginazione / la strada dei passi passati da qui / sento una dolce evasione negli occhi / che mi hanno guardato così”, Al posto del mondo, Chiara Civello). Si nota una ricerca espressiva più sofisticata, meno consueta, tendente a liberarsi dalle pastoie della canzone “all’italiana” (si pensi anche alle decisive innovazioni metriche e sintattiche introdotte dalla “cantantessa” Carmen Consoli), come è evidente nella presenza di versi più lunghi e sintatticamente più complessi (“No questo no, non è l’inferno ma non / comprendo com’è possibile pensare che / sia più facile morire”, Non è l’inferno, Emma; “Avere l’impressione di restare sempre al punto di partenza”, Sono solo parole, Noemi), nella sostituzione di assonanze alle rime baciate (“appena io mi rendo conto / di avere perso la metà del tempo, / e quello che mi resta è di trovare un senso”, E tu lo chiami Dio, Eugenio Finardi), nelle figure retoriche (similitudine: “Come sassi in un torrente / come fanno i nostri sogni”, La tua bellezza, di Francesco Renga), nell’uso di un lessico più quotidiano (“c’è un camionista da accontentare”, Nanì, di Pierdavide Carone e Lucio Dalla; “per chi ci vuol fregare”, Ci vediamo a casa, di Dolcenera). Paradossalmente, è la presenza meno “sanremese” di tutte, quella del gruppo rock dei Marlene Kuntz, a tener conto giudiziosamente del contesto (il tipo di pubblico, il supporto di una grande orchestra) e a presentare la loro Canzone per un figlio (di ispirazione letteraria, come spesso succede nel repertorio della band) meno trasgressiva di quanto ci si sarebbe atteso (altrove il congiuntivo disperda rimava provocatoriamente con merda), affidando alla musica e soprattutto all’interpreta
zione la forza di un testo che rivela dimestichezza con la scrittura poetica, con litoti (“La felicità non è impossibile”), similitudini (“come un’ebbrezza effimera che può imbrogliare”), personificazioni (“la felicità che sorride”), e via dicendo. Parole per musica, appunto. E persino a Sanremo, a lungo considerato il tempio inespugnabile della conservazione, si può affacciare alla scena un nuovo italiano. •
| Febbraio 2012pretesti38
Anima del mondo
Paesaggi della letteratura
LA CITTà INVISIBILE
Berlino: immagini in dissolvenzadi Luca Bisin
on c’è più il battipalo a vapore ad Alexanderplatz, sbuffante e strillante mentre al ritmo cadenzato dei suoi colpi trafig
ge un suolo scavato, rimestato, squarciato, lacerato, nel frastuono dei cantieri per la metropolitana e nello stridere incessante dei tram. Non c’è più l’umanità variopinta che si aggira per le strade nei dintorni, chi sgobba, chi osserva, chi si affanna, chi sta fermo, chi beve, chi ha freddo, chi esce da un negozio, chi s'infila in una bettola, chi attraversa la piazza, chi si accalca su un marciapiede, ma allo sferzare indifferente del vento i loro volti sono tutti uguali e “cosa succede in loro? chi potrebbe dirlo?”, a scriverlo ne verrebbe un libro enorme ma poi
nessuno lo leggerebbe. Se non bastassero già i nomi mutati di certe vie o di certe insegne, ci penserebbe la torre della televisione, col suo profilo così sfacciatamente sovietico, tanto insolente da riuscire alla fine quasi bello, a raccontarci quanta storia è trascorsa all’Alex da quel 1929 in cui Alfred Döblin, in Berlin Alexanderplatz, ne sanciva la potenza simbolica di una città lanciata senza freni alla costruzione della propria identità di metropoli. I turisti ordinatamente in fila, mentre attendono di salire a gettare da 212 metri uno sguardo alla Berlino degli architetti, delle sperimentazioni, delle nuove tendenze, dei giovani con pochi soldi, della musica elettronica, dell'estro che reinventa gli spazi, non hanno certo più molto del
N
| Febbraio 2012pretesti39
lo smarrimento che, nel romanzo, provava Franz Biberkopf appena uscito dal carcere di Tegel, mentre col tram 41 s'inoltrava nelle viscere della città babelica e implacabile, e "dentro di lui qualcosa gridava con terrore: attenti, attenti, si comincia!". Eppure, non è che Berlino ci parli oggi con meno irruenza. In un certo senso, anzi, la città è divenuta quasi il prodotto vivente di quel montaggio frenetico che Döblin esercitava nelle pagine del suo romanzo, sgretolandone la for ma narrativa in un arruffio di segni, voci, balenii, schegge, mentre da dietro il più piccolo dettaglio (l'insegna di un negozio, lo scorcio di un caffè, il titolo di giornale…) poteva far capolino lo sguardo di un futuro troppo irrefrenabile e incerto per non riuscire minaccioso. A chi passeggi oggi per Berlino, quasi ogni batter d'occhio è come un gioco audace di stacchi, dissolvenze, incroci lungo una narrazione di cui la storia stessa si è incaricata di mescolare i tempi e gli spazi: le linee inflessibili del vecchio aeroporto di Tempelhof, nella cui severità ancora s'indovina l'allucinata monumentalità della capitale Germania vagheggiata da Hitler, accolgono senza imbarazzo l'atmosfera svagata e un po' fricchettona di un parco; e sulle facciate solenni degli edifici lungo la Karl-Marx-Allee, réclame architettonica del socialismo reale nella Berlino divisa, si aprono come nulla fosse le vetrine chiassose dei supermercati e dei fastfood. Ma tutto questo ci arriva nella figura già rasserenata di una storia che conosciamo, di una città che è proprio quella che ci hanno raccontato e che siamo venuti a vedere.
È forse vero allora, come ha osservato Wim Wenders, che a parlare oggi di Berlino sono soprattutto i suoi spazi vuoti, come gli scorci in cui la città dei simboli storici e delle arditezze architettoniche offre al nostro sguardo un varco d'incertezza, il pretesto di uno smarrimento che non avevamo previsto e che ci lascia più interdetti di quanto possa mai fare la vista, improvvisa ma non davvero inattesa, di una Trabant. Del resto, proprio Döblin affermava che "Berlino è
per la maggior parte invisibile", a ricordarci come quel balenare di segni, quel tramestare beffardo della storia sia ancora niente o quasi: Berlino trapela altrove, in un certo nostro sguardo più sottile e
involontario, e nel remoto turbamento che ci procura. Vista da una finestra all'angolo della Taubenstrasse, come in un racconto di E.T.A. Hoffman, la Berlino del 1822 poteva già produrre "una piccola vertigine che assomigliava al delirio non sgradevole di un sogno a venire", solo nell'ondeggiare della folla in una piazza durante un giorno di mercato. E la Berlino guglielmina dei romanzi di Theodor Fontane, appena sbozzata negli interni ordinati della case borghesi, nelle passeggiate lungo la Sprea, nei balconi affacciati sul Tiergarten, sapeva però già pungolare crucci inconfessati e smascherare inquietudini a lungo represse: una passeggiata per l'Unter den Linden poteva rivelare alla giovane Effi ciò che la signora von Briest ignorava, compiaciuta della bontà d'animo della propria figlia che viveva senza pretese, "fra fantasticherie e sogni": il fatto che, nondimeno, in certe questioni Effi aveva
È forse vero, come ha osservato Wim Wenders,
che a parlare oggi di berlino sono soprattutto i suoi
spazi vuoti
| Febbraio 2012pretesti40
delle pretese; e durante l'afflitta monotonia del matrimonio con il barone Instetten, è la prospettiva di un trasferimento a Berlino ad estorcerle l'involontaria ammissione di un'infelicità che il costume borghese voleva invece inconfessabile: "Dio, ti ringrazio!", sussurra Effi in tono di preghiera, abbracciata alle ginocchia del marito. Berlino, in fondo, ha sempre avuto la natura sfuggente e un po' scorbutica di una città che non accoglie, non sorride, non lancia seduzioni appariscenti, ma ci tocca in un modo più misterioso e importuno, quasi intimo e per questo inquietante. Come in certi romanzi berlinesi di Nabokov, dove la città può sorprendere con non più che una strada in una notte di pioggia, con "l'opaco luccichio dell'asfalto" sul quale le cose e le persone si rifrangono in un caleidoscopio di riflessi e di colori "sparendo tra le ombre e riemergendo nella luce obliqua riflessa dalle vetrine" (Re, donna, fante). O come nel fulminante racconto Dettagli di un tramonto, sempre di Nabokov, dove
l'estasi di un uomo che torna a casa dopo l'incontro con la sua promessa sposa, incerto sulle sue gambe per la troppa felicità e il troppo bere, sembra quasi risplendere nelle strade e negli edifici trasfigurati alla luce del crepuscolo, fino alla disillusione di un finale agghiacciante. È certo solo a Berlino che il giovane Walter
Benjamin, passeggiando per il Tiergarten, poteva imparare a "smarrirsi in una città come ci si smarrisce in una foresta"; o che Joseph Roth poteva riconoscere nella vista innocua di uno snodo ferroviario l'immagine più evocativa e
pregnante di una vita intera, "il cuore di un mondo". E a Berlino, ancora oggi, potrebbe succedere che un dettaglio inoffensivo, uno scorcio apparentemente scialbo o perfino brutto ci tocchi tanto nel profondo da risvegliare in noi quello sgomento che provava Franz Biberkopf di fronte a un futuro ancora vago, quella smania di "pretendere dalla vita qualcosa di più che il pane quotidiano". •
È certo solo a berlino che il giovane Walter benjamin,
passeggiando per il Tiergarten, poteva imparare
a "smarrirsi in una città come ci si smarrisce in una
foresta"
| Febbraio 2012pretesti41
di Francesco Baucia
A ROMAN PUNCH IN NEW YORKIl cocktail dei papi nell'Età dell'innocenza di Edith Wharton
Alta cucinaLeggere di gusto
Edith Wharton
| Febbraio 2012pretesti42
iò che stava o non stava 'bene' gio-cava un ruolo nella New York di Newland Archer altrettanto im-portante di quello degli inscrutabili
totemici terrori che avevano governato i destini dei suoi progenitori migliaia di anni fa.” L'età dell'innocenza, romanzo di Edith Wharton vincitore nel 1921 del premio Pulitzer, è uno struggente racconto d'amore e, come molte storie d'amore, è anche una storia spietata. Perlomeno nella misura in cui rappresenta lo scontro di un sentimento con un sistema di rigide regole che ne ostacola la completa maturazione. Dalla vicenda archetipica di Romeo e Giulietta a quella narrata nell'Età dell'innocenza il passo è breve, perché anche qui ci troviamo di fronte al consumarsi di una passione all'ombra di convenzioni sociali tanto radicate e articolate quanto assurde. E buona parte del libro è dedicata appunto al ritratto accurato dell'insieme di dettami in cui sono impigliati, come in una ragnatela, i personaggi principali della vicenda. Non è un caso infatti che Martin Scorsese, un cineasta che ha dedicato parte significativa del proprio lavoro al racconto delle ferree regole delle comunità criminali (Mean streets, Quei bravi ragazzi, The departed, solo per citarne alcuni), sia stato attratto da questo romanzo tanto da trarne nel 1993 una straordinaria versione cinematografica.Protagonista della vicenda è Newland Archer, giovane esponente dell'alta borghesia
newyorchese di fine Ottocento. All'inizio del libro lo vediamo in un palco dell'Academy of Music di New York, dove si sta rappresentando il Faust di Gounod. Più che al melodramma, Newland è attento a quanto succede in un palco dirimpetto al suo in cui si trova la giovane promessa sposa May Welland insieme al parentado. Nella balconata fa il suo ingresso una figura femminile inattesa, una più matura cugina della ragazza, la contessa Ellen Olenska. La donna sta divorziando da un nobiluomo europeo, e questo episodio ha suscitato molte chiacchiere nel
milieu da cui provengono sia Newland che May. Archer è un individuo il cui animo è conteso da empiti di ribellione e da prepotenti rigurgiti di conformismo. Inutile dire che l'incontro con l'affascinante Ellen, di cui finirà per innamorarsi perdutamente, metterà a repentaglio le sue già piuttosto labili certezze riguardo al proprio futuro. E il rischio cui va incontro dando
seguito a quella passione è proprio lo spauracchio più temibile per un animo timoroso come il suo: la messa al bando dall'abbraccio confortante ma crudele di quella società che non tollera sbandamenti dai propri modelli di riferimento. Il largo della prosa di Edith Wharton segue così lo svilupparsi di questo conflitto nell'animo del protagonista fino a quando, molti anni dopo il primo incontro, Newland e Ellen si ritroveranno, finalmente liberi dai
C“
I modi di imbandire le tavole, i piatti che
vi si consumano abitualmente, l'abilità dei servitori sono un insieme di segni che
rivela le caratteristiche profonde di chi dà i ricevimenti, oltre
l'immagine che essi vogliono offrire di sé
| Febbraio 2012pretesti43
rispettivi legami sociali e matrimoniali, e lontani dall'ambiente di provenienza. Le decisioni dettate nel passato dagli scrupoli avranno ancora un peso sulle loro scelte? A conclusione della vicenda, nelle ultimissime pagine del libro l'autrice saprà regalarci un esito sconsolato e commovente per questa avventura d'amore "impossibile". Ma ciò che avvince i lettori, forse più che la suspense per l'eventuale coronamento della passione, è l'affresco dettagliato che Edith Wharton restituisce di una società allo stesso tempo opulenta e severa, una versione raffinata della comunità dei padri fondatori d'America, potentemente ritratta da Nathaniel Hawthorne nella Lettera scarlatta. E un affresco così accurato non poteva mancare di soffermarsi sul palcoscenico in cui le regole di comportamento trovano spesso la loro rappresentazione più sontuosa, ossia le riunioni conviviali. Nell'Età dell'innocenza sono raccontati infatti numerosi pranzi, feste e rinfreschi: i modi di imbandire le tavole, i piatti che vi si consumano abitualmente, l'abilità dei servitori sono un insieme di segni che rivela le caratteristiche profonde di chi dà i ricevimenti, oltre l'immagine che essi vogliono offrire di sé. Ad esempio, quando Sillerton Jackson, un noto pettegolo dell'alta società, viene invitato a pranzo dalla signora Archer, madre del protagonista, sa che è solo perché questa desidera qualche notizia
indiscreta di prima mano. La non perfetta cura della cucina in casa Archer denota d'altronde un fatto noto e irrevocabile, quasi una legge, che Jackson così compendia nel suo pensiero: "New York, a memoria d’uomo, era sempre stata divisa nei due grandi gruppi fondamentali dei MingottManson e tutto il loro clan, ai quali importava il cibo, i vestiti e il denaro, e degli ArcherNewland
van der Luyden, tribù dedita ai viaggi, all’orticoltura e ai migliori romanzi e che disdegnava le forme di piacere più grossolane." Così chi è ospite degli Archer può aspettarsi ad accoglierlo conversazioni
"sui panorami alpini e sul Fauno di marmo", mentre chi va dai MingottManson può godere pasti in cui sono serviti "anatra moretta, zuppa di tartaruga e vini d'annata". Non è un caso dunque che proprio in uno dei ricercati pranzi organizzati dai Lovell Mingott (ramo del clan MansonMingott di cui fa parte la fidanzata di Newland) faccia capolino una pietanza dalla storia curiosa. Si tratta del Roman punch, una sorta di cocktaildessert che, invece di essere servito a fine pasto, si consumava tra le due portate principali, come si usa a volte fare con i sorbetti. Le sue origini affondano nientemeno che nelle cucine vaticane del Settecento, dove la bevanda era nata per rinfrescare il palato dei papi nei mesi estivi. Pare che la ricetta sia rimasta segreta fintanto che, con la campagna d'Italia di Napoleone, il figlio di un cuoco di Pio
| Febbraio 2012pretesti44
VI decise di unirsi al seguito di Bonaparte, diventando prima servitore di Giuseppina di Beauharnais, poi di altri aristocratici europei e diffondendo con i suoi viaggi la deliziosa bevanda. Chi voglia infrangere l'antica segretezza dei ricettari papali può prepararsi un bicchiere di Roman punch tenendo presenti questi ingredienti e proporzioni: 1/5 di succo d'arancia, 2/5 di limonata, 1/5 di champagne, 1/5 di rum, la crema ricavata
da un albume montato a neve con una spolverata di zucchero a velo e qualche goccia di succo di limone.Si serve mescolando delicatamente gli ingredienti base del punch in un bicchiere capiente con cubetti di ghiaccio. Poi si guarnisce la bevanda con uno strato della crema di albume, limone e zucchero. È consigliato inserire uno stirrer nel cocktail in modo che si possa mescolare il punch con la crema soffice prima di berlo.•
Ingredienti:1/5 di succo d'arancia2/5 di limonata1/5 di champagne1/5 di rum1 albume montato a neve1 cucchiaino di zucchero a velosucco di limone
ROMAN PUNCH
Il Roman punch, è una sorta di cocktail-dessert che, invece di essere servito a fine pasto, si consumava tra le due portate
principali, come si usa a volte fare con i sorbetti
| Febbraio 2012pretesti45
Roberto Saviano sbarca sul web e sbanca. Feltrinelli Zoom lancia un’iniziativa a 99 centesimi di euro che subito porta l’autore di Gomor-ra a confermarsi scrittore leader anche per il digitale. Eppure il testo è un racconto breve, 55mila caratteri, che riconduce buona parte degli italiani a un’infanzia mai dimenticata e vissuta come nostalgia. Il Super Santos contro il Super Tele, qualità a basso prezzo contro il solo basso prezzo. Il racconto è in realtà una ripubblicazione di un inedito uscito con il Corriere della Sera il 2 giugno del 2011, festa della Repubblica del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. L’infanzia degli italiani e l’infanzia dell’Italia, quindi, sulla carta. Ma la carta è stata scavalcata dal web e allora da questo successo in nuova forma dovremo ripartire, anche per chiederci se non sia finita la nostra infanzia di carta e ora vogliamo tutti ricordare, ma senza lasciare davanti a noi resti di questa memoria. Quante angherie abbiamo fatto e quante subito da ragazzini per una partita vietata a un compagno, per un vetro rotto, per non arrivare tardi a casa? Dario, Rino, Giovanni e Giuseppe sono le tentazioni che tutti abbiamo vissuto da piccoli, quando c’era da capire cosa fosse il bene e cosa il male e un pallone diventava occasione per un’azzuffata o per imparare delle regole. I quattro ragazzi di Super Santos imparano anche loro
delle regole, hanno i loro arbitri che intervengono quando qualcuno le infrange, ma sono regole di boss, di sottomissione e spavento. “Per i ragazzi essere pali significava poter vivere giocando a pallone. Per il clan giocare a pallone significava poter vivere mentre i ragazzi facevano i pali”, così sintetizza Saviano le due prospettive differenti con le quali venivano viste le regole del gioco (del calcio o della
camorra). E proprio nel momento in cui il gioco diventa occasione di formazione per lo stato di diritto, quello sulla carta, la cultura criminale innesta i propri rami. Che bello allora poter leggere Super Santos sul pc o sul tablet o sul telefonino, se possiamo in un istante cancellare questa memoria dell’infanzia perduta che si annida in ciascuno di noi. Per questo forse vogliamo leggere Super Santos in ebook: per poterlo cancellare subito dopo. È il rischio più grande della nostra infanzia digitale, quello di rimuovere il male compiuto, ma in fondo
anche il futuro della nostra coscienza collettiva di giocatori di pallone. “Guagliò, o Super Santos s’è bucato. Guagliò accattamm’ n’ato Super Santos”. La carta non muore mai (“carta canta”, si dice) i palloni invece si bucano, i files si perdono o si cancellano, ma quell’ora di curiosità che ci ha fatto ricordare chi siamo ci ha senz’altro lavati dalle impurità e rianimati di uno spirito nuovo: non ci si ricorda del male compiuto senza la nostalgia per l’innocenza perduta. Sta a noi scegliere ogni giorno se essere pali o capocannonieri.
La nostra coscienza digitale
SUPER SANTOSdi Roberto saviano
Recensioni
Disponibile su www.biblet.it
| Febbraio 2012pretesti46
BUk. FESTIVAL DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIAe gli altri eventi del mese
Appuntamenti
BUK. FESTIVAL DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIAProgrammato in origine per il 4 e il 5 febbraio, a causa del maltempo che ha colpito buona parte d'Italia la quinta edizione del Festival di Modena è stata ufficialmente posticipata al 3 e 4 marzo. La manifestazione, che si terrà presso il Foro Boario (via Bono da Nonantola 2), rimane uno dei fiori all'occhiello nell'agenda dei lettori più attenti alle proposte editoriali "di nicchia". Molto intenso il programma della kermesse: tra i numerosi eventi proposti (presentazioni, reading e conferenze) segnaliamo gli incontri con il giornalista Stefano Feltri del "Fatto Quotidiano" che parlerà del suo libro Il giorno in cui l'euro morì (Aliberti Editore) e con l'ex maresciallo dei Ris Luciano Garofano e la reporter Andrea Vogt, autori del volume Uomini che uccidono le donne (Rizzoli), che dialogheranno con Rossella Diaz sui casi più scottanti della cronaca italiana recente. All'interno della cornice del festival saranno inoltre annunciati i nomi dei vincitori del premio letterario "Due Vittorie" e del premio di giornalismo scolastico "Prima pagina". 3 e 4 marzo
LIBRI COME. FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURAL'Auditorium Parco della Musica di Roma ospita la terza edizione di "Libri come", un evento che si propone già dal suo titolo di portare i lettori dietro alle quinte dell'officina del libro, sia sul versante degli autori che su quello degli editori. Saranno presenti infatti scrittori big della letteratura nazionale (Gianrico Carofiglio, Enzo Bianchi) e internazionale (John Banville, Carlos Ruíz Zafón, Tzvetan Todorov), e non mancheranno spazi per workshop e laboratori sulla scrittura e le professioni dell'editoria. Molto si parlerà del destino del libro, coinvolgendo gli scenari digitali che già ne costituiscono un solido presente. Dall'8 all'11 marzo
INCONTRI LETTERARI DI CASA MELANDRINella sala D'Attorre di Casa Melandri a Ravenna (via Ponte Marino 2), sede del Centro relazioni culturali, è in svolgimento la trentottesima edizione di una fortunata serie di incontri con scrittori, poeti e artisti. A oggi l'iniziativa, nata nel 1975, si pregia di aver presentato nel corso degli anni più di 1250 opere letterarie. Tra gli appuntamenti di febbraio segnaliamo, venerdì 17, l'intervento di Francesco Fioretti, autore del recente bestseller targato Newton Compton Il libro segreto di Dante; la settimana successiva sarà invece ospite della rassegna il critico Flavio Caroli (personaggio noto anche al pubblico televisivo per la rubrica sulle vite degli artisti nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio) che presenterà il suo volume sulla storia dell'arte edito nel 2011 da Mondadori Electa. Fino al 24 febbraio
TUTTI MATTI PER I GATTI"Dio ha creato il gatto perché l'uomo provasse il piacere di accarezzare la tigre" ha scritto Charles Baudelaire, e il poeta francese non è l'unico letterato ad aver tratto ampia ispirazione dalla Musa felina. Da otto anni presso la Libreria Mursia di Milano (Via Galvani 24) si tiene la rassegna "Tutti matti per i gatti", dedicata tanto agli amanti dei libri quanto agli appassionati dei più seducenti amici dell'uomo. Il tema di questa edizione è la curiosa predilezione di molti dei potenti della Storia per i felini. Chi non ricorda, ad esempio, la celebre foto di sir Winston Churchill che si inchina per accarezzare il suo inseparabile gatto Jock? Lo spunto per discutere di questo argomento è fornito dal libro di Marina Alberghini Gatti di potere. I gatti consiglieri dei grandi della terra (Ugo Mursia Editore), che l'autrice presenterà all'interno della manifestazione venerdì 17 febbraio, insieme con lo storico Luca Gallesi. Contestualmente alla rassegna si potrà visitare, sempre nei locali della libreria Mursia, la mostra "Gatti famosi" con opere del pittore Franco Bruna. Fino al 17 febbraio
| Febbraio 2012pretesti47
Tweets
Bookbugs
@LACASEBooks
Ebook, il mercato decolla sulle
ali del Tablet e fa nascere
nuovi editori
@pandemiaUna spruzzatina sul
tuo ebook reader e risolvi
l’assenza del profumo della
carta > Smell of Books
@Pianeta_eBookJonathan #Franzen sugli – o meglio contro – gli #eBook: “danneggiano la società”
@la_stampacrescere sul digitale non signi-
fica in alcun modo intaccare la
qualità del giornale di carta.
@FinzioniEccola la domanda da un milione
di euro: ma dopo quanto escono
i libri in ebook? Nessuno ci sa
rispondere?@criboavidasto leggendo editoria digitale sul kindle. Navigo, condivido e non provo nostalgia per il profumo della carta:)
PreTesti • Occasioni di letteratura digitaleGennaio 2012 • Numero 2 • Anno II
Telecom Italia S.p.A.
Direttore responsabile:Roberto Murgia
Coordinamento editoriale:Francesco Baucia
Direzione creativa e progetto grafico:Fabio ZaninoAlberto Nicoletta
Redazione:Sergio BassaniLuca BisinFabio FumagalliPatrizia MartinoFrancesco Picconi
Progetto grafico ed editoriale:Hoplo s.r.l. • www.hoplo.comIn copertina: Gene Gnocchi
L’Editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge verso gli eventuali aventi diritto delle immagini pubblicate per le quali non è stato possibile reperire il credito.
Per informazioni [email protected]
Occasioni di letteratura digitale
pretesti
www.biblet.it