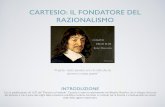N°9 - MAR - APR - osdislessialiguriaonlus.webnode.it fileNel corso della storia vi è stato un...
Transcript of N°9 - MAR - APR - osdislessialiguriaonlus.webnode.it fileNel corso della storia vi è stato un...
1
Notizie
in collaborazione con
N. 9 –marzo/ aprile 2011
Equipe
Multidisciplinare
Tecnico
Riabilitativa
2
_____________________________________________________
Carissimi lettori,
con la nostra 9° newsletter cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno partecipato al nostro
primo incontro presso la biblioteca Berio.
Buona lettura!
N.B. Le informazioni della nostra pubblicazione hanno uno scopo divulgativo. Per questo, pur
essendo state scritte da personale qualificato, non possono sostituire il parere del medico nelle
decisioni e nelle scelte terapeutiche.
3 - Orientarsi nel mondo: la percezione
7 - Il ruolo del pediatra nel riconoscimento dei DSA
9 - Ruolo della memoria di lavoro nei disturbi del linguaggio orale e scritto
11 - Area riservata ai non addetti al lavoro!
14 - Focus: la discalculia
15 - Abbiamo fatto… e faremo!
17 - Eventi formativi e culturali
Indice
____
___________________________________________________
_____________________________________________________
Orientarsi nel mondo: la percezione
___________________________ di Floriana Marino - psicologa____________________________
"La farfalla non conta gli anni ma gli istanti: per questo il suo breve tempo le basta"
Tagore, 1913
La percezione è quell’insieme di funzioni psicologiche che permettono all'organismo di acquisire
informazioni circa lo stato e i mutamenti del suo ambiente, grazie all’azione di organi specializzati
(vista, udito, tatto, olfatto, gusto).
Secondo un modello definito “realismo ingenuo”, vi è una corrispondenza puntuale tra le
caratteristiche della realtà fisica (oggettiva) e quelle della realtà percettiva (soggettiva). In realtà, il
mondo percettivo non consiste in una mera fotocopia dell'ambiente in cui viviamo, ma è il risultato
di una sequenza di mediazioni fisiche, fisiologiche e psicologiche: l'oggetto percepito è influenzato
dall'oggetto-stimolo, ma anche dal soggetto che percepisce (“realismo critico”). Si pensi, ad
esempio, agli ultrasuoni o agi ultravioletti, che sono oggetti fisici, ma non vengono percepiti;
oppure al fenomeno dell’illusione che può risultare dalla discrepanza tra oggetto fenomenico e
corrispondente oggetto fisico (l’illusione della luna è la più antica ad essere osservata e descritta: la
luna quando è all'orizzonte appare molto più grande di quando è allo zenit, pur essendo, invece,
delle medesime dimensioni). Questi sono esempi che sanciscono l'inadeguatezza del modello
ingenuo a favore di quello critico.
Uno dei principali problemi incontrati nello studio della percezione riguarda il modo in cui si
ricostruisce a livello fenomenico (soggettivo) l’unità dell’oggetto fisico: il problema del costituirsi
dell’oggetto. Tra i modelli che hanno fornito una spiegazione di questo fenomeno, quello più
accreditato è rappresentato dalla Scuola della Gestalt (Wertheimer, 1912). Secondo l’impostazione
di questa Scuola, la percezione è una ricostruzione interna ad ogni osservatore della realtà
ambientale, favorita dalle proprietà degli stimoli e dalle attività proprie dell’organismo.
4
_____________________________________________________
Vi è una tendenza comune e una capacità innata negli individui a porre ordine nel caos delle
sensazioni, ad organizzarle sulla base di alcune leggi (l’oggetto si costituirebbe secondo esse):
la legge dell’organizzazione figura-sfondo: diviene figura, cioè oggetto, la parte del campo
visivo più piccola, inclusa da margini, con margini convessi;
le leggi della segmentazione del campo visivo: a parità di altre condizioni, vengono
percepite come oggetti le parti rispettivamente più vicine (vicinanza), somiglianti
(somiglianza), delimitate da margini chiusi (chiusura), con minor numero di cambiamenti ed
interruzioni (continuità di direzione), più armonici, regolari, simmetrici (buona forma), di
cui abbiamo esperienza passata.
Il processo della percezione riguarda, inoltre, la costanza degli oggetti che ci circondano
(grandezza, forma, identità), il movimento, lo spazio e il tempo nel quale ci muoviamo; questo
processo ci permette un'organizzazione immediata e significativa delle informazioni sensoriali
indispensabile per orientarci nel mondo.
Nel corso della storia vi è stato un acceso dibattito fra Innatisti (Cartesio e Kant) e Empiristi
(Berkeley e Locke) circa lo sviluppo della percezione: secondo i primi l’uomo nasce già con questo
tipo di capacità percettiva; secondo gli Empiristi, invece, l’uomo impara attraverso l'esperienza del
mondo circostante la maniera di percepirlo. Oggi queste due posizioni sono state superate a favore
di un’integrazione fra le prospettive: il bambino è attivo nell'elaborazione delle informazioni e
dotato di competenze che hanno bisogno dell’interazione con l'ambiente per potersi interamente
dispiegare ed evolvere. Un esperimento che evidenza la funzione dell'apprendimento nella
percezione è la famosa illustrazione chiamata “la giovane e la suocera” di Boring (1930). Si tratta di
una figura ambigua, nelle illustrazioni ci si può vedere sia l’una che l’altra delle figure, ma il modo
in cui viene interpretata e percepita, è chiaramente influenzato dalla figura osservata in precedenza,
quindi dall’apprendimento precedente. Esperimenti che illustrano una certa quota di propensione
innata nei risultati percettivi sono quelli di Franz e Gibson (1960) sulla percezione del neonato, che
dimostra che il bambino è in grado fin dai primissimi mesi di discriminare l’uno dall'altro colori
diversi e diverse forme degli oggetti.
La percezione è stata studiata anche in relazione ai bisogni, alla motivazione, agli stati emotivi e
alla personalità del soggetto percepente; ponendosi il problema di come questi possano influenzare
l’atto percettivo.
5
_____________________________________________________
I ricercatori che si sono dedicati a queste indagini appartengono al filone di ricerca denominato New
Look, che utilizzava come metodologia quella di porre l’attività percettiva in vere e proprie
situazioni problematiche (situazioni svantaggiose o ambigue) pensando che in queste condizioni
l’attività percettiva riveli meglio l'influenza di fattori quali i bisogni, i valori, le difese, le emozioni
e gli atteggiamenti.Più precisamente cinque sono le ipotesi che sottendevano tali studi:
I bisogni organici tendono a determinare ciò che è percepito;
Le punizioni o ricompense hanno effetti su ciò che viene percepito (apprendimento);
Il valore individuale degli oggetti influisce sulla velocità di riconoscimento (es. le parole
aventi un riferimento positivo con gli atteggiamenti del soggetto vengono riconosciute in un
tempo significativamente più basso di quello richiesto dalle parole aventi un significato
negativo);
Il valore dell'oggetto influisce sulla grandezza percepita;
L’organizzazione percettiva è influenzata anche dalle differenze individuali e dalla
personalità del soggetto percepente.
Circa quest'ultimo punto, l'autore che maggiormente ha studiato il rapporto tra personalità e
percezione è Witkin (1950), i cui esperimenti lo hanno portato ad individuare due categorie di
persone: quelle caratterizzate da passività nel rapporto con l'ambiente, da scarsa fiducia e paura dei
propri impulsi accompagnata da insufficiente controllo e da mancanza di autostima; e persone
caratterizzate da attività ed autonomia in rapporto all'ambiente, che hanno un maggior controllo dei
propri impulsi e posseggono un buon livello di autostima. Secondo Witkin la prestazione di un
individuo in certi compiti percettivi fornisce un "modello" del suo modo di agire. Questa
prospettiva sottolinea, quindi, come la percezione non sia non solo una organizzazione autonoma e
regolata da leggi generali, ma anche una funzione che può rispondere ai dinamismi psichici più
sensibili ai diversi bisogni che regolano l'integrazione dell'individuo all'ambiente.
La motivazione e gli stati affettivi della persona, infatti, hanno l'effetto di sensibilizzare
selettivamente essa stessa verso gli oggetti che corrispondono alle sue tendenze e avversioni, gioie e
paure. È stato dimostrato che soggetti frustrati tendono ad avere un allungamento del tempo di
riconoscimento degli stimoli (Bonaiuto e Canestrari, studi iniziati alla fine degli anni ‘60); bambini
ed adulti con controllo affettivo insoddisfacente tendono a mantenere costanti le strutture percettive,
sino a percepire la realtà in modo non obiettivo (“rigidità percettiva”).
6
_____________________________________________________
Sul piano applicativo queste ricerche mostrano quanto sia importante per un bambino ricevere
un’adeguata stimolazione ambientale, sia nel contesto familiare sia in quello scolastico, per lo
sviluppo di un’attività percettiva tesa a determinare l’armonia psichica della personalità
complessiva nell’età evolutiva.
7
_____________________________________________________
Il ruolo del pediatra nel riconoscimento dei DSA
___________________________ di Zara Mehrnoosh - pedagogista____________________________
Nel riconoscimento della presenza di un disturbo specifico di apprendimento il pediatra può giocare
un ruolo fondamentale, in quanto figura professionale che custodisce la storia del bambino perché
lo vede crescere, formarsi e trasformarsi. Seguendolo regolarmente fin dalla sua più tenera età,
instaura un rapporto privilegiato con i genitori, arrivando quasi ad essere “di famiglia” e può
accorgersi quando “qualcosa” non segue il suo naturale sviluppo, non solo nel corpo, ma anche nel
linguaggio. Ciò che il pediatra deve innanzitutto ricercare nella storia anamnestica del bambino è la
presenza di disturbi o ritardi nella comparsa e acquisizione del linguaggio. Sappiamo, infatti, che
circa l’80% dei bambini che hanno presentato un disturbo di linguaggio, svilupperanno, in età
scolare, un disturbo di apprendimento. Il processo è intuibile facilmente: dalla difficoltà di
riconoscere e riprodurre i suoni che formano le parole, si passa alla difficoltà di riconoscere e
leggere le lettere (grafemi) che formano le parole scritte.
Altro aspetto è la familiarità (65%): ciò significa che un bambino che possiede un genitore o un
parente stretto con disturbi specifici di apprendimento ha una probabilità assai più alta di avere il
medesimo disturbo.
Altri aspetti possono essere rintracciati nel comportamento che il bambino ha verso la scuola: rifiuto
di andare a scuola, rifiuto verso i compiti a casa, ma anche sintomi somatici al mattino, comparsa di
diuresi notturna, stati di ansia.
Il pediatra e il medico di famiglia dovrebbero prendere sempre in considerazione la
possibilità che le difficoltà comportamentali o come difficoltà comportamentali o
come difficoltà di relazione con l’insegnante, siano un segnale della presenza di
disturbo di apprendimento e dovrebbe quindi suggerire alla famiglia una
valutazione specialistica, se non altro per escludere la natura neuropsicologica del
deficit prima di affrontare altre ipotesi.1
1 Giacomo Stella La dislessia, Il Mulino, Bologna, 2004, pag. 90
8
_____________________________________________________
Desidero concludere questo breve articolo sottolineando l’importanza di un riconoscimento precoce
perché è con la messa in atto di interventi tempestivi che si possono ottenere i migliori risultati
terapeutici e si può riconoscere le difficoltà e gli insuccessi scolastici come indipendenti dalla
volontà e impegno dello studente, evitando così di colpevolizzarlo come svogliato, pigro o poco
intelligente.
Bibliografia
Giacomo Stella La dislessia, Il Mulino, Bologna, 2004
9
_____________________________________________________
Ruolo della memoria di lavoro
nei disturbi del linguaggio orale e scritto
___________________________ di Anna Novero - logopedista____________________________
Interventi di Anna Chilosi, Daniela Brizzolara, Dipartimento di Neuroscienze dell’età evolutiva
IRCCS Stella Maria, Pisa, in occasione del V Corso di formazione permanente Neuroscienze
cognitive e dello sviluppo. Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani. Torino 10-12 novembre 2010.
Come sappiamo i disturbi di linguaggio correlano assai spesso con la Dislessia.
Negli ultimi vent’anni numerosissimi studi hanno confermato il dato tanto frequentemente
osservato da genitori e terapisti. I bambini che sviluppano il linguaggio in ritardo e/o con particolari
difficoltà, in molti casi (circa l’80%) avranno difficoltà ad acquisire il linguaggio scritto e le abilità
di lettura. Questo intervento analizza da vicino il perché di questa correlazione.
Come accennato in un precedente articolo la Memoria a Breve Termine (detta anche Working
Memory o Memoria di Lavoro) si compone di numerose sottocomponenti. In questa trattazione, le
autrici si concentrano in particolare sulla Memoria di Lavoro Fonologica (Phonological Working
Memory; acronimo PhWM).
La Memoria di Lavoro Fonologica è la capacità di mantenere e manipolare l’informazione
fonologica. È la capacità che ci permette di fare il “gioco del bastimento”, la fusione di sillabe e
suoni, e molti passatempi enigmistici, come lo scambio di iniziale, le rime etc.
Sappiamo che sia i bambini con DSL (Disturbo Specifico di Linguaggio)1 che quelli con Dislessia
presentano spessissimo deficit a livello di questa componente mnemonica (nel 90% circa dei casi).
1 In inglese LI (Language Impairment)
10
_____________________________________________________
La memoria di lavoro fonologica si sviluppa molto precocemente nei bambini e favorisce
l’apprendimento del lessico, più tardi è implicata nei processi di decifrazione della lettura e di
comprensione del testo.
Ci si accorge istintivamente di come tali abilità siano deficitarie nei bambini con disturbo del
linguaggio e dislessia.
Fra l’altro è significativo che tale deficit sia molto persistente anche in adolescenza.
I test per valutare la memoria di lavoro fonologica sono test di ripetizione di parole e non-parole.
Sarebbe molto importante che la memoria di lavoro fonologica fosse sempre valutata in sede di
diagnosi di DSL e di dislessia e che anche la terapia riabilitativa non trascurasse questa
componente.
11
_____________________________________________________
Area riservata ai non addetti al lavoro!
___________________________ di Anna Novero - logopedista ____________________________
Uno spazio, per spiegare, nella maniera più
chiara e precisa, come sono fatti e cosa
indagano i diversi test a cui possono essere
sottoposti i bambini.
In questo numero: la valutazione della scrittura
Esistono diversi protocolli per la valutazione delle capacità di scrittura, i principali sono:
Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica nella scuola
dell’obbligo (C. Cornoldi e P.E. Tressoldi)
Batteria per la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva DDE - 2 (G. Sartori, R.
Job, P.E. Tressoldi)
Valutazione della abilità di scrittura (P. Giovanardi Rossi, T. Malaguti).
Le prove sono divise per classe scolastica frequentata e sono composte da brani e frasi che vengono
dettati al bambino.
Successivamente il tecnico provvede alla correzione delle prove. Ogni test è completato da tabelle
con le quali si stabilisce, in base al punteggio di errore di ogni singolo bambino, se la prova rientra
nella norma, se vi sono difficoltà che meritano attenzione, o se si può ipotizzare un disturbo.
Tuttavia questo aspetto di “etichettatura” è solo l’inizio del percorso. La cosa più importante per il
bambino, la sua famiglia e il tecnico riabilitatore è l’analisi degli errori commessi.
Solo facendo questo tipo di analisi il test sarà stato davvero utile e permetterà alla famiglia e al
terapista di comprendere le reali difficoltà del bambino, e, quindi, di poterlo aiutare in modo
adeguato.
12
_____________________________________________________
Una prima grande distinzione fra le tipologie di errori di scrittura è quella fra errori fonologici ed
errori non fonologici.
Gli ERRORI FONOLOGICI sono quelli che riguardano la sostituzione, l’omissione, l’aggiunta,
l’inversione dei grafemi che compongono una parola.
Leggendo una parola, o una frase contenente un errore fonologico, saremo in grado di sentire
l’errore. Un tipico errore fonologico è la confusione fra grafemi che rappresentano suoni sordi e
sonori (come ad esempio: f/v, p/b, t/d); se un bambino scrive *varvalla e legge la parola, noi saremo
in grado di percepire l’errore. Un errore fonologico cambia la resa uditiva della parola errata.
Gli ERRORI NON FONOLOGICI, invece, sono quelli che non possono essere percepiti semplicemente
ascoltando la lettura della parola errata.
Generalmente questi errori riguardano le convenzioni grammaticali ed ortografiche tipiche di una
particolare lingua, oppure le separazioni/fusioni fra le parole.
Per fare qualche esempio pratico…
Scrivere “*Ai mangiato la pasta *ho la minestra?” è scorretto, mentre scrivere “Hai mangiato la
pasta o la minestra?” è corretto. Ma leggendo le due frasi appariranno entrambe corrette.
Allo stesso modo scrivendo *accua, *squola, o *accuisto si commettono sempre errori non
fonologici.
Analogamente i famigerati errori “di apostrofo” come *lerba invece di “l’erba” o di fusione come
*in sieme invece di “insieme” sono non fonologici. Una categoria particolare di errore non
fonologico riguarda le cosiddette “doppie” che tanto fanno pensare bambini e ragazzi (e genitori e
terapisti). Molti adulti si chiedono come mai i bambini non “sentano” la doppia ed insistono nel
dare enfasi alla loro pronuncia (“Non hai sentito? PALLLLLLLLLLA”), in realtà occorre prestare
molta attenzione all’aiuto che si dà. In realtà, infatti, il suono della “doppia” viene reso per iscritto
con due grafemi uguali, in realtà, quando pronunciamo una “doppia” non diciamo due suoni, ma un
suono allungato; nessuno di noi pronuncia “pal-la”, semplicemente prolunga il suono della /l/.
Proprio questa ambiguità genera confusione nei bambini, per non parlare dei molti dialetti e delle
molte lingue che praticamente ignorano l’uso delle doppie.
13
_____________________________________________________
Generalmente (ma non sempre) gli errori fonologici riguardano i primi anni di scuola, poi tendono a
risolversi e subentrano quelli non fonologici (più complessi perché non basta il feed-back uditivo
per risolverli) che tendono ad essere anche molto resistenti.
È molto importante che la valutazione non si limiti a dire che un bambino è disortografico, ma
indichi, con la maggior precisione possibile, che tipo di errori commette e quali sono questi errori.
Questo permetterà al tecnico terapista di cominciare subito un lavoro mirato e di non sfinire il
bambino e la famiglia con ulteriori sessioni di test.
14
_____________________________________________________
Focus
___________________________ di Zara Mehrnoosh - pedagogista ____________________________
Un introduzione alla discalculia
La discalculia è un disturbo specifico di apprendimento che riguarda la componente del calcolo.
La Consensus conference ha riconosciuto due profili distinti di discalculia:
Il primo risulta caratterizzato da debolezza nella cognizione numerica, ovvero nella seriazione,
quantificazione, comparazione, strategie di calcolo mentale, ecc., una sorta di cecità ai numeri:
«Come ci sono persone che nascono cieche ai colori ci sono anche individui che nascono con una
sorta di cecità per i numeri» (Butterworth). Il questo caso il bambino fatica a leggere e scrivere i
numeri (la maestra detta “137” e il bambino scrive 100-30-7), a riconoscere i simboli matematici, a
comprendere la struttura interna del numero composto da unità, decine, centinaia ecc.
Il secondo fa riferimento alle procedure esecutive e al calcolo, ovvero all’automatizzazione del
calcolo a mente, del codice di grandezza (che permette di fare previsioni sul risultato delle
operazioni, senza conoscerne il risultato: ad esempio nel caso di 375 + 829 si dovrebbe essere in
grado di “prevedere” che il risultato sarà un poco maggiore di 1000), all’automatizzazione dei fatti
numerici (ad esempio nel caso delle tabelline o degli algoritmi più semplici, come 3+3 o 6+4), ecc.
Esistono poi errori dovuti alle difficoltà spaziali, che possono implicare errori di incolonnamento, di
inversione nella scrittura di numeri e nella procedura esecutiva, ecc.
15
_____________________________________________________
Abbiamo fatto…e faremo!
___________________________ di OSD - Genova e Tigullio ____________________________
Laboratorio “Io imparo così”per i bambini della scuola primaria
Il laboratorio “Io imparo così”, rivolto ai bambini della scuola primaria, è nato come risposta alle
richieste delle famiglie di essere supportate nell’aiuto dello svolgimento dei compiti, momento
spesso vissuto con difficoltà e tensione.
Il laboratorio, svolto in piccolo gruppo, si articola attraverso un percorso di 10 incontri, per un
totale di 15 ore, ed è condotto dai volontari della nostra associazione. Oltre allo svolgimento dei
compiti è dato spazio a un momento di gioco didattico e a una merenda, offerta dall’associazione,
da consumare tutti insieme. Questi due momenti consentono ai bambini di vivere il laboratorio
anche come momento aggregativo. Il laboratorio Io imparo così non è un percorso riabilitativo
né terapeutico, pertanto tutte le attività proposte non si scontrano con i percorsi terapeutici (di
logopedia, neuropsicomotricità, pedagogia, ecc.) che il bambino potrebbe già svolgere.
È in partenza un nuovo ciclo del laboratorio con il seguente calendario (orario 15.15 - 16.45):
Febbraio: martedì 22
Marzo: martedì 8 martedì 15 martedì 22 martedì 29
Aprile: martedì 12 martedì 19
Maggio: martedì 10 martedì 17 martedì 24
Il laboratorio è finanziato da Organizzazione a Sostegno della Dislessia - Genova e Tigullio.
Si richiede all’atto di iscrizione un contributo di € 80, quale rimborso spese per la segreteria e il
materiale didattico utilizzato negli incontri.
Laboratorio “Io imparo così” per ragazzi della scuola media e superiore
Il laboratorio, rivolto a ragazzi della scuola media e primi anni della scuola superiore, nasce come
risposta al fatto che spesso i ragazzi non hanno un proprio metodo di studio che li aiuti a studiare
con efficacia. Durante il percorso verranno presentati alcuni strumenti didattici che possono
facilitare l’apprendimento, in modo che i ragazzi possano utilizzarli per sviluppare autonomamente
un personale metodo di studio, confrontandosi anche con altri coetanei.
16
_____________________________________________________
Il laboratorio, svolto in piccolo gruppo, si articola attraverso un percorso di dieci incontri della
durata di un ora ciascuno, ed è condotto dai soci fondatori e volontari della nostra associazione.
Il laboratorio Io imparo così non è un percorso riabilitativo né terapeutico, pertanto tutte le
attività proposte hanno un carattere didattico che non si scontra con i percorsi terapeutici (di
tutoring, neuropsicomotricità, pedagogia, ecc.) che il ragazzo potrebbe già svolgere.
È in partenza un nuovo ciclo del laboratorio con il seguente calendario (orario 14.00 - 15.00):
Febbraio: martedì 22
Marzo: martedì 1 martedì 8 martedì 15 martedì 22 martedì 29
Aprile: martedì 5 martedì 12 martedì 19
Maggio: martedì 3
Il laboratorio è finanziato da Organizzazione a Sostegno della Dislessia - Genova e Tigullio.
Si richiede all’atto di iscrizione un contributo di € 150, quale rimborso spese per la segreteria e il
materiale didattico utilizzato negli incontri.
I laboratori si svolgono presso il nostro sportello informativo attivo in piazza Colombo 1 int. 12
Per informazioni: cell. 340 8042550 [email protected]
www.osdgenovaetigullio.webnode.it
Inoltre ricordiamo che siamo attivi con uno sportello informativo, libero e gratuito, rivolto
a genitori, insegnanti, pediatri... per ricevere informazioni, materiale scientifico e didattico sui DSA.
Vi aspettiamo:
- a Genova il mercoledì ore 10 - 12 presso lo Studio di Pedagogia (piazza Colombo 1 int. 12
3° piano). Per informazioni cell. 3408042550 oppure [email protected]
- a Santa Margherita in via Favale 35, il lunedì ore 15 - 17. Per informazioni cell. 3930936648
oppure [email protected]
Presso gli sportelli è possibile consultare e prendere in prestito libri, articoli scientifici e schede
didattiche della nostra biblioteca tematica, sui disturbi del linguaggio e apprendimento e libri di
narrativa per bambini e ragazzi, scritti con linguaggio sintattico e un font dedicato a chi fatica nella
lettura. Inoltre molti libri di narrativa sono corredati di audio libro.
17
_____________________________________________________
Eventi culturali e formativi
___________________________ a cura dell’equipe multidisciplinare ____________________________
Date: febbraio - giugno 2010
Luogo: Biblioteca Berio
Via del Seminario 16 - Genova
Partecipazione: libera e
gratuita
Ciclo di incontri sui
Disturbi Specifici di Apprendimento
rivolto genitori, insegnanti, educatori, pediatri…
Per il secondo anno consecutivo torna alla Biblioteca Berio il Ciclo di incontri sui Disturbi
Specifici di Apprendimento organizzato da EMTR - Equipe Multidisciplinare Tecnico Riabilitativa,
in collaborazione con l’Organizzazione a Sostegno della Dislessia, allo scopo di approfondire e
discutere la complessa tematica dei disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disortografia,
disgrafia, discalculia).
Martedì 1 febbraio Introduzione ai disturbi specifici di apprendimento e di linguaggio.
Martedì 1 marzo La lettura: dislessia e disturbo della comprensione del testo scritto.
Martedì 5 aprile La scrittura: disortografia e disgrafia.
Martedì 3 maggio Discalculia e disturbi visuo spaziali.
Martedì 7 giugno Memoria e attenzione.
dalle ore 17.00 alle ore 19.00