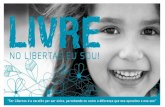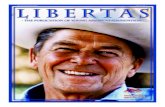libertas 6 Layout 1 - libertates.com · libertas trimestrale di cultura politica ed economica...
Transcript of libertas 6 Layout 1 - libertates.com · libertas trimestrale di cultura politica ed economica...

libertastrimestrale di cultura politica ed economicadiretto da Dario Antiseri
6 aprile2015
Il “Buono Scuola” per una “Buona Scuola”
StudiLe minoranze da rottamare: Come cambiano le élite politiche in ItaliaAntonio Campati
Focus Dario AntiseriIl “Buono Scuola” per una “Buona Scuola
Economia sociale di mercatoLe punture di spillo non rendono più competitivo il PaeseFabio G. Angelini
70 di Bretton Woods e la perenne tentazione del serpenteFlavio Felice
DibattitiLa Dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarie-tà, le casse di credito cooperativo e le banche popolariFrancesco Forte
RubricaLe grandi figure del cattolicesimo liberale:Luigi Taparelli d’AzeglioDario Antiseri
Segnalazioni bibliografiche
Libertas è una rivista di Libertates
cattolici per la libertà

Editoriale di Dario Antiseri
Studi- Le minoranze da rottamare ANTONIO CAMPATI - Fellow Centro Studi Tocqueville-Acton
Focus- Il “Buono Scuola” per una “Buona Scuola” – DARIO ANTISERI
Economia sociale di mercatoLe punture di spillo non rendono più competitivo il Paese FABIO G. ANGELINI - Direttore del Centro Studi Tocqueville-Acton, Professore di Costituzioni comparate alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma
70° di Bretton Woods e la perenne tentazione del serpente - FLAVIO FELICE Professore ordinario di DottrineEconomiche e Politiche alla Pontificia Università Lateranense e presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton (Roma-Milano)
Dibattiti“La Dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le casse di credito cooperative e le banche popo-lari” FRANCESCO FORTE Professore emerito Università di Roma, La Sapienza
RubricaLe grandi figure del cattolicesimo liberale: Luigi Taparelli d’Azeglio, DARIO ANTISERI
libertastrimestrale di cultura politica ed economica
cattolici per la libertà
DIRETTORE EDITORIALEDario AntiseriCOMITATO DI REDAZIONEFlavio Felice - coordinatore
Fabio G. AngeliniDario AntiseriPaolo ArmelliniPaolo AsolanAntonio CampatiRocco PezzimentiFrancesco Saverio ProfitiMaurizio SerioPierluigi Torre
COMITATO EDITORIALE
Dario Antiseri, Direttore della rivistaVladimir Bukovskij Presidente Generale dei Comitati per le LibertàDino Cofrancesco Presidente del Comitato Esecutivo Comitati per le LibertàFlavio Felice, Presidente del Centro Studi Tocqueville-ActonAngelo Gazzaniga Presidente del Comitato Esecutivo di LibertatesGiovanni Rabbia Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo
La rivista è gratuita e liberamente scaricabile in formato pdf.Gli articoli possono essere riprodotti anche in maniera parziale solo su autorizzazione dell’autore.Il sito libertates.com è pubblicato sotto Licenza Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5).Per informazioni: [email protected]
Editore: Libertates, 20154 Milano, via Piero della Francesca 38Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno VII Copyright © 2003
N. 6 - aprile 2015

Il tradimento dell’intellighenzia culturalee politica cattolica
1. Ai nostri giorni, quella del partito “ideologico”, cioè del partito custode dell’unica vera visione del mondoe dell’unica giusta società, è un’idea che, almeno in Occidente, troviamo sepolta sotto le macerie del Murodi Berlino. E il passaggio dal partito “ideologico” al partito “post-ideologico” è il passaggio dal partito con-cepito, abbracciato e difeso come fonte di Verità e come sorgente infallibile di soluzione per ogni problema,al partito pragmaticamente considerato come fonte di proposte per la soluzione di specifici problemi. Fu que-sta già la posizione di M. Y. Ostrogorski o di quella “tattica delle singole iniziative” che G. Salvemini teoriz-zò nel suo “problemismo” o “concretismo” contro le chiacchiere dei “barbassori inconcludenti” e dei “fab-bricatori del buio”. Tutto ciò sul presupposto che più idee in competizione nell’affrontare concreti e pressan-ti problemi non sono una miseria quanto piuttosto una ricchezza. Ed è ovvio che, in un orizzonte del genere,viene meno la portata presunta esplicativa ed insieme fortemente prescrittiva della tradizionale contrapposi-zione tra “destra” e “sinistra”.
2. “Fantasmi” vide già Luigi Sturzo nei concetti di “destra” e “sinistra”. E il 6 marzo del 1992, in una con-ferenza tenuta a Siviglia, Karl Popper dichiarava che «noi dovremmo tentare di occuparci di politica al difuori della polarizzazione sinistra-destra». “Sinistra”-“Destra”: due concetti ormai non solo inutili ma addi-rittura dannosi – sogni manichei unicamente capaci di proibire soluzioni adeguate, empiricamente controlla-bili, di problemi reali occultati da fantasie olistiche di un avvento imminente di paradisi in terra.
3. Ebbene, nell’attuale Fiera di soggetti politici che da ogni parte seguitano a sbucare, con a capo piccoli con-sunti gerarchi, quel che colpisce è la totale assenza di una proposta cattolica. Già scomparsi dalla competi-zione elettorale – sia nelle elezioni nazionali che in quelle per l’Europa –, con il cappello in mano per elemo-sinare qualche posizione in Parlamento o attorno a qualche greppia di sottogoverno, i cattolici in politica fun-gono solo da ascari accampati in tende delle più diverse formazioni. È stato Giuseppe De Rita, tempo addie-tro, a mettere il dito nella piaga: in politica «l’appartenenza cattolica è diventata un elemento del curriculumindividuale, non il riferimento a un’anima collettiva di proposta politica». E dimentichi di quanto nel dopo-guerra i cattolici seppero fare per la ricostruzione del nostro Paese, i nostri eroi si beano al grido: «Nonvogliamo morire democristiani”». E se è ben vero che il bavaglio spalmato di miele riesce a rendere tacitur-ni anche i più loquaci, di “clarinetti” tuttavia non si nota l’assenza. In ogni caso, non inganni l’apparenteululato di qualcuno: non ci sono veri lupi, abbaiano solo cani da pagliaio addestrati alla professione dellaredditizia arte del servilismo.
4. Todi 1 aveva suscitato la grande e motivata attesa di un nuovo partito politico di cattolici. Calpestandoidee, proposte ed articolati progetti elaborati alla luce della Dottrina sociale della Chiesa dalle diverseAssociazioni presenti nel Convento di Montesanto, maneggioni di Palazzo – con la benedizione di qualcheeminente ecclesiastico – a Todi 2 avevano già affossato ogni speranza e proibito al laicato cattolico più con-sapevole, meglio intenzionato e disponibile, di dare il proprio contributo alla vita politica italiana. Dalla dia-spora all’assenza: questa, dunque, la strada battuta dall’intellighenzia culturale-politica cattolica. Un bran-co di paludati disertori incapaci, per esempio: di intercettare non poche legittime ragioni di protesta contropalesi ingiustizie, privilegi vergognosi ed osannati e corruzione le quali hanno dato sangue al Movimento 5Stelle; di denunciare – tra un convegno e un meeting sul valore della persona – una legge, come quella elet-torale, tramite la quale quattro Caligola nominano servi ubbidienti a difesa dei propri interessi e non di quel-
3libertas

li dei cittadini; di venire incontro alla famiglia almeno con proposte relative alla costruzione, sempre piùurgente, di nidi e asili per l’infanzia; di progettare efficaci rimedi contro l’abbandono scolastico; di contra-stare riforme dell’Università, restando silenti, tanto per esemplificare, sull’applicazione meccanica, piuttostoche “oggettiva” cioè “funzionale”, del 3+2 (laurea breve – laurea magistrale), sulla abolizione delle Facoltàsostituite da Dipartimenti diventati il più delle volte luoghi di insanabili litigi, su di un concorso per idoneitàa professore associato e a professore ordinario effettuato sulla base di sgangherati criteri bibliometrici; diportare con coraggio davanti all’Europa il dramma dell’immigrazione e farlo diventare un problema euro-peo; di proporre misure contro quegli impedimenti (fisco asfissiante, burocrazia opprimente, criminalità orga-nizzata, giustizia civile alla paralisi, non erogazione del credito da parte delle banche) che sono causa di stra-gi di imprese con la conseguenza di una disoccupazione da far paura; di alzare la voce contro i tanti sprechie le disfunzioni in ambito sanitario; di avanzare idee e di impegnarsi per il miglioramento culturale e civicodi una TV pubblica e privata in gran parte involgarita, rissosa e scuola di servilismo. In questi ultimi anni èmorta una scuola libera, cioè non statale, ogni tre giorni – ebbene, questo stillicidio liberticida ha lasciato elascia nell’indifferenza più incomprensibile i politici cattolici imboscati nei vari partiti. Ed è davvero irragio-nevole il sospetto che la difesa (quando c’è o c’è stata) dei valori non negoziabili da parte di soggetti politi-ci estranei alla tradizione cattolica non sia puramente strumentale in vista, magari, di fare man bassa nei piùsvariati ambiti della vita sociale? Ma, poi, aveva torto Machiavelli a pensare che è meglio perdere con trup-pe fedeli piuttosto che vincere con bande di mercenari?
5. Non si tratta qui di erigere un tribunale sulle intenzioni dei cattolici impegnati in politica. Queste potran-no essere – e in non pochi casi sicuramente lo sono – anche le migliori, le più degne. Solo che, soprattutto inpolitica, le buone intenzioni (sempre ed ovunque necessarie) non sono sufficienti, a parte il fatto che non èraro che esse si risolvano in esiti non solo diversi ma addirittura opposti a quelli intesi. Buone intenzioni etestimonianza morale in politica non bastano. In politica contano i numeri. E dietro ai numeri ci deve essereuna organizzazione guidata da uomini moralmente credibili e tecnicamente preparati – giacché, come soste-nuto da John Stuart Mill, «non si possono fare grandi cose con piccoli uomini». La politica, insomma, la fannoi partiti. Don Luigi Sturzo un partito laico di ispirazione cristiana lo fece; e cosa sarebbe stata l’Italia deldopoguerra senza la D.C. di De Gasperi o la Germania senza la C.D.U. di Adenauer? I cittadini cattolici pos-sono legittimamente scegliere, come anche accadde nel dopoguerra e come è accaduto pure in seguito, eseguita ad accadere, di militare nelle più diverse formazioni politiche, ma perché non dovrebbe essere legitti-mo e auspicabile un partito di cattolici pronti a denunciare le violazioni dei diritti della persona – ovunquequesti vengano calpestati o negati – e ad elaborare proposte e ad impegnarsi per ristabilirli?
6. Il mondo cattolico è un mondo ricchissimo di risorse umane, di competenze, di giovani generosi e ben pre-parati – un mondo di tantissima gente onesta, laboriosa e solidale – basti pensare alle Associazioni di volon-tariato, alla Caritas, alle scuole e agli istituti di formazione, ai centri di ascolto e a quelli antiusura. Ebbene,da chi è rappresentato politicamente questo vasto mondo? Perché insistere nel proibire a questo mondo dientrare nell’agone politico e di contribuire alla soluzione delle gravi difficoltà in cui versa il nostro Paese?Dunque: restare inchiodati alla prospettiva funesta e senza futuro di una esangue intellighenzia o rimettersicon coraggio, progetti chiari e concreti e senso di responsabilità sulla strada dei “liberi e forti”? Chi sta tra-dendo il più vasto e sano mondo cattolico e, con esso, l’Italia?
Una versione ridotta di questo articolo è apparsa sul “Corriere della Sera” il 9 ottobre 2014
4libertas

Un fallimento annunciato? Poco più di vent’anni fa, nel febbraio del 1992, GiovanniSartori pubblicava un denso, ma agile libretto dal titoloemblematico: Seconda Repubblica? Si, ma bene. Il poli-tologo fiorentino offriva ai lettori un’analisi del quadropolitico italiano ordinata in tre parti: la prima si soffer-mava sulla descrizione dei diversi modelli istituzionali,analizzando in primo luogo il sistema elettorale e la suapossibile riforma, la seconda delineava la proposta del«presidenzialismo alternante», mentre la terza raccoglie-va alcuni editoriali pubblicati pochi mesi prima, fram-menti di un dibattito giornalistico accesosi a suo tempo
1.
Senza volerci addentrare nei particolari, anche una lettu-ra superficiale dei cambiamenti poli-tici ci indica come in una «SecondaRepubblica» siamo entrati (almenoper eccesso di intenzioni), ma piutto-sto «male» e quindi l’auspicio conte-nuto nel titolo del pamphlet di Sartoriè stato a tutti gli effetti disatteso. Èpur vero che un cambiamento nellalogica istituzionale è parzialmenteavvenuto, ma il periodico dibattitosulle riforme istituzionali (e non solo)dimostra che gran parte di ciò che siauspicava prima del biennio 1992-1994 non è statoancora realizzato
2.
Prendere atto di un fallimento, però, non è mai sempli-ce. Infatti, come osservano Lorenzo Ornaghi e VittorioEmanuele Parsi, per il nostro Paese, l’«elemento di con-tinuità fra le sue diverse stagioni sembra essere il ciclicoricominciare da zero», talmente radicato che si riparte dazero anche quando non ce n’è strettamente bisogno, per-sino quando «la finzione del nuovo inizio risulta addirit-tura controproducente rispetto alla futura, possibile soli-dità di quello che si sta intraprendendo»
3. Infatti, «il
crollo è il momento che, per eccellenza, conclude unastagione vecchia. Inversamente, di solito, la rivoluzioneè l’evento che apre una stagione nuova», ma mentre ilprimo comporta una riflessione sulle cause del fallimen-to, la seconda, trasportata dall’urgenza dell’edificare il
nuovo, non affronta gli interrogativi sul passato4. E inol-
tre, quando l’occhio dell’osservatore si allunga verso lepiù profonde trasformazioni che si sono susseguite nellastoria italiana, si trova spesso davanti a «false rivoluzio-ni»: rivoluzioni che «assolvono la funzione speciale difar sfuggire al bilancio rigoroso di ciò che si lascia allespalle»
5. Sempre secondo l’analisi di Ornaghi e Parsi,
una delle ultime rivoluzioni «fasulle» è stata proprioMani Pulite. Non solo perché le cronache quotidiane ciinformano che pratiche legate al malaffare persistono esi radicano ancora oggi (e all’interno dei diversi livelliistituzionali), ma anche grazie all’atteggiamento che leélites economico-sociali hanno avuto assecondando, in
larga parte, gli eventi che hanno travol-to una classe politica in attesa che se neinstallasse una nuova.Simultaneamente, la stessa società ita-liana ha estremizzato un carattere checiclicamente ripropone e, proprio per lasua ostinazione a presentarlo comealibi, capace di invalidarne la parte diverità che implica: la tendenza ad auto-assolversi, a riversare sempre e comun-que la responsabilità sul ceto politiconella sua interezza
6.
Dunque, per gran parte degli studiosi, il bilancio della«Seconda Repubblica» appare piuttosto negativo.Giovanni Belardelli, per esempio, non ha dubbi nel par-lare di una «catastrofe» della politica negli ultimi annidovuta al fatto che «sempre più l’etica e il diritto hannosottratto spazi alla politica, senza peraltro che il rispettodelle leggi e la moralità pubblica e privata ne abbianotratto particolare giovamento»
7. Per non parlare delle
«promesse non mantenute» dell’ingegneria elettorale:secondo Damiano Palano, a partire dall’inizio degli anniNovanta, questa tende a tramutarsi in una vera e propria«ossessione» poiché viene definita come lo strumentoche può finalmente trasformare l’Italia in un “Paese nor-male”
8. Nonostante sottolinei come l’ingegneria eletto-
rale sia uno strumento prezioso e cruciale nel dar formaalla dinamica politica, Palano ricorda come proprio negli
5libertas
Le minoranze da rottamareCome cambiano le élite politiche in Italia
di Antonio Campati
Anche una letturasuperficiale dei
cambiamenti politici ci indica come in una«Seconda Repubblica»
siamo entrati. Ma piuttosto male.

anni di avvio della cosiddetta «Seconda Repubblica» siassiste alla diffusione di una sua versione «mitizzata»,originariamente non prodotta dalla comunità politologi-ca, ma che presto riesce a influenzarla, tanto da spinger-la a uniformarsi al clima secondo il quale il passaggio aun modello di democrazia maggioritaria avrebbe prodot-to una modernizzazione del sistema politico italiano
9.
L’illusione secondo la quale il cambiamento del sistemaelettorale avrebbe determinato la fine dell’«anomalia»italiana ha alimentato un crescendo di aspettative ancheattorno all’immagine della «transizione», che, oggi,dovrebbe essere seriamente messa in discussione, anchesolo per il semplice motivo che gli elementi di effettivocambiamento si accompagnano, però, a tratti di sorpren-dente resistenza del passato
10.
Quali élites all’orizzonte?Indubbiamente, nella vicenda politica degli ultimidecenni, un ruolo non marginale lo ha assunto la «disce-sa in campo» di Silvio Berlusconi. Un interessante lavo-ro di Giovanni Orsina ha approfondito non tanto la figu-ra del magnate televisivo che si candida alle elezioni uti-
lizzando le notevoli risorse (economiche e non solo) asua disposizione, quanto il suo «discorso pubblico», ilmessaggio che ha trasmesso e, quindi, come è statoaccolto e perché ha avuto successo, nonostante nonabbia poi prodotto i risultati attesi
11. Fra i diversi passag-
gi approfonditi da Orsina, uno in particolare si soffermasulla principale fra le domande tradizionali della storiad’Italia che il Cavaliere ha adottato, ossia come riuscirea identificare una nuova élite politica virtuosa capace di
risolvere i problemi del paese12. Secondo Orsina, dun-
que, Berlusconi non ha prodotto affatto quella fratturarispetto alla nostra vicenda nazionale che sarebbe consi-stita nell’enfatizzare il ruolo delle istituzioni e la possi-bilità che le élite circolassero secondo la volontà deglielettori. Al contrario, il leader di Forza Italia «ha utiliz-zato un linguaggio perfettamente comprensibile a unpubblico che le élite hanno abituato da sempre a badarenon a come siano organizzate le istituzioni, ma a chi siaal potere – e ancor di più a chi debba essere escluso, aogni costo, dal potere»
13.
Da un’altra prospettiva, Carlo Galli ha rilevato come larelazione di Berlusconi con le élites sia effettivamentecomplessa. Infatti, se da un lato il Cavaliere non ha biso-gno delle élites perché «non ha bisogno né di progetti nédi mediazioni tra il potere e il popolo», dall’altro, quasiin maniera paradossale, la sua presenza sulla scena poli-tica ha determinato il loro «trionfo»
14. Ma, a dire il vero,
le élites sociali, attraverso Berlusconi, «hanno persegui-to un ennesimo tentativo di imboscarsi come élites, dinegarsi come portatrici di uno specifico ethos, di un visi-bile decoro, e di affermarsi soltanto come gruppi di pote-re economico-affaristico, adattandosi sia al nuovo stilepolitico sia alle nuove modalità di funzionamento delcapitale»; e, così, le stesse élite «giocano la carta delpopulismo, in rivolta davanti alle proprie responsabili-tà»
15. Ciò è stato reso più semplice dal fatto che secondo
Galli, la borghesia italiana si è «autoeclissata» consen-tendo a tali nuclei di potere di tornare al loro «particula-re» e quindi di non distinguersi più dal popolo, salvoalcune eccezioni, «se non quantitativamente, cioè per lostile di vita omologato ma molto più costoso». Infatti,«anziché vigilare sulle forme di cooptazione e di adde-stramento dei propri membri, allentano le deontologie,rilassano le pratiche di controllo, chiudono un occhio suinsufficienze e infrazioni (purché sia garantita la docili-tà dei nuovi entrati)»
16.
Le tinte abbastanza fosche con le quali viene dipinto ilquadro di azione delle élites nella stagione berlusconia-na sembrano assumere, però, colori più vivaci nel
6libertas
Le minoranze da rottamareCome cambiano le élite politiche in Italia

momento in cui l’esperienza governativa del Cavalierevolge al termine. Quando, con l’avvento al governo diMario Monti, secondo Galli, viene confermato lo sche-ma in base al quale «sull’orlo del baratro, davanti a unvincolo esterno minaccioso, si muovono le élites» che,in una situazione di emergenza, ritrovano senso diresponsabilità e capacità di individuare gli interessi per-manenti della nazione
17.
L’élite «tecnocratica» che arriva al governo alla fine del2011 in Italia ha avuto come mandato ufficiale, secondoGiuseppe De Rita e Antonio Galdo, quello di evitare ildefault finanziario e di gettare le basi per il futuro. Inrealtà, tali ‘compiti’ sono simili a quelli che venneroaffidati ad almeno altri due gruppi di élites (nell’imme-diato secondo dopoguerra e dopo il crollo della «PrimaRepubblica»), ma per quanto riguarda quella formatasiattorno al governo Monti, sempre per De Rita e Galdo,se la prima parte della missione può essere consideratacompiuta, la seconda «si è infranta di fronte a una seriedi resistenze e di errori che hanno fatto archiviare senzaparticolari rimpianti questa ennesima fase di supplenzatecnica»
18.
In effetti, dopo la parentesi del governo Letta, l’avventodell’esecutivo guidato da Matteo Renzi sembra averripristinato il ‘primato’ della politica. E così si è iniziatoa scrivere un nuovo capitolo sulle élites. In verità, comehanno sottolineato David Allegranti e Sofia Ventura,Renzi (come Berlusconi) sembra condividere una sortadi «disprezzo» per le élites e gli intellettuali, che rappre-senterebbero una parte di quel ceto influente (ma ossifi-cato) che ha «bloccato» l’Italia negli ultimi decenni
19. È
evidente che tale atteggiamento è il frutto di una piùampia strategia che tende a costruire un discorso pubbli-co basato sulla permanente contrapposizione fra chi pro-muove l’innovazione e chi, al contrario, si ostina a impe-dirla. Ma a prescindere da tale ‘schema’, è ugualmenteevidente che una effettiva circolazione delle élites politi-che (e economiche) è stata messa in atto. Ma un interrogativo dovrà essere sciolto nelle analisi enelle ricerche future: nella sostanza, è stata «rottamata»una élite per far spazio a un’altra élite, oppure è statosemplicemente rinnovato un «cerchio magico»? In altritermini, l’azione politica di Matteo Renzi riuscirà a inne-scare quel ricambio (non solo basato su dati generazio-nali) della classe dirigente del Paese con uomini e donnedotate di quelle qualità che possano consentire loro diessere realmente dirigenti, oppure comporterà semplice-mente la nomina nelle posizioni apicali di «fedeli» alnuovo corso in atto, in sostituzione dei «vecchi»?
1G. SARTORI, Seconda Repubblica? Sì, ma bene, Rizzoli, Milano 1992.
2Sul processo di trasformazione, seppur «in una direzione non prevista», verso la«presidenzializzazione del governo italiano» si veda, per esempio, F. MUSELLA, Ilpremier diviso. Italia tra presidenzialismo e parlamentarismo, EGEA, Milano2012.
3L. ORNAGHI, V.E. PARSI, Lo sguardo corto. Critica della classe dirigente italiana,Laterza, Roma-Bari 2001, p. 30.
4Ivi, p. 31.
5Ibidem.
6G. CRAINZ, Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale, Donzelli,Roma 2009, p. 195; per una ricostruzione più completa, pp. 183-210. Per un per-corso storico del periodo 1989-2011 si veda S. COLARIZI, M. GERVASONI, La tela diPenelope. Storia della Seconda Repubblica, Laterza, Roma-Bari 2012.
7G. BELARDELLI, La catastrofe della politica nell’Italia contemporanea. Per una sto-ria della seconda Repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 5.
8D. PALANO, Le promesse non mantenute dell’ingegneria elettorale in «Vita ePensiero», n. 6 (2012), pp. 109-116, in particolare p. 111.
9Ivi, p. 112.
10Cfr. D. PALANO, La «transizione» è finita? Forse non è mai cominciata in «Rivistadi Politica», n. 2 (2014), pp. 19-24, in particolare pp. 23-24. In questo articolo, ven-gono citati, fra gli altri, due lavori che, da prospettive differenti, analizzano gli ulti-mi anni della politica italiana: P. IGNAZI, Vent’anni dopo. La parabola del berlusco-nismo, Il Mulino, Bologna 2014 e M. ALMAGISTI, L. LANZALACO, L. VERZICHELLI
(a cura di), La transizione politica italiana. Da tangentopoli a oggi, Carocci, Roma2014.
11G. ORSINA, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Marsilio, Venezia 2013.
12Ivi, p. 159.
13Ivi, pp. 159-160.
14C. GALLI, I riluttanti. Le élites italiane di fronte alla responsabilità, Laterza,Roma-Bari 2012, pp. 106-107.
15Ivi, pp. 107-109.
16Ivi, pp. 110-111. In alcuni passaggi successivi, Galli sostiene che se si vuole esse-re «davvero radicali» e andare «oltre» il pur rilevante apporto di Berlusconi, nelloschema delle élites riluttanti è subentrata una inedita configurazione di potere chevedrebbe le élites travolte «dalla fine del pensiero (e della pratica) della forma poli-tica in generale, dall’autorità che plasma e dà un volto riconoscibile alla politica».
17Ivi, pp. 123.
18G. DE RITA, A. GALDO, Il popolo e gli dei. Così la Grande Crisi ha separato gliitaliani, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 53-55.
19D. ALLEGRANTI, S. VENTURA, Matteo e i suoi. Il leader e il suo entourage, in«Rivista di Politica», n. 2 (2014), pp. 113-128, in particolare p. 124.
7libertas
Le minoranze da rottamareCome cambiano le élite politiche in Italia

1. Messaggio cristiano e desacralizzazione del poterepolitico
Il 26 novembre del 2003, su «Il Giornale», l’allora car-dinale Ratzinger, intervistato da Antonio Socci, affrontaalcuni temi presenti nel libro Fede, verità, tolleranza(2003) e ritorna, tra l’altro, sulla questione del relativi-smo. Chiede Socci: «C’è una novità nel suo libro a pro-posito del relativismo. Lei sostiene che nella praticapolitica, il relativismo è benvenuto perché ci vaccina,diciamo, dalla tentazione utopica. È il giudizio che laChiesa ha sempre dato sulla politica?». Ratzingerrisponde: «Direi proprio di sì. È questa una delle novitàessenziali del cristianesimo per la storia. Perché fino aCristo l’identificazione di religione e stato, divinità estato, era quasi necessaria per dare stabilità allo stato.Poi l’islam ritorna a questa identificazione tra mondopolitico e religioso, col pensiero che solo con il poterepolitico si può anche moralizzare l’umanità. In realtà, daCristo stesso troviamo subito la posizione contraria: Dionon è di questo mondo, non ha legioni, così dice Cristo,Stalin dice non ha divisioni. Non ha un potere mondano,attira l’umanità a sé non con un pote-re esterno, politico, militare ma solocol potere della verità che convince,dell’amore che attrae. Egli dice “atti-rerò tutti a me”. Ma lo dice propriodalla croce. E così crea questa distin-zione tra imperatore e Dio, tra ilmondo dell’imperatore al quale con-viene lealtà, ma una lealtà critica, e ilmondo di Dio, che è assoluto. Mentrenon è assoluto lo stato». È per decre-to religioso che, per il cristiano, lo stato non è tutto, lostato non è l’assoluto. E all’intervistatore che fa presen-te che «questo è uno straordinario punto di incontro trail pensiero cristiano e “cultura liberal-democratica”,Ratzinger replica: «Io penso che la visione liberal-demo-cratica non potesse nascere senza questo avvenimentocristiano che ha diviso i due mondi, così creando unanuova libertà. Lo stato è importante, si deve ubbidire alleleggi, ma non è l’ultimo potere. La distinzione tra lo
stato e la realtà divina crea lo spazio di una libertà in cuiuna persona può anche opporsi allo stato. I martiri sonouna testimonianza per questa limitazione del potereassoluto dello stato. Così è nata una storia di libertà.Anche se poi il pensiero liberal-democratico ha preso lesue strade, l’origine è proprio questa».
2. Quello che l’Occidente deve al CristianesimoÈ un pensatore laico come Karl Popper a porre l’atten-zione sul valore che la tradizione cristiana attribuiscealla coscienza di ogni uomo e di ogni donna. Per un
umanitario, e soprattutto per un cristia-no, egli scrive ne La società aperta e isuoi nemici, «non esiste uomo che siapiù importante di un altro uomo». E«riconosco − egli aggiunge − che granparte dei nostri scopi e fini occidentali,come l’umanitarismo, la libertà,l’uguaglianza, li dobbiamo all’influssodel cristianesimo […] Il solo atteggia-mento razionale e il solo atteggiamen-to cristiano anche nei confronti della
storia della libertà è che siamo noi stessi responsabili diessa, allo stesso modo in cui siamo responsabili di ciòche facciamo delle nostre vite e soltanto la nostracoscienza, e non il nostro successo mondano, può giudi-carci […] Il metro del successo storico appare incompa-tibile con lo spirito del cristianesimo […] I primi cristia-ni ritenevano che è la coscienza che deve giudicare ilpotere e non viceversa». E ancora la coscienza di ognisingola persona, unita con l’altruismo, «è diventata −
8libertas
Difesa della libertà di scuola
di Dario Antiseri
È un pensatore laicocome Karl Popper aporre l’attenzione sul
valore che la tradizionecristiana attribuisce allacoscienza di ogni uomo
e di ogni donna.
FOCU
S

scrive Popper − la base della nostra civiltà occidentale.È la dottrina centrale del Cristianesimo (“ama il prossi-mo tuo”, dice la Scrittura, e non “ama la tua tribù”) ed èil nucleo vivo di tutte le dottrine etiche che sono scaturi-te dalla nostra civiltà e l’hanno alimentata. È anche, peresempio, la dottrina etica centrale di Kant (“devi semprericonoscere che gli individui umani sono fini e che nondevi mai usarli come meri mezzi ai tuoi fini”). Non c’èalcun altro pensiero che abbia avuto tanta influenzanello sviluppo morale dell’uomo».
3. La “rivoluzione cristiana” è stata la più grande rivo-luzione che l’umanità abbia mai compiuto
E, prima di Popper, Benedetto Croce. «Il cristianesimo− egli scrive nel noto saggio del 1942 Perché non pos-siamo non dirci cristiani − è stato la più grande rivolu-zione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande,così comprensiva e profonda, così feconda di conse-guenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi,che non meraviglia che sia apparso o possa ancora appa-rire un miracolo, una rivoluzione dall’alto, un direttointervento di Dio nelle cose umane, che da lui hannoricevuto legge e indirizzo affatto nuovo». Tutte le altrerivoluzioni e tutte le maggiori scoperte che segnano glisviluppi della storia umana − prosegue Croce − rispettoalla rivoluzione cristiana appaiono particolari e limitate:«Tutte, non escluse quelle che la Grecia fece della poe-sia, dell’arte, della filosofia, della libertà politica, eRoma del diritto: per non parlare delle più remote dellascrittura, della matematica, della scienza astronomica,della medicina, e di quanto altro si deve all’Oriente eall’Egitto». E c’è di più, poiché «le rivoluzioni e le sco-perte che seguirono nei tempi moderni, in quanto non
furono particolari e limitate al modo delle loro preceden-ti antiche, ma investirono tutto l’uomo, l’anima stessadell’uomo, non si possono pensare senza la rivoluzionecristiana, in relazione di dipendenza da lei, a cui spetta ilprima perché l’impulso originario fu e perdura il suo».Dunque: il cristianesimo è stata la più grande rivoluzio-ne che l’umanità abbia mai compiuto. E «la ragione diciò è che la rivoluzione cristiana operò nel centro del-l’anima, nella coscienza morale, e, conferendo risaltoall’intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve chele acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spiri-tuale, che fin allora era mancata all’umanità. Gli uomi-ni, i geni, gli eroi, che furono innanzi al cristianesimo,compirono azioni stupende, opere bellissime, e ci tra-smisero un ricchissimo tesoro di forme, di pensieri e diesperienze; ma in tutti essi si desidera quel proprioaccento che noi accomuna ed affratella, e che il cristia-nesimo ha dato esso solo alla vita umana».
4. Káysar non è KýriosNel 112 d.C. Plinio il giovane, governatore della Bitinia,invia un resoconto all’imperatore Traiano, dove gli noti-fica di aver condannato a morte tutti quei cristiani che sierano rifiutati di adorare Cesare come Signore (KýriosKáysar) e di maledire Cristo (Anáthema Christós). Conil messaggio cristiano aveva fatto irruzione nel mondol’idea che il potere politico non è il padrone dellacoscienza degli individui, ma che è la coscienza di ogniuomo e di ogni donna a giudicare il potere politico. Peril cristiano solo Dio è il Signore, l’Assoluto. Lo Statonon è l’Assoluto: Káysar non è Kýrios. E con ciò il pote-re politico veniva desacralizzato, l’ordine mondano rela-tivizzato e le richieste di Cesare sottoposte al giudizio dilegittimità da parte di coscienze inviolabili, di persone“fatte ad immagine e somiglianza di Dio”.La Grecia ha passato all’Europa l’idea di ragione comediscussione critica, ma non fu la Grecia a passareall’Europa i suoi déi. Questi, come ha scritto GiovanniReale, erano già stati resi vani dai filosofi a cominciaredai presocratici. Il Dio delle popolazioni europee è il Diodella Bibbia e del Vangelo, il Dio giudaico-cristiano: ilDio che desacralizza il mondo e così, come sostieneMax Scheler, lo rende disponibile alla manipolazione eall’indagine scientifica in una misura prima impensabi-le; il Dio che desacralizza il potere politico offrendo cosìall’Occidente le basi di una prospettiva non teocratica; ilDio che rende sacra e inviolabile la persona libera eresponsabile con il conseguente ridimensionamento del-l’ordine politico. Per queste ragioni − e non solo perqueste ragioni − è davvero impossibile dar torto a
9libertas
Difesa della libertà di scuola

Thomas S. Eliot allorché scrive che «se il cristianesimose ne va, se ne va tutta la nostra cultura. E allora sidovranno attraversare molti secoli di barbarie».Il messaggio cristiano libera l’uomo dall’idolatria: il cri-stiano non può attribuire assolutezza eperfezione a nessuna cosa umana. È,dunque, per decreto religioso che loStato non è tutto, non è l’Assoluto. Esia con la dissacrazione di Cesare,vale a dire dell’assolutizzazione delpotere politico, sia con il valore datoalla libera e responsabile coscienza diogni persona, il cristianesimo ha crea-to, a livello politico, una tensione cheattraversa tutta la storia dell’Oc -cidente. Si tratta, infatti, di idee ed ideali che, pur tra ten-tazioni “teocratiche” o rifiuti “satanocratici” del poterepolitico, hanno esercitato, nell’evoluzione storica, unapressione a volte travolgente sull’elemento mondanoantitetico.
5. La grande tradizione del cattolicesimo liberaleÈ esattamente in questo orizzonte che va presa in consi-derazione la grande tradizione del cattolicesimo liberale.Tralasciando qui il contributo della Scuola francescanadel Trecento e quello ancor più influente della Tardo-scolastica spagnola del Seicento, c’è da dire chedell’Ottocento la figura più prestigiosa del pensiero libe-rale cattolico è quella di Alexis de Tocqueville (1805-1859): «Ciò che, ai miei occhi caratterizza i socialisti di
tutti i colori è un tentativo con tinuo, vario, incessante,per mutilare, per raccorciare, per molestare in tutti imodi la libertà umana; è l’idea che lo Stato non debbasoltanto essere il direttore della società, ma deb ba esse-re, per così dire, il padrone di ogni uomo; il suo pa drone,il suo precettore, il suo pedagogo […]; in una parola, èla confisca, in un grado più o meno grande, della libertàu mana».Insieme a Tocqueville, un altro cattolico francese,Fédéric Bastiat (1801-1850): «Allorché si sarà ammes-so in via di principio che lo Stato ha l’incarico di ope-rare in mo do fraterno in favore dei cittadini, si vedran-no tutti i cittadini trasformarsi in postulanti [...] Il teso-ro pubblico sarà letteral mente saccheggiato. Ciascunotroverà buone ragioni per di mostrare che la fraternitàlegale deve essere intesa in questo senso: “I vantaggiper me ed i costi per gli altri [...]”. Lo sforzo di tuttitenderà a strappare alla legislazione un lembo di privi-legio fraterno».Sempre nell’Ottocento, in Italia, tra altri cattolici libera-li, Antonio Rosmini (1797-1855): «La proprietà costitui-sce una sfera intorno alla persona, di cui la persona è ilcentro; nella quale sfera niun altro può entrare».E poi nel Novecento Wilhelrn Rópke (1898-1966): «Il
liberalismo non è [...] nel la sua essen-za un abbandono del Cristianesimo;bensì è il suo legittimo figlio spirituale[...] Il liberale diffida di ogni ac -cumulazione di potere, perché sa chedi ogni potere, che non viene tenutonei suoi limiti da contrappesi, si fa pre-sto o tar di abuso».Luigi Einaudi (1874-1961): «Il grandemerito dei governi liberali in confron-to a quelli tirannici sta appunto nel
fatto che nei regimi di libertà discussione e azione pro-cedono attraverso il metodo dei tentativi e degli errori.Trial and error è l’emblema della superiorità dei metodidi libertà su quelli di tirannia. Il tiranno non ha dubbi eprocede diritto per la sua via; ma la via conduce il Paeseal disastro».Luigi Sturzo (1871-1959): «La mia difesa della liberaini ziativa è basata sulla convinzione scientifica chel’economia di Stato non solo è anti-economica ma com-prime la libertà e per giunta riesce meno utile, o più dan-nosa, secondo i casi, al benessere sociale».Cattolici liberali dei nostri giorni sono, per tacere di altri,negli Stati Uniti, Robert Sirico e Michael Novak; inFrancia, Jean-Yves Naudet e Jacques Garello; in Italia,don Angelo Tosato.
10libertas
Difesa della libertà di scuola
Il liberalismo non è [...]nel la sua essenza
un abbandono del Cristianesimo; bensìè il suo legittimo figlio
spirituale

Padre Robert Sirico: «Se, come avvenuto negli ultimivent’anni, la Chiesa alla ricerca della verità, ha potutodialogare coi pensatori influenzati da Marx, allora forseè maturo il tempo perché si apra il dialogo con il libera-lismo classico».Michael Novak: «La democrazia politica [...] è compati-bi le solo con un’economia di mercato»; «L’unione dicapitali smo e democrazia non porterà il regno dei Cielisulla Terra; ma, per liberare i poveri dalla miseria e dallatirannia e per dar spazio alla loro creatività, il capitali-smo e la democrazia possono fare molto di più di quan-to sia in potere di tutte le altre alternative esistenti».Jean-Yves Naudet: «L’inefficienza dei regimi di sociali -smo reale proveniva dal rifiuto di riconoscere la naturadel l’uomo e i suoi diritti, a cominciare da quello di per-seguire il proprio fine personale, e ancora dal diritto diproprietà o dal diritto di iniziativa economica».Jacques Garello: «Coniugando liberalismo e cattolicesi -
mo, l’Occidente ritrova e ritroverà il suo equilibrio intel-let tuale, morale e spirituale».Don Angelo Tosato: «Se per “capitalismo” si intende [...]onesta ricerca del benessere personale, familiare e col-lettivo, e più ancora un sistema che dia a tutti la facoltàdi esercitare liberamente e proficuamente la propriacapacità in campo e conomico, allora il rapporto col cri-stianesimo non può che essere di sintonia e di collabora-zione».
6. Grandi pensatori a difesa della libertà di scuolaIl nucleo fondamentale del pensiero cattolico liberale èla difesa della inviolabilità, libertà, responsabilità dellapersona umana, di ogni singola persona. Ora, la doman-da che qui ci poniamo è la seguente: il monopolio (oquasi-monopolio) statale dell’istruzione garantisceinviolabilità, libertà e responsabilità della personaumana o ne è, piuttosto, la negazione, la soppressione?Ancor più chiaramente: lo Stato di diritto può avanzarela pretesa del monopolio statale nella gestione dellascuola?È più che opportuno riflettere sulle risposte che a talinevralgiche questioni hanno dato grandi pensatori i quali– pur da differenti prospettive – convergono tutti sullanecessità della libertà di insegnamento.Alexis de Tocqueville: «[...] voglio che si possa organiz-zare accan to all’università una seria concorrenza. Lovoglio perché lo richiede lo spirito generale di tutte lenostre istituzioni; lo voglio anche perché so no convintoche l’istruzione, come tutte le cose, ha bisogno, per per-fezionarsi, vivificarsi, rigenerarsi all’occorrenza, dellostimolo della concorrenza».Antonio Rosmini: «I padri di famiglia hanno dalla natu-ra e non dalla legge civile il diritto di scegliere per mae-stri ed educatori della loro prole quelle persone, nellequali ripongono maggiore confiden za».John Stuart Mill: «Le obiezioni che vengono giustamen-te mosse all’educazione di Stato non si applicano allaproposta che lo Stato ren da obbligatoria l’istruzione, mache si prenda carico di dirigerla: che è una questionecompletamente diversa».Bertrand Russell: «Lo Stato è giustificato nella sua insi-stenza per ché i bambini vengano istruiti, ma non è giu-stificato nel pretendere che la loro istruzione proceda suun piano uniforme e miri alla produ zione di una squalli-da uniformità».Gaetano Salvemini: «Dalla concorrenza delle scuole pri-vate, le scuole pubbliche – purché stiano sempre in guar-dia, e siano spinte dal la concorrenza a migliorarsi, e non
11libertas
Difesa della libertà di scuola

pretendano neghittosamente di eliminare con espedientilegali la concorrenza stessa – hanno tutto da guadagnaree nulla da perdere».Antonio Gramsci: «Noi socialisti dobbiamo essere pro-pugnatori della scuola libera, della scuola lasciataall’iniziativa privata e ai Comuni».Luigi Einaudi: «In ogni tempo, attraverso tentativi ederrori ogno ra rinnovati, abbandonati e ripresi, le nuovegenerazioni accorreranno di volta in volta alle scuole lequali avranno saputo conquistarsi repu tazione più alta distudi severi e di dottrina sicura».Luigi Sturzo: «Ogni scuola, quale che sia l’ente che lamantenga, deve poter dare i suoi diplomi non in nomedella repubblica, ma in no me della propria autorità [...]».Karl R. Popper, ne La società aperta e i suoi nemici,scrive: «Io senza esitazione credo che compito delloStato sia quello di vigilare affinché ai suoi cittadini siadata un’educazione che li abiliti a parteci pare alla vitadella comunità e di mettere in opera tutti i mezzi chepromuovono lo sviluppo dei loro particolari interessi etalenti; e lo Stato dovrebbe anche provvedere [...] a chele insufficienti disponibilità finanziarie dei singoli nonimpediscano loro l’accesso agli studi superiori [...].L’interesse dello Stato non dev’essere invocato a cuorleggero per difendere misure che possono mettere inpericolo la più preziosa di tutte le forme di libertà,cioè la libertà intellettuale».
7. Il principio di sussidiarietàLe basi teoriche della libertà di insegnamento sonoda rintracciare nel principio di sussidiarietà e nelprincipio della competizione.«Gli americani di tutte le età, condizioni e tenden-ze, si associano di continuo. Non soltanto possiedo -no associazioni commerciali e industriali, di cuitutti fanno parte, ne hanno anche di mille altre spe-cie: reli giose, morali, grandi e futili, generali e spe-cifiche, vastissime e ristrette. Gli Americani siassociano per fare feste, fondare seminari, costruirealberghi, innalzare chiese, diffondere libri, inviare mis-sionari agli antipodi; creano in questo modo ospedali,prigioni, scuole. Dap pertutto, ove alla testa di una nuovaistituzione vedete, in Francia, il governo, state sicuri divedere negli Stati Uniti un’associazione». È così cheAlexis de Tocqueville, ne La democrazia in America,descrive il funzionamento, nella vita sociale, di quelprincipio che in seguitò verrà chiamato «principio disussidiarietà». Tale princi pio – autentico baluardo a dife-sa della libertà degli indi vidui e dei «corpi intermedi»nei confronti delle pretese onnivore dello statalismo –
trova una formulazione, ormai diventata classica,nell’Enciclica Quadragesimo anno (1931) di Pio XI,dove, al paragrafo 8, si dice che «siccome non è lecitotogliere agli individui ciò che essi possono compiere conle forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità,così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta socie-tà quello che dalle minori e inferiori comunità si puòfare. Ed è questo insieme un grave danno ed uno scon-volgimento del retto ordine della società; perché l’ogget-to naturale di qualsiasi inter vento della società stessa èquello di aiutare in maniera suppletiva le membra delcorpo sociale, non già distrug gerle e assorbirle».Siffatto principio di sussidiarietà, successivamente ripre-so in altre Encicliche papali e in documenti ufficia lidella Chiesa – basti richiamare la Pacem in Terris (1963)di Giovanni XXIII o la Centesimus Annus (1991) dipapa Wojtyla – era stato già formulato da Rosmini nellaFilosofia della politica, dove leggiamo che «il gover nocivile opera contro il suo mandato, quand’egli si mette inconcorrenza con i cittadini, o colla società ch’essi strin-gono insieme per ottenere qualche utilità speciale; moltopiù quando, vietando tali imprese agli individui e alleloro società, ne riserva a sé il monopo lio». In breve: loStato «faccia quello che i cittadini non possono fare». Èquesto, dunque, il principio di sussidiarietà orizzontale
ben diverso dall’altra formulazione che porta il nome disussidiarietà verticale dove, per esempio, si dice che laRegione farà quello che non fa lo Stato, la Provincia faràquello che non fa la Regione, e i Comuni e le aree metro-politane faranno quello che non fa la Provincia. E qui èchiaro che, se il principio di sussidiarietà verticale nonviene esplicitamente coniugato con quello di sussidiarie-tà orizzontale, si cade in modo inequivocabile in una piùsubdola e pericolosa forma di statalismo celebrata nellaformula: ciò che non fa il pub blico lo fa il pubblico. Maè proprio contro ogni forma di oppressione nei confron-ti della libertà, responsabilità, spirito di iniziativa dei sin-
12libertas
Difesa della libertà di scuola

goli e delle associazioni spontanee che è stato difeso ilprincipio di sussidiarietà orizzontale e ovviamente nonsolo dai cattolici. La Filo sofia della politica di Rosminiè del 1838. Undici anni più tardi, nel 1849, J.S. Millpubblica On Liberty, ben consapevole che «i malicominciano quando invece di fare appello alle energie ealle iniziative di individui e associazioni, il governo sisostituisce ad essi; quando invece di informare, consi-gliare e, all’occasione, denun ciare, e imporre dei vinco-li, ordina loro di tenersi in disparte, e agisce in lorovece».Su questa linea si sono mossi i grandiliberali del nostro secolo: CarlMenger, Ludwig von Mises, Friedrichvon Hayek e Karl Popper, tra gli altri.Scrive Hayek: «È totalmente estraneaai principi base di una società liberal’idea secondo la quale tutto ciò di cuiil pubblico ha bisogno debba esseresoddisfatto da organizzazioni obbliga-torie». Il vero liberale, ad avviso diHayek, deve auspicare il maggiornumero possibile di associazioni volontarie, di quelleorganizzazioni «che il falso indivi dualismo di Rousseaue la Rivoluzione francese vollero sopprimere». E, infine,Karl Popper: «Io sostengo che una delle caratteristichedella società aperta è di tenere in gran conto, oltre allaforma democratica di governo, la libertà di associazionee di proteggere e anche di incorag giare la formazione disotto-società libere, ciascuna delle quali possa sosteneredifferenti opinioni e credenze».
8. La competizione come la più alta forma di collabora-zione
Interconnesso con il principio di sussidiarietà è il princi-pio di competizione. Come, tra altri, ha insegnato KarlPopper, la scienza avanza attraverso la più severa com-petizione tra idee; progredisce da proble mi a problemisempre più profondi sulla strada delle congetture e delleconfutazioni. «La mia concezione del metodo dellascienza è sempli cemente questa: esso sistematizza ilmetodo prescientifico dell’impa rare dai nostri errori: losistematizza grazie allo strumento che si chia ma discus-sione critica. Tutta la mia concezione del metodo scien-tifico si può riassumere dicendo che esso consiste diquesti tre passi:
1) inciampiamo in qualche problema;2) tentiamo di risolverlo, ad esempio proponen-do qualche nuova teoria;
3) impariamo dai nostri sbagli, specialmente daquelli che ci sono resi presenti dalla discussionecritica dei nostri tentativi di riso luzione.
O, per dirla in tre parole: problemi-teorie-critiche. Credoche in queste tre parole problemi-teorie-critiche, si possariassumere tutto quanto il modo di procedere della scien-za razionale». Questo scrive Popper nel saggioProblemi, scopi e responsabilità della scienza.D’altra parte, il metodo scientifico trova nelle regoledella demo crazia il suo analogo nella vita sociale. Anchela democrazia è una competizione tra progetti politici,tra proposte di soluzione di problemi. E la libera econo-mia è competizione di merci e servizi sul mercato. È ilprincipio della competizione, dunque, a costituire l’ani-ma della scienza, della democrazia e dell’economia dimercato. La competizio ne è la più alta forma di collabo-razione.
9. Il monopolio statale dell’istruzione è negazione dilibertà, viola la giustizia sociale, genera inefficienza,accarezza l’irresponsabilità, fa lievitare i costi
Una cosa deve essere chiara: chi difende la scuola libe-ra non è contrario alla scuola di Stato, non vuole abolirela scuola di Stato. Chi di fende la libertà di scuola è sem-plicemente contrario al monopo lio statale dell’istruzio-ne. E non è un caso che nelle Costitu zioni dei Paesi chesi sono liberati dal comunismo (Unghe ria, Croazia,
13libertas
Difesa della libertà di scuola
Interconnesso con il principio di sussidiarietà è il principio
di competizione

Bulgaria, Estonia, ecc.) sia stata stabilita, senza possibi-lità di equivoci, la libertà di scuola.La scuola di Stato è un patrimonio che va salvato. Lascuola di Stato è ciò che abbiamo. Essa è malata: mala-ta di statalismo. E questa malattia va guarita tramite dosidi com petizione. Quanti difendono il monopolio stataledell’istru zione non aiutano la scuola di Stato a sollevar-si dalla crisi in cui versa. La competizione aiuta amigliorare sia le scuole statali che quelle non statali.Nessuna scuola sarà mai uguale all’altra – un preside piùattivo, una segretaria più operosa, insegnanti più prepa-rati, ecc., bastano a fare la differenza. Ma se nessunascuola sarà mai uguale all’altra, tutte potran no miglio-rarsi attraverso la competizione. In breve, la nostra con-vinzione è che soltanto tramite la competizione tra scuo-la e scuola che si può sperare di salvare la nostra scuola:la scuola statale e quella non-statale.La realtà è che, è bene ripeterlo, il monopolio statale del -l’istruzione è la vera, acuta, pervasiva malattia dellascuola i taliana. Il monopolio statale nella gestione del-l’istruzione è negazione di libertà; è in contrasto con lagiustizia sociale; devasta l’efficienza della scuola, favo-rendo l’irresponsabilità di studenti ed insegnanti.Il monopolio statale dell’istruzione è negazione di li -bertà: unicamente l’esistenza della scuola libera garanti-sce alle famiglie delle reali alternative sia sul piano del-l’indirizzo culturale e dei valori che sul piano della qua-lità e del conte nuto dell’insegnamento.Il monopolio statale dell’istruzione viola le più basilariregole della giustizia sociale: le famiglie che iscrivono ilpro prio figlio alla scuola non statale pagano due volte; laprima volta con le imposte – per un servizio di cui nonusufruisco no – e una seconda volta con la retta da corri-spondere alla scuola non statale.Il monopolio statale dell’istruzione devasta l’efficienzadella scuola: la mancanza di competizione tra istituzioniscola stiche trasforma queste ultime in nicchie ecologi-che protette e comporta di conseguenza, in genere, irre-sponsabilità, inef ficienza e aumento dei costi. La que-stione è quindi come introdurre la logica di mercato nelsi stema scolastico, fermo restando che ci sono due vin-coli da rispettare: l’obbligatorietà e la gratuità dell’istru-zione.
10. Milton Friedman propone l’idea di buono-scuolaÈ la riflessione attenta sui danni prodotti dal monopoliostatale dell’istruzione che induce a pensare a quella tera-pia consistente nella proposta della introduzione dellacompeti zione all’interno del sistema scolastico italiano.E qui diciamo subito che le soluzioni che potrebbero rie-quilibrare le sorti del la scuola italiana in senso conformealle regole del mercato – in modo da migliorarne i ren-dimenti e moralizzarne i compor tamenti, già soltantointroducendo dosi incrementali di libera competizione –sono due: una radicale, il buono-scuola, l’altra di valorequanto meno «terapeutico», il credito di imposta.È al premio Nobel per l’economia (1976) Milton Fried -man che dobbiamo l’esplicita formulazione dell’idea dibuo no-scuola. Scrive dunque Friedman: «Una societàstabile e democratica è impossibile senza un certo gradodi alfabetismo e di conoscenze da parte della maggioran-za dei cittadini e senza una diffusa accettazione di alcu-ni complessi comuni di valori. L’educazione può contri-buire a entrambi questi a spetti. Di conseguenza, il gua-dagno che un bambino ricava dall’educazione nonridonda solo a vantaggio del bambino stesso o dei suoigenitori, ma anche a vantaggio degli altri membri dellasocietà. L’educazione di mio figlio contribuisce anche alvostro benessere contribuendo a promuovere una socie-tà stabile e democratica. Non è possibile identificarequali siano i singoli (o le famiglie) che ne beneficiano e,quindi, addossare ad essi gli oneri specifici per i serviziresi. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un importante casodi “ef fetto indotto”. Quale genere di intervento pubblico
14libertas
Difesa della libertà di scuola

risulta giustificato da questo particolare effetto indotto?Il più ovvio è quello di assicurare che ogni bambinoriceva una data quantità di servizio scolastico di un certotipo [...] I governi potrebbero imporre un livello minimodi scolarità e assicu rarne il funzionamento concedendoai genitori dei titoli di credito rimborsabili per una deter-minata somma massima annua per ciascun figlio qualo-ra fosse spesa per servizi sco lastici “approvati”. I geni-tori in tal caso sarebbero liberi di spendere questasomma, e ogni altra somma addiziona-le di tasca propria, per l’acquisto di ser-vizi scolastici da un istituto di loro pro-pria scelta, ma “approvato” dalla pub-blica auto rità. I servizi scolasticipotrebbero in tal modo essere forniti daimprese private gestite a fini di profittoo da istituzioni senza scopo di lucro. Ilruolo del governo, in tal caso, sareb besoltanto quello di assicurare che lescuole soddisfino certi requisiti mini-mi, come, ad esempio, la inclusione neilo ro programmi di un contenuto comu-ne minimo, allo stesso modo, peresempio, che ora il governo provvedealla sorve glianza sui ristoranti pergarantire che essi rispettino gli stan -dard sanitari minimi fissati dalle autorità».
11. Friedrich A. von Hayek si trova d’accordo con Mil -ton Friedman
Ne La società libera Friedrich August von Hayek,anch’egli premio Nobel per l’economia (1974), affer-ma: «Non solo le ragioni in contrario all’amministra-zione pubblica della scuola appaiono oggi più che maigiustificate, ma sono scom parse gran parte delle ragio-ni che in passato avrebbero potu to essere addotte infavore. Qualunque cosa possa essere sta ta allora vera,oggi con le tradizioni e le istituzioni dell’educazioneuniversale solidamente stabilite e con i moderni mezzidi trasporto che risolvono gran parte delle difficoltàdovute alle distanze, è indubbio che non è più necessa-rio che lo stato non solo finanzi l’educazione ma diret-tamente vi provveda».E qui richiamandosi esattamente al saggio di Friedmandel 1955, The Role of Government in Education, Hayek
pro pone che «si potrebbe benissimo provvedere allespese per l’istruzione generale, attingendo alla borsapubblica, senza che debba essere lo Stato a mantenerele scuole, dando ai genitori dei buoni che coprano lespese dell’istruzione di ciascun ragazzo, buoni da con-segnare alla scuola di loro scelta». Hayek prosegue: «Sipotrebbe anche auspicare che lo Stato provveda diretta-mente alle scuole in alcune comunità isolate dove, per-ché possano esistere scuole private, il numero dei ragaz-zi è troppo basso (e il costo medio dell’i struzione per-tanto troppo alto). Ma nei confronti della grande mag-gio ranza della popolazione, sarebbe senza dubbio pos-sibile lasciare l’in tera organizzazione e amministrazio-ne dell’istruzione agli sforzi priva ti, mentre da parte sua
lo Stato dovrebbe semplicementeprovvedere al finanziamento di base ea garantire uno standard minimo pertutte le scuole in cui potrebbero esse-re spesi i suddetti buoni. Un altro deigrandi vantaggi di questo pianosarebbe che i genitori non si trovereb -bero più davanti all’alternativa o didover accettare qualsiasi tipo di istru-zione fornita dallo Stato o di pagaredi tasca propria il prezzo di un’istru-zione un po’ più cara; e se scegliesse-ro una scuola diversa da quelle comu-ni, dovrebbero pagare solo un costoaddizionale».
12. Il credito d’impostaSe l’introduzione del buouo-scuola dovesse, per le ra -gioni più varie, apparire come improponibile, in un datomo mento storico, allora – come soluzione intermediasulla via del buono-scuola – linee di competizionepotrebbero venir innescate all’interno del nostro siste-ma scolastico tramite il credito di imposta. Il credito diimposta è la detrazione che si applica sull’ammontaredell’imposta dovuta, la quale viene decurtata di tutta odi una parte della retta scolastica che de ve pagare chisceglie una scuola libera. Va da sé che ai ra gazzi difamiglie nullatenenti va pagata la retta da parte delloStato. E anche in questo caso lo Stato risparmierebbe.Ecco, di seguito, un rapido esempio. Prendiamo in con-siderazione l’anno scolastico 1992-1993. In quell’annogli alunni che fre quentano la scuola elementare sono2.700.000 (circa). Ogni alunno costa alla comunità(Stato ed enti locali) circa 6.000.000 all’anno. Dunquela spesa totale si aggira sui 16 mila miliardi di lire peranno. Con un credito di imposta pari al 70% del costo
15libertas
Difesa della libertà di scuola
«Non solo le ragioni in contrario
all’amministrazionepubblica della scuolaappaiono oggi più chemai giustificate, masono scom parse gran
parte delle ragioni chein passato avrebberopotu to essere addotte
in favore.

effettivo di un alunno della scuola statale – i 243.125alunni che nell’anno scolastico 1992/93 hanno fre -quentato le scuole non statali – verrebbero a costare 985mi liardi circa di lire. Alle scuole statali questi 243.125alunni co sterebbero 1.358.750.000.000. Il risparmiosarebbe, pertanto, di quasi 400 miliardi. E tutto questosenza badare all’incre mento del valore di libertà dellefamiglie; alla maggiore effi cienza quale effetto dellacompetizione; alla possibilità di in gresso di giovaniinsegnanti nel sistema educativo.
13. Perché va combattuta l’idea di «convenzione »Quella che va combattuta è l’idea di convenzione – ideaabbracciata a destra, anche al centro, e soprattutto asinistra; e pure da buona parte del mondo cattolico. Laverità è che la convenzione mette sin dall’inizio tutte lescuole libere, in ma niera totale, nelle mani dello Stato odella Regione: cioè nel le mani dei partiti e dei burocra-ti. La convenzione equivale – lo si voglia o meno – allacreazione di centri produttori di clientes. Con la conven-zione (sovvenzioni, pagamenti degli stipendi ai profes-sori, e simili misure) si dà vita non ad un si stema con-correnziale, ma ad un sistema spartitorio, conso ciativo ecollusivo. La realtà è che: chi paga compra. Benefi ciumaccipere, libertatem est vendere. Laconvenzione strap pa la scuola dallemani delle famiglie per renderlapreda del le brame di burocrati politi-cizzati. La convenzione elimina lacompetizione. Qui non si voglionome t tere in discussione le buoneintenzioni e l’onestà di quanti sosten-gono la conven zione. Solo che dibuo ne intenzioni sono lastricate levie del l’inferno. Quella della conven-zione è la via dell’asservimento tota-le della scuola.Le scuole libere, ai nostri giorni,sono unicamente libere di morire. Si capisce, pertanto,che chi sta rischiando la scom parsa, invochi un po’ diossigeno e si rifugi nella richiesta della convenzione.Tutto ciò è comprensibile. E, tuttavia, non dovremmomai stancarci di ripetere, sinché avremo forza, che laconvenzione è il colpo finale alla libertà della scuola. E,allora, sarebbe forse più dignitoso morire in piedi, piut-to sto che sopravvivere da accattoni ricattabili.La verità è che il tipo di finanziamento della scuola libe -ra non è indifferente per l’autentica libertà della scuola.Il buono-scuola equivale alla scuola libera; il credito di
impo sta introduce serie misure di competizione all’in-terno del si stema scolastico italiano; la convenzionerende statali pure quelle poche scuole libere che ilnostro Paese può ancora vantare.
14. Obiezioni contro il buono-scuola (e repliche alleobiezioni)
Con il buono-scuola, dunque, i fondi statali – sotto for -ma di “buoni” non negoziabili (vouchers) – andrebberonon alla scuola ma ai genitori o comunque agli studentiaventi di ritto, i quali sarebbero liberi di scegliere pressoquale scuola spendere il buono in questione. Il valore delbuono-scuola si determina dal rapporto fra ciò che loStato spende attual mente per un dato tipo di scuola e ilnumero degli studenti che frequenta quel dato tipo discuola.Il buono-scuola amplia la libertà delle famiglie; rendepiù efficienti – tramite la concorrenza – la scuola statalee quella non statale; è una carta di liberazione per le
famiglie meno abbienti.La proposta del buono-scuola è la pro-posta di una giusta terapia per le malat-tie della scuola italiana. È una terapiache non è né di de stra né di sinistra. Èuna buona idea, una soluzione ragione-vole di un problema urgente. Se unidraulico ripara una fogna che si èrotta, la riparazione è di destra o disinistra? Se un chirurgo conduce abuon fine una difficile operazione, nonha alcun senso chiedersi se il suo lavo-ro sia di destra o di sinistra. È così,allora, che ragionevoli «uo mini di sini-stra» e ragionevoli «uomini di destra»
hanno proposto e difeso l’idea di buono-scuola esatta-mente quale adeguata soluzione di un problema urgente.E sarebbe forse tempo di farla finita con l’idea che èbuono tutto e solo ciò che è pubblico; che è pubblicosolo ciò che è statale; che è statale tutto quello che puòessere preda dei partiti. E dobbiamo chiederci: svolge unmigliore servizio pubblico una scuola statale inefficien-te oppure una scuola non statale ben funzionante, menocostosa, più efficiente? È «più pubblica» una scuola nonstatale efficiente ovvero una scuola statale improduttivae sciupona?
16libertas
Difesa della libertà di scuola
Il buono-scuola ampliala libertà delle famiglie;
rende più efficienti,tramite la concorrenza,
la scuola statale e quella non statale;
è una carta diliberazione per le
famiglie meno abbienti

Ma ecco la prima obiezione contro la proposta del buo -no-scuola: la scuola è un settore strategico, dunque nonpuò venire lasciata al «mercato». A costoro replichiamoin modo deciso e secco: proprio perché la scuola è unsettore strategi co, essa va gestita con le regole del mer-cato, mettendo in competizione scuole statali e scuolenon statali. E aggiungia mo: niente è più necessario delpane – quello del pane è si curamente un settore strategi-co –, eppure noi abbiamo il pane buono ogni mattina,per la ragione che se un forno ci ser visse male noiavremmo la possibilità di servirci da un altro fornaio.Adam Smith docet. Ed è così che la competizione è lapiù alta forma di collaborazione.Altra obiezione – abbracciata da più parti – è che, inregime di buono-scuola, poche famiglie sarebbero ingrado di scegliere la scuola adeguata per i loro figli. Talepresa di posizione è un affronto alla democrazia (eletto-ri a diciotto anni, tanti italiani – uomini e donne – sareb-bero, ancora più avanti negli anni – incapaci di far la
migliore scelta per la scuola dei propri fi gli). Ed èun’idea falsa, nella generalità dei casi: anche nei paesipiù sperduti della nostra Penisola, pure la mamma me nocolta e il padre più distratto sanno qual è la maestra piùbrava, più disponibile, più umana; e sanno quali sono ido centi più validi della locale scuola media; e vanno daldiret tore didattico o dal preside a chiedere e ad insistereperché il loro figlio o la loro figliola vengano iscritte inuna sezione piut tosto che in un’altra. L’interesse è sor-gente di energia per la cattura delle informazioni. In ognicaso, se un genitore sba glia, sbaglia per suo figlio; i poli-tici possono sbagliare per in tere generazioni.La verità è che le scuole statali serie non hanno nulla datemere dall’introduzione del buono-scuola. Temono lacon correnza le scuole poco serie – siano esse statali onon statali – e tutti coloro che atterriti alla sola idea didover competere con scuole magari meglio organizzatee in cui operano colle ghi più preparati, preferirebberoevitare qualsiasi confronto e soprattutto il giudizio degliutenti.All’obiezione secondo cui la competizione, introdottanel sistema scolastico, avrebbe come esito la negazionedell’e guaglianza, di scuole uguali per tutti, c’è da repli-care che nessuna scuola è e sarà mai uguale all’altra – unpreside più attivo, professori più prepa rati, una segrete-ria più efficiente, ecc. fanno la differenza. Nessuna scuo-la è o sarà mai uguale all’altra; ma tutte le scuole, quel-le statali e quelle non statali, posso no migliorare sotto lostimolo della competizione.C’è poi in giro un anticlericalismo becero e fuor di luogoe fuor di tempo, in base al quale non si vuole la scuolalibera perché questa sarebbe «la scuola dei preti».Posizioni del ge nere non meritano neppure di esserediscusse e la verità è che quei pochi cattolici che lottanoper la scuola libera non lottano solo per la loro scuola,lottano per la più ampia li bertà di insegnamento. E aquanti sostengono che le scuole di orientamento confes-sionale non debbono esistere perché sarebbero fabbrichedi intolleranza, va semplicemente ricor dato che la veritàsta nel contrario: proibire e soffocare le dif ferenze puòessere – come ha affermato non molto tempo fa l’arcive-scovo di Parigi, card. Lustiger – la prima causa della loroviolenta esplosione. In Germania esistono scuole neutree scuole confessionali, protestanti e cattoliche. Le diver-sità di visioni del mondo e di valori scelti sono l’essen-za della so cietà aperta. Proibire le scuole di orientamen-to confessiona le o comunque farle morire per mancanzadi fondi equivale alla negazione della società aperta. Lasocietà aperta è chiu sa solo agli intolleranti. Di conse-guenza, non esistono ragio ni per proibire le scuole di
17libertas
Difesa della libertà di scuola

orientamento confessionale, se queste si inseriscono nelquadro dei valori della nostra Costi tuzione: tolleranza,antirazzismo, solidarietà, ecc. Negare la presenza dellescuole di orientamento confessionale signifi ca distrug-gere l’esistenza di pezzi della nostra migliore storia eproibire sviluppi futuri di questa. E qui è più cheopportu no far presente che, per esempio, in Belgioaccanto a scuole libere di orientamento cattolico e pro-testante, troviamo an che istituti gestiti da autorità reli-giose ebraiche ed islamiche; e scuole induiste ed islami-che sono in funzione nei Paesi Bassi.E le cose non si fermano qui, giacché si aggiunge che lescuole ad orientamento confessionale sarebbero – quasiex definitione – centri di formazione acritica. Dunque,per esempio, la “scuola cattolica” consisterebbe di pro-fessori dogmatici e studenti acritici. Tutto questo sullabase dell’idea che un credente non può che essere acriti-co. Non c’è bisogno di richiamare Max Scheler per veni-re a conoscenza del fatto che, per esempio, una fede cri-stiana consapevole favorisce e po tenzia menti critiche.Basterà qui richiamare il fatto che Newton era cristiano,che lo fu Kant, e prima di loro lo furono Cartesio ePascal. Dunque: Cartesio, Pascal, Newton e Kant – tuttiacritici perché cristia ni? Acritici: Agostino, Tommaso,Scoto, Ockham? E davvero critici gli statalisti anticleri-cali? Hilary Putman è un ebreo osservante: anch’egli,dunque, vittima dell’indottrinamento e mente acritica,sprofondato nel più bieco dogmatismo e un pericolo perla democrazia?I laicisti dovrebbero essere più attenti e meno dogmaticie meno acritici nei loro pronunciamenti e nelle loro sco-muniche. Il laicismo, subito coniugato con lo statalismo,contrasta con la prospettiva laica della concezione libe-rale. Il laico non è un laicista. E un laicista non è un veroliberale. Lo Stato liberale, cioè laico,non ha un agnosticismo da privilegia-re o da imporre. L’agnosticismo – chepoi si impasta con il rifiuto di ognifede rivelata – è una concezione filo-sofica che, in una autentica societàaperta, convive con altre concezionifilosofiche e re ligiose della vita – èuna concezione rispettabile, ma nonpuò pretendere di essere onnivora, diergersi a «religione di Stato», e a giu-dice inappellabile di altre scelte di concezioni della vita,non può porgersi come unica prospettiva del sistemascolastico, e presumere di cancellare da questo sistemaquello che secoli di storia hanno costruito e ci hanno tra-
mandato: le visioni religiose della vita e della storia -oriz zonti di senso e di valori entro i quali spendere lavita. Un sistema sco lastico che al suo interno non favo-risce l’istituzione di scuole ad orien tamento religiosoproibisce lo sviluppo delle diverse identità; è frutto dimenti indottrinate e dogmatiche cariche di clericalismorovesciato.Si ripete, sempre da più parti, che le scuole private – esegnatamente quelle cattoliche – sarebbero «luoghi diindot trinamento», a differenza delle scuole statali vistecome centri di co struzione di menti critiche. È chiaroche siamo di fronte ad una accusa generica e generica-mente infamante. Insegnanti critici si trovano in scuolestatali e in scuole non statali; così come guarnigioni diinsegnanti dogmatici si trovano in scuole statali e nonstatali. Solo che da gli insegnanti dogmatici delle scuole
statali, le famiglie, che non hanno lapossibilità di mandare i propri figli inaltre scuole, non possono facil mentedifendersi. E che il dogmatismo abbiacostituito una malattia grave di tantidocenti, soprattutto negli anni passati,è testimoniato dal la estesa diffusionedi non pochi libri di testo – per esem-pio, di filoso fia, letteratura, storia –non costruiti di certo da menti scienti-fiche, aperte, capaci di dubbi e proble-
matiche, libri di testo che non hanno si curamente contri-buito a formare menti critiche.Altra obiezione, questa volta da parte di un noto giuristaitaliano: la Scuola deve rimanere saldamente e totalmen-
18libertas
Difesa della libertà di scuola
Il laico non è unlaicista.
E un laicista non è un vero liberale

te nelle mani dello Sta to a motivo del fatto che è soltan-to la scuola pubblica in grado di garantire la formazionedel cittadino. Ed ecco la replica di Angelo M. Petroni:«La tesi è semplicemente falsa sul piano descrittivo(qualcuno può pensare che il cittadino inglese formatoad Eton sia peggiore del cittadino italiano formato nelmigliore Liceo statale italiano?). Ma evi dentemente èancora più inaccettabile sul piano dei valori liberali.Dietro di essa vi è l’eterna idea dello Stato etico, di unoStato che ha il diritto di formare le menti dei propri cit-tadini/sudditi, sottraendo i gio vani alle comunità natura-li e volontarie, prime tra le quali quella della famiglia».L’introduzione del buono-scuola attuerebbe l’unicasoluzio ne compatibile con le regole di una democrazialibera: la possibilità di scegliere tra scuole diverse quel-la più affine alle proprie convinzioni culturali, filosofi-che e religiose. Solo la varietà, diversità e pluralità dellescuole possono garantire la libertà, che viceversa è nega-ta dalla unicità del sistema scolastico, compagna ineli-minabile del finanzia mento pubblico.
15. Luigi Sturzo e la difesa della scuola liberaCoraggioso e acuto difensore della competizione nelsistema scola stico, cioè della scuola libera, è stato donLuigi Sturzo. Si riportano, di seguito, alcune sue prese diposizione.- Nel luglio del 1947 su «Sophia» e sul n. 7 di «Idea»Sturzo pub blica un articolo riguardante La libertà dellascuola. Qui, con acume e preveggenza impressionantiSturzo pone il dito su di una piaga che da quei giorni nonsi è più rimarginata. Leggiamo: «L’eredità fascista nelcampo della scuola è stata disastrosa come in campomilitare e politico. Il monopolio statale fu completo; lascuola privata credette giovar si delle concessioni e deifavori che pagò con la perdita di ogni libertà didattica efunzionale». Dunque: per salvare la scuola è necessario,urgente, cambiare rotta; sennonché – egli annota – «ildisorientamento persiste, e le linee sostanziali tracciatedagli articoli 27 e 29 della Co stituzione (che poi diven-tarono gli articoli 33 e 34 del testo costituzio nale), inve-ce di fissare una chiara direttiva accettabile, con il loro
pe sante impaccio legislativo ne aggravarono la crisi».Un giorno un amico di Sturzo, colpito dalle aspre criti-che di costui nei confronti della scuola monopolizzatadello Stato, chiese quali fos sero le sue proposte per rifor-marla. E la sua risposta fu «di aprire le fi nestre e fareentrare una buona corrente d’aria di libertà, altrimenti visi morirà asfissiati». Certo, Sturzo ben conosceva leradici e le ragioni della scuola di Stato in Italia. Egli nonintendeva minimamente pro porne l’abolizione. Volevasoltanto che il sistema scolastico venisse riformato«senza improvvisazione e con sani criteri didattici esocia li». Ma il punto principale era, a suo avviso, «quel-lo dell’orientamen to dell’opinione pubblica verso lalibertà scolastica e contro il mono polio di Stato». Tuttociò nella convinzione che «finché la scuola in Italia nonsarà libera, neppure gl’italiani saranno liberi: essi saran-no servi, servi dello Stato, del partito, delle organizza-zioni pubbliche e private di ogni specie [...]. La scuolavera, libera, gioiosa, piena di en tusiasmi giovanili, svi-luppata in un ambiente adatto, con insegnanti impegnatialla nobile funzione di educatori, non può germogliarenell’atmosfera pesante creata dal monopolio burocraticostatale».- Sull’«Illustrazione italiana» del 12 febbraio del 1950Sturzo af fronta (con un articolo dal titolo: Scuola ediplomi) la questione dei di plomi – del pezzo di carta,del titolo rilasciato dallo Stato, visto come talismano ingrado «di aprire le porte dell’impiego stabile». Sturzo èdeciso: «Occorre capovolgere la situazione: sia lo stu-dio, non il diplo ma ad aprire le porte dell’impiego». Edecco la sua proposta: «Ogni scuola, quale che sia l’enteche la mantenga, deve poter dare i suoi di plomi non innome della repubblica, ma in nome della propria auto -rità: sia la scoletta elementare di Pachino o di Tradate,sia l’università di Padova o di Bologna, il titolo vale lascuola. Se una tale scuola ha una fama riconosciuta, unatradizione rispettabile, una personalità nota nella provin-cia o nella nazione, anche nell’ambito internazionale, ilsuo diploma sarà ricercato, se, invece, è una delle tante,il suo diploma sarà uno dei tanti». Sturzo, inoltre, siponeva il problema degli inse gnanti, e proponeva che siale scuole statali che quelle non statali avessero «il dirit-to di partecipare alla scelta dei professori» – giacchéaltrimenti si dovrebbe dire che le scuole siano esclusiva-mente in fun zione degli insegnanti.- La direzione dell’«Illustrazione italiana», nel pubblica-re l’artico lo di Sturzo, espresse in una nota alcune riser-ve. Sturzo, allora, inviò al giornale una lettera in cui pre-cisava che le sue idee sulla libertà di scuola erano notesin da prima della fondazione del partito popolare e che
19libertas
Difesa della libertà di scuola

egli l’aveva difesa nei quattro anni del suo segretariatopolitico «quando alla Camera furono contrastati i tredisegni di legge scolasti ca proposti da Croce, da Corbinoe da Anile». E aggiungeva che le sue esperienze inglese,olandese, svizzera, belga e americana dal 1924 al 1946«sono state posteriori, e sono servite a confermarmi nel-l’idea che solo la libertà può salvare la scuola in Italia».E poi: «La storia del “confessionalismo scolastico” chesi avvan taggerebbe della “libertà”, fa pendant con quel-la del “comunismo” che si avvantaggia della libertà, odel “laicismo” che si avvantaggia della libertà. Bisognascegliere o la libertà con tutti i suoi “inconvenienti”ovvero lo statalismo con tutte le sue “oppressività”. Ioho scelto la li bertà fin dai miei giovani anni, e tento dipotere scendere nella tomba senza averla mai tradita.Perciò ho combattuto in tutti i campi, e non solo in quel-lo scolastico, lo “statalismo”, sia quello pre-fascista, siaquello fascista, e combatto oggi lo statalismo post-fasci-sta, del quale parecchi dei miei amici, bongré, malgré, sisono fatti garanti.L’intolleranza scolastica dei laicisti è sostanziata dallapresunzione che essi difendono la libertà: mentre lalibertà non è monopolio di nes suno. Il monopolio scola-stico dello stato è sostanziato da una presun zione chesolo lo stato sia capace di creare una scuola degna delno me; mentre non è riuscito che a burocratizzarla e fos-silizzarla. In so stanza: non c’è libertà dove c’è intolle-ranza e dove c’è monopolio. Questa è la triste situazio-ne italiana». Lo era nel 1950. E lo è, disgra ziatamente,anche oggi.- Il sofisma della libertà appare su «La via» del 23 set-tembre del 1950. Qui Sturzo contesta le equazioni laici-ste stando alle quali «scuo la-di-stato uguale libertà d’in-segnamento: scuola privata uguale priva zione dellalibertà di insegnamento». In questa sede riveste tuttavia
grande rilevanza la lettera che lo stesso giorno, a com-pletamento dell’articolo, don Sturzo invia all’on. GuidoGonella, allora ministro della Pubblica istruzione:
«Caro Gonella,ho letto articolo per articolo il progetto di riforma scola-stica e, mentre apprezzo l’enorme lavoro compiuto e losforzo di dare ordine all’attuale sistema scolastico, hoparecchi dubbi, non poche perplessità e persino delleserie obiezioni. Forse, partendo da criteri diversi e daesperienze diverse, non troviamo il terreno comune diintesa in mate ria così grave e complessa. Mi rendo contoche tu non sei libero di at tuare un tuo ordinamento e seivincolato da tutto il sistema burocratico che opprime lascuola statale, e che tende a rendere soggetta allo stato lascuola non statale e tutte le iniziative culturali e assisten-ziali della scuola.Io combatto lo statalismo, malattia che va sempre piùsviluppando si nei paesi cosiddetti democratici, che inItalia (come in Francia) to glie respiro e movimento allascuola. Siamo arrivati a questo, che quella piccola e con-trastata partecipazione civica nell’ordinamento dellascuola (comune e provincia) che era nell’Italia pre-fasci-sta, non ha più posto neppure nel tuo progetto, e che lepoche attribuzioni date dalla costituzione alla regionesono, nel tuo progetto, regolamentate e soverchiate conl’ingerenza burocratica del ministero e degli ispettora tiregionali (violando, perfino, i diritti delle regioni a statu-to speciale). Non ti dico quale disappunto per me legge-re le disposizioni che ri guardano l’insegnamento privato.Un italiano andato in America, mi scriveva scandalizza-to che là non c’è un ministero della pubblica istruzione.Gli risposi, a giro di posta, che, perciò, l’americano è unpopolo libero e l’italiano no. Comprendo bene chel’Italia, senza lo stato (e il suo ministero della pubblicaistruzione) sarebbe senza scuole sufficienti per una
20libertas
Difesa della libertà di scuola

popola zione così densa e così povera; perciò bisognarassegnarsi alla scuola di stato, come il minor male, evi-tando, però, che resti così accentrata, burocratizzata emonopolizzata come l’abbiamo ereditata dai fascisti ecome, purtroppo, sembra che venga tramandata (auspicela democra zia cristiana) ai nostri posteri».
16. Perché Sturzo ammirava Maria MontessoriIl 6 maggio del 1952 si spegneva a Noordwijck, inOlanda, Maria Montessori. Nel giugno dello stessoanno, ancora su «La via», viene pubblicato un articolo diLuigi Sturzo intitolato Ricordando Maria Montessori.«1907: ero da due anni sindaco di Caltagirone. La scuo-la mi inte ressava più di ogni altro ramo dell’amministra-zione: non invano avevo insegnato per dodici anni alseminario vescovile, ed avevo già fatte le prime battaglieper la libertà della scuola. Le mie gitea Roma erano frequenti allora, sia perl’associazione nazionale dei comuni,della quale ero consigliere, sia per gliaffari del mio comune; così mi capitòdi incontrare presso amici la dottores-sa Montessori che mi invitò a vi sitarela sua scuola nel quartiere S. Lorenzo.Sapevo che sospetti di naturalismoavevano ostacolato l’iniziativa; dopoun lungo colloquio decisi di visitare lascuola e rendermi conto del tipo di scuola e delle ragio-ni del metodo. Andai più volte a S. Lorenzo; il mio inte-ressamen to si accrebbe di volta in volta; e MariaMontessori non dimenticò mai il piccolo prete che per ilprimo aveva preso diretto interesse alla sua iniziativa,l’aveva incoraggiata, ed aveva affermato che nessunapre giudiziale anticristiana fosse alla base di quell’inse-gnamento; cosa che poteva essere introdotta in questo ein altri metodi da maestri non cre denti. Da quel periodoiniziale non ebbi occasione di rivedere la Mon tessori chepiù tardi, in qualche sua sosta a Roma, dopo la fine dellaprima guerra mondiale, con rapidi incontri per conosce-re i progressi delle sue molteplici iniziative.Poscia a Londra, il giorno di S. Luigi 21 giugno del1925, in una casa religiosa di Fulham Road, mi vedoportare nella mia stanzetta, un bel mazzo di garofanibianchi: erano della Montessori ed io ignoravo ch’ellafosse nella stessa città. Mi si fece viva in un giorno a mecaro: in un’ora di forte nostalgia, quando lontano dallasorella e dagli amici, mi venivano in mente le care festedell’onomastico, in un paese dove l’onomastico non siricorda e di amici a Londra non ne segnavo allora chepochi, anzi pochissimi. Così ci rivedemmo; e si parlò
dell’Italia, soprattutto dell’Italia, e delle vicende nostre edello sviluppo del meto do Montessori nel mondo, e deipiani del futuro e ricordammo la visita del prete caltagi-ronese alla scoletta di S. Lorenzo.L’alone di simpatia e di fiducia che circondarono le varieiniziative all’estero della Montessori e la diffusione delsuo metodo, il premio Nobel, tutto servì a far mettere inprima linea nel mondo la figura di questa italiana. Laconfrontavo con un’altra italiana, maestrina, fonda tricedi ordine religioso, allora beata e poscia santa FrancescaSaverio Cabrini, che l’America del nord stima sua con-cittadina, e che ha fama anche presso il mondo prote-
stante. L’avevo conosciuta anch’essaper sonalmente, dieci anni prima diaver conosciuto la Montessori, pro-prio per il mio interessamento allescuole infantili ed elementari, neldesi derio di avere a Caltagirone unacasa delle figlie missionarie del S.Cuore da lei fondate; così come avevodesiderato aprirvi una scuola Mon -tessori. Le mie iniziative fallironoallora, l’una e l’altra per man canza disoggetti.
Mi son più volte domandato perché da quarantacinqueanni ad oggi, il metodo Montessori non sia stato diffusonelle scuole italiane. Allora come oggi, debbo dare lastessa risposta: si tratta di vizio organico del nostro inse-gnamento: manca la libertà; si vuole l’uniformità; quel-la im posta da burocrati e sanzionata da politici. Mancaanche l’interessa mento pubblico ai problemi scolastici;alla loro tecnica, all’adattamento dei metodi, alle moder-ne esigenze. Forse c’è di più: una diffidenza ver so lo spi-rito di libertà e di autonomia della persona umana, che èalla base del metodo Montessori. Si parla tanto di liber-tà e di difesa della li bertà; ma si è addirittura soffocatidallo spirito vincolistico di ogni atti vità associata dovemette mano lo Stato; dalla economia che precipita neldirigismo, alla politica che marcia verso la partitocrazia,alla scuola che è monopolizzata dallo Stato e di conse-guenza burocratizzata».
21libertas
Difesa della libertà di scuola
Mi son più voltedomandato perché
da quarantacinque anniad oggi, il metodo
Montessori non sia statodiffuso nelle scuole
italiane.

L’ennesima messa in scena del Governo Renzi, incontemporanea con l’enfatico annuncio deimilioni di posti di lavoro magicamente creati
dal Jobs Act (ma chi ci crede?), si è consumata sul pal-coscenico della concorrenza. Nell’articolo 1 “Finalità” del disegno di legge licenziatodal Consiglio dei Ministri si legge che “la pre-sente legge interviene a rimuovere ostacoliregolatori all’apertura dei mercati, a promuo-vere lo sviluppo della concorrenza e a garanti-re la tutela dei consumatori, anche in applica-zione dei principi del diritto dell’Unione euro-pea in materia di libera circolazione, concor-renza e apertura dei mercati, nonché, alle poli-tiche europee in materia di concorrenza”. Oh,finalmente…si potrebbe dire! E, invece, no. Per rasentare il ridicolo, ormai ilGoverno Renzi gli annunci li inserisce anche neitesti di legge, quasi a voler dire “noi l’abbiamoscritto, se non succede nulla che volete da noi?La colpa sarà dei soliti gufi”.Al di là degli scherzi, se già le lenzuolate di ber-saniana memoria apparivano ben poca cosarispetto alle esigenze di concorrenzialità delPaese, le punture di spillo di Renzi, più che apromuovere la concorrenza e a liberalizzare imercati, sembrano poco più che un timido (e difficil-mente realizzabile) tentativo teso a far risparmiare qual-che spicciolo a qualche consumatore. Non si intravede,dunque, né una strategia per favorire la crescita, né ungrande piano redistributivo teso a promuovere l’equitàsociale. Ancora una volta, non resta che molta propagan-da e poca sostanza. Ma, del resto, è questa la cifra delGoverno Renzi. Si interviene su qualche settore (assicurazioni, energia,professionisti, telecomunicazioni, servizi bancari, far-macie), si pone qualche obbligo in più sulle imprese, siimpongono per legge sconti o prezzi amministrati, si tra-sferisce un regime di privativa da una categoria ad un’al-tra (magari meno costosa), si permette l’ingresso deisoci di capitale in studi legali e farmacie, tenendosi ben
alla larga dal nodo dei conflitti di interesse insiti nelsistema, ed ecco fatto, si raggiungono ben tre obiettivi inun colpo solo. Il Governo Renzi può continuare a spac-ciare per grandi riforme strutturali interventi marginali espesso dannosi per il Paese, gli elettori (forse) risparmia-no qualche euro su qualche aspetto altrettanto margina-le della propria vita (ovviamente, da compensarsi conqualche altro aumento di tasse), ed il sistema economi-co – almeno nei talk show e sui giornali - diventa con-correnziale. È l’impostazione che è sbagliata. La concorrenza aiuta arendere più efficienti i mercati e, mercati più efficienti,significa spesso prezzi più bassi, migliore qualità delleprestazioni ed un maggiore grado di innovazione. Soloseguendo quest’ordine, un intervento normativo teso a
22libertas
Fabio G. Angelini
Economia sociale di mercatoLe punture di spillo non rendono più competitivo il Paese

“rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati,a promuovere lo sviluppo della concorrenza” può ambi-re, nello stesso tempo, a tutelare i consumatori miglio-rando i servizi ed abbassandone i costi, ad attirare gliinvestimenti e a creare sviluppo. Occorre tradurre in provvedimenti nor-mativi una ricetta economica precisache, puntando sulla concorrenza e sullaliberalizzazione dei mercati - da realiz-zarsi principalmente riducendo il peri-metro dell’intervento pubblico nel-l’economia, rimuovendo le situazionidi conflitto di interesse e riducendo imargini di discrezionalità della pubbli-ca amministrazione - possa innescareun modello di sviluppo incentrato sul-l’inclusione e sull’equità sociale, rove-sciando il paradigma su cui ancor oggipoggia il nostro sistema economico-imprenditoriale. Il paradigma cioè delle istituzioniestrattive che, concentrando il potere (economico, poli-tico, mediatico) nelle mani di pochi, priva il sistema diquella dinamicità e creatività necessaria per competeresui mercati globali e risulta incapace di promuovere lacoesione sociale. Seguendo tale impostazione, uno dei terreni su cui è piùurgente intervenire è quello dei servizi pubblici o,meglio, dei servizi di interesse economico generale che,per la loro rilevanza economica, possono avere un gran-de impatto in termini di attrazione di nuovi investimen-ti. Pensiamo al settore dei trasporti, a quanto la crescita
dimensionale di un aeroporto (e non certo la prolifera-zione di tanti piccoli aeroporti ad uso e consumo degliinteressi di pochi) e l’affidamento della relativa gestionead operatori internazionali scelti con gara possa favorirelo sviluppo del turismo. In questo senso, anche se la strada è ancora lunga,l’esempio della Puglia e di come lo sviluppo degli aero-porti di Bari e Brindisi abbia favorito gli investimenti è
illuminante. Pensiamo al settore deiservizi pubblici locali, dove la con-correnza può giocare un ruolo fonda-mentale per favorire l’integrazione trai piccoli operatori ed il progressivoabbandono del modello del capitali-smo pubblico locale, ovvero, perscardinare le rendite di posizione efavorire nuovi investimenti infrastrut-turali. In questo senso, ove le condi-zioni di mercato lo permettano,occorrerebbe superare completamen-te il modello della “concessione diservizi”, sostituendola con un piùsemplice “contratto di servizi” che –
su aree vaste – definisca gli obblighi di servizio pubbli-co e regoli l’utilizzo dei beni pubblici necessari perl’erogazione dei servizi. E, ancora, fare uscire la politicadalla gestione di tali attività, liberando i concessionaridei servizi pubblici dalle catene del clientelismo e, inqualche caso, purtroppo anche della corruzione.Pensiamo ancora a quante attività, specie nel settoresociale, potrebbero essere svolte anziché da organizza-zioni burocratiche, dalla società civile, promuovendoinvestimenti nel terzo settore e liberando interi comparti(dalla salute ai servizi sociali) dal peso della burocraziae degli interessi di parte. Pensiamo, infine, a quanto ilnostro Paese necessiti di un’industria dei servizi effi-
23libertas
La concorrenza aiuta a rendere più efficienti i mercati e, mercati più
efficienti, significaspesso prezzi più bassi,
migliore qualità delle prestazioni
ed un maggiore gradodi innovazione
Economia sociale di mercatoLe punture di spillo non rendono più competitivo il Paese

ciente e competitiva (turismo, cultura, finanza, profes-sioni, informazioni, ecc…), capace di diventare motoredello sviluppo e di supportare adeguatamente il settoremanifatturiero; e di quanto, invece, l’eccessiva invaden-za del settore pubblico ne impedisca spesso la crescita.In particolare, l’industria dei servizi informativi andreb-be completamente liberalizzata, mettendo a disposizionedel mercato l’immenso patrimonio informativo pubbli-co, permettendo l’erogazione di servi-zi a valore aggiunto in grado di accre-scere la competitività delle nostreimprese. Sono questi i settori di intervento sucui dovrebbe concentrarsi un disegnodi legge sulla concorrenza. È su que-sti temi, su cui però non si riscontranoproposte, che si gioca tanto la crescitaquanto la capacità del sistema econo-mico di creare nuovi posti di lavoro. Nel suo intervento, il Premier Renziha sottolineato come convivano duediverse immagini dell’Italia e degliitaliani. La considerazione è certa-mente condivisibile, ma le motivazioni fornite per giu-stificarle però no. L’immagine di chi guarda l’Italia dal-l’esterno, riconoscendo la creatività, la capacità di adat-tarsi e di rimboccarsi le maniche degli italiani non va
contrapposta a quella degli italiani chepraticano lo sport di lamentarsi ad ognicosto del proprio Paese. No, non è cre-dibile. L’altra immagine dell’Italia,infatti, è quella di chi la guarda dall’in-terno, di chi spesso trova sbarrate leporte del proprio futuro a causa di unsistema che si alimenta di clientele e dicorruzione, in cui il sistema bancariofinanzia le persone (ed i connessi inte-ressi) piuttosto che le idee, in cui icosti (soprattutto quelli immateriali)per l’avvio di un’impresa risultano tal-
mente elevati da scoraggiare anche le buone idee.Promuovere la concorrenza significa scardinare proprioqueste barriere e, quindi, promuovere un modello inclu-
sivo, fondato sull’equità e sul merito.Questo però non c’entra davvero nulla coni piccoli interventi sulle tariffe assicurativeo sulla concorrenza nella distribuzione deicarburanti per autotrazione o, ancora, sul-l’eliminazione dei vincoli per il cambio difornitore di servizi di telefonia. Avrannosicuramente la loro utilità, ma per favorenon chiamiamoli interventi pro concor-renziali.
24libertas
Spesso trova sbarrate le porte del proprio
futuro a causa di un sistema che
si alimenta di clientele edi corruzione, in cui il sistema bancariofinanzia le persone
(ed i connessi interessi)piuttosto che le idee
Economia sociale di mercatoLe punture di spillo non rendono più competitivo il Paese

Il 22 luglio del 1944, in una città del New Hampshire,molto probabilmente fino a quel momento conosciu-ta solo ai suoi abitanti, si firmavano gli accordi di
Bretton Woods. Il problema economico fondamentaledel Dopoguerra, e che la conferenza di Bretton Woodsintendeva affrontare, era evitare un sistema di cambiflessibili che avrebbero potuto alimentare le ragioni delconflitto internazionale. Per scongiurare un tale esito sidiede inizio ad un processo, finalizzato alla creazione diistituzioni internazionali e ad un sistema di convertibili-tà della moneta a cambio fisso.Nella Primavera del 1944 vennero presentati ai Paesimembri ONU il Piano Keynes e il Piano White, dalnome dei due principali estensori. Mentre il primo pro-poneva un’unione internazionale di Clearing, il secondoindicava un fondo internazionale di stabilizzazione. Inentrambi i casi, lo scopo era di individuare un meccani-smo per risolvere il problema economico delDopoguerra: saldo del deficit, bilancia dei pagamenti indeficit, restrizione della domanda estera, recessioneinternazionale. In definitiva, con gli accordi di BrettonWoods si intese ricercare un meccanismo di cambio coo-perativo globale per ristabilire unequilibrio tra le singole nazioni.Con il Piano Keynes emergerannole proposte di una Banca CentraleSoprannazionale e del Bancor,un’unità di moneta internazionale,per compensare il deficit dellabilancia dei pagamenti. L’obiettivoera di istituzionalizzare un governomondiale della moneta medianteincentivi e disincentivi, rispettiva-mente, per deficit e surplus. Il PianoWhite proponeva un Fondo diStabilizzazione che avrebbe potutoconcedere crediti a paesi con deficitda bilancia dei pagamenti, previacompatibilità della politica econo-mica, nonché si sarebbe agganciatala valuta di ogni Stato membro al
dollaro e quest’ultimo all’oro: cambio aureo.Il 1° luglio del 1944 a Bretton Woods ebbe inizio laConferenza Monetaria e Finanziaria Internazionale delleNazioni Unite che si concluse il 22 luglio con un com-promesso tra Keynes e White e la nascita del FondoMonetario Internazionale (FMI) e della BancaInternazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo(BIRS). La prima istituzione rispondeva alla propostaWhite, la seconda a quella di Keynes. In pratica, si sta-biliva la convertibilità delle valute in dollari e l’agganciodi quest’ultimo all’oro, con un’oscillazione massima
25libertas
Economia sociale di mercato
di Flavio Felice70° di Bretton Woods e la perenne tentazione del serpente

dell’1%. Una volta stabilita la parità monetaria nessunol’avrebbe potuta modificare, se non per correggere unosquilibrio fondamentale e dopo aver accolto i suggeri-menti del Fondo. La difesa della parità bilaterale era affi-data alle Banche Centrali che, mediante interventi nelmercato monetario, acquistando o vendendo, avrebberoricondotto la valuta dentro i parametri.Il meccanismo che ne verrà fuori sarà quello della dop-pia convertibilità, detto Gold Exchange Standard, inforza del quale la valuta statunitense assumerà il centrodel sistema monetario internazionale, diventerà mezzodi pagamento e strumento di riserva.Il meccanismo prevedeva che i singoli Paesi si impe-gnassero a convertire la propria valuta in dollari ad unprezzo fisso, riservandosi il diritto (minaccia) di conver-tire i dollari in oro al prezzo concordato. Ad ogni modo,la minaccia non fu sufficiente e ragioni politiche, unite arigidità interne, decretarono il fallimento del meccani-smo che entrò in vigore solo alla fine del 1958. Negli anni ‘60 aumentò il costo di produzione dell’oro eil dollaro si deprezzò e i dollari provenienti dal deficitdei pagamenti divennero fonte di liquidità internaziona-le: la Federal Reserve avrebbe dovuto accrescere le sueriserve auree in misura proporzionale all’emissione didollari, ma il cambio, essendo anacronistico, divenneinsufficiente a remunerare la produ-zione. L’aumento della spesa pubblicastatunitense, anche per finanziare laguerra in Vietnam e il crescente inde-bitamento fecero aumentare le richie-ste di convertibilità del dollaro in oro.Di fatto, il 15 agosto del 1971, ilPresidente Richard Nixon dichiarò lasospensione della convertibilità deldollaro in oro. Alla fine degli accordisi giunse nel dicembre del 1971 con loSmithsonian Agreement che compor-tò la svalutazione del dollaro e il ritor-no a cambi fluttuanti. La fine degliaccordi di Bretton Woods non signifi-cò lo smantellamento delle istituzioniche quegli accordi avevano sancito e,sebbene con compiti diversi, il Fondo MonetarioInternazionale e la Banca Centrale sopravvissero, men-tre il General Agreement on Tariff and Trade (GATT) nel1995 venne sostituito con il World Trade Organization(WTO).Molta acqua è passata sotto i ponti da allora ad oggi el’istituzione della moneta unica europea ha di fattomodificato lo scenario economico e monetario interna-
zionale. La crisi finanziaria ed economica registrata dal2007 ad oggi e l’emergere di nuove economie (BRICS)hanno spinto alcuni esperti e operatori economici a pro-porre la convocazione di un grande summit, una sorta dinuova Bretton Woods per ridiscutere le regole del giocoeconomico a livello globale. In tal caso, credo sia oppor-tuno avere un’idea chiara sull’oggetto e sul metodo deilavori.Qualora il tema fosse riequilibrare il peso delle econo-mie tradizionalmente avanzate con quello delle econo-mie dei paesi emergenti, registriamo un significativopasso avanti con gli accordi di Fortaleza dello scorso 16
luglio e la costituzione della cosiddet-ta banca BRICS, articolata nella NewDevelopment Bank (NDB) e in unFondo di riserva monetario denomina-to Contingent Reserve Arrangement(CRA – Accordo sui Fondi diRiserva). La banca avrà sede aShangai e sarà operativa dal prossimoanno, avrà un presidente dei governa-tori russo, un presidente del consigliodi amministrazione brasiliano, mentreil presidente della banca sarà indiano.Alla nuova banca potranno aderireanche altri paesi delle Nazioni Unite,sebbene la quota dei BRICS non potràscendere sotto il 55%. Lo scopo
dichiarato è di “rafforzare, sulla base di sani principibancari, la cooperazione tra i Paesi BRICS, integrare glisforzi delle istituzioni finanziarie multilaterali e region-ali per lo sviluppo globale, contribuendo a conseguirel’obiettivo di una crescita forte, sostenibile ed equilibra-ta”. In pratica, come registrato da alcuni commentatori(non molti sinceramente, cfr. Tino Oldani, Putin e iPaesi Brics fondano una Banca che sotterra Bretton
26libertas
Il meccanismo che ne verrà fuori saràquello della doppia
convertibilità, detto Gold Exchange
Standard, in forza del quale la valuta
statunitense assumerà il centro del sistema
monetariointernazionale
Economia sociale di mercato70° di Bretton Woods e la perenne tentazione del serpente

Woods e rivoluziona la governance mondiale. Sui gior-naloni, neppure una riga, in “Italia Oggi”, 18/7/2014), sitratta della nascita di una nuova Banca mondiale e delsuperamento della logica di Bretton Woods, che vedevagli Stati Uniti e il dollaro al centro del sistema globale,dotata di ampie riserve, che si pone come alternativa alFMI e alla Banca Mondiale, e crea le premesse di unanuova architettura e governance finanziaria globale,“dove gli Stati Uniti non potranno più fare il bello e ilcattivo tempo”.Diverso il discorso se per “nuova Bretton Woods” inten-diamo l’operazione ingegneristica di government, tesa apretendere di voler ridisegnare a tavolino “l’architetturadel nuovo capitalismo”, un’autorità politica ed economi-ca globale, questa volta immune dai limiti e dalle imper-fezioni che hanno sancito la crisi dell’attuale sistema.Per procedere in questa direzione, in primo luogo, biso-gnerebbe condividere il giudizio sul capitalismo e sulleragioni della crisi e, ad oggi, non mi sembra che ci siauna simile comunanza di vedute, ma soprattuttodovremmo essere d’accordo sull’ipotesi che l’attualecrisi stia aprendo ad un nuovo modello economico cheprescinda dal libero mercato globale, ovvero se non stia,più realisticamente, correggendone le storture, per con-
sentire alle istituzioni di funzionaremeglio.Ammesso e non concesso cheabbiano ragione coloro i qualisostengono che la gravità dell’at-tuale crisi necessiti di una rivolu-zione paradigmatica e non soltantodi profonde riforme, al momento,credo che nessuno possieda glistrumenti analitici, la conoscenza ela sufficiente prospettiva storica perprevedere quale sia, da un punto divista sistemico, l’esito dell’attualecrisi. Nel 1944 a Bretton Woods erafisicamente e culturalmente crolla-to un mondo, era definitivamentefallita un’idea di nazione, c’erano
dei vincitori e dei vinti, l’oggetto del “sinodo” era chia-ro a tutti ed anche l’individuazione del metodo dei lavo-ri appariva ragionevolmente condiviso. Dunque, una cosa è operare per istituzionalizzare lapoliarchia e riequilibrare posizioni di dominio anacroni-stiche, altro è proclamare la sentenza di morte della“mano invisibile”. Alcuni sostengono che l’attuale crisidimostrerebbe che abbiamo sempre più bisogno di una“mano visibile” e che una nuova Bretton Woods dovreb-be orientare gli Stati in questa direzione. È evidente cheè entrata in crisi una certa interpretazione anarcoide delmercato ed è giusto evidenziarne i limiti teorici. Ad ognimodo, sappiamo che l’espediente della “mano invisibi-le” è stato elaborato da Smith “non tanto e non solo” perconsolidare teoricamente il laissez faire, quanto per evi-denziare “anche e soprattutto” un dato epistemologicoda sempre conosciuto dagli studiosi delle scienze socia-li: il problema delle conseguenze inintenzionali delleazioni intenzionali. Una nuova Bretton Woods, alla lucedella teoria della “mano invisibile”, dovrebbe tenereconto in primo luogo delle conseguenze non intenziona-li dei piani posti in essere dal “grande architetto” diturno.
27libertas
Economia sociale di mercato70° di Bretton Woods e la perenne tentazione del serpente

In breve, in termini economici, esistono azioni “buone insé” che ci esimano dalla responsabilità di controllarne leconseguenze? Ovvero dovremmo preoccuparci anchedelle conseguenze non intenzionali di azioni poste inessere da persone mosse delle migliori intenzioni? Lasaggezza popolare a questo punto offre una miriade diproverbi, di aforismi e di aneddoti che tutti conosciamo. Il broker che avesse agito in vista delle conseguenze nonsolo su di sé, ma anche su altri sé, avrebbe contribuito acostruire un sistema finanziario più virtuoso. Dunque, il“sistema” dipende dalla prospettiva morale del broker edei tanti broker, del banchiere e dei tanti banchieri, del-l’imprenditore e dei tanti imprenditori, del governante edei tanti governanti. Le regole sono espressione di unadeterminata prospettiva antropologica, la quale non èmai neutra, è sempre figlia di una visione etica. Eccoperché non mi convince una nuova Bretton Woods che siprefigga obiettivi salvifici, mentre trovo estremamenteinteressante la nascita di nuove istituzioni che di fattomodificano dal di dentro il sistema economico interna-zionale; se la sfida è morale, con quali arnesi andremmoa sostituire un sistema che di per sé non nega la virtù?Semmai non la favorisce, non la premia e, fortunatamen-te, non la impone, con un altro sistema altrettanto imper-fetto? Allora, dovremmo adoperarci per correggere ilsistema globale sempre più poliarchico e rendere piùinnocue possibili le azioni viziose, attraverso un sistemadi governance costituito da pesi e contrappesi (le regoleed i controlli) che Sabino Cassese ha indicato conl’espressione “Global Polity”
1. Tuttavia, esisterà mai un
sistema politico-economico (fatto di/da uomini per altriuomini) che “renda impossibile il male”, in forza delquale l’uomo non possa che agire sempre in modo vir-tuoso per sé e per gli altri ed in virtù del quale tale azio-ne virtuosa rappresenti un bene per tutti e per ciascuno?Ovvero non sarebbe anche questa una versione nobiledell’onnipresente tentazione del serpente?
1 SABINO CASSESE, Chi governa il mondo?, il Mulino, Bologna, 2013. Mi permetto di rinviare alla mia recensione pubblicata da “La civiltà cattolica”,Quaderno N° 3932 del 19/04/2014.
28libertas
Economia sociale di mercato70° di Bretton Woods e la perenne tentazione del serpente

1. Note introduttiveNella dottrina sociale della Chiesa il tema delle banchenon è un tema occasionale o strumentale, come sembraemergere da tesi correnti degli economisti vicini allacosiddetta finanza laica che fa guerra alla finanza cattoli-ca. Va infatti tenuto presente che per molto tempo, nelpensiero cristiano, dalle origini all’alto medioevo, nelcampo finanziario, ha avuto un ruolo dominante la teoriadel credito come usura, basata su due temi. Il primo èquello del prestito alle persone per scopi di consumo, incui è facile osservare che non vi è un elemento di produt-tività, che giustifichi un tasso di interesse. Il secondo,connesso solo in parte al primo, quello del prestito esoso,ossia usurario nel senso proprio attuale e di Roma antica,in cui il creditore sfrutta ed opprime il debitore con tassiesorbitanti che esso non riesce a ripagare anche quandoimpiega il denaro in attività produttive, dato che esse nonpossono avere un rendimento così elevato. Una impor-tante svolta, rispetto a questa impostazione
1, si è avuta già
nel VI secolo con Sant’Ambrogio che tratta dell’usuracome attività finanziaria eticamente illecita e quindi vie-tata dal diritto canonico solo in rela-zione al prestito esoso e ingannevoleal consumo, ma allora questa dottrina,di grande rilievo teorico nella storiadel pensiero economico, era minorita-ria. La svolta decisiva si è avuta nelbasso medioevo nel XV secolo con lateoria di San Bernardino da Siena, percui il prestito bancario alle imprese varemunerato perché il denaro è produt-tivo in quanto consente di acquistare iltempo necessario per effettuare la produzione e la produ-zione dei beni che servono all’uomo nella produzione.Però il tempo, che produce il reddito tramite il capitalefisso e circolante, è un fatto divino, il tempo è di Dio e gliva reso, mediante un impiego fruttuoso economicamenteeffettuato in modo efficiente ed onesto
2. L’idea della fun-
zione sociale del risparmio e del credito comincia a ger-mogliare nel pensiero cristiano del rinascimento,mediante la creazione di istituti di credito che non siano
usurari, cioè iniqui nel senso della teoria di san Tommasodella giustizia commutativa nei contratti (con eguaglian-za aritmetiche) e distributiva nelle azioni collettive, pub-bliche e private (eguaglianza geometrica ossia riparto deivantaggi e delle perdite in rapporto alle quote di lavorosvolto, di capitale impiegato, di merito esplicato)
3. Il
Monte dei Paschi di Siena nel medioevo è un esempiotipico di questa elaborazione culturale del pensiero cri-stiano perché ciascuno conferisce una quota di risparmioal fondo comune “il Monte” e ha diritto a una remunera-zione proporzionale della sua quota (principio di giusti-zia distributiva) e ottiene da questo Monte di cui è com-
proprietario un prestito basato sul tassoche è stato pagato a chi conferisce più icosti e il rischio del prestito (principiodi giustizia commutativa)
4.
Ma bisogna attendere il milleottocento,nell’epoca capitalistica, per avere ilpensiero ufficiale della Chiesa Cat -tolica riguardo alla banca sulla base diteorie che hanno rilevanza per la scien-za economica, che si era, nel frattempo,sviluppata a livello teorico e di politica
economica e sociale con varie scuole. In essa si dibattevala questione del ruolo del mercato e dello stato nell’eco-nomia, che – per certi teorici - poteva spingersi a un vastosettore di imprese pubbliche e spese pubbliche finanzia-te con tributi e debito pubblico e controlli pubblici, e peraltri, come Marx, anche al collettivismo. Nella formulazione allora prevalente alle insufficienzedel mercato, nei suoi stili individualistici di ricerca delmassimo utile, provvede lo stato mediante l’economia
29libertas
La dottrina sociale della Chiesa,il principio di sussidiarietà, le Casse di credito Cooperativo e le Banche Popolari
di Francesco Forte
Nella dottrina socialedella Chiesa
il tema delle banchenon è un temaoccasionale ostrumentale
DIB
ATT
ITI

pubblica. La dottrina cattolica e, poi, anche quellacristiana non cattolica contrappone a questa dicoto-mia un modello più articolato, ispirato al principiodella sussidiarietà, sia verticale, fra persona e pote-re pubblico periferico e centrale che orizzontale fraazioni personali e azioni collettive private con con-trollo delle persone, organizzazioni cooperative,organizzazioni non profit e potere pubblico ad ognilivello verticale locale, regionale, nazionale, sovra-nazionale e internazionale.
2. Il principio di sussidiarietà nelle Encicliche e inEucken e Ropke
Il principio di sussidiarietà nasce con l’Enciclica diLeone XIII sulla “Costituzione cristiana degli stati”che comincia con la parola “Libertas” e ivi vienecosì enunciato “lo stato è un organismo rivestito diautorità, che ha per fine un bene pubblico e cioè ilraggiungimento di quei beni che l’opera privata dasola non può raggiungere”. Questo concetto è ripre-so e chiarito nella “Rerum Novarum” con il branoin cui si dice “Noi parliamo dello stato, non come è costi-tuito o come funziona in questa o quella nazione, madello stato nel suo vero concetto, quale si desume daiprincipi della retta ragione, in perfetta armonia con ledottrine cattoliche come noi medesimo esponemmo ne“la Costituzione cristiana degli stati”
5Nella Enciclica
“Quadragesimo anno” del 1931 di Pio XI, il fondamentoe il contenuto del principio di sussidiarietà vengono ulte-riormente sviluppati con le seguenti parole “ siccome nonè lecito togliere agli individui ciò che essi possono com-piere con le forze e l’industria propria per affidarlo allacomunità, così è ingiusto rimettere a una più alta socie-tà quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.Ed è questo, insieme, un grave danno e uno sconvolgi-mento del retto ordine della società poiché l’oggettonaturale di qualsiasi intervento della società stessa è quel-lo di aiutare in maniera sussidiaria le membra del corposociale, non già di distruggerle o assorbirle”. La dottrina della sussidiarietà viene adottata in modosistematico dalla teoria economica liberale di WalterEucken, capo scuola di Ordo, la scuola di Friburgo da cuitrae origine l’economia sociale di mercato e da WilhelmRopke, che si ricollega a questa scuola con la sua teoriadell’economia liberale di concorrenza, la terza via fra ilcapitalismo storico e il dirigismo. Eucken nei suoi “Principi di politica economica”
6scrive
che la fonte originaria del principio di sussidiarietà è nel-l’opera di Tommaso d’Aquino, ma che la sua applicazio-ne ai problemi sociali del nostro tempo si deve alle due
grandi encicliche papali Rerum Novarum del 1891 eQuadragesimo anno del 1931, che pongono come princi-pio superiore della conformazione della vita sociale lasussidiarietà: “l’edificio della società deve procedere dalbasso verso l’alto. Quello che i singoli e i gruppi posso-no fornire da soli deve essere lasciato alla loro iniziativaper realizzarlo con i loro sforzi migliori. Lo Stato deveintromettersi solo quando il loro reciproco aiuto non è inalcun modo sufficiente”. Come si nota nell’interpretazio-ne di Eucken le associazioni private per obbiettivi di inte-resse e di bene comune sono espressione del principio disussidiarietà. Ropke, analogamente, definisce la sussidiarietà come il“principio del decentramento politico” e, in Civitas Hu -mana (1947) scrive “il principio del decentramento poli-tico è un principio universale e largo, che sorpassa i limi-ti del principio federativo e potrebbe definirsi nel migliormodo con una espressione presa dalla dottrina socialecattolica come principio della sussidiarietà. Ciò vuoldire che dal singolo individuo sino al centro statale, ildiritto originario è sul gradino più basso e ogni gradinosuperiore subentra soltanto come sussidio al posto diquello immediatamente più basso quando un compitoesorbita dal territorio di quest’ultimo. Ne risulta una gra-dinata dall’individuo attraverso la famiglia e il comunealla provincia e infine allo stato centrale, una scala chedelimita lo stato stesso e vi contrappone il diritto propriodei gradini inferiori con la loro inviolabile zona di liber-tà. In questo senso sussidiario, il principio del decentra-
30libertas
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

mento politico contiene già il programma del liberalismonella sua accezione più lata e generale, un programmache è una delle condizioni essenziali di uno stato sanoche impone a sé steso i limiti necessari e conserva nelrispetto delle libere zone non statali la propria sanità , lapropria forza e stabilità”
7.
L’Enciclica Centesimus annus adotta esplicitamente ilprincipio di sussidiarietà, accanto a quello di solidarietàcon questa affermazione. “Esiste certo una legittima sferadell’agire economico in cui lo stato deve entrare -Questo, però, ha il compito di determi-nare la cornice giuridica al cui internosi svolgono i rapporti economici e disalvaguardare in tal modo le condizio-ni prime di una economia libera chepresuppone una certa eguaglianza frale parti. Al conseguimento di questifini lo stato deve concorrere sia diretta-mente che indirettamente. Indirettamente e secondo il principiodi sussidiarietà, creando le condizionifavorevoli al libero esercizio dell’atti-vità economica, che porti ad una offer-ta abbondante di opportunità di lavoroe di ricchezza. Direttamente, secondo il principio di soli-darietà ponendo a difesa dei più deboli alcuni limitiall’autonomia delle parti, che decidono le condizioni dellavoro e assicurando in ogni caso un minimo vitale allavoratore disoccupato”
8.
3. Il principio di sussidiarietà, il risparmio e il creditobancario
Il principio di sussidiarietà orizzontale comporta di pre-ferire le istituzioni del mercato più vicine alla personarispetto a quelle che se ne distaccano maggiormente.Quindi le cooperative rispetto alle imprese in cui si scin-de il lavoro dal capitale e il processo produttivo fra unaparte forte e una debole. Esso comporta altresì di preferi-re, per il risparmio e per il prestito, le banche che opera-no sul territorio per la clientela dei piccoli operatori eco-nomici e delle famiglie, formate in gran parte da piccoli
azionisti, legati al territorio in cui esse operano. Nel suoriferimento alla cooperative e alle banche del territorio,anche non cooperative, come le casse di risparmio e lecasse rurali, il movimento a cavallo fra 800 e 900, ispira-to al pensiero cristiano e alla dottrina sociale della Chiesasi è intrecciato al riformismo ottocentesco dei liberaliriformatori tedeschi di religione protestante comeHermann Schulze Delitsch
9che si focalizza sul riferi-
mento alla comunità cioè al territorio e il pastore prote-stante Friedrich Wilhelm Raiffeisen
10che insiste invece
sulla cooperazione In Italia questo pensiero e analogheiniziative sono sviluppate dai liberali riformatori.Alessandro Rossi cattolico
11e Luigi Luzzatti
12laico di
origine ebraica, si fanno propugnatori del modello diSchulze. Leone Wollemborg laico che si ispira al Van -gelo
13, invece, si fa propugnatore del modello di Raif -
faisen, per le casse di credito14. Wollemborg teorizza la
coesistenza di cattolici e non cattolici nelle casse rurali,purché ispirati al medesimo principiodi reciproco aiuto con una circoscri-zione su base parrocchiale o comuna-le. Don Luigi Cerutti, leader del movi-mento cattolico italiano delle casserurali, si ispira al pensiero diWollemborg per la creazione di cassedi credito rurali. Questi critica la pras-si della distribuzione di dividendi,come l’economista cattolico GiuseppeToniolo. Entrambi argomentano chel’utile, derivante dal moderato tasso diinteresse applicato dalla cassa e dalrisparmio sui costi, non va distribuito,
ma accumulato come riserva indivisibile, per irrobustirela cassa di fare credito e accrescerne la capacità di finan-ziare le classi umili, nei loro investimenti
15. Il Toniolo, a
differenza del Wollenborg, sostiene la necessità che lebanca cooperative di credito cattolico siano collegate alleattività del clero cattolico e quindi autonome da quellelaiche. Il tema era allora complicato dal divieto ai catto-lici di partecipazione alla vita politica che stimolava a farpolitica con altri mezzi
16. Tuttavia sino al 1919 anche le
casse rurali cattoliche fecero parte della Lega nazionaledelle cooperative, in cui prevalevano, oramai, quellesocialiste. Il modello cooperativo era nato dal pensierodei socialisti non marxisti come il francese Proudhommee il tedesco Lasalle quale strumento per superare la dico-tomia fra capitale e lavoro; e fra piccoli produttori agri-coli e trasformatori del prodotto e venditori di beni stru-mentali e di consumo e compratori. Ciò onde tutelare la
31libertas
Il principio disussidiarietà orizzontalecomporta di preferire
le istituzioni del mercato più vicinealla persona rispetto a quelle che se ne
distaccanomaggiormente.
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

parte debole, ossia il lavoratore, il coltivatore diretto, ilcompratore di beni strumentali e di consumo, dallo sfrut-tamento dell’imprenditore “capitalista”. La cooperativanon abolisce la proprietà privata individuale, ma trasfor-ma la parte debole in proprietaria di altro segmento dellafiliera, unendo capitale e lavoro, produzione primaria esecondaria, produzione e commercio, commercio e con-sumo. Nel modello cooperativo c’è il fine di lucro, maesso è temperato dalla mutualità, cioè dalla collaborazio-ne fra le parti nell’aiuto reciproco, che ha in sé un vinco-lo morale di do ut des. Il pensiero cristiano – che, nellasua tradizione aveva il tema dell’usura, cioè dello sfrutta-mento della parte debole del prestito e il tema del com-pletamento della persona umana con il diritto di proprie-tà, contrapposto al collettivismo – ha adottato il modellocooperativo dei socialisti. Dal canto loro inizialmente isocialisti erano riluttanti a fondare le banche di creditocooperativo , in parte perché secondo la tesi del Lasalleera utopico che esse potessero servirealla classe lavoratrice, che non avevamezzi adeguati per farlo, data la leggebronzea dei salari
17. E in parte – e
soprattutto – perché consideravanoprioritarie le organizzazioni cooperati-ve di produzione e lavoro, come quellein agricoltura e nell’edilizia, le coope-rative di assicurazioni mutua dei lavo-ratori, le cooperative di consumo. Maper lo sviluppo delle cooperative c’era la necessità difinanziamenti bancari ed i socialisti riformisti, quali quel-li della Società Umanitaria di Milano, all’inizio del 900adottano il modello della banca popolare per sorreggerele nuove cooperative di lavoro e produzione. Ciò mentrenel credito al consumo si sviluppava la raccolta delrisparmio dei cooperatori-consumatori, utilizzato per ilcredito alla cooperativa. Analogamente avveniva nellecooperative edilizie, in cui il risparmio dei nuovi coope-ratori veniva (e viene ) utilizzato per i mutui ai preceden-ti cooperatori che hanno raggiunto la quota di risparmioproprio che dà luogo al loro diritto al prestito. Il modellodella raccolta risparmio dei cooperatori destinato a unfine specifico si stava sviluppando anche nella assicura-zione mutua, per la malattia, la mancanza di lavoro, l’in-fortunio, la vecchiaia. Il principio della riserva obbligato-ria e volontaria che cresce nel tempo capitalizzando l’im-presa cooperativa è comune a ogni specie di cooperative,sia a quelle di produzione e di lavoro, che alle bancarie,che alle edilizie che quelle assicurative e previdenziali. Si cominciava così a realizzare a cavallo fra l’800 e il 900
quell’incrocio virtuoso fra pensiero cristiano, liberale esocialista riformista che, negli anni 50 e 60 del 900 l’eco-nomista tedesco Muller-Armack ha considerato come labase fondante dell’economia sociale di mercato, di cui èstato il leader. Si è trattato di un incrocio che spesso nonsi è realizzato sul terreno politico, data la contrapposizio-ne fra partiti democratici cristiani, partiti socialisti e par-titi liberali su altre tematiche e data l’ambiguità dei movi-
menti socialisti, in cui convivevano (econvivono) due anime. In primo luogoquella per cui il movimento cooperati-vo è un mezzo per correggere il merca-to e contenere l’intervento pubblico,principio che è fatto proprio anchedagli economisti della scuola diFriburgo, Dietze, Eucken e Lampe nelsaggio del 1943 riguardante l’ordineeconomico e sociale conforme alla
dottrina cristiana18. Ma che anche la tesi per cui la coope-
rativa è uno degli strumenti per ridurne, man mano, ilruolo del mercato e preparare il terreno per dare il prima-to nell’economia a quella pubblica. E’ rimasto, così, sottotraccia, il principio unificante di questi movimento emodelli di credito popolare, che è il principio di sussidia-rietà, tramite cui l’economia di mercato può supplire,mediante forme di cooperazione, alle carenze che si pos-sono determinare, nel funzionamento del mercato indivi-dualistico, rendendo – in tal modo – meno necessariol’intervento dell’economia pubblica. .
4. Il principio del riferimento alla persona non all’indi-viduo.
Nel riferimento alla persona del principio di sussidiarietàproprio dell’etica cattolica e più in generale dell’etica cri-stiana vi è una idea filosofica fondamentale che distingueil pensiero liberale “umanistico” e il (liberal) socialismoumanistico da quello individualistico razionalista – utili-tarista egoistico (selfish). Nel pensiero basato sulla perso-na c’è il suo completamento mediante il diritto di pro-
32libertas
quell’incrocio virtuosofra pensiero cristiano,
liberale e socialistariformista
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

prietà e mediante la relazione con gli altri: dalle piccolesocietà naturali, come la famiglia, alle altre forme dicomunità via via maggiori. La persona, per essere se stes-sa, deve esse libera. E per esser tale deve poter esser pro-prietaria di beni e poter ampliare le sue attività e le suescelte nella comunità. In una società evoluta la personaamplia le sue scelte personali e di lavoro e di impresamediante il risparmio e il credito. Nel modello economico basato sulla persona il mercatonon può trattare le persone come merci e deve considera-re i debitori e i risparmiatori come persone e non comesemplici intestatari di flussi finanziari. La società del risparmio diffuso in cui il risparmiatorenon è un mero soggetto passivo, ma controlla il destinodel suo risparmio e non è succube della banca nel credi-to, ma è in posizione paritaria, consente alla persona diessere parte attiva e non succube del sistema economicoe dello sviluppo del mercato globale: si arriva cioè alcapitalismo popolare. Se si fa riferimento alla persona e non all’individuo comemero soggetto egoistico razionale ci si rende conto che larazionalità è limitata e che la nostra capacità di fare lecose che consideriamo giuste è limitata. Ulisse si lega perfar prevalere la ragione sul sentimento che indebolisce lavolontà di far la scelta conveniente. Qui emerge la virtùdel risparmio, come previdenza da stimolare. Il principio di sussidiarietà nel risparmio e nel creditoserve a favorire l’eguaglianza di trattamento delle perso-ne e a far funzionare meglio il mercato per le persone.
5 La banca popolare come espressione di sussidiarietàverticale e la banca di credito cooperativo comeespressione di sussidiarietà orizzontale.
Il modello della banca di credito popolare che in
Germania ed Austria si ispira ai prin-cipi dello Schulze e in Italia a quellidel Rossi e del Luzzatti e il modellodella cooperativa di credito, che inGermania e soprattutto in Austria sidiffonde ispirandosi ai principi delRaiffaisen e in Italia alle iniziative diLeone Wollemborg, di don Cerruti edi Giuseppe Toniolo, differiscono fraloro perché si focalizzano su duediversi aspetti della sussidiarietà. Il
primo si focalizza sulla sussidiarietà verticale, cioè sullacomunità fra persone organizzate orizzontalmente conrapporti di diritto privato fra di loro quale terza via fra labanca pubblica che dipende dal governo e la comunitàpolitica, che comporta una organizzazione gerarchicacon rapporti di diritto pubblico e il mercato “capitalisti-co” del risparmio e del credito con le sue imperfezioni.Ossia le asimmetrie informative fra le parti; la condottaopportunistica del debitore verso il creditore sia quandoquesto è la banca, nel caso dei prestiti e sia quando que-sta è il debitore, per gli investimenti del risparmiatore; ei poteri di monopolio della banca). Quello dellabanca popolare è un modello associativo di mercato,regolato dal diritto privato, che prende il metodo di for-mazione del consenso dalla democrazia politica cioèadotta il voto capitario. Esso genera parità fra i soci, evi-tando che si leda il principio del vantaggio per il massi-mo numero. Il modello della cassa di credito invece sifocalizza sulla sussidiarietà orizzontale, riguardante lepersone, quale terza via fra il mercato imperfetto (per leragioni di cui sopra) e l’economia pubblica, che intervie-ne al suo posto. Nella cassa di credito cooperativa debi-tore e creditore si identificano. Qui il voto capitario nascedalla esigenza che la scissione fra i ruoli non si riprodu-ca, mediante il fatto che la banca diventa di chi detiene lamaggioranza delle quote. Fra il movimento delle banchepopolari di cui il Luzzatti è il teorico e il propugnatore equello delle cooperative di credito, soprattutto rurali, teo-rizzato da Wollemborg si sviluppa una polemica in rela-zione al fatto che nel primo modello i soci versano unaquota di capitale, che viene investita dalla banca, che intal modo possiede un suo patrimonio, a garanzia dellasua solvibilità, nei riguardi dei depositanti e dei creditorifinanziari. Invece nel secondo modello la banca è solo
33libertas
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

una cassa, che ha come garanzia non un proprio patrimo-nio sociale, ma solo quello dei soci, che rispondono deisuoi debiti verso i depositanti e i creditori finanziari conle proprie garanzie patrimoniali. La banca popolare pre-sta il denaro anche a chi non è socio, mentre per la cassadi credito cooperativo agricolo ed artigiano in linea diprincipio non è ammesso, essendovi un elemento mag-giore di solidarietà fra i depositanti e i soci della banca,che si assumono il rischio delle sue crisi di liquidità e disolvibilità. Va notato che la banca di credito cooperativofa prestiti a lungo termine ai soci agricoltori e artigianimentre i singoli depositanti possono ritirare a vista lesomme depositate. Ciò implica che i soci si debbonoaccollare il rischio che la banca diventi illiquida, anche senon insolvente. Essi rinunciano alla distribuzione degliutili, che va nella riserva obbligatoria della cooperativa ein quella volontaria. Ciò genera un captale costituito nondai versamenti dei soci, ma dalla loro rinuncia a ricavareun reddito dalla loro partecipazione al rischio bancario. Èlogico, dunque, che il credito sia limi-tato ai soci. Anche nel modelloSchulze originario vi è la responsabili-tà illimitata dei soci. Ma essa intervie-ne dopo che è stato esaurito il patrimo-nio, costituito dai versamenti dei soci,dalla riserva obbligatoria della coope-rativa e da quella volontaria. In linea diprincipio i soci si attendono, comun-que, un dividendo o un aumento divalore per le proprie quote, in relazio-ne all’accumulo della riserva volontaria. La banca devetenerne conto, nella sua gestione. Nel modello di bancapopolare propugnato dal Luzzatti i soci rispondono solocon le quote patrimoniali che hanno conferito alla banca.Data questa limitazione del rischio per i soci e l’incre-mento di valore che può derivare alle loro quote, dai pre-stiti e dai servizi resi ai clienti, alla banca conviene effet-tuare prestiti e fornire servizi finanziari anche a non soci,che fanno parte della medesima comunità. La bancapopolare ha il compito di unire il capitale del piccolo emedio risparmio e il credito alla piccola e media impresaagraria, artigianale, industriale, commerciale, collegandofra loro le nozione di profitto e di servizio alla comunitàdei piccoli e medi operatori che opera su un dato territo-rio, dando luogo a rapporti di mercato di cui si avvantag-
gia ciascuno ed economie esterne reciproche. Pur con questa differenza, che tende a far allontanare labanca popolare dal modello ordinario della cooperativa,le due formule si ispirano entrambe al principio di sussi-diarietà e sono, a ben guardare, complementari. La bancapopolare come banca di una società cooperativa operacome banca del territorio capace di estendersi a unaampia comunità e a più comunità territoriali e la cassacooperativa di credito agricolo e artigiano è invece limi-tata ad ambiti più ristretti, ma si unisce ad altre analoghebanche in un reticolo nazionale. Le banche del territoriooperano per lo sviluppo del capitalismo popolare diffusoai fini della dignità della persona umana e del benesseredella comunità, con una formula, variamente declinata,di interesse bene inteso, secondo la definizione delToqueville, che racchiude l’utilità, ma anche la mutualitàe sono, tendenzialmente, società di capitali facenti capoai soci. Le banche di credito cooperativo operano per isoci, hanno un rapporto mutualistico personalizzato euna dimensione più modesta e sono tendenzialmente,società personali. Comune ad entrambe è l’etica del benecomune, nel senso del bene di ciascuno, come persona,che si realizza nella società, tramite l’azione individuale
e la cooperazione volontaria con glialtri, in cui ciascuno sente l’obbligo direciprocare. Il pensiero liberal sociali-sta , nell’indirizzo cattolico di Vanoni,Paronetto e Saraceno e nelle diversevaranti dei liberal socialisti e del socia-lismo umanistico e quello liberale diRopke, sull’economia della civitashumana, con la teoria degli interventiconformi, pur nelle loro differenze,appaiono ricongiungersi in questa con-
cezione. Ma essa non è esente da equivoci e da degene-razioni.
6. Il principio del profitto nelle banche popolari e di cre-dito cooperativo.
E a questo punto sorgono due domande. Può esservi unabanca che non persegua il profitto? Che ruolo hanno ivalori etici e il credo nei valori etici nell’attività dellebanche popolari e di credito cooperativo che hanno,come si è visto, un grande, nobile ruolo, nei loro model-li teorici e in chi li ha ispirati e promossi? Cominciamodal primo quesito. Una banca popolare e una cassa di cre-dito cooperativo, che devono stare sul mercato non pos-sono non perseguire il profitto. Ciò era vero nel passato,lo è a maggior ragione attualmente, poiché tutte le ban-
34libertas
Può esservi una bancache non persegua
il profitto? Che ruolohanno i valori etici e il credo nei valori
etici nell’attività dellebanche popolari?
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

che e tutte le imprese, grandi, medie o piccole debbonocompetere nella realtà globale, che permea oramai lanostra economia e la nostra finanza. La banca popolaredeve poter remunerare il capitale dei soci perché ciòincrementa la riserva indivisibile della cooperativa ban-caria e perché essi pur contentandosi di un dividendolimitato, hanno bisogno di avere una remunerazione delproprio risparmio, vuoi come guadagno distribuito e vuoicome aumento del valore della loro quota. D’altra partenel caso di banche popolari quotate, è importante cheesse possano presentare buoni bilanci positi-vi. E, comunque, la vigilanza bancaria lochiede ai fini della tutela del risparmio e delcredito a cui essa presiede. Ma ciò non impli-ca che la banca popolare debba massimizza-re il profitto di breve termine. Ciò sarebbeerrato per qualsiasi banca, se ciò comportaun rischio elevato di medio, lungo termine.Ed è comunque in contrasto con la missionedella banca popolare. La banca del territorio,con soci che, in prevalenza, sono piccolirisparmiatori, invero, se vuole essere coeren-te con il suo mandato, deve operare con unastrategia di lungo termine. A ben guardare,per altro, la nozione di guadagno ottimale dilungo termine non è affatto univoca: dipendedalle strategie prescelte per il rapporto fraguadagno e rischio o meglio incertezza.Molti economisti ed esperti di finanza com-mettono l’errore di supporre che l’attività bancaria abbiaun rischio calcolabile; ma essa, nell’economia dei merca-ti globali, nella prospettiva di lungo termine, ha un oriz-zonte caratterizzato da rischio incerto, ossia da incertez-za. E le strategie ottimali in regime di incertezza nonimplicano la massimizzazione del guadagno, perchéentra in gioco il principio della difesa dai risultati peggio-ri, la cui probabilità non è calcolabile. Nel caso dellabanca del territorio, cui partecipano risparmiatori mode-sti, dotati di elevata utilità marginale dei loro redditi e deiloro risparmi e che effettua impieghi a favore di piccoli emedi operatori economici, che non hanno una grandediversificazione dei loro impieghi, si addicono strategieche tengano conto di ciò e quindi diano un ampio spazioal requisito della sicurezza. Ecco così che il ragionamen-to economico corretto suggerisce comportamenti pru-denti, “non speculativi” nel senso corrente del termineche tende a identificare quelli speculativi con i compor-tamenti azzardati. Questo ragionamento vale a fortioriper le casse di credito cooperativo. Infatti esse sono espo-
ste a rischi e incertezze maggiori. E i loro soci, deposi-tanti e clienti dei finanziamenti sono soprattutto personee ditte modeste, con risorse limitate. È dunque doverosoadottare, nei loro confronti, condotte prudenziali e nonesporle a rischi elevati.
A questo punto si presenta il secondo quesito. Se è veroche le banche sono condizionate dai mercati globali, cheinducono a perseguire il profitto di lungo termine con unastrategia prudenziale, che rilevanza hanno i valori etici,che stanno alla base dei due modelli del credito coopera-tivo e delle casse di credito? .Una prima, fondamentale,risposta sta proprio nel modello di profitto che la bancapopolare dovrebbe perseguire: che è quello prudenzialedi lungo termine. Il preferire il lungo termine al guada-gno immediato, non è una solo una scelta economica, èuna scelta etica. Anche la condotta prudenziale, che siestrinseca in strategie economiche che privilegiano lasicurezza rispetto alla massimizzazione rischiosa è unascelta etica. Infatti, chi rischia molto ed ha una propen-sione al rischio lo fa perché ha una elevata utilità margi-nale per i guadagni molto elevati, che cambiano il suostatus, lo rendono “ricco”. E per questo fine è dispostoanche a perder gran parte di ciò che ha. Invece, chi adot-ta la condotta prudenziale adotta la regola per cui il gua-dagno molto grosso ha una bassa utilità marginale, per-ché soddisfa a bisogni secondari, come quello del potere
35libertas
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

e del prestigio dell’avere molto denaro, mentre il piccologuadagno ha una elevata utilità marginale, perché soddi-sfa a bisogni primari propri e della famiglia, la cui sod-disfazione consente di dedicarsi meglio a bisogni chedanno uno scopo e un senso alla propria esistenza e aquella di chi ci circonda. È chiaro che questa diversa con-cezione dell’utilità marginale dipende da diversi giudizidi valore di natura etica. Quella della condotta pruden-ziale è anche una scelta antropologica, che muove dalriconoscimento della limitatezza della nostra conoscenzadel presente e dalla limitazione della nostra capacità diprevisione del futuro ossia dalla consapevolezza che lanostra razionalità è limitata. C’è poi un secondo aspetto, che impegna eticamente labanca popolare, quello dell’obbiettivo del servizio al ter-ritorio, che deve estrinsecarsi sia nell’azione quotidiana,capillare, riguardante il credito diffu-so e gli altri servizi finanziari allefamiglie e alle imprese, sia in quellariguardante la gestione dei portafoglidella clientela, che dovrebbe ispirarsisoprattutto ai principi prudenziali.Non vi è contrasto, ma coerenza, fraquesta impostazione di servizio al ter-ritorio e alla sua comunità e il princi-pio del profitto: la reputazione che labanca consegue, nel medio-lungo ter-mine con una condotta di questa natu-ra, genera una fidelizzazione della suaclientela. La condotta corretta generacondotta corretta. Anche per la cassa di credito cooperativo vale il principiodel profitto di lungo termine, con una condotta pruden-ziale, che dovrà esser accentuata, in relazione alla suanatura, meno capitalistica, di quella della banca popola-re, che espone i suoi soci a maggiori alee. Anche per essavale l’osservazione che questo principio non è solo unprincipio economico, comporta anche una scelta etica.Anche per essa vale, come criterio etico ed insieme eco-nomico, il principio del servizio: che in essa si riferisce aisoci, cooperatori.
7. Le banche popolari e il credito cooperativo nel model-lo italiano attuale.
La banca popolare e la banca di credito cooperativo sonodue diverse espressioni del principio di sussidiarietà. In
un caso, l’elemento saliente è costituito dalla diffusionefra le famiglie e i piccoli operatori di un dato territorio.Cioè del principio della valorizzazione del servizio allepiccole energie che fanno parte di una o più comunità acui si rivolge la banca considerata. Nell’altro, quello delmodello della banca di credito cooperativo, l’elementosaliente è la coincidenza soggettiva fra risparmio e suoimpiego. I due modelli, all’inizio spesso simili, si sonodivaricati sempre di più, soprattutto nel caso degli istitu-ti maggiori . Ma il voto capitario, il limite alle deleghe assembleari, illimite alla trasferibilità delle azioni tramite il principio digradimento dei nuovi soci, le basse soglie di pacchettoazionario, in genere, sono criteri che sono stati adottati inentrambi i modelli. La tesi per cui i casi recenti di crisi delle cooperative e dibanche popolari dipendono dal fatto che il voto capitariofavorisce l’affermarsi di una oligarchia al vertice dellabanca, bloccandone la sottoposizione al vaglio del mer-cato non sembra corrispondere alla realtà. Nel caso della
Banca Popolare di Milano la patologia èderivata dal fatto che si è consentito ailavoratori della banca di controllarlamediante il loro voto capitario comesoci, dando luogo a un palese conflittodi interessi. Questo conflitto di interessisnatura la banca popolare ed è necessa-rio che si adottino regole per sterilizzar-lo. Nel caso della Banca Popolare di Lodila patologia si è verificata mediante unimproprio intreccio politico. Ciò che famale alle banche cooperative, alla ban-che popolari, alle banche orientate al
territorio, alle banche in genere, è la loro politicizzazio-ne, e la loro sindacalizzazione. Nel caso del Monte dei Paschi di Siena e di Carige, nonsi tratta di una banca popolare, ma di banche controllateda Fondazioni bancarie soggette al controllo politico diclientele locali. Se la Fondazione bancaria è controllatada enti locali essa non deve controllare la banca. Questaregola dovrebbe valere in generale. E’ paradossale che sivogliano trasformare in spa soggette a cattura da parte deifondi di investimento internazionali, le maggiori banchepopolari, compromettendone le funzioni di servizio alterritorio ed espropriando del voto capitario i milioni disoci che ne sono titolari, mentre ancora si consente cheFondazioni bancarie sotto controllo dei poteri politici dichi governa gli enti locali possano avere una ingerenzanella gestione delle banche.
36libertas
La tendenzaalla crescita
dimensionale e al distacco dal modello
della cooperativa di credito è in atto
da tempo per le Banche Popolari
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

C’è la necessità di una riforma, in relazione all’evoluzio-ne dell’unione monetaria europea, in cui la BCE, labanca centrale ha assunto il controllo del sistema banca-rio, per assicurarne un funzionamento competitivo alivello europeo. Essa, ora, adotta misure non convenzio-nali di finanziamento al sistema bancario, che richiedo-no, negli istituti di credito, una modernizzazione cheimplica sprovincializzazione e internazionalizzazione,una managerialità e un incremento patrimoniale, che neaccresca la dimensione e la capacità operativa e la dimen-sione.
8. Il problema delle banche popolari. Critica al progettodi riforma dicotomica mediante decreto legge delGoverno Renzi, irrispettoso dei vincoli costituzionali ein contrasto con il principio di sussidiarietà
La tendenza alla crescita dimensionale e al distacco dalmodello della cooperativa di credito è in atto da tempoper le Banche Popolari. Ma ciò comporta l’esigenza dimodifiche del modello, che ne favoriscano uno sviluppoconforme alla sua natura, di modello di banca del territo-rio, con compiti di sussidiarietà rispetto alle iniziativepubbliche di sviluppo regionale nell’economia dei mer-cati globali dell’era digitale. Le banche popolari, che sino ad ora, sono classificatecome una forma ibrida di cooperative di risparmio e cre-dito hanno sempre più perso tale caratteristica perchégran parte dei prestiti e dei depositi non è fatto da soci,sicché il loro voto capitario non ha più una funzione coo-perativa, ma rappresenta un modo di governare unabanca diffusa sul territorio. In effetti le banche popolari,prima della crisi del 2007-8 avevano circa un milione disoci ma 11 milioni di conti di deposito e 1,5 milioni diclienti debitori, con importi di prestiti privi di una rela-zione con le loro eventuali quote di partecipazione allabanca. Vi è una divaricazione anche fra banche popolari.Quelle autorizzate, al 2011, sono 37, ma 5 di esse hannoil 74% dell’attivo patrimoniale e 7 sono quotate in borsacon un valore superiore a 12 miliardi, mentre 16 sono acapo di gruppi bancari. Una parte delle banche popolariha un capitale proprio che supera il miliardo di euro,spesso di un multiplo. Per le banche popolari con uncapitale di un miliardo, la regola per cui i soci debbanoessere almeno 200 e debbano avere quote societarie divalore facciale di almeno 10 mila euro, se fosse applica-ta alla lettera, potrebbe implicare soci con 10 milioni dieuro a fronte di soci con 10 mila euro. La regola per cuinessun socio può avere più del 2% del capitale socialecomporterebbe comunque soci con 5 milioni di euro.
Il voto capitario, se ci sono grandi squilibri nelle quote,tende a generare redistribuzioni di potere che possonoportare a violare a favore di determinati soci e a danno dialtri sia la regola di giustizia corrispettiva che quella digiustizia proporzionale su cui la buona banca che sta sulmercato deve potersi fondare. E ciò, ovviamente, com-porta l’inosservanza dei principi economici ed etici, dibanca al servizio delle famiglie a basso e medio reddito edei piccoli e medi operatori di date comunità territoriali. Ci possono essere state deviazioni da questa loro missio-ne, a favore di interessi particolari, anche in banchepopolari diverse da quelle in precedenza indicate. Maciò non riguarda necessariamente di più quelle di mag-
gior di mensione per patrimonio e attività, ossia le 10 convolume di attività superiore a 8 miliardi a cui il decretolegge del gennaio 2015 impone la trasformazione entro18 mesi in società per azioni o la liquidazione. Una rifor-ma che ha tre difetti: contiene rilevanti elementi di inco-stituzionalità; elimina – per le banche popolari maggio-ri – il modello della banca popolare al servizio del terri-torio anziché farlo evolvere riguardando le banche popo-lari con un attivo superiore agli 8 miliardi; crea una bar-riera alla crescita dimensionale delle altre 26 banchepopolari ostacolandone i progetti di concentrazione edespansione. A favore di una riforma evolutiva e non soppressiva,depone non solo la validità del modello di economia dimercato umanistica a cui si ispira il modello della bancapopolare come banca del territorio, sussidiaria rispettoalle politiche pubbliche di sviluppo regionale, ma anche
37libertas
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

la considerazione che le banche popolari, nonostante lecritiche di anacronismo, che si rivolgono al loro modello,hanno retto alla crisi del 2007-2007 meglio delle altre ele loro quote di mercato sono cresciute. La soluzione proposta dal governo con decreto legge perle dieci banche popolari con attività in eccesso ad 8miliardi, consistente nella loro trasformazione in societàper azioni entro 18 mesi o nella loro liquidazione sembraviolare due principi costituzionali: innanzitutto quellodell’articolo 77 per cui il governo ha facoltà di adottare ildecreto legge solo in caso di urgenza e necessità che ècontraddetto, in questo caso dai 18 mesi di intervallo frala entrata in vigore del decreto legge e la sua effettivaapplicazione. E inoltre quello dell’articolo 42 secondocui il diritto di proprietà non può essere espropriato, senon vi è un un motivo di interesse generale e, comunque,non senza indennizzo. Il voto capitario ha un valore patri-moniale consistente, derivante dal potere di controllo chedà mediante le piccole quote di capitale possedute. Il suo
esproprio senza indennizzo, senza un chiaro motivo diinteresse generale appare viziato da doppia incostituzio-nalità. Che diventa tripla ed estremamente rilevante nelcaso in cui venga vietato il recesso dalla società per azio-
ni bancaria, come è stabilito nel decreto legge, qualoraesso dia luogo a una riduzione dei parametri della banca,al di sotto di quelli minimi stabiliti dalla vigilanza euro-pea. La violazione dell’articolo 42 diventerebbe eclatante se siaccertasse che il decreto serve a criteri opportunistici disalvataggio di banche in difficoltà come Carige e Montedei Paschi che si aggregherebbero con qualcuna delledieci maggiori popolari obbligate a trasformarsi in spaentro 18 mesi, con possibile divieto di recesso dei soci.Inoltre, come si è appena osservato, l’obbligo di trasfor-mazione in società per azioni ordinarie per le banchepopolari con attività in eccesso ad 8 miliardi pone unostacolo alla crescita delle attività delle restanti, che sono27 per cui vi è un maggior bisogno di sviluppo e raffor-zamento.
9. Una soluzione unitaria evolutiva, per tutte le banchepopolari, che ne salvaguardi il modello, mediante ilpassaggio dalla banca con un solo livello decisionalecon voto capitario alla banca con livello decisionaleduale e voto capitario parziale al livello superiore, inquota decrescente al crescere della dimensione
A me pare che sia invece possibile attuareuna soluzione che può valere per tutto ilsistema delle banche popolari, mediante unmodello duale di società azionaria, con unconsiglio di sorveglianza con soli compiti diindirizzo e controllo, di nomina del consigliodi amministrazione e di svolgimento di com-piti etico-sociali e un consiglio di ammini-strazione dotato di tutti i restanti compiti,con incompatibilità dei membri del consigliodi sorveglianza di partecipare a quello diamministrazione o di passarvi, una volta ter-minata tale loro carica, se non dopo un con-gruo intervallo di anni. Attualmente, questomodello, in Germania, in Olanda e in altripaesi, viene adottato per attuare la “mitbe-stimmung”, ossia la compartecipazione deirappresentanti dei lavoratori alle decisionidell’impresa19.Nel modello qui proposto, lamitbestimmung invece avrebbe luogo, nelconsiglio di sorveglianza fra gli azionistipersone fisiche, dotate di voto capitario e gliazionisti dotati di voto proporzionato alla
quota di capitale posseduta. Il principio del voto capita-rio con regole come le attuali varrebbe per le elezioni diuna quota del consiglio di sorveglianza, non superiore al
38libertas
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

50% mentre il voto pro quota varrebbesia per la nomina di una quota del con-siglio di sorveglianza non inferiore al50% che per la nomina del consiglio diamministrazione e l’approvazione delbilancio di esercizio in caso di dissensodi almeno il 50% del consiglio di sor-veglianza. Le assemblee dei soci sareb-bero due, una speciale con i soci perso-ne fisiche che deliberano con il votocapitario per il consiglio di sorveglian-za e per altre delibere di natura straor-dinaria, previste dallo statuto riguar-danti la ratifica di attività del consigliodi sorveglianza; l’altra per la gestione,che si riunisce almeno una volta all’an-no per approvare il bilancio di esercizio e in tutti gli altricasi in cui ciò è richiesto. Essa delibererebbe anche suitemi su cui è chiamato a deliberare il consiglio di sorve-glianza, cui però, in tali materie, spetterebbe l’ultimaparola. Nelle piccole banche popolari che lo desideranorimarrebbe il regime attuale con qualche eventuale retti-fica; non ci sarebbe l’obbligo di spa e non ci sarebbebisogno del modello duale con consiglio di sorveglianzae consiglio di amministrazione; in quelle di media e gran-de dimensione invece ci sarebbe l’obbligo di trasformar-si in spa con il modello duale. Nelle medie l’assembleadei soci con voto capitario eleggerebbe la metà del con-siglio di sorveglianza; mentre nelle banche popolari dimaggior dimensione e comunque in quelle quotate l’as-semblea costituita dai soci con voto capitario eleggereb-be solo il 30% dei membri del consiglio di sorveglianza.Ovviamente non è difficile mettere insieme una quota del5-10% costituita da azionisti privati e istituzionali chepreservano le banche popolari dal diventare preda difondi di investimento e di azionisti che non hanno unavocazione comunitaria.Mi preme però sottolineare, nella conclusione, che ilsistema elettorale è uno strumento. Ma ciò che conta è ilfine: quello del mantenimento del principio di sussidia-rietà, per una banca del territorio che consideri i suoi socie i suoi clienti come persone e che abbiano come missio-ne la promozione delle piccole energie e la loro fusionein grandi realtà.Ci sono due tipi di modello di economia di mercato:
quello del capitalismo con tendenza al monopolio e allatecnocrazia e quello dell’economia sociale di mercato. Inquesto secondo modello, anche nel XXI secolo, c’è unampio ruolo per il principio di sussidiarietà, a cui posso-
no dare un importante contributo lebanche popolari e le banche di creditocooperativo.
BIBLIOGRAFIABAIETTI S. E G. FARESE, (a curadi), (2012) Sergio Paronetto e il for-marsi della Costituzione economicaitaliana, Rubbettino, SoveriaMannelli 2012CAFARO P. (2001), La solidarietàefficiente. Storia e Prospettive delCredito Cooperativo in Italia, Bari,Laterza, con Prefazione di AntonioFazio.
COIAZZI A.(1020), Le Rerum Novarum, conIntroduzione e commento , Torino, SEI EUCKEN W. (1954 e 2004), Grundsatze del WirtschaftPolitik, Tubingen, Mohr SiebeckFORTE F.(1999), Storia del pensiero dell’economia pub-blica, Vol. I, Il pensiero antico. Greco, Romano,Cristiano, Milano, Giuffrè FORTE F. e F. FELICE (2010), Il liberalismo delle rego-le. Genesi e sviluppo dell’economia sociale di mercato,Soveria Mannelli, Rubbettino.LASALLE F. (1864), Il signor Bastiat-Schulze Delitsch:il Giuliano economico ossia capitale e lavoro. Ristampaanastatica, La Nuova sinistra, Milano, Samonà e SavelliLEONARDI A. (2002), L’esperienza cooperativa di F.W. Raffeisen e i suoi primi riflessi in area tirolese, Trento,Regione Trentino Alto Adige.LUZZATTI L. (1863), La diffusione del credito e le ban-che popolari, PadovaROPKE W. (1947), Civitas Humana, Milano, Rizzoli ROSSI A. (1880), del Credito popolare e delle odierneassociazioni cooperative. Ricerche e Studio, Firenze,Barbera SCHULZE H. (1871), Delle unioni di credito ossia dellebanche popolari, con introduzione di L. Luzzatti, trad. itdella IV edizione tedesca, Venezia,. Tipografia del com-mercio TONIOLO, G. Opera Omnia, sez. 4, Iniziative Sociali ,vol. 3, Iniziative culturali e di azione cattolica, Città delVaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana
39libertas
Mi preme peròsottolineare,
nella conclusione, che il sistema elettorale
è uno strumento. Ma ciò che conta è il fine: quello
del mantenimento del principio disussidiarietà,
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

VON NELL-BREUNING O. (1990), Baugesetze derGeselleschaft Solidarität und Subsidiarität, Frieburg,Herder Verlag WOLLEMBORG L. (1935), Scritti e discorsi di econo-mia e finanza, con Prefazione di Augusto Graziani,Torino, Bocca
1Come si può leggere nella mia opera in 2 volumi, Storia del pensiero dell’economiapubblica, Milano, edizioni Giuffrè vol. I.
2 Su san Bernardino e sugli altri pensatori cristiani che sviluppano la nuova teoria deltasso di interesse cfr. la mia opera citata, vol I.
3Anche per il pensiero di San Tommaso sui temi di cui al testo cfr. la mia opera cita-ta vol. I
4Sul tema del Monte dei Paschi nella mia opera citata. Vol I c’è una esposizione sin-tetica e i riferimenti ai principiali studi di storia economica al riguardo.
5Cfr. ad es. A. COIAZZI (1020), Le Rerum Novarum, con Introduzione e commento, Torino, SEI
6W. EUCKEN (1954,2004), Grundsatze der Wirtschaft Politik, 7 edizione, pag.348.L’opera era però già pronta come dattiloscritto per la stampa nel 1950 e non potéessere pubblicata allora, per la morte prematura a Londra dell’autore.
7 W. RÖPKE (1947), Civitas Humana, Milano, Rizzoli pp-104-105
8 Testo base per il principio di sussidiarietà nel pensiero cattolico OTTO VON NELL-BREUNING (1990), Baugesetze der Geselleschaft Solidarität und Subsidiarität,Frieburg, Herder Verlag
9H. SCHULZE (1871), Delle unioni di credito ossia delle banche popolari, con intro-duzione di L. Luzzatti, trad. it della IV edizione tedesca, Venezia,. Tipografia delcommercio
10Sul cui pensiero cfr. la bella monografia di ANDREA LEONARDI, (2002), L’esperienzacooperativa di F. W. Raiffeisen e i suoi primi riflessi in area tirolese, Trento, RegioneTrentino Alto Adige. La parte iniziale del lavoro descrive i due modelli di Schulzee di Raiffeisen.
11Di cui si veda ALESSANDRO ROSSI (1880), del Credito popolare e delle odierne asso-ciazioni cooperative. Ricerche e Studio, Firenze, Barbera
12Cfr. L. LUZZATTI (1863), La diffusione del credito e le banche popolari, Padova
13Nel saggio “L’ordinamento delle casse di prestito del 1884” nel volume citato allanota seguente p.101 il Wollemborg dice “ tale comunione di forti e deboli, tale com-partecipazione di persone diverse per ceto e censo è una sublime utopia, attuataappunto, è un capitolo del Vangelo non predicato soltanto , ma praticamente adem-piuto…..L’ideale più eccelso e la realtà più concreta mirabilmente si identificano esula, base più salda perché a ciascuno, partecipe il benessere dei compagni sta acuore come il suo stesso”
14 Cfr.L. WOLLEMBORG (1935), Scritti e discorsi di economia e finanza, con Prefazionedi Augusto Graziani, pag. 79-164 e, in particolare, oltre al saggio di cui alla notaprecedente: .Lo svolgimento delle imprese cooperative accanto alle Casse di presti-ti; Il mostro poco scrupoloso del dividendo; Le obbiezioni al principio dell’illimita-ta responsabilità nelle associazioni cooperative di credito; Le casse rurali ;
15Cfr. G. TONIOLO (1900), L’avvenire della cooperazione cristiana. Discorso dichiusura del Congresso delle casse rurali ed operaie, Parigi 1900, in G. Toniolo,Opera Omnia, sez. 4, Iniziative Sociali , vol. 3, Iniziative culturali e di azione cat-tolica, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana.
16Su tutte queste vicende cfr. l’approfondito studio di P. CAFARO (2001), La solidari-età efficiente. Storia e Prospettive del Credito Cooperativo in Italia, Bari, Laterza,con Prefazione di Antonio Fazio, che fa parte della “Storia delle banche italiane”,promossa dall’Associazione Bancaria Italiana
17Cfr. F. LASALLE (1864. ), Il signor Bastiat-Schulze Delitsch: il Giuliano economicoossia capitale e lavoro. Ristampa anastatica, La Nuova sinistra, Milano, Samonà eSavelli . Secondo il Lasalle i salari tendono al minimo di sussistenza, perché quan-do si elevano la classe lavoratrice fa più figli o se ne riduce la mortalità nei primianni di vita e quindi c’è una maggiore offerta di forza lavoro. La legge demografi-ca in questione, ovviamente, è stata sementita dai fatti, perché il progresso riduce lenascite; e comunque da un lato si sono formate le leghe dei lavoratori; dall’altro si
è sviluppata l’esigenza di forza lavoro qualificata specializzata e pertanto unadomanda di lavoro che comporta maggiori retribuzioni.
18Cfr. i saggi di Muller-Armack nell’antologia di saggi del pensiero economicotedesco della scuola di Friburgo di Ordo e dell’economia sociale di mercato e acura di F. Forte e F. Felice, Il liberalismo delle regole. Genesi e sviluppo dell’econo-mia sociale di mercato, Soveria Mannelli, Rubbettino.
19Cfr. C. V. DIETZE, W. EUCKEN, A. LAMPE (1943ee 2010), Ordine economico esociale, in F. Forte e F. Felice, (2010), (a cura di), Il liberalismo delle regole. Genesied eredità dell’economia sociale di mercato, Soveria Mannelli. Rubbettino pp.121-140 e spec. p.139, § 12. Cfr anche la Prefazione di F. Felice spec.§7 pp.17-18 el’Introduzione di F: Forte §10 pp.41-43 ,
20Erroneamente si considera Adam Smith come assertore di questo indirizzo, dimen-ticando che la sua teoria dei sentimenti morali è basata sul valore della simpatia.Einaudi sostiene che il liberismo egoistico è un modello evocato generalmente perscreditare il “vero pensiero liberale” Cfr .anche il saggio di Dietze, Eucken e Lampecitato nel § 3, nota 14 pag. 128 con riferimento al fondamento morale della “manoinvisibile “di Adam Smith, riguardante la corrispondenza fra il bene comune, in unordine corrispondente con l’agire in vista dell’utile personale, in regime generale disana concorrenza.
21Su cui S. Baietti e G. Farese. (a cura di), Sergio Paronetto e il formarsi dellaCostituzione economica italiana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012 e special-mente il mio saggio ivi sul contributo dei tre economisti .
22Il riferimento che faccio a questo modello di codeterminazione, ai fini del modelloduale, riguardante le banche popolari non implica una adesione ad esso per i rap-porti di lavoro, per i quali ritengo che sia preferibile il modello della contrattazionedecentrata, in cui i sindacati non partecipano agli organi decisionali di vertice del-l’impresa, ma collaborano con essa mediante le proprie rappresentanze sindacaliaziendali, per la applicazione del contratto di lavoro aziendale. Sulla estraneità dellamitbestimmung al modello dell’economia sociale di mercato cfr. la miaIntroduzione al volume a cura di F. Forte ed F. Felice (2010), Il liberalismo delleregole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, citato nel § 3, nota 14,§ 8.
40libertas
DibattitiLa dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà, le Casse di Credito cooperativo e le Banche Popolari

1. Luigi Taparelli d’Azeglio nasce a Torino il 24 novem-bre del 1793. Studia nel seminario di Torino per poientrare nella ricostituita Compagnia di Gesù. Rettore delCollegio Romano (oggi Università Gregoriana) si impe-gna a reintrodurre il tomismo nella formazione deigesuiti – progetto su cui insiste, da provinciale del -l’Ordine, anche a Napoli. Nel 1833 viene trasferito aPalermo quale professore di diritto naturale. Tra i suoiallievi napoletani sono da ricordare Carlo M. Curci(1810-1891) e Matteo Liberatore (1810-1892), il qualefu uno dei principali ispiratori della Rerum Novarum. IlCurci con lo scritto Fatti ed argomenti in risposta allemolte parole di Vincenzo Gioberti intorno ai gesuiti(1845) replicò all’attacco sferrato dal Gioberti contro igesuiti nei suoi Prolegomeni al Primato (1845); e controRosmini polemizzò il Liberatore, denunciando l’incom-patibilità della prospettiva filosofica rosminiana con iltomismo e il non aver affatto evitato, il Rosmini, i peri-coli dell’ontologismo. Significative opere, tra altre, delLiberatore sono: La Chiesa e lo Stato, 1871; e Principidi economia politica, 1889. È qui da notare che ilTaparelli, diversamente dal suo discepolo MatteoLiberatore, non fu avverso a Rosmini. Scrive CarloGray: «Parlare di L. Taparelli d’Azeglio, uomo come ilfratello Massimo di acuto ingegno e di vasta cultura,sebbene di idee discordi ed appartenente ad Ordine reli-gioso diverso o meglio avverso a quello rosminiano, ècaro ai seguaci del filosofo di Rovereto che non possonodimenticare esser egli stato uno dei pochi che sincera-mente ammirarono fin dal principio l’opera filosoficadel Rosmini, e si astennero dal partecipare alla campa-gna antirosminiana culminante più tardi nella condannadelle XL proposizioni. Non solo si astenne ma la disap-provò; cosa ardita per un religioso della Compagnia diGesù, nella quale però non mancarono altri come il P.Suryn, il P. Bresciani, il P. Perrone che amanti sinceridella verità, sapevano ch’essa si può e si deve discutere,ma non condannare, ed ebbero pel Rosmini lodi lusin-ghiere» (C. Gray, A. Rosmini e L. Taparelli d’Azeglio, in«Rivista Rosminiana», XIV, 2, 1920, p. 3).A Palermo, Taparelli scrive la sua più importante opera:
Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto(Palermo 1840-1843, voll. 5; Roma 1949, 2 voll., quar-ta ristampa dell’edizione del 1855). Ampliando l’epilo-go riassuntivo del Saggio pubblica nel 1843 Taparelli unfortunatissimo Corso elementare del natural diritto aduso delle scuole. Al 1847 risale la sua singolare operaDella nazionalità, dove si sostiene che, certamente, unanazione ha il diritto a costituirsi in stato autonomo, mache non è questo il suo primo diritto dato che è necessa-rio rispettare pure i legittimi diritti dei governi anteriori.In altri termini, Taparelli – a proposito della questione,tanto difficile per i cattolici di allora, dell’unità d’Italia –non si dichiara contrario al “diritto naturale” per cui unanazione dipenda da un stato di nazionalità diversa. È conarticoli pubblicati su «La Civiltà Cattolica» (La libertàin economia, in «La Civiltà Cattolica», 1860, VIII, pp.33-53; 159-174; 414-433) – raccolti in volume e tradot-ti in francese da R. Jacquin – che Taparelli interviene suiproblemi dell’economia. L’Essai sur les principes philo-
41libertas
Dario Antiseri
Le grandi figure del cattolicesimo liberale
Luigi Taparelli d’Azeglio
RUBR
ICA

sophiques de l’Économie politique apparso nel 1943 acura, appunto, di Robert Jacquin ha per nucleo centrale,come vedremo, «l’idea di una economia “cristiana”,fondata sulla supremazia dell’ordine anziché su quelladell’interesse» (G. Soleri). Taparelli si è spento a Romail 21 settembre del 1862.
2. È sul fatto che Taparelli intende fondare il suo Saggioteoretico di diritto naturale: sul fatto, e cioè sulla naturae la coscienza dell’uomo. Neotomista convinto, egli dàper certi i principi di fondo quali l’esistenza di Dio, i pre-dicati della Trascendenza, la creazione, l’ideadell’Essere ecc., e argomenta per il principio in base alquale, dato che l’intero universo è stato creato per unfine, anche l’uomo, per natura, tende ad un fine, vale adire al bene. E il vero bene convenevole ed onesto o benedi ordine è quello che si ha quando si rispetta e si seguel’ordine posto dal Creatore nell’universo. E se sulla terranon è possibile per l’uomo conseguire il bene nella suainterezza, ciò sarà realtà nell’altra vita, allorché «l’intel-letto, impossessandosi dell’Essere infinito, conoscerà ilVero, giacché il Vero è l’essere considerato come obiet-tivo dell’intelligenza; e la volontà giunta così al terminedi sue brame, godrà parimenti delBene illimitatamente, giacché l’Es -sere considerato come obietto dellavolontà si dice bene» (Saggio teoreti-co di diritto naturale appoggiato sulfatto, I, n. 40, p. 24). Bene che per lapersona consiste nel conseguimentodi fini come la beatitudine eterna nel-l’altro mondo, la conservazione dellavita e la propagazione della specie (Lalibertà in economia, in «La CiviltàCattolica», 1860, VIII, p. 422).Dunque: l’intelletto apprende il finedel creato, fine che è bene; la volontàabbraccia questo bene, tende ad esso come suo oggettonaturale, tende all’ordine voluto dal Creatore, sceglien-do liberamente i mezzi che l’intelletto reputa più ade-guati in vista del fine. L’intelletto, pertanto, fa conosce-re il fine dell’azione morale, la quale è frutto di volontà,e anche i mezzi per conseguirlo, e si è liberi nella sceltadi questi mezzi: «Ecco – scrive Taparelli – i tre principidella moralità delle azioni per parte dell’operante, ecco itre principi del bene morale e della perfezione dell’uo-mo» (Op. cit., I, n. 76, p. 39). Il vero bene, il bene ogget-tivo, è quello voluto dal Creatore. Da qui l’identificazio-ne di etica e diritto che Taparelli sviluppa nella riflessio-ne sulle attività individuali e sociali, sui problemi gene-
rati dalla convivenza politica, sui rapporti tra nazioni,sulla “società cristiana”. E sulla base di quanto precisa-to ben si comprende che, per Taparelli, non va apprezza-ta «la felicità d’una società dal più o meno di poteri poli-tici che vi gode la moltitudine (del che certuni fannotanto conto!), ma della saviezza delle leggi civili e dellaretta amministrazione della giustizia: ragionevolmente,dico, giacché pel fine si stimano i mezzi. Nel che (siadetto ad onore del senso comune) il volgo suol giudica-re più saggiamente di molti filosofi, e cioè lietissimosenza Carte ed Assemblee quando non gli manchi pace,pane e giustizia» (Op. cit., I, n. 736, p. 338). E, infine,«Cristianità od Etnarchia cristiana» chiama il Taparelli ilsuo progetto di una società di nazioni cristiane, con un
capo designato dai singoli Stati – ma,data la forza associante della religionecristiana, su questo capo del grandestato federale cristiano, dovrà avere lapreminenza il Capo della Chiesa (Op.cit., II, n. 1437, pp. 218-221).
3. È la morale che sta a base del dirit-to; il diritto deve riflettere l’ordinemorale – di conseguenza «non [...]dalla utilità, ma dall’ordine del creatodee derivarsi, come ogni altro diritto,così anche il diritto di libertà o il dove-re di dipendenza nel disporre dei pro-
pri averi» (La libertà in economia, cit., p. 45). E con ciòsiamo nel cuore del pensiero economico di Taparelli, peril quale «l’uso della proprietà, della ricchezza, è primiti-vamente e per sé libero, perchè la proprietà stessa è [...]primitivamente ordinata alla persona» (Op. cit., p. 423).Ordinata alla persona è la proprietà in quanto essa è infunzione del bisogno naturale di sussistenza della perso-na stessa. Proprietà e libero utilizzo degli averi persona-li sono realtà che trovano il loro fondamento, ad avvisodi Taparelli, «nelle antiche dottrine della scuola cattoli-ca: in quelle che formarono lo spirito di vera libertà edabbatterono nel medio evo le tradizioni del dispotismocesareo e bizantino, ereditate dalle teorie e dai codici
42libertas
Proprietà e liberoutilizzo degli averi
personali sono realtàche trovano il loro
fondamento, ad avviso di Taparelli,«nelle antiche dottrinedella scuola cattolica
Luigi Taparelli d’Azeglio
Rubrica

pagani» (Op. cit., p. 422). A tale scopo, afferma il nostroAutore, è sufficiente «vederne la prova» nella Sommateologica di san Tommaso d’Aquino.Dunque: libertà economica, ma nonquella «libertà eterodossa» che sostitui-sce la forza al diritto e che cambia l’ob-bedienza in servitù. Difatti, «lasciata allepassioni umane una piena libertà, si for-merà un centro regolatore compostodelle borse più potenti, dei banchi piùaccreditati, che governano a bacchettanon che le tasse dei salari, delle permu-tazioni, delle monete, del credito, perfi-no le sorti degli imperi gittati a baliad’un giocatore di borsa. E cotesta servi-tù voi volete appellare libertà economi-ca? E non vedete che concedendo in tal guisa la libertà aciascun individuo vi rendete possibile la servitù univer-sale e fate schiava la società?» (Op. cit., p. 36).Contrario, quindi, al monopolio economico dei privati,Taparelli lo è altrettanto nei confronti dello Stato onni-potente: «Nel Cattolicesimo lo Stato viene ordinato albene della persona; nella eterodossia è sacrificata albene dello Stato. Qui lo Stato maiuscolo sarà ricco,potente, indipendente; ma il più delle persone è povero,abietto, oppresso» (Op. cit., p. 429). E ancora: contrarioall’uso della forza degli operai contro i capitalisti e deicapitalisti contro gli operai - «nel primo caso è monopo-lio di braccia, nel secondo di capitale» (Op. cit., p. 38),Taparelli insiste su di una libertà economica regolata daldiritto e non lasciata in balia degli interessi: «Finché glieconomisti vengono a dirci che la libertà arricchisce gliStati, che torna a conto anche delle famiglie, che prospe-ra il commercio, che agevola l’industria ecc.; cotesteragioni potranno servire d’incitamento, ma non costitui-scono obbligazione. L’obbligazione allora soltanto potràottenersi quando si dimostrerà che la libertà economicaè essenzialmente connessa con l’ordine morale. Questaè l’assoluta base necessaria di ogni vera libertà sociale:e coloro che vogliono trovare libertà senza diritto alzanoun edifizio senza fondamenti» (Ib.).
4. Da quanto sin qui detto, appare chiaro che il fonda-mento della libertà regolata dal diritto sta nell’idea di per-sona: «La vera libertà [...], anche per l’economia, nonistà nella libertà delle passioni, ma nella sicurezza ragio-
nevole dei diritti. E l’economia allora potrà dirsi liberaquando ciascuno potrà, secondo suo diritto, usare le forzee gli averi. Questa scurezza dei diritti ottengasi poi permezzo dell’autorità suprema, o di convinzioni fra uguali,ciò poco monta: sempre vi sarà libertà quando ai dirittivivi e non collisi non si contrapponga alcun ingiusto
impedimento» (Op. cit., p. 37). Daqui, su queste basi, il rifiuto da partedi Taparelli, delle pretese dei difen-sori dell’”ente collettivo” concepitocome fine e non come mezzo.All’opposto di siffatta concezione,«il Cattolicesimo [...] riguardandol’ente collettivo quale mezzo, e lepersone qual fine, prima vuole salvoil fine, la persona, poi le procaccia ilsussidio quanto può maggiore, per-fezionando anche l’ente sociale»(Op. cit., p. 429). In breve, netta è la
contrapposizione tra la dottrina cattolica e quella etero-dossa: «Il principio cattolico dice: rispetto della persona;l’eterodosso dice: idolatria dello Stato» (Op. cit., p. 430).La realtà è che «quegli economisti che vogliono conce-dere allo Stato mille ingerenze vessatrici sulle persone,sulle famiglie, sui municipi, sulle province, giungono aquesto dispotismo per una deplorevole ignoranza sulvero principio d’ordine. Se conoscessero questo, distin-guerebbero assolutamente l’ordine personale dal dome-stico, il domestico dal comunale, dal provinciale, dalnazionale [...]. Questa libertà [...] dipende dal ben com-prendere che l’autorità è facoltà ordinatrice e non giàpadronanza» (Op. cit., p. 433).Un contributo al personalismo liberale italiano del XIXsecolo vede Paolo Heritier nel pensiero di Taparelli, purse resterebbero da precisare numerosi problemi a comin-ciare dalla centrale concezione che Taparelli ha dell’or-dine, che «può oggi apparire assi discutibile e fuoritempo». In ogni caso, afferma Heritier, «non è teoretica-mente sostenibile [...] considerare questo padre gesuitacome estraneo al pensiero liberale, come si è troppo disovente fatto in passato, ma soprattutto alla difesa dellaquestione dell’irrinunciabilità antropologica della liber-tà personale, all’interno di una riconfigurazione dellaquestione storica del liberalismo italiano, politico edeconomico, nei suoi rapporti con la libertà cristiana» (P.Heritier, Il personalismo liberale italiano cattoliconell’Italia del XIX secolo, in AA.VV., Storia del libera-lismo in Europa, Rubettino, Soveria Mannelli, 2010).
43libertas
libertà economica, ma non quella
«libertà eterodossa» che sostituisce la forzaal diritto e che cambial’obbedienza in servitù.
Luigi Taparelli d’Azeglio
Rubrica

44libertas
LUIGI STURZO
Servire non servirsiLa prima regola del buon politico(Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 82, € 9,00)«Non si corregge l’immoralità solo con le prediche egli articoli dei giornali. Bisogna che la prima a esse-re corretta sia la vita pubblica: ministri, deputati, sin-daci, consiglieri comunali, cooperatori, sindacalistidiano l’esempio di amministrazione rigida e di osser-vanza fedele ai principi della moralità. Mi riderannodietro gli scettici di profesisone, coloro che non cre-dono che l’uomo sappia e possa resistere alle tenta-zioni. Il mio articolo non è diretto a loro. È principal-mente diretto ai democratici cristiani»(Luigi Sturzo, Moralizziamo la vita pubblica, 3novembre 1946)«Da queste pagine emerge la grande importanza cheSturzo poneva nella funzione pedagogica della buonapolitica. Egli credeva in una specie di causa-effetto:la politica è utile se buona ed è tale se sostenuta dallabuona cultura. Questa si acquisisce con lo studio delvero e del bene, studio a cui il cristianesimo ha datoun fondamentale contributo. É tempo che inizi a “farescuola”, direbbe oggi Sturzo»(Dalla prefazione di Giovanni Palladino)
LUIGI EINAUDI
Il paradosso della concorrenzaa cura di A. Giordano(Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 134, €10,00)Il paradosso della concorrenza, scrive Luigi Einaudinel 1942, consiste nel fatto che essa non sopravvivealla sua esclusiva dominazione. Gli esseri umani, perloro natura, non desiderano né riescono a competereincessantemente sul mercato; cosicché la libertà eco-nomica, assai desiderabile e auspicabile quale regolagenerale, deve trovare dei limiti, delle eccezioninelle sue parole, delle “oasi franche”. A distanza disettant’anni il messaggio di Einaudi, uno dei pochiliberali di caratura internazionale che l’Italia possa
vantare, ci giunge immutato nella sua freschezza.Convinto che la società viva e prosperi solo se agliindividui vengono garantite autonomia d’azione elibertà di scelta degli stili di vita, al riparo dell’inva-denza dei poteri pubblici e degli interessi settoriali,Einaudi crede però che la concorrenza vada inseritain un reticolo istituzionale ben congegnato, capace difavorire il più ampio pluralismo ma anche la condivi-sione di un nocciolo di valori e tradizioni comuni.Nei saggi raccolti in questo volume, alcuni pressochésconosciuti al lettore contemporaneo, troviamoinsomma un Einaudi che ci ammonisce a non dimen-ticare che i mercati, per funzionare al meglio, hannobisogno di premesse e di vincoli extra-economici. Uninsegnamento che la crisi perdurante rende dramma-ticamente attuale.
ENZO DI NUOSCIO
Ermeneutica ed economiaSpiegazione ed interpretazione dei fatti economici(Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 166, €15,00)Economia ed ermeneutica. È la storia di un incontroprecario, segnato da dure polemiche e logorato daimperdonabili equivoci. Una disputa intensa, svilup-patasi a partire dagli anni Settanta, che ha visto filo-sofi ed economisti scontrarsi duramente sullo statutoepistemologico della scienza economica.Raccogliendo la giusta intuizione degli interpretativeeconomists, questo libro vuole dimostrare come l’er-meneutica possa rappresentare uno dei più efficacistrumenti nella «cassetta degli attrezzi» dell’econo-
Segnalazioni bibliografichea cura della Redazione

mista, a condizione che si abbandoni quella diffusaed errata concezione antiscientifica dell’ermeneuticae si accetti l’idea secondo la quale il «circolo erme-neutico » di H.-G. Gadamer e il metodo «problemi-teorie-critiche» di K.R. Popper, descrivono, con lin-guaggi diversi, il medesimo procedimento per la sco-perta di conoscenze oggettive. Sulla base di questaimpostazione risulta evidente come l’adozione dellaprospettiva interpretativa in ambito economico nonsolo non comporta una rinuncia all’oggettività, maconsente invece una più efficace applicazione delmodello di spiegazione causale, permettendo dimigliorare gli standard di scientificità delle teorieeconomiche.
ARMANDO RIGOBELLO
Dalla pluralità delle ermeneutiche all’allargamen-to della razionalità(Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 56, € 8,00)L’allargamento della razionalità potrebbe essere ilritorno ad una nozione “forte” di ragione, che non siisoli nell’analitica del fenomeno, come è proprio delsapere scientifico, ma colga la dialettica che muove lastessa ricerca scientifica: l’avvertimento di una esi-genza di senso che la scienza non può esaurire.
ANDREA GENTILE
Ognuno è un universo(If Press, Roma 2014, pp. 208, € 18,00)Ognuno di noi è un’individualità irripetibile nel flui-re del tempo. Ognuno è un universo in cui «dormonoforze ignote come re mai nati». Nella nostra sogget-tività sono connaturate delle potenzialità che nelcorso della nostra vita spesso rimangono nell’ombra:in uno stato oscuro, implicito, latente. «Noi nonconosciamo nemmeno noi stessi – osserva Herder – esolo ad istanti, come in sogno, cogliamo qualche trat-to della nostra vita profonda». «Ognuno solleva unagrande o una piccola onda»: la novità di ognuno nellasua unicità, nella sua profondità, nella sua libertà ecapacità di scegliere e di decidere, di agire, di cono-
scere, di creare. «L’uomo è la sua anima».Viveresecondo natura significa «conoscere se stessi» ed«essere se stessi»: significa ricercare la vita autentica.In questo orizzonte, definiamo la nostra unicità irri-petibile in rapporto ai sentimenti, le intuizioni, leaspirazioni, le passioni, gli interessi, i desideri, lemotivazioni, le imperfezioni, i bisogni, gli errori, ipregiudizi, le speranze, le delusioni, le paure, le situa-zioni-limite e tutto l’insieme delle emozioni umane.Siamo noi stessi, in ogni istante irripetibile dellanostra vita, in ogni momento in cui facciamo dellescelte e diamo un senso profondo e autentico allanostra esistenza nel fluire del tempo.
GIULIO BATTIONI
La nozione di potestas civilis e il rapporto fra Statoe Chiesa in Francisco de Vitoria (Aracne, Roma 2014, pp. 476, € 20,00)Vitoria ha avuto il merito di porre le premesse per ilsuperamento degli assolutismi teologico-politici del-l’età medievale, dal clericalismo confessionaleall’“imperialismo pagano”. Al Professore diSalamanca si deve la prima teoria giuridica che hareso pensabile il pluralismo culturale e spiritualecome ordinamento internazionale informato ai prin-cipi del diritto naturale e della dignità universaledella persona umana. “A cavallo tra due epoche”,Vitoria ha cercato una sintesi possibile tra la via anti-qua e la via moderna: da un lato ha tentato di rimane-re fedele a san Tommaso d’Aquino e alla sua filoso-fia del primato dell’oggetto e dell’atto sulla facoltàovvero del iustum sulla iustitia; dall’altro ha accoltol’impostazione soggettivistica del diritto cara alnominalismo e alla Scuola francescana. Sollecitatodalle vicende politiche americane e di fronte ai graviinterrogativi morali e giuridici sulla condotta colonia-le della Spagna di Carlo V, Vitoria elaborò una teoriadel potere fondato sulla dottrina del diritto naturale esu una prospettiva finalistica. Il rapporto tra Stato eChiesa è da leggersi nell’ottica di una secolarizzazio-ne more aristotelico che, Doctor Angelicus mediante,ricompone il dissidio tra naturalismo politico esovrannaturalismo teologico. “Vino antico versato inotri nuove”, il genio di Vitoria ha saputo parlare almondo che lo circondava all’insegna di una rinnova-ta apertura alle ragioni della libertà umana, della lai-cità della potestas civilis e del diritto della Chiesa dievangelizzare il mondo.
45libertas
Segnalazioni bibliografiche

ROCCO PEZZIMENTI
Etica. Le sfide della modernitàPer una morale condivisa(Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 262, €16,00)Dopo una prima parte critica verso una visione filo-sofica che ci ha portati dalla ricerca di una moraleprovvisoria alla provvisorietà della morale, il presen-te lavoro analizza il problema dei valori morali socia-li cercando di arrivare a una morale sociale condivi-sa. Si scoprono così una serie di presupposti irrinun-ciabili – come il lavoro, la persona, la responsabilità,il pluralismo, l’etica del conflitto, il diritto alla veri-tà, il senso del limite, la fiducia sociale, la cittadinan-za, la fratellanza e loro corollari: libertà, dignità,eguaglianza, giustizia, solidarietà, e altri ancora – checostituiscono i cardini di una vita sociale nella qualetutti possono realizzare le proprie più legittime aspi-razioni. Tali valori sociali, in un clima di crescentesicurezza, consentono lo sviluppo dell’intelligenza el’accrescimento della cultura, aspirazioni caratteriz-zanti della natura umana. Il libro si chiude con unbrevissimo itinerario per un’analisi storica, canovac-cio per ulteriori ricerche, nell’intento di sottolinearecome, nonostante alcune ricorrenti visioni pessimisti-che, il cammino dell’umanità sia costellato da uncostante sforzo di miglioramento, anche se questoviene, a volte, infranto da frustranti e pericolose fasidi anormalità politica.
FEDERICO LEONARDI
Tragedia e storiaArnold Toynbee: la storia universale nella mascheradella classicità(Aracne, Roma 2014, pp. 160, € 11,00)Arnold Toynbee (1889-1975) fu figura controversa esfuggente, antichista e bizantinista, teorico delleRelazioni Internazionali: il suo nome è legato soprat-tutto a A Study of History, una storia comparata delleciviltà in dodici volumi, opera che esercitò influenzasu Martin Wight, Karl Popper, Henry Kissinger,William McNeill. Toynbee sembra aver portato allaluce alcuni gangli vitali della cultura europea: il rap-porto con il mondo greco-romano, il senso tragicodegli avvenimenti, la tensione globale della sua civil-tà. Come Spengler, Toynbee ha tentato di elevarel’analogia a scienza, di farne il perno della compara-zione storica. Tuttavia, l’analogia è pensabile soltan-to con le categorie della tragedia greca e quest’ultima
soltanto come religione. Così, al crollo delle certezzeoccidentali, il libro riflette sul senso della culturaclassica e sui limiti della storia universale. Grecia oRoma, rivoluzione o tramonto, democrazia o imperosono i dilemmi su cui l’Occidente s’interroga. La tesifinale è che l’Occidente cerca di rappresentarsi comedemocrazia, liberandosi dalle tentazioni imperiali:cerca tragicamente la catarsi, stornando da sé la tra-gedia dell’impero, che rappresentò la fine del mondoantico.
RAIMONDO CUBEDDU
L’ombra della tirannideIl male endemico della politica in Hayek e Strauss(Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 326, €24,00)Intesa come “il male congenito alla vita politica” latirannide/totalitarismo non è semplicemente la dege-nerazione di un regime politico. Può presentarsi informe sempre nuove; e la democrazia non ne è l’an-tidoto. Hayek e Strauss si chiesero come mai la filo-sofia politica del Novecento non seppe riconoscere ilpericolo e perché teorizzò una “tirannide buona”.All’origine della mentalità tirannica sarebbero allorail desiderio di gloria, di accelerare politicamente, equindi con la coercizione, i processi storici, economi-ci e sociali verso lo “Stato universale e omogeneo”, ela dimenticanza della fragilità della conoscenzaumana. Ma se Strauss pensa che l’analisi dei classicisia tuttora insuperata, Hayek immagina rimedi a unmale che i fallimenti della troppa politica finisconoper aggravare.
AA.VV.Dizionario del liberalismo italiano, tomo II(Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 1194, €48,00)Il secondo tomo del Dizionario del liberalismo italia-no presenta una selezione di biografie di 360 perso-nalità che hanno fatto parte del “mondo liberale”dagli inizi dell’Ottocento a tutto il ventesimo secoloe cioè dagli anni di preparazione del Risorgimentoalla fine della Prima Repubblica. Si tratta di un cor-pus che riguarda primi ministri, statisti, leader politi-ci dell’età liberale, personalità che hanno avuto unruolo nell’antifascismo, nella Resistenza e nella fon-
46libertas
Segnalazioni bibliografiche

dazione del sistema repubblicano. Accanto a loroeconomisti, filosofi, poeti, scrittori, storici, diploma-tici, funzionari dello stato, uomini di cinema, artisti,musicisti ecc. Le voci sono state redatte da storici,filosofi, economisti, giuristi, musicologi, studiosiappartenenti a diverse scuole di pensiero ed orienta-menti culturali, che hanno lavorato in piena autono-mia e che hanno in comune l’interesse e la competen-za sul tema assegnato. Dalla lettura del Dizionarioesce un quadro interessante di una classe politica e diun ceto dirigente, ricostruito senza intenti agiografici,né liquidatori, ma realistici e oggettivi, nella convin-zione che per dare un giudizio nei loro confrontioccorre lasciare liberi i lettori di fare una compara-zione con le classi politiche precedenti e con quellesuccessive.
SILVIO PELLICO
Tommaso Moroa cura di L. Poggi(Fontana di Trevi, Roma 2014, pp. 130, € 13,00)“Nella vita e nella morte di Moro, Pellico, letterato‘impegnato’, rivede la sua stessa vita, la vita di unuomo imprigionato per aver lottato per ideali di liber-tà e per essersi opposto ad una tirannia politica e,come lui, per aver trovato nella fede un forte sostegnoai suoi ideali. Come egli stesso riconosce nella dedi-ca della sua nuova opera, Pellico era affascinato dallapossibilità di rendere in una tragedia la morte diTommaso Moro, il contrasto tra ‘la tirannia del reapostata’ e ‘la rettitudine del fido cattolico suo oppo-sitore’”. (Dalla Prefazione di Luca Poggi)
ABBY JOHNSON
ScartatiLa mia vita con l’aborto(Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 320)Nell’ottobre 2009, quando Abby Johnson si licenziòda direttrice di una clinica texana in cui si eseguiva-no aborti, negli Stati Uniti il suo caso ebbe una gros-sa risonanza. I giornali e le televisioni accorsero datutto il paese per conoscere la sua storia. In questolibro la Johnson racconta la sua drammatica conver-sione da sostenitrice dell’aborto ad attivista cristianaper la vita. Non si tratta però di un libro ideologico.L’autrice narra i fatti che ha vissuto in prima persona,le sue emozioni, il suo dialogo con Dio, gli scrupolimorali che l’hanno portata a rifiutare per semprel’aborto come soluzione ai problemi delle donne.Abby Johnson non esita a parlare dei segreti più ter-
ribili della sua vita, ma non usa mai, verso nessuno,parole d’odio o di condanna. La sua vicenda dimostrache l’amore, la gentilezza e la compassione possonofare la differenza nel dibattito sull’aborto.
ENRIQUE FUSTER (A CURA DI)La figura del padre nella serialità televisiva(ESC Roma 2014, 360 pp., € 28,00)“La figura del padre nella serialità televisiva” è iltema del Convegno che la Facoltà di Comunicazionedella Pontificia Università della Santa Croce ha orga-nizzato a Roma il 22 e 23 aprile del 2013, i cui attisono raccolti in questo volume. Partendo dalla figuradel padre si voleva riflettere su come persona, fami-glia e società siano oggi rappresentate nelle serie tele-visive, che sembrano vivere una nuova età d’oro:hanno raggiunto grandi livelli di qualità tecnica, egrazie alla globalizzazione e a internet hanno molti-plicato la loro capacità di creare e modellare stili divita, al punto che qualcuno ha indicato i loro autoricome “i grandi narratori del XXI secolo”. Il modellonarrativo è quello tipico della serialità, usato fin dal-l’antichità nella letteratura popolare e da numerosiscrittori classici. L’uscita differita nel tempo dei varicapitoli e delle varie puntate possiede un grandefascino e offre ampie possibilità per lo sviluppo ditrame, personaggi e temi. Ma può anche generaremeccanismi perversi che diminuiscono l’unità el’identità narrativa di questo tipo di prodotti d’intrat-tenimento, ormai fortemente condizionati dalla pub-blicità e dall’audience.
FRANCESCO CURRIDORI
Indro MontanelliUn giornalista libero e controcorrente(Aracne, Roma 2011, pp. 188, € 12,00)Indro Montanelli è stato senza dubbio il giornalistache ha saputo, meglio di chiunque altro, raccontare lastoria del Novecento nel nostro paese. È stato l’alfie-re della libertà di stampa e dell’autonomia del potere.Agli albori della sua amata professione, Montanelli sidimostrò anarchico e anticonformista. Dapprimafascista e poi frondista finì per essere antifascista. Siè sempre considerato un uomo di Destra, ritenuto nonsolo uno spazio politico ma una condotta morale.Tuttavia egli ha cambiato spesso pensiero nella suavita lunga quasi un secolo, non per questioni politi-che, bensì per seguire la sua personalità così perento-ria e carismatica. Non voleva per nessun motivoassoggettarsi al potere e la sua unica prerogativa eraquella di rimanere indipendente per perseguire ciòche lui stesso definiva: “il dovere dell’onestà, della
47libertas
Segnalazioni bibliografiche

Missione e profilo
Il Tocqueville-Acton Centro Studi e Ricerche è un think-tank indipendente, di ispirazione cattolica e libe-rale, che intende:
- favorire l’incontro tra studiosi, intellettuali, cultori ed accademici interessati alle tematiche filosofiche,storiografiche, epistemologiche, politiche, economiche, giuridiche e culturali, avendo come riferimentola prospettiva antropologica ed i principi della dottrina sociale della Chiesa;
- promuovere una discussione pubblica più consapevole ed informata sui temi della concorrenza, dello svi-luppo economico, dell’ambiente e dell’energia, delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, della fisca-lità e dei conti pubblici, dell’informazione e dei media, dell’innovazione scientifica e tecnologica, dellascuola e dell’università, del welfare e delle riforme politico-istituzionali.
Si intende così rispondere all’assenza, nel nostro Paese, di un centro di elaborazione politica e culturale diispirazione cattolica e liberale, capace di promuovere nella società civile, nelle istituzioni e nella politica iprincipi dell’economia sociale di mercato, della dottrina sociale della Chiesa e dell’etica negli affari.
Philosophy statement
Vision“Una società aperta, libera e virtuosa dove la persona non sia ridotta a mero strumento ma a fine ultimodell’agire umano, affinché ognuno, con il proprio lavoro, possa partecipare alla continua opera creatrice,secondo le proprie attitudini, competenze e capacità, nei settori dell’economia, della politica e delle istitu-zioni” .
Purpose“Divenire un riconosciuto punto di riferimento per l’economia sociale di mercato e l’etica nell’econo-mia e nelle istituzioni, un luogo scientificamente eccellente di riflessione e di elaborazione sulla fun-zione, l’insorgenza e l’attuazione delle norme morali, giuridiche e sociali che regolano la convivenzatra gli uomini”.
Means“Dar vita ad un think-tank nel quale, attraverso il costante riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, sicoltivi la responsabilità morale e sociale di quanti prendono le decisioni nelle imprese, nelle professioni enella pubblica amministrazione e si sostenga, con una produzione scientifica di punta, l’elaborazioneimparziale di politiche pubbliche, alle quali possano ispirare la propria azione i responsabili delle decisio-ni politico-amministrative democratiche nelle istituzioni di governo centrali e locali”.
www.tocqueville-acton.org

Libertates crede nella capacità dei cittadini di auto-organizzarsi per difen-dere i propri ideali e interessi. Al centro dei loro principi c’è la culturadelle libertà, cioè l’adesione ai valori liberali e la volontà di partecipazio-ne alle scelte politiche. Più in particolare, gli aderenti sostengono il libe-ro mercato, la diffusione universale dei principi di democrazia, il federa-lismo e la sussidiarietà come metodi organizzativi, lo sviluppo di ogniforma – globale e locale – di democrazia diretta.Fondata nel 1998, Libertates ha come organi statutari un Comité de
Patronage internazionale, presieduto da Vladimir Bukovskij; un Comitato di Presidenza rappre-sentativo della cultura liberale; un Esecutivo che elegge il Presidente. Attorno a questi organi,una rete di Comitati locali responsabili dell’attività sul territorio, per la diffusione e l’afferma-zione della cultura delle libertà. Chiunque può chiedere di aderire alla federazione e farne parte,dopo la ratifica dell’Esecutivo.L’atttività di Libertates si può conoscere attraverso: - il sito internazionalewww.Libertates.com; - le news settimanali “Libertates” - le riviste digitali; - la casa editriceLibertateslibri; - eventi e incontri organizzati durante l’anno..
Il terzo strapotereSaggio di Antonio Martino eFabio Florindi sulla magistratu-racon interviste aPiero Alberto CapotostiPaolo GuzzantiMario CattaneoBenedetto Della VedovaStefano d’AmbruosoMario Cervi
Maledetta proporzionale
Saggio di Dario Fertilio sullaleg ge elettoralecon giudizi di HannahAhrendt e Karl Popper;interviste a Willer Bordon,Giu seppe Calderisi, DanieleCapez zone, Benedetto DellaVedova, Paolo Guzzanti,Giovanni Guz zetta, AngeloPanebianco, Gian francoPasquino, Mario Segni, MarcoTaradash, Adriano Teso,Guido Roberto Vitale
Contro gli statosauri
Volume di Stefano Magni cheraccoglie saggi di studiosi delfederalismo e interviste a perso-nalità che si occupano di questotema anche nell’ottica politicaed economica.Una serie di valutazioni e pro-poste per un federalismo auten-tico, moderno, realistico e van-taggioso per tutti.
Se vuoi far l’americano, co -me si entra in politica ne gliUSA e come la si fa: una le -zione per gli italiani.Saggio in cui Ennio Caretto, scrit-tore e giornalista, corrispondenteella Sera” prende spunto da unalettera-riflessione di Adriano Teso,imprenditore e liberale, a un gio-vane che vuole entrare in politica. L’autore traccia un ritratto del siste-ma politico ed elettorale america-no senza nasconderne limiti edifetti. Ma ritrae anche un sistemacapace di ga rantire un’autenticademocrazia in cui ogni cittadinoha davvero la possibilità di essereeletto e di scegliere i propri rap-presentanti.
Tutti i libri editi da Bibliotheca Albatros (la casa editrice dei Comitati per le Libertà) si trovano e si ordinano attraverso il sito www.libertates.com