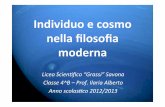LE OPERE E I GIORNI - giancarlobova
Transcript of LE OPERE E I GIORNI - giancarlobova

1
■ LE OPERE E I GIORNI
Giancarlo Bova
La vita quotidiana a Capua al tempo delle Crociate
ed. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001
Le distruzioni (quale quella saracenica dell’841), gli incendȋ, i sacchi, non
possono essere mai tanto forti da annientare una città, pur rimasta senza più
mura.
Così Capua Vetere sarebbe rimasta in vita, al sicuro nel cuore d’un pioppe-
to, con le sue vie, l’asinaria e la vaccara, con i suoi frutti, della vinea e
dell’olivetum, a volerla vinta sulla desolazione delle paludes e sulla violenza
degli uomini.
Votata all’Assumptio, la città antica non fu abbandonata dagli angeli, da
quegli spiriti beati, lasciati dal buon Dio liberi di danzare sulle sue macerie,
come a volerne suscitare nuova linfa, per una sua resurrezione.
In verità la città antica non è mai morta, né nell’aria celeste dello spirito né
nella mente terrena dello storico: le due Capue, vecchia e nuova, convivono,
sì da augurarcene, noi figli del 2018, l’unificazione.
Il Mito e la Storia convivono, ma la Storia avanza, senza comunque semi-
nare il pànico né cancellare la memoria.
Entriamo nella Città fridericiana, dopo aver superato gli anni longobardi e
normanni.
Capua nuova ha il suo Spazio occupato da hostarie e casali, movimentato
da seterie e tintorie, animato da apothece e mulini, di quelli idraulici, costruiti
lungo il Volturno, il fiume che si avvolge intorno alla città, per poi srotolarsi
lungo la campagna, fino a lambire i cavalli e gli ovini che vi lavorano.

2
Capua nuova ha il suo Tempo, governato dalla Chiesa, che gli uomini mi-
surano contando i tocchi del campanile.
Di quegli uomini, delle loro microstorie di vita, si è interessato lo storico
Giancarlo Bova, dèdito allo studio delle pergamene, che sotto i loro “aridi
formulari”, scrive Bova, nascondono quei “brandelli di vita interiore” propri
della storia reale, quotidiana, della storia che conta.
Mosso dalla “curiositas”, lo storico capuano interroga le pergamene otte-
nendo risposte distanti dalla “Grande Storia” cartacea, risposte vicine alla
quotidianità dei soggetti sociali, con i loro materiali economici, i codici isti-
tuzionali, i condizionamenti culturali, anche con le loro proiezioni immagina-
rie.
Quegli uomini capuani, che isieme allo storico pur s’interrogano sui grandi
temi esistenziali quali la vecchiaia e la morte, intenzionati a non abbandonare
la speranza di vivere a lungo, si raccontano facendo i loro gesti quotidiani,
espressioni dei loro bisogni d’ogni giorno.
A partire dall’Alimentazione: l’installazione dei forni nelle vicinanze delle
chiese; i legumi a tavola, dai cicera ai pisa alle lenticulae; il piccante equica-
seum; la frutta in abbondanza; il vino per i più abbienti.
Passando all’Abbigliamento: con le cinture di cuoio per gli uomini e le cin-
ture d’argento per le donne.
All’Arredamento: il letto in ferro e i materassi di vegetali e di piume in ca-
mera, le pentole e i tegami di rame in cucina.
Ai Costumi: delle madonne distinte e separate dalle donne pericolanti.
Alla Cultura: scientifica, prevalentemente medica e astronomica; giuridica,
di notai e giudici; letteraria, cavalleresca e amorosa; musicale, con la colloca-

3
zione dell’organo nella cattedrale del ’400; teatrale, dalle rappresentazioni
sacre ai numeri degli iocolarii e dei buffolani.
Ai Divertimenti: la caccia e la pesca per i più ricchi votati al tempo libero,
diversamente dal bosco e dal fiume utilizzati dai più poveri per la sopravvi-
venza; il gioco dei dadi, capace di attrarre tutti, ricchi e poveri; le scommesse
sui galli da combattimento.
Alle Fiere: di una durata anche superiore alle due settimane, dominate dai
porci onnipresenti…
Una variegata galleria di Tipi umani attraversa Capua medievale: dai cava-
lieri fieri ciascuno della sua spada agli ospedalieri rappresentati da fratres e
sorores mossi dalla fede religiosa a soccorrere poveri e malati; dagli avari
agli astuti; dai tafuri ai giramundi ovvero gli immancabili truffatori e vaga-
bondi.
E passando dalla società laica alla società clericale, anche qui la tipologia è
variegata: dall’Arcivescovo di Capua alla truppa dei sacerdoti, non tutti
rispettosi dell’obbligo del celibato; dai giudici ecclesiastici ai bibliotecari
vescovili, questi ultimi con mansioni anche di cancelliere; dai sacrestani ai
nutriti, i monaci allevati nel monastero fin dall’infanzia; fino agli affreschi
delle chiese dotati d’una loro animazione, alcuni tenebrosi e inquietanti, altri
luminosi e affascinanti, quale quello della Madonna delle Grazie, risalente al
’300, segnalata dallo storico per la sua particolare “bellezza”, comprendente
tratti occidentali e orientali, a dirci di Capua città-crocevia di popoli e culture,
campagne e porti, di fiumi e di mari, dal Mediterraneo al Nero, dalla Siria al-
la Persia, fino alla Cina.
Ancora nell’àmbito ecclesiastico una figura spicca perché particolarmente
suggestiva, è il turiferario, così dettagliatamente descritto dal nostro storico:

4
“Si tratta del chierico incaricato di portare il turibolo (da “tus turis”, “incen-
so”), cioè il piccolo vaso di metallo dall’ampia bocca, sostenuto da tre cate-
nelle e contenente un piccolo braciere per sostenere i carboni sui quali, duran-
te le funzioni liturgiche, si pone l’incenso onde farne uscire il fumo profuma-
to, simbolo della preghiera”.
In quel fumo ci sembra di vedere, odorare, sentire qualcosa di spirituale,
d’una spiritualità che aleggia sulla “vita quotidiana a Capua” pur governata
dalla produzione e dal commercio, bisognosa non solo di uomini d’affari ma
anche di uomini in “preghiera”, perché la vita sia vissuta senza dolore, possi-
bilmente con letizia.
Con la stessa letizia spirituale della “domenica delle ghirlande”, ricordata
in chiusura dell’ultimo capitolo del libro dedicato alle Feste religiose: quan-
do, la prima domenica di maggio, si celebrava la traslazione del corpo di San-
to Stefano da Costantinopoli a Roma, omaggiandolo con corone di rose e di
altri fiori.
Antonio Falcone
Firenze, 2018

5
■ LEZIONE DI STORIA
Giancarlo Bova
Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana (1281-1282)
ed. Palladio, Salerno, 2017
L’Introduzione di Giancarlo Bova al suo testo vale di per sé quanto un
libro, uno di quei libri degli “annalisti” francesi che mi davano ossigeno:
studente universitario, costretto a leggere spesso testi asfittici, a volte mi
capitava tra le mani qualcosa di più arioso, ad esempio un Emmanuel Le Roy
Ladurie con i suoi “Contadini di Linguadoca”, a dirmi che la Storia è una
questione di uomini con la loro vita quotidiana piuttosto che di idee con la lo-
ro presunzione imperitura… leggendo le pagine di Bova, mi sono rituffato
nel clima di quella storiografia così particolare, praticata per gli esami uni-
versitari di Storia, che furono impegnativi per me.
La piccata premessa di Bova, in merito al suo lavoro ostacolato dalle istitu-
zioni assenti, dalla presente “parentopoli” accademica, dall’ostracismo e
dall’irriconoscenza, ha meritato la mia attenzione: come non essere ricono-
scente ad uno storico come lui?, come non incoraggiarlo a continuare il suo
lavoro?, di uno storico che opera con onestà intellettuale, che disdegna le ma-
novre truffaldine degli storici improvvisati, usi a glissare sui testi mai analiz-
zati, a pilotare le bibliografie, ad allestire convegni.
In direzione contraria, il nostro storico va alle fonti con la curiosità solerte
del ricercatore che si è dato il dovere di “aprire strade nuove, reperire nuovi
documenti”.
Così, prendendo le distanze dagli orecchianti, l’Autore rivendica il diritto
allo studio, che conduce da decenni verso traguardi sempre superati, con quel

6
suo rigore che non è solo occhiuta acribìa, è generoso impegno, utile ai lettori
disposti, insieme a lui, alla ricerca della verità: verità nascosta sotto le per-
gamene (normanne, sveve, angioine, aragonesi) da investigare, quelle perga-
mene nella quali lo storico si rispecchia per intero.
Di qui le sue “sudate carte”, che dicono di uno studio non solo cartaceo,
non sedentario, che dicono di un cammino attraente…
Non solo capitoli, ma anche siti da rintracciare, all’inseguimento di qualco-
sa che vada oltre la regolamentazione dei beni, oltre la loro giustificazione
spirituale: al di qua delle cattedrali ci sono le campagne e i loro contadini
ancora viventi da interrogare; al di là delle cattedrali ci sono altre ragioni di
vita, esistenze che si schiodano dall’Economia e dalla Chiesa, esistenze sfug-
genti che tocca allo storico inseguire, non catturarle, ma comprenderle.
Valgano alcune immagini proposte dall’Autore, a dirci del desiderio, pro-
prio dello storico, di fermare la Storia, e della consapevolezza, ancora dello
storico, dell’impossibilità dell’operazione, comunque da tentare, perché sul
Tempo c’è da scommettere: si avverte una sua sofferenza psicologica mista
ad un suo godimento tattile, a contatto con quelle pergamene conservate nelle
sacche come appartenenti ad un “archivio mobile”, con quei “quaterni” sciol-
ti mai rilegati, con quelle bolle vescovili fornite di “sigilli pendenti” di piom-
bo o addirittura d’oro… materiali prelevati dai “depositi”, alcuni “in restau-
ro”, altri “scomparsi”.
La fluidità, per non dire la precarietà degli uomini e delle cose, ci indurreb-
be a deporre le armi, ma lo storico non si dà per vinto, egli continua a com-
battere per un’improbabile completezza, lo storico resiste perché forse crede
più degli altri nella vita, nella possibilità di custodirla per sempre.

7
Così può succedere che lo storico s’aggrappi alla numerazione a lapis sul
dorso della cartella o al signum lasciato dal notaio, mantenendo il conto delle
“pezze” di terra e dei mulini dati in concessione, il conto delle transazioni, il
conto dei tarì e dei fiorini a disposizione della Storia.
Storia spirituale e materiale, attraversata dalle confraternite devozionali e
dalle corporazioni lavorative: dai maestri, grammatici, bibliotecari, archivisti,
cancellieri; ai falegnami, canestrai, sarti, tintori, calzolai, pure “calzolai che
rappezzavano le vecchie pianelle”; agli addetti alle cibarie quali i molinari, i
farinari, i maccaronari, i cernitori di grano.
Storia delle convergenze e delle costruzioni: si produce, si mangia e si cre-
sce a Capua, città europea sul Volturno e sull’Appia, pari a una città marinara
italiana come Amalfi.
Storia dei contrasti e delle lacerazioni: un benessere diffuso laddove la fa-
me, talvolta congiunta alla violenza, vedeva i genitori affidarsi alla Provvi-
denza “per il futuro alimentare dei loro figli”.
Capua medievale che ospita Francesco e assiste ad un miracolo del santo
che salva una donna dalle acque del fiume, Capua che ospita Boccaccio in-
namorato di Fiammetta… Capua redditizia della lana, della canapa e del lino,
che conosce anche la povertà, la società degli affamati, ricordati dallo storico.
Un atteggiamento storiografico va riconosciuto a Bova, da lui stesso rileva-
to in una nota critica indirizzata a quegli storici, o sedicenti tali, che forzano i
documenti a “dire ciò che non dicono”.
Nella quantificazione delle superfici e nella qualificazione degli uomini che
le hanno ricoperte l’Autore è risultato equo, equilibrato, non fazioso.
Le luci e le ombre di Capua medievale vengono denunciate tutte, senza
riserve, parlandone con passione, misurata passione, dalle origini ai giorni fu-

8
turi: da Capua antica incendiata dai Saraceni a Capua nuova fondata sulle ri-
ve del Volturno, dall’841 all’856 fino al 2017, quando, in una lettera al mini-
stro dei Beni Culturali, Bova traccia il disegno delle due Capue (vetere e neo)
unificate sotto l’auspicabile guida di un unico sindaco.
“Capua… un Museo all’aperto”, non uno slogan, turistico e pubblicitario,
ma una proiezione, storica e culturale.
Antonio Falcone
Firenze, 2018

9
■ UN FIUME, UNA VIA
Giancarlo Bova
Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana (1439-1442)
ed. Palladio, Salerno, 2016
Fu Leonardo, uscito dal cuore del Rinascimento, a dirci della de-compar-
timentazione dei saperi e a darcene le sue stupende dimostrazioni.
Da storico e non da artista, addetto alle letture interpretative del mondo che
c’è piuttosto che alle congetture creative del mondo che sarà, Giancarlo Bova
nella premessa al suo testo fa una preziosa puntualizzazione sul lavoro dello
storico, chiamato appunto alla de-compartimentazione: vi si afferma, prati-
candola, un’idea di Storia avvalentesi di diversi saperi, di varie discipline
quali l’antropologia, l’economia, la giurisprudenza, oltre all’araldica, l’ono-
mastica, la toponomastica, insieme alla paleografia, alla diplomatica, all’ar-
chivistica, queste ultime particolarmente care al nostro Autore.
Si potrebbe dire ancora qualcosa di più: la de-compartimentazione, che at-
tiva ingressi e uscite e rientri di sempre nuove conoscenze, si affianca ideal-
mente alla sinestesìa, che non è solo una soluzione retorica propria della lette-
ratura, ma è anche, nel nostro caso, una modalità storiografica seguìta dallo
storico interessato a coinvolgere i suoi lettori, la loro mente, compresi i loro
cinque sensi.
Quanto ci raccontano “Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Ca-
puana” attrae la nostra vista, l’udito, l’odorato, il tatto, il gusto, sì da comuni-
carci sensazioni che mescolate insieme possano impressionarci, oltre che in-
formarci: quegli anni particolari nel cuore del Quattrocento hanno da lasciarci
delle impressioni, dei ricordi incancellabili.

10
E lo storico, per ottenere tali risultati, non gioca a rincorrere effetti speciali,
non è il regista di una fiction, non assegna i ruoli agli attori sociali, lo storico
ha da lavorare duro, per un numero incalcolabile di giorni, lasciando che gra-
zie ai suoi studi sia il Tempo a disegnare i netti profili degli uomini e delle
cose.
È il lavoro di Giancarlo Bova che non nasconde di divertirsi così, dando
prova che la puntualità dello storico non è greve come invece un malinteso
concetto di Storia vorrebbe: essa, sostenuta dalla coscienza etica dello studio-
so, è pur movimentata dall’incoscienza felice del ricercatore, che a modo suo
è uno scommettitore, uno che gioca a indovinare, e che a volte si dispera,
quando per esempio le note apposte alle pergamene in epoche diverse non lo
aiutano a risolvere il problema.
Per lo storico, c’è sempre un problema in quello che il documento dice, nel
modo in cui lo dice, anche in quello che esso tace.
Da quarant’anni, estati roventi comprese, Bova è lì, puntuale, nel silenzio
degli archivi, a svelare i corpi e le voci assenti, meritevoli di considerazione
in questo nostro tempo sconsiderato.
- - -
Dicevamo della de-compartimentazione.
Nell’epoca del Re Utriusque Siciliae, il Sud d’Italia, da L’Aquila a Catania,
fu un grande porto di carri e natanti confluenti, animati da soggetti recitanti le
loro vite sotto le guide laiche e spirituali, alla luce delle istituzioni e delle
chiese, coinvolte negli accadimenti chiaroscurali franco-spagnoli.
Di Capua, “capoluogo di circoscrizione regia e religiosa”, città sul fiume
Volturno e sulla via Appia, lo storico meridionale ci spiega l’orgogliosa
“Capuanitas”, l’identità particolare di una popolazione tanto territoriale

11
quanto globale, protagonista di traffici commerciali e di feste religiose, pron-
ta a coniugare con disinvoltura tarì e preghiere, ecclesiastici tesorieri in pri-
mis.
Capua, una città oggi “appena indicata in una carta geografica”, in età me-
dioevale non inferiore ad Amalfi, è stata crocevia di operatori economici lo-
cali e forestieri quali gli abruzzesi e gli umbri e stranieri dagli svizzeri ai russi
passando per il Medio Oriente.
Agli ecclesiastici di fiducia del re Alfonso il compito dell’amministrazione
dei beni della Chiesa di Capua: soprattutto la percezione del censo “mediante
la locazione di botteghe, terre, mulini e porti, con le relative tasse di entratu-
ra”; non solo locazioni, ma anche concessioni, anche vendite; e non solo
promosse da enti religiosi, ma pure da privati.
Dall’àmbito amministrativo a quello giudiziario, veniamo a sapere che i
capitani di giustizia, prevalentemente spagnoli, si sono avvalsi della “collabo-
razione di giudici, bàiuli e sostituti locali”.
Le vendite delle pezze di terra dietro la corresponsione di decine di tarì
d’argento erano redatte dal notaio, figura, questa, frequentata dallo storico,
interessato a tradurne quanto scritto sulla pergamena con quell’inconfondi-
bile sigillo “in cera rubea” che sembra voler riassumere un’intera civiltà in
un simbolo.
Ma il Medioevo, simbolista per eccellenza, avrebbe fatto pure spazio alla
techne, accogliendo e diffondendo i primi sìntomi della modernità: del muli-
no idraulico, di cui si provvedono le chiese, i monasteri, oltre alle famiglie
benestanti, si sarebbe promosso un utilizzo allargato a varie attività, “dalla
macina del grano alla segatura del legno, delle piante, delle fibre”.

12
L’edilizia, in riparazione e in espansione, voleva il rifacimento dei tetti e il
controllo dei ponti, oltre all’edificazione di nuovi castelli e all’innalzamento
di nuove torri.
E le famiglie che vi abitavano?, i loro nomi? “È sempre abbastanza com-
plesso poter ricostruire dai documenti l’origine di un gruppo familiare, a me-
no che esso non abbia fatto qualcosa di eccezionale, passando per così dire
alla Grande Storia, lasciando memoria di sé”, risponde lo storico, invogliato,
come per una compensazione, alla ricerca di documenti che dicano dei picco-
li nuclei familiari della “piccola storia”: si legga, a mo’ d’esempio, quanto lo
storico scrive della famiglia Cece con le sue varianti Cecio, Ceci, Cecere,
ecc. (dal latino cicer a voler indicare un’“escrescenza rotondeggiante sul vi-
so” al toscano popolare cecio relativo alla “pianta erbacea delle legumino-
se”), d’origine laziale-romagnola e da secoli presente in Campania, a partire
dal cognomen di Marco Tullio Cicerone fino al garibaldino Gaetano Cecio di
S. Maria Capua Vetere decorato con medaglia tra i “Benemeriti della Libera-
zione di Roma 1849-1870”.
Pur mantenendo la centralità degli anni del Quattrocento, 1439-1442, si può
sconfinare nel passato e nel futuro di quel tempo, dimezzando e raddoppian-
do, dal Duecento di Federico II all’Ottocento del Risorgimento, a dimostra-
zione della dinamicità della Storia, delle mobili irradiazioni di una città signi-
ficativa come Capua.
- - -
Dicevamo della sinestesìa.
Sullo sfondo del grand récit di Bova si stagliano le figure nitide della socie-
tà capuana quattrocentesca: i terrìcoli, i naviganti, i mercanti ancor più degli

13
amministratori, con la loro canapa soprattutto, a fondamento dell’economia
in Terra di Lavoro.
Salgono le voci, dei dialetti e delle lingue, a dire delle diverse culture, delle
loro misture, destinate ad arricchire Capua, non certo a depauperare la città
come qualche maldestro storico razzista sosterrebbe: lingue mediterranee e
mediorientali, dialetti del Centro-Nord d’Italia, flessioni napoletane trattan-
dosi della Campania, e timbri particolari, quali quelli femminili, delle bades-
se addette a smistare il traffico dei servizi, delle corresponsioni monetarie, dei
capponi di Natale, dando ordini anche verbali, chissà se bruschi o aggraziati.
Ed insieme ai suoni gli odori: dei profumieri e degli stallieri, provenienti
dagli alambicchi e dagli animali, soprattutto la puzza della canapa macerata
nei lagni, in quelle conche naturali alla periferia di Capua.
Una buona narrazione storica può coinvolgere anche il tatto del lettore: ci
sembra di toccare con mano quella pagnotta data insieme ad una misura di
vino dal monastero al lavoratore giornaliero, con lui sistemiamo gli assi dei
carri, mettiamo i cerchi alle botti, lisciamo la cotenna della bufala uscita idra-
tata dal garamone.
Contadini, coltivatori e allevatori non solo, anche ubriaconi e meretrici fan-
no parte dell’umanità che lo storico non può ignorare, insieme ai frutti lussu-
reggianti o bacati che la natura procura: come disconoscere, per esempio, il
gusto delle castagne e delle mele della nostra terra?
- - -
È il destino dello storico: di ritornare alla sua terra, dopo aver attraversato i
meridiani e i fusi d’ogni spazio e d’ogni tempo… si riproducono quei frutti di
Terra di Lavoro ogni autunno che viene, si ripropongono le acque del Voltur-
no verdi sotto ogni sole promettente, si rincorrono a tutt’oggi le voci degli

14
ambulanti lungo l’Appia, ignari eredi d’un tesoro, custodito in un libro di
Storia.
Antonio Falcone
Firenze, 2019

15
■ ARAGONESE
Giancarlo Bova
Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana (1443-1449)
ed. Palladio, Salerno, 2018
Da un volume di oltre seicento pagine che cosa attendersi? Perché il lettore
non resti schiacciato dalla sua mole, ha da oltrepassare la quantità della Storia
contenuta nel libro, ha da seguire piuttosto la modalità storiografica adottata
dall’autore, per darsi un modo di leggere, o ancora meglio, di studiare il testo.
Giancarlo Bova, che ne è l’autore, dalla ponderosa materia raccolta, costi-
tuita dalle “Pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana” di metà
Quattrocento, c’invita ad estrarre lo spirito, conducendoci nel percorso segna-
to nell’antico spazio meridionale e conteggiato dal primo tempo moderno,
con quella severa passione, così particolare, che lo distingue tra gli storici
medievisti in attività ai giorni nostri.
La severità è degli studi condotti da Bova in profondità, di anni vissuti ad
indagare sotto le innumeri carte di un determinato periodo storico (1443-
1449), come sotto gli scogli di un mare mai prima esplorato.
La passione è nella sua ricerca, continua, ripetuta, ma sempre nuova, negli
anfratti della Storia, fino al ritrovamento delle cose che contano: le pergame-
ne da decifrare come pietre da scolpire, con la forza del Tempo che presta le
sue mani allo storico.
Che cos’è se non passione quella del nostro storico?, che perviene, e noi
con lui, alla sensibilità e alla mentalità dei soggetti narrati insieme agli ogget-
ti, con così umana premura.

16
Al logos dello studio dello storico campano si aggiunge il pathos della sco-
perta, fatta da chi ha toccato veramente con mano le pergamene.
Ne ha tirato fuori i messaggi, ne ha interpretato il senso, ne ha individuato
il concetto per poi modellarne la forma, il pensiero degli uomini di quel tem-
po e i loro strumenti per fare: lavorare, commerciare, scambiare, comunicare,
pregare.
Tutto questo emana dalle “membrane”, a volte da soli “frammenti membra-
nacei”, da pergamene tanto lacere da non poter essere ricostruite filologica-
mente con certezza.
E lo storico se ne rammarica, anche pensando alle pergamene date “in re-
stauro” e di fatto trafugate, anche scoprendo le “lacune” causate dalla scolori-
tura dell’inchiostro, perché il colore è importante, perché il rosso e il nero de-
gli inchiostri che risaltano sulla carta accendono gli occhi dello storico, che
ha il gusto dell’estetica.
Un ordine, una bellezza ordinata, tiene insieme le pagine di Bova che, pur
non tacendo le anomalìe: certo “cattivo stato di conservazione” delle perga-
mene, l’asportazione di “sigilli impressi in cera rossa ai documenti”, le “svi-
ste” imperdonabili di storici principianti, continua il suo lavoro storiografico
ininterrotto, da quarant’anni e più, mosso dal bisogno etico, oltre che profes-
sionale, di dare luce e voce a uomini e cose del Sud, spesso riprovevolmente
ignorato dall’industria culturale.
Del Sud, della Campania, dell’area capuana in particolare, qui lo storico
meridionale vuole considerare quel nuovo ceto di intermediari fondiari, costi-
tuenti l’albero motore, per così dire, della nuova società in formazione nel
cuore del Quattrocento: uomini tardo-feudali, anche neo-borghesi, prendono
in affitto tenute agricole di proprietà della Chiesa, o di signori feudali, non

17
solo assicurando un buon livello di rendita ma anche un’intensa attività eco-
nomica, animata da una più razionale e più redditizia amministrazione delle
terre, con un conseguente movimento crescente dei prodotti agricoli nei cir-
cuiti mercantili, prodotti propri delle colture di alberi e piante in espansione.
Natura e denaro convivono, i moggi di terra si prestano ad una loro valuta-
zione monetaria: dai “carlini” d’argento, ai “tarì” d’oro, ai “ducati” che non
sono pochi quando la terra è buona.
Tra fitti e donazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, investimenti ed anche
speculazioni, se ne dedurrebbe una società in crescita, migliorata, se non fos-
se per gli strati inferiori del mondo rurale condannati ad uno sfruttamento più
duro che nel passato, stridente con l’Umanesimo promettente del tempo.
Quegli anni del Quattrocento hanno fatto registrare sì stridenti contraddi-
zioni.
Nei documenti d’età aragonese, relativi ai fitti in enfitèusi, possono darsi
terreni sconnessi, sterili, incolti da cinquant’anni; oppure terreni fertili, flori-
di, vivacizzati da oliveti, vigneti, nocelleti.
Alle starze abbandonate per la carenza di braccianti dovuta alle guerre e al-
le epidemie si contrappongono spazi popolati d’alberi ed acque fluviali e tor-
rentizie, punteggiati da mulini, catalizzatori di imprese e interessi economici,
anche di imprenditori lontani dal Capitolo Capuano quali Fiorentini e Vene-
ziani.
Capua e il circondario è l’area d’elezione attorno alla quale ruota la ricerca
storica di Bova, con i suoi uomini e le sue cose: gli uomini figli della terra e
della macchina, dotati dei loro strumenti umani; le cose che portano sempre
un nome, che riescono a mantenere una loro identità, pur esposte come sono

18
alle transazioni economiche, ai fitti e alle donazioni, alla produzione e al
commercio, allo scambio dei beni.
Le botteghe artigiane in Terra di Lavoro ci dicono della industriosità dei
suoi uomini e della loro capacità di arricchimento: dalla lavorazione delle
pelli a Capua alla lavorazione del lino e della canapa a Marcianise, terra be-
nedetta, di maceratoi ambìti anche da quei Napoletani che riuscivano a rice-
verli in concessione dall’Arcivescovo di Capua.
I luoghi e la toponomastica annessa hanno un’importanza pari a quella at-
tribuita agli uomini e alle opere: c’è Bellona che ha preso il suo nome da una
dea, Casapulla paese anch’esso col nome di un dio pagano, c’è Triflisco dei
boschi e delle acque, c’è Capua nuova a valle di Sicopoli con la sua fortezza
data alle fiamme dai Saraceni, i predatori passati nell’856 per il Ponte de la
Mala Nocte.
Di luogo in luogo, allontanatici nel tempo, ritorniamo a Capua del Quattro-
cento, la città sul Volturno, scossa da eventi anche naturali, drammatici, de-
stinati a volte ad alimentare l’immaginario collettivo: il riferimento storico è
al terremoto del dicembre 1456, a breve distanza dall’apparizione della come-
ta di Halley nel giugno del medesimo anno.
Qui la cronaca buia della città di Capua dove “morirono persone senza nu-
mero e le case furono eguagliate al suolo” si combina con la visione lumino-
sa di una “strella redonda e grande come uno occhio de boe, de la quale ne
uscìa una fiama larga a modo d’una choda de paone”.
Come dire d’una terra ripiegata e d’un cielo straordinario… anche questo è
Storia.
Sotto gli occhi vigili del “giudice”, del “notaio” e dei “testimoni”, che ri-
troviamo immancabili in apertura d’ogni “carta declarationis” (“concessio-

19
nis”, “donacionis”, “locacionis”, “vendicionis”), come un refrain, scorre in-
sieme al Volturno la pellicola della vita ordinaria, quella quotidiana, sociale,
economica e religiosa, incluso qualche fotogramma straordinario, fuori dalla
quotidianità, che interviene a rompere la lunga, pur vera e necessaria, teoria
delle “Carte”.
Ci viene da indugiare su certe immagini proposte dal nostro storico, custo-
de dell’immaginario collettivo: la principessa Arniperga battezzata, da bam-
bina o da donna, chissà su quale corso d’acqua; il principe Ǧem, partito dalla
Turchia per morire a Capua, dopo essere stato venduto e ceduto più volte ai
potenti della Terra; i duemila buoi di Annibale dotati di fascine infiammate
sulle corna nella loro folle corsa contro i legionari romani, secondo quanto
Tito Livio ci narra.
È bene, e Giancarlo Bova lo pensa, che dinanzi alle immagini narrate dagli
storici, a guardare un film della Storia, noi lettori ci accendiamo, restiamo un
attimo stupìti, per poi continuare.
Antonio Falcone
Firenze, 2019

20
■ TRANSAZIONI
Giancarlo Bova
Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana (1283-1292)
ed. Palladio, Salerno, 2019
La macina della Storia continua a girare, non sempre spietata, a volte
disposta ad accogliere certi buoni umori degli uomini, riconoscendone le
aspirazioni religiose che trovano nella Chiesa il loro luogo istituzionale,
l’officina delle anime aspiranti alla salvazione, individuale e collettiva, alle
condizioni d’un esercizio spirituale richiedente non solo l’afflato del fedele,
ma anche l’adesione del cittadino ai codici, ai calcoli, ai conseguenti compor-
tamenti previsti dalle istituzioni laiche e religiose, addette all’organizzazione
della vita di ogni uomo.
Lo Stato e la Chiesa si ritrovano reciprocamente compromessi nella recente
opera di Giancarlo Bova: “Le pergamene angioine della Mater Ecclesia
Capuana”, relative al periodo 1283-1292, successivo al già edito 1281-1282.
Siamo a Capua, al tempo dei sovrani angioini, verso i quali i Capuani
hanno mostrato costantemente “affetto e devozione”, a partire da Carlo I (re
di Sicilia e di Napoli, poi a causa della sommossa palermitana del 1282 solo
re di Napoli), seguìto dal nipote Carlo Martello, reggente negli anni della pri-
gionia del padre Carlo II in Sicilia per mano degli Aragonesi.
A dimostrazione dei rapporti stretti tra mondo laico e mondo religioso, val-
gano due annotazioni dello storico: Carlo Martello operò sotto la protezione
di papa Martino IV; Carlo II, una volta liberato, sarebbe stato incoronato re
da papa Bonifacio VIII.

21
Siamo sul finire del ’200, alle porte del ’300, quando il passaggio dall’Alto
Medioevo feudale e cavalleresco al Basso Medioevo comunale e commercia-
le fa registrare un’intensificazione dell’economia, che la Chiesa è chiamata a
riconoscere.
Ne sono una testimonianza le transazioni economiche della Chiesa capuana
nel contado: da Capua Vetere a Camigliano, da Marcianise a Capodrise, da
S. Prisco a S. Tammaro, da Curti a Recale, da Caserta alla più lontana
Castelvolturno…
Le transazioni economiche hanno toccato anche numerose chiese del centro
di Capua, monasteri limitrofi, nonché ospedali: immobili destinati ad un
probabile abbandono, rimessi in vita dalle Carte “concessionis, donacionis,
locacionis, vendicionis”.
All’immancabile “presenza del giudice, del notaio e dei testimoni”, si con-
cedono, si donano, si locano, si vendono pezze di terra, richiedenti un costo,
promettenti un realizzo.
È un traffico di once e di tarì d’oro, motivato da interessi economici, anche
se non sono da escludere le aspettative spirituali: tra i concessionari, i donata-
ri, i locatari, gli acquirenti, non manca chi dichiara la destinazione del denaro
alla congregazione in un particolare giorno festivo del calendario cristiano.
Oltre alle transazioni, lo storico medievista ha considerato i contratti, di di-
versi tipi: dal “livello” (il contratto di affitto per 29 anni con la clausola di un
rinnovo con l’impegno di un miglioramento della terra concessa, non per 30
anni che avrebbero legittimato il concessionario a rivendicare la proprietà di
quella terra); all’“estaglio” (l’affitto di una terra a cottimo, che prevedeva la
remunerazione del colono secondo il risultato ottenuto); all’“enfitèusi” (l’af-
fitto per un tempo di 3 generazioni o per sempre); alla “precaria” (la conces-

22
sione provvisoria di un immobile presupponente la domanda in forma di pre-
ghiera).
Bova si muove a suo agio nel ginepraio delle pergamene, col gusto dell’in-
quisitore, nel senso storiografico del termine, suggerito da Carlo Ginzburg
che raccomanda allo storico la massima attenzione alle “spie”, agli indizi,
prerogativa dello scienziato, del ricercatore, dello studioso di uomini e cose.
La Storia rinvìa alle storie di predicatori e di lavoratori, intenti a curare
l’anima e il corpo, quanto c’è di spirituale e di materiale nella vita degli uo-
mini, nei loro traffici, nei loro scambi di beni benedetti, crescenti in un tempo
prossimo alla modernità.
Lo storico, mosso da una curiosa passione, rintraccia quelle storie, ne recu-
pera i sensi persi, ne ricuce le pagine sparse, narrandone le origini e i destini,
alle dure e pur piacevoli condizioni di una ricerca storiografica puntuale e
profonda, che sia da mònito ai troppi sedicenti storici frettolosi e superficiali,
talvolta non estranei al plagio, circolanti nell’inaffidabile mercato editoriale
dei giorni nostri.
Le ricerche di Bova, compresa quest’ultima, sono attraversate dalla scienza
non disgiunta dall’entusiasmo: sembra che lo storico si disperi per poi diver-
tirsi nelle sue indagini, per esempio nella scoperta di “fori”, “lacune”, “lace-
razioni” delle pergamene prese in esame, tali da causare la perdita di decine
di lettere, che però lo studioso s’impegna a integrare ricorrendo a letture di
pergamene coeve o tentando congetture, richieste dalla sua attività investiga-
tiva.
Va riconosciuto il lavoro particolare del medievista, al continuo insegui-
mento della “scrittura minuscola gotica” dei documenti, del “signum del no-
taio” spesso di difficile interpretazione, del “signum del giudice” costituito da

23
varie figure non sempre immediatamente leggibili: un segno di croce, un pu-
gno chiuso, una sorta di giglio…
A sventare il rischio di un lavoro routinario, intervengono luoghi, testamen-
ti, eventi, da accendere la curiosità del lettore.
Riportiamo alcuni esempi.
Dei luoghi: S. Angelo in Formis, con quella sua denominazione che si pre-
sta a più di un’interpretazione (“in formis”, “presso acquedotti”; “informis”,
“incorporeo”, immateriale come può essere un angelo; “forma”, “mappa cata-
stale” dei beni della basilica di S. Angelo).
Dei testamenti: Nicola figlio del fu Giacomo nomina suo erede il figlio An-
gelo, stabilisce una somma di denaro da destinare ai sacerdoti per i suoi fune-
rali, prenota 500 messe cantate da religiosi e 500 da sacerdoti secolari per la
sua anima, chiede cha a una settimana dalla sua morte siano distribuiti pane
e caciocavallo ai poveri, decide la chiesa dove seppellire il suo corpo, defini-
sce la costruzione di 3 altari in onore della Vergine Madre di Dio – di S. Mi-
chele – della Croce di Gesù, destìna altro denaro ai frati minori di Capua – ai
frati di S. Agostino – agli ospedali di S. Giovanni e di S. Lazzaro, lascia la
sua casa alla moglie Giuliana a condizione che gli resti fedele dopo la sua
morte, altri beni alla sorella Pavia.
Degli eventi: il Carnevale di Capua, menzionato per la prima volta in un
atto del 1272 dove la badessa Rogasia del Monastero di S. Giovanni delle
Monache concede a Roberto Testor una pezza di terra sita a Casa Cerere
presso S. Angelo in Formis a condizione che il concessionario s’impegni a
consegnare ogni anno 2 tarì di Amalfi e 2 galline (più avanti nel tempo, nel
’500, lo storico annota con ironia che alle tenere “carni di gallina” si sarebbe-

24
ro sostituite le impure “carni di porco”, da procurarsi “a sufficienza per tutto
Carneuale” insieme al “lardo” e all’“insogna”).
Last but not least: merita altrettanta attenzione la cura grafica del testo del
nostro storico sammaritano: le 600 e più pagine avorio, le foto in bianco e ne-
ro, quelle a colori vivaci, comprendenti un mondo di borghi e di carte atte-
stanti la vita attiva dell’ultimo Medioevo al crocevia tra l’inquietudine delle
anime e la scommessa degli affari.
A voler conoscere le ansie e le aspirazioni degli uomini di quegli anni
1283-1292 c’è da passare per le porte delle città, da entrare nelle case e nelle
chiese, da salire sui loro campanili.
C’è da familiarizzare con gli stemmi dei reali, dei clericali, delle famiglie,
così come con le fotografie dei monumenti laici e religiosi raccolti nell’accu-
rato inserto insieme ai ritratti e ai bronzi raffiguranti persone care all’Autore,
fino all’ultima “cappellina piena di storia”.
Dulcis in fundo, ma anche in principio, la “Madonna col Bambino” in co-
pertina, risalente al ’300, ospitata nella Chiesa della Madonna delle Grazie di
S. Maria Capua Vetere, ottimizzata da un giovane bravo fotografo, Graziano
Bova: quella donna che nutre al seno la sua creatura, le dita affusolate di en-
trambi, i volti candidi e rosati, tra l’oro e la porpora, sotto il manto bianco,
sembrano voler proteggere anche noi, nutrirci alla fonte della vita.
Sarà questa la lezione della Storia?
Antonio Falcone
Firenze, 2020

25
UOMINI E TERRE
Giancarlo Bova
Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana (1449-1454)
ed. Palladio, Salerno, 2020
Era il 21 marzo, il giorno di primavera, del 1561, quando il doge veneziano
Girolamo Priuli destinò una sua lettera al patrizio napoletano Girolamo Seri-
pando appena nominato cardinale, nella quale esprimeva la “grandissima al-
legrezza” provata per la promozione al cardinalato, insieme alla fiducia nel-
l’“aiuto alla repubblica christiana” che il nuovo cardinale avrebbe certamen-
te dato.
In quegli anni turbolenti, si richiedevano ai ministri della Chiesa contributi
spirituali, come con altrettanta urgenza si erano sollecitati nel ’400, quando
l’arcivescovo Giordano Gaetano in una sua lictera del 1489 invitava i sacer-
doti a preferire l’intima preghiera all’ostentazione del culto esteriore.
Quell’arcivescovo operante nella Ecclesia Capuana, vicino agli Aragonesi
subentrati agli Angioini, provvide a riordinare quanto sconvolto dalla guerra
di successione, non disdegnando il potere, da lui esercitato in virtù della sua
alta carica.
Giordano, pervenuto alla nomina di patriarca antiocheno nel 1485, a sua
volta dispensò promozioni a canonici al suo servizio, concedendo loro la fa-
coltà di presiedere cause civili e penali e di emettere sentenze.
Lo stesso Giordano, oltre a garantirsi i vicari più fidati, procurava alle sue
chiese pittori e organisti, perché anche l’arte contribuisse alla bellezza dello
spirito.

26
E non la sola spiritualità avrebbe contraddistinto Giordano, ma anche l’at-
tenzione economica, praticata nella società clericale di un Quattrocento tardo-
medioevale e pre-moderno al tempo stesso.
Nella gestione dei beni della Chiesa ritroviamo Giordano, in linea con le ri-
chieste organizzative del re Alfonso I d’Aragona di mettere ordine nelle pro-
prietà terriere, precisandone i confini, le pertinenze, i censi.
Un’esemplificazione del nesso stretto tra le due dimensioni, spirituale e
temporale, dell’uomo religioso ci è data dalla nomina voluta dal papa Nicola
V nel 1447 del giovane Giordano non ancora trentenne, Eletto Capuano “in
spiritualibus et temporalibus”.
Nell’ordinaria amministrazione ecclesiastica, al traffico delle indulgenze
per i vivi e per i morti, si aggiunge quello più prosaico delle locazioni e delle
vendite dei beni immobili, di proprietà della Chiesa.
Il Clero, sia maschile che femminile, regista di quei movimenti economici,
è dentro “le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana” studiate da
Giancarlo Bova.
Sono le Carte “concessionis, donacionis, locacionis, vendicionis”, carte a-
nimate, che lasciano intravedere le vite umane dietro quegli atti notarili, vite
che non si vedono del tutto, perché non imbrigliabili nelle rigide procedure
della Legge.
C’era comunque da mettere ordine, da trovare la soluzione vantaggiosa, da
accantonare eventualmente la pietà cristiana per il buon affare, facendo spa-
zio al calcolo, perseguìto con una mentalità che oggi si direbbe manageriale.
Così può darsi la presenza di sei sacerdoti alla transazione di una vigna sita
nelle pertinenze di Capua, sacerdoti che acconsentono alla vendita ricevendo
dall’acquirente quindici tarì de carlenis argenti e ottenendo dallo stesso l’ob-

27
bligo a versare alla congregazione cinque grani d’oro ogni 15 agosto dell’an-
no (il giorno di Maria Assunta).
Al femminile, sono badesse, monache e procuratrici dei conventi a dare il
consenso alla locazione in enfiteusi di pezze di terra.
E alle monete sonanti d’oro e d’argento si aggiungono i capponi, la richie-
sta anche di mezzo cappone ogni 24 giugno (il giorno di Giovanni Battista).
Talvolta, in virtù dei servizi resi ad un monastero e della corresponsione di
denaro, si fittano di nuovo pezze in enfiteusi già tenute dallo stesso fittavolo
che per anni non ha pagato il censo dovuto.
Altre volte, alla presenza del canonico di turno, si fittano terreni incolti con
l’impegno di renderli coltivabili entro un certo numero di anni, oltre all’ob-
bligo del versamento annuale alla Camera Arcivescovile di grani d’oro ogni
26 dicembre (il giorno di Santo Stefano).
La toponomastica agricola di quel tempo ci dice dei luoghi di stazionamen-
to o di trànsito, alberati o scoperti, stretti o larghi, locati dai monasteri pro-
prietari: flumarie, starze, lenze, spesso desolate, messe all’asta per lungo
tempo senza successo, lente a produrre il grano, l’orzo, i legumi necessari.
I contratti stipulati dagli ecclesiastici con gli uomini dei villaggi vicini non
sempre registrano cifre ragguardevoli, che possono invece risultare molto
modeste: una peciola è concessa in enfiteusi dalla badessa ad Antonio detto
Gravino in cambio di una gallina all’anno.
Ma non sono solo le terre al centro dei traffici notarili, sono anche le case,
vendute con l’obbligo per l’acquirente di versare ogni anno alla congregazio-
ne la somma di grani d’oro pattuita, oltre all’impegno ad apportare al fabbri-
cato le modifiche richieste dai procuratori della congregazione presenti alla
transazione.

28
Anche la vendita delle botteghe deve passare attraverso il filtro della Chie-
sa: Bartolomeo, l’acquirente di una bottega di due stanze con una corticella,
ottiene il consenso della prebenda arcidiaconale a condizione che s’impegni a
versare ogni anno dieci grani d’oro.
Né mancano contenziosi all’interno dello stesso clero: è il caso del libellum
presentato dal canonico Troilo contro il cappellano Giovanni, detentore ille-
gittimo da oltre dieci anni di un immobile non di sua pertinenza, di cui viene
richiesta la restituzione.
Ad ogni declaratio, fatta alla puntuale presenza del giudice e del notaio, i
testimoni giurano sui Vangeli di aver detto la verità: in tal modo il diritto e
l’economia si giustificano davanti a Dio.
Così per centinaia di Carte il Bova procede, col rigore dovuto, senza cedere
alle tentazioni emotive che non sono dello storico, ricorrendo a rare esclama-
zioni, quale quella da lui usata – che qui segnaliamo concedendoci una pausa
sorridente – a proposito della locazione di una pezza confinante con una terra
della chiesa di S. Germano: “La veneranda chiesa di S. Germano (IX sec.),
sita a Capua di fronte al campanile della cattedrale, oggi è adibita a pizze-
ria!”.
O tempora! O mores!, ci verrebbe da dire sconsolati, ricorrendo anche noi
ai punti esclamativi, non retorici, di disapprovazione.
C’è altro da approvare, e da rispettare: pensiamo al tempo, alle energie, che
lo storico impiega nel suo lavoro quotidiano, ininterrotto, convinto.
È quanto distingue Giancarlo Bova, nel suo studio e negli archivi, in mo-
vimento, a prendersi cura delle lacerazioni e delle scoloriture delle pergame-
ne, a non arrendersi alle lacune causate dai fori, a decifrare i fragmenta picta

29
sotto le tettoie delle chiese, a interrogarsi sulla bellezza di quella terra cam-
pana piantata a vigneto latino.
Antonio Falcone
Firenze, 2021