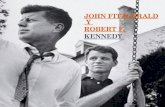La Vita Di John Fitzgerald Kennedy - Barbara Luigi
description
Transcript of La Vita Di John Fitzgerald Kennedy - Barbara Luigi
Luigi Barbara
La Vita Di John Fitzgerald Kennedy© 1985
INTRODUZIONE
A Dallas, nel Texas, erano le 12.30 del 22 novembre 1963 allorché John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, fu colpito alla nuca da una pallottola calibro 6,5. Kennedy si trovava a bordo di una «Lincoln» nera scoperta con tre file di posti. Accanto a lui sedeva la moglie Jacqueline Bouvier; dirimpetto a lui, su uno strapuntino, si trovava il governatore del Texas, John Connally. Mentre Kennedy, colpito a morte, scivolava all'indietro senza emettere un lamento, Jacqueline Bouvier vide che uno spruzzo del suo sangue le aveva imbrattato la giacca del tailleur rosa. Nello stesso momento il governatore Connally le cadde addosso, colpito alla schiena.
Per un momento la «Lincoln» scoperta rallentò la sua marcia; poi un agente dei servizi segreti balzò sul cofano posteriore e gridò all'autista di procedere. Alle 12.36, quando la «Lincoln» arrivò al Parkland Memorial Hospital, il presidente degli Stati Uniti era morto.
Ottanta minuti dopo l'attentato, nel cinema Texas Theatre di Dallas fu arrestato un uomo di nome Lee Harvey Oswald, sposato con una sovietica naturalizzata americana di nome Marina Nikolaevna. Oswald venne accusato di avere sparato al presidende Kennedy dal quinto piano di un deposito di libri all'incrocio di Elm Street con Houston Street. Sul luogo, distante 130 metri in linea d'aria dal punto in cui John Kennedy era stato colpito, un poliziotto aveva trovato una carabina Mannlicher-Carcano. La canna dell'arma, che in seguito risultò essere stata acquistata da Oswald per corrispondenza, era ancora calda.
Due giorni dopo, il 24 novembre 1963, Lee Oswald fu avvertito
Luigi Barbara 2 1985 - John Fitzgerald Kennedy
che sarebbe stato trasferito dalla caserma della polizia in cui era stato rinchiuso alla prigione della contea. Ammanettato, uscì dalla sua cella e scese al pianterreno dell'edificio, scortato da un nugolo di agenti. Nell'atrio della caserma sostava un gruppo di persone, per la maggior parte giornalisti. Da esso si staccò un individuo tarchiato, Jack Rubinstein, detto «Ruby», gestore di un locale notturno a Dallas. Egli trasse di tasca una piccola rivoltella e, a bruciapelo, sparò nel ventre di Oswald, uccidendolo. Jack Rubinstein, per il suo delitto, fu condannato alla camera a gas. I suoi difensori ricorsero contro la sentenza. Nel 1966, essendo imminente la revisione del processo, Rubinstein morì. Altre quarantacinque persone in qualche modo collegate all'assassinio del presidente Kennedy, durante i venti anni che seguirono al delitto, sarebbero morte in modo misterioso.
Un cineamatore dilettante, Abraham Zapruder, consegnò alla polizia il film che aveva girato sul luogo dell'attentato. Si appurò che l'intero evento delittuoso (il colpo di carabina fatale per John Kennedy, quello da cui il governatore Connally era stato ferito ed un terzo andato a vuoto) era «racchiuso» in 89 fotogrammi della pellicola di Zapruder, esattamente fra il 225° e il 314°.
Poiché la pellicola girava alla velocità di 18 fotogrammi e un terzo al minuto secondo, tutte e tre le fucilate erano state esplose in 4 secondi e otto decimi. Una commissione di esperti stabilì che non era possibile in alcun modo, in uno spazio di tempo così breve, sparare per tre volte, ricaricando e prendendo ogni volta la mira, con un fucile Mànnlicher Carcano, residuato di guerra non automatico. In altre parole, escluse che a sparare contro la «Lincoln» scoperta del presidente degli Stati Uniti potesse essere stato un solo attentatore.
La verità, sull'uccisione di Kennedy, assai probabilmente, è contenuta in un «dossier» conservato nelle casseforti a prova di atomica del Dipartimento di Stato americano, «dossier» che verrà aperto il 22 novembre 2013, cinquant'anni dopo il delitto. Ma c'è anche chi è convinto dell'inutilità di qualsiasi indagine, della sterilità di qualunque ricerca: John Fitzgerald Kennedy «doveva» morire, e ai mandanti del suo assassinio nessuno potrà
Luigi Barbara 3 1985 - John Fitzgerald Kennedy
mai risalire.Ma chi era, e quali caratteristiche intellettuali e di
temperamento aveva John Fitzgerald Kennedy, detto «Jack», idolatrato e contrastato presidente degli Stati Uniti, marito inquieto di Jacqueline Bouvier, interlocutore privilegiato di due Pontefici romani e contraltare - agli occhi di tanta parte del nostro secolo travagliato - del «premier» sovietico Nikita Kruscev?
Questo ritratto biografico, condotto sulla scorta di documenti e di testimonianze, ambisce a ricostruire l'avventura pubblica e privata di un uomo destinato a rimanere nella storia. Oltre al Kennedy politico e uomo di Stato, incontreremo il Kennedy meno conosciuto dei patteggiamenti e degli amori burrascosi, del quale è stato detto: «La tragica, scespiriana potenza di quest'uomo che passò come una meteora nei cieli del mondo, balza ancor oggi vivida. E il rimpianto per la sua morte prematura si accompagna all'ammirazione».
Luigi Barbara 4 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO ILA SAGA DEI KENNEDY
La grande famiglia dei Kennedy, una delle più potenti d'America, mosse i primi passi dalla miseria e dalla fame. La sua storia ebbe inizio nel 1848. Marx pubblicava il Manifesto; sull'Europa soffiava il vento delle rivoluzioni; l'Irlanda, un paese poverissimo i cui abitanti potevano contare sulle patate come unico nutrimento e sull'acqua come unica bevanda, era sconvolta dalla tremenda carestia che nel 1846-47 aveva provocato più di un milione di morti.
Si scatenò allora, da quel Paese, la corsa all'emigrazione. Tra il 1848 e il 1849 un milione di irlandesi si trasferì in America e un numero ancora maggiore in Inghilterra; e anche il giovane agricoltore Patrick Kennedy decise di lasciare la natia New Ross, nella contea di Kilkenny, e di attraversare l'Atlantico per sfuggire alla fame e ai soprusi britannici.
Un biglietto di andata per il Nuovo Mondo costava soltanto venti dollari, ma erano pochi coloro che riuscivano a raggranellare quella somma. La traversata poi, disastrosa, durava circa 160 giorni e le navi su cui viaggiavano gli emigranti differivano poco dalle famigerate imbarcazioni negriere. La notte ci si buttava a dormire sulla paglia in totale promiscuità e in condizioni igieniche terrificanti; i casi di tifo - un particolare tipo di tifo chiamato «febbre della nave» - erano frequentissimi. «Se si potessero innalzare delle croci sull'acqua - annotò un funzionario americano dell'ufficio immigrazione - la strada degli emigranti attraverso l'Atlantico sarebbe un immenso cimitero!».
Nel 1848, su centomila emigranti irlandesi partiti dalla madrepatria, solo sessantamila sbarcarono negli Stati Uniti. Tra quei fortunati era anche Patrick Kennedy.
Della vita americana di Patrick Kennedy si sa poco, soltanto che si stabilì vicino a Boston e si guadagnò da vivere facendo il bottaio. Si sposò ed ebbe quattro figli, l'ultimo dei quali, Patrick jr., il nonno del futuro presidente dell'Unione, nacque nel 1862. Patrick jr. crebbe forte come una quercia; era un giovanottone alto più di un metro e ottanta, con gli occhi azzurri e i capelli di un biondo paglia. Cominciò lavorando nel porto come facchino, ma dimostrò subito una gran voglia di farsi strada. Sgobbava molto e parlava poco, e in breve riuscì a lasciare la dura vita del porto e ad
Luigi Barbara 5 1985 - John Fitzgerald Kennedy
aprire un saloon, quindi una ditta per il commercio del carbone, e infine una banca, la Columbia Trust Company. A soli trent'anni era già un uomo influente e stimato.
Assieme a Patrick jr. Kennedy, andava emergendo un altro irlandese: era John F. Fitzgerald, un uomo che aveva avuto fortuna negli affari e godeva di un certo benessere. Per un irlandese, e per giunta cattolico, non era facile farsi avanti perché gli irlandesi - come del resto gli italiani - erano guardati con sospetto dagli americani di origine anglosassone. Ma John Fitzgerald, soprannominato «the little general» (il piccolo generale), oppure «Honey Fitz» (Fitz di miele, per la sua melliflua eloquenza), non era uomo da lasciarsi mettere i piedi in testa. Era pieno di risorse e di estrosa inventiva; divenne persino sindaco di Boston.
Tra Kennedy e Fitzgerald, che pur militavano nello stesso partito, non correvano rapporti amichevoli. Fu merito della seconda generazione se le due famiglie si avvicinarono, fino a fondersi l'una nell'altra. Nel 1914, infatti, Joseph P. Kennedy, figlio di Patrick, sposò Rose, figlia di «Honey Fitz». Fu un avvenimento indubbiamente sorprendente - racconta V. Lasky, che studiò profondamente l'origine delle due famiglie -, perché i due patriarchi, anche se spesso si schieravano dalla stessa parte della barricata, nutrivano così scarsa simpatia l'uno per l'altro che, prima del matrimonio dei figli, «avrebbero provato un brivido di disgusto all'idea di diventare nonni dei medesimi nipotini».
Joseph Kennedy, detto Joe, aveva dimostrato fin da bambino la sua vocazione per gli affari.
A dieci anni, in occasione dello shabbat, andava ad accendere le candeline degli ebrei per raccogliere mance; negli altri giorni faceva lo strillone o il commesso.
A quindici anni si improvvisò manager di una squadra di baseball: affittava persino il terreno di gioco e vendeva in proprio i biglietti d'ingresso. La rivista «Fortune», nel settembre del 1937, dedicò un lungo articolo alla carriera di Joe Kennedy, rivelando che la vecchia aristocrazia del denaro di Boston (i «bramini», i «veri americani») aveva storto la bocca quando lui, «figlio di un taverniere cattolico», aveva sposato nella cappella privata del cardinale O'Connell addirittura la figlia del sindaco, uno dei migliori partiti della città.
Non storsero la bocca, invece, gli amici di Joe: sapevano che era ambizioso e che riusciva bene in tutto: sarebbe stato dunque un bravo
Luigi Barbara 6 1985 - John Fitzgerald Kennedy
marito e un ottimo padre.«Honey Fitz» cercò fino all'ultimo di ostacolare le nozze, persuaso che
Rose, la sua prediletta, dovesse aspirare a un partito migliore. Ma Rose non volle saperne di altri, tra cui il re del tè, l'inglese sir Thomas Lipton, e la spuntò, sposando il suo Joe «il rosso».
Già in luna di miele, Joe si affrettò a fare alla moglie una promessa che poteva sembrare quanto meno avventata. Le disse che avrebbe guadagnato un milione di dollari per ogni figlio che lei gli avesse dato.
Si sbagliava... ma per difetto. Rose partorì infatti nove figli e Joe guadagnò una fortuna che, nel 1960, era valutata più di 250 milioni di dollari. E qualche anno dopo la stima era ancora più alta. Joe aveva messo insieme un'autentica fortuna, costruita con l'acume, l'intraprendenza, lo spirito d'avventura, l'ambizione... e il cinismo. Tutte qualità che avrebbe tramandato ai figli, specie a John, il futuro presidente.
La gente di Boston si rese conto di avere in Joe Kennedy un uomo che prometteva d'andare molto lontano nel 1914 (l'anno del matrimonio), quando i giornali locali prima e quelli nazionali poi pubblicarono la notizia che a soli venticinque anni il figlio dell'ex taverniere era diventato il più giovane presidente di banca degli Stati Uniti.
Com'era riuscito, l'ancor giovanissimo Joe, ad ottenere una simile affermazione?
Appena uscito da Harvard, era stato nominato ispettore statale delle banche, una carica che oltre a dargli uno stipendio tutt'altro che irrisorio gli permetteva di conoscere le pratiche più segrete degli istituti di credito. Poté così opporsi alla manovra che tendeva a far assorbire la Columbia Trust Company da uno dei più grossi complessi finanziari di Boston. Racimolando tutti i suoi risparmi, ottenendo crediti da ogni parte, mobilitando parenti, amici e conoscenti, Joe riuscì a mettere insieme i 45.000 dollari che gli servivano per mantenere l'indipendenza della banca che rappresentava. Suo padre ne fu nominato presidente, ma si dimise subito e gli cedette la carica.
Durante i convulsi anni Venti, a Wall-Street consideravano Joe l'uomo del mistero; anzi, qualcuno allora gli affibbiò un soprannome che l'avrebbe accompagnato per sempre: «lupo solitario». Non compariva mai di persona sul mercato, ma si serviva sempre di altri; per speculare con profitto aveva un suo sistema. Fondava consorzi finanziari che, mediante acquisti e vendite irregolari ma sapientemente reclamizzate, facevano lievitare il
Luigi Barbara 7 1985 - John Fitzgerald Kennedy
prezzo dei titoli a buon mercato, impressionando così i più sprovveduti. Quando il prezzo dei titoli era salito a sufficienza, il consorzio vendeva tutto con strabilianti guadagni, mentre ai gonzi non restavano che i pezzi di carta che regolarmente si dimostravano senza valore.
Era, quello di Joe Kennedy, un sistema poco ortodosso? Per giunta vietato dalle leggi degli Stati Uniti? Lui si difendeva dicendo che, in fondo, si «faceva solo un po' di pubblicità».
Intanto la moglie Rose sfornava figli a ritmo impressionante. Nel 1915 era nato Joe jr., nel '17 John, nel '18 Rosemary, nel '20 Kathleen, nel '21 Eunice, nel '24 Patricia, nel '25 Robert, nel '28 Jean e infine, nel 1932, Edward.
Il patriarca Joe amava molto stare con i figli, ma doveva assentarsi spesso, chiamato in ogni angolo degli Stati Uniti dai suoi frenetici affari.
Era ambizioso, si è detto, e la sua numerosa famiglia non ne frustrò certo i progetti: li moltiplicò, semmai.
La sua corsa al denaro divenne inarrestabile. «Volevo che tutti i miei rampolli potessero contare su un proprio patrimonio. Volevo che dal punto di vista finanziario ciascuno di essi potesse guardarmi negli occhi e dirmi di andare all'inferno».
E infatti legò a ogni figlio una somma che, sul finire degli anni Venti, prima della grande crisi, era già ragguardevole e, comunque, superiore alle stesse aspettative del dinamico pater familias. Appena sposati, Joe e Rose erano andati ad abitare nel modesto quartiere di Brookline, alla periferia di Boston, al numero 83 di Beals Street, ma con l'arrivo della quartogenita, Kathleen, traslocarono in una casa più comoda, in Naples Road, dove rimasero sei anni.
Nel 1926, venuti al mondo altri figli, Joe «il rosso» trasferì tutta la famiglia a Roverdale (New York) e tre anni dopo a Bronxville.
Lo spostamento a New York doveva aprire più ampi orizzonti a Joe Kennedy, per il quale Boston era ormai divenuta stretta e provinciale, e dove peraltro la bella gente continuava a non accettare «quegli irlandesi arricchiti e cattolici».
Nel frattempo, l'ormai ricco «lupo solitario» aveva comperato una casa a Hyannis Port, a Cape Cod, in quello che doveva diventare il celebrato «complesso residenziale della famiglia».
A Hyannis Port, i Kennedy trascorrevano gran parte delle loro estati e quelle solide mura divennero «la casa» per eccellenza, anche se gli abitanti
Luigi Barbara 8 1985 - John Fitzgerald Kennedy
di Cape Cod non mostrarono mai di apprezzare la rumorosa presenza del «clan».
Dopo un week-end trascorso nella villa dei Kennedy, un invitato compilò un prontuario di regole per gli ospiti di Cape Cod, che la tribù giudicò talmente comico da farlo copiare e mettere negli archivi familiari.
Ammoniva il prontuario: «Preparatevi leggendo le riviste che più piacciono ai Kennedy (e ne faceva l'elenco), imparate a memoria almeno tre storielle spiritose. Aspettatevi che ognuno dei Kennedy chieda la vostra opinione su: a) vestito, b) pettinatura, c) rovescio (nel tennis), d) ultima impresa pubblica di un altro Kennedy. Non mancate mai di rispondere 'stupendo'. Questo dovrebbe farvi superare l'ora del pranzo... In quanto al football, è micidiale. Se non giocate, vi faranno mangiare in cucina e nessuno vi rivolgerà la parola».
Il prontuario proseguiva così: «Non lasciatevi ingannare dalla femminilità delle Kennedy. Anche quando aspettano un bimbo sono capaci di farvi fare una brutta figura. Correte a perdifiato in ogni azione di gioco e fate molto rumore. Non date però l'impressione di divertirvi troppo. Vi accuserebbero di non prendere la partita abbastanza sul serio. Non criticate la squadra avversaria: ci saranno dei Kennedy anche in quella e ai Kennedy le critiche non piacciono. Per diventare ben accetto, dovete dar prova d'essere uno spericolato, cadendo ogni tanto lungo disteso o irrompendo in casa per rincorrere la palla. I Kennedy vi approveranno: dandosi tanto da fare, dimostrerete che prendete il gioco sul serio quanto loro».
Il prontuario, scherzoso e mordace, sapeva cogliere in pieno l'atmosfera che regnava perennemente nelle case dei Kennedy, dove i maschi erano tutti degli sportivi fanatici, rudi e spericolati al punto da rompersi le ossa.
In mezzo all'infernale frastuono, Joe meditava sugli affari del giorno dopo. La Columbia Trust Company era per lui solamente una tappa, un trampolino per lanciarsi in imprese più rischiose e redditizie. Con l'entrata degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale, l'intraprendente irlandese assunse la vice direzione di un cantiere navale e quindi quella della segreteria del ministero della Marina. Ma dopo due anni, eccolo di ritorno nel mondo degli affari.
Acquistò delle sale cinematografiche e si avventurò nella produzione di film «western», sfornandone uno alla settimana. Non si preoccupava della qualità del prodotto, ma della cassetta, e se le sue pellicole non potevano
Luigi Barbara 9 1985 - John Fitzgerald Kennedy
aspirare a premi prestigiosi, gli fruttavano tuttavia altissimi utili.In questo periodo, Joe Kennedy dovette assentarsi spesso da casa, e fu
proprio mentre viveva come un nababbo in uno dei più esclusivi alberghi di Hollywood che conobbe Gloria Swanson, innamorandosi di lei. Le attrici, occorre dire, avevano un fascino irresistibile per i Kennedy... La dolce Rose perdonò la sbandata del marito, ma non volle più vedere film della Swanson.
Joe, intanto, volgeva la sua attenzione al mondo della politica. Di punto in bianco abbandonò il cinema, dal quale, per altro, aveva ricavato dollari a palate, e sostenne la candidatura di F. Delano Roosevelt, al cui fianco animò la campagna elettorale del 1932 con un posto di prim'ordine sul treno che portava il futuro presidente da una costa all'altra degli States.
Joe Kennedy era ricco e poteva permettersi di gettare denaro per cooperare con un uomo che, divenuto potente, avrebbe potuto essergli utile.
Ed era ricco perché aveva saputo superare le secche della grande crisi del 1929.
Il 29 ottobre di quell'anno il cosiddetto «giovedì nero», Wall Street subì un pauroso tracollo e per milioni di americani fu la rovina.
Miliardi di dollari si volatilizzarono. Joe Kennedy, invece, vendendo allo scoperto, si procurò un favoloso profitto, calcolato allora in quindici milioni di dollari.
Un breve ritorno al cinema, per finanziare dei lavori della Swanson, segnò per Joe il primo insuccesso finanziario. Perse infatti 800.000 dollari con il film «Queen Kelly», che fu un autentico fallimento. La produzione ne accollò la responsabilità al regista, l'estroso Erich von Stroheim, che aveva voluto raccontare la storia di un'ex collegiale (Gloria Swanson, nella pellicola), erede di una catena di case di tolleranza che nella scena finale riceveva i sacramenti da un giovane pretino, turbato dalle sue grazie. Il film non fu mai proiettato negli Stati Uniti e Joe lasciò Hollywood.
Tornato in famiglia senza più grilli in testa, ancora innamorato della moglie, riprese a occuparsi degli affari e delle sue ambizioni politiche. Ma anche la politica doveva riservargli delle delusioni.
Dopo la vittoria di Roosevelt, Joe non ottenne alcun gabinetto, nonostante, a detta degli amici, ambisse alla segreteria del Tesoro.
Roosevelt, tuttavia, non dimenticò l'aiuto prestatogli durante la maratona dei discorsi e dei comizi, e nel 1934 avallò la nomina di Joe Kennedy a
Luigi Barbara 10 1985 - John Fitzgerald Kennedy
capo di una commissione preposta al controllo delle operazioni di cambio.Lo stupore e l'indignazione furono generali. Il «lupo solitario» era
conosciuto come uno speculatore dalle mani non sempre pulite, e la gente non riusciva a capire come un incarico tanto delicato fosse stato affidato a un uomo di così pochi scrupoli. Joe tagliò corto: conservò quel posto di «gran controllore» solo per breve tempo, poi tornò alla vita privata. Fu dopo questa esperienza che Joe Kennedy pubblicò un libro, Io sono per Roosevelt, in cui incensava il presidente del New Deal, il programma che mirava a una più equa distribuzione della ricchezza e a una maggiore stabilità economica, senza tuttavia compromettere i fondamenti del capitalismo.
Joe sapeva di poter contare sull'appoggio del presidente e sperava di sfruttarne l'amicizia per imbastire altri lucrosi affari. Ed il suo fiuto doveva riservargli un altro strepitoso successo nel mondo degli affari.
Non si sa come (ma è probabile in seguito ad una propizia «soffiata»), egli ebbe l'intuizione che Roosevelt avrebbe abolito il proibizionismo.
In precedenza - benché il governo fosse ancora lontano dal prendere una simile decisione - aveva fatto circolare la voce (falsa) che la società vetraria Libby-Owens-Ford, data la prossima abolizione del proibizionismo, avrebbe ricavato fantastici profitti dalla produzione di bottiglie per l'industria degli alcolici.
Aveva intanto comprato moltissimi titoli di quella società e prima che precipitassero li aveva rivenduti. Quando poi seppe per certo che il proibizionismo sarebbe stato cancellato, si affrettò a ricomprare i titoli della Libby per una manciata di dollari.
Non solo. Dopo aver fondato la Somerset Importers Ltd., società per l'importazione di distillati, Joe fece un viaggio in Gran Bretagna col figlio del presidente Roosevelt, James, dal quale si fece presentare a produttori di whisky (Haig & Haig, King William, John Dewar) e di gin (Gordon's), i quali gli concessero per 118.000 dollari l'esclusiva dell'importazione negli Stati Uniti dei loro prodotti.
Riuscito in seguito a strappare al governo la licenza d'importazione di whisky e di gin «per uso medicinale», provvide a riempire i depositi della sua ditta. Così, quando finalmente, nel dicembre del 1933, Roosevelt abolì per davvero il regime proibizionista, nell'improvvisa alluvione alcolica Joe Kennedy guadagnò un patrimonio.
Gettò sul mercato tutto il liquore che aveva portato dall'Inghilterra e
Luigi Barbara 11 1985 - John Fitzgerald Kennedy
stipato nei suoi magazzini e da ultimo vendette le sue rappresentanze generali per circa nove milioni di dollari.
Il patriarca non era certo uno stinco di santo, ma la moglie Rose, nelle sue memorie, lo descrive soltanto come un padre esemplare.
Rose era una brava donna di casa che si dedicava esclusivamente alla cura dei figli. Raramente si concedeva una vacanza, e il giorno in cui decise di farlo provocò le proteste del piccolo John, che le gridò rosso di rabbia: «Bella mamma che sei, a lasciarci soli». Rose fu presa da un senso di rimorso. Salì egualmente in macchina, ma continuava a sentire nelle orecchie la frase di John.
Il caso volle che, rientrata in casa perché aveva dimenticato un cappellino, vedesse i suoi figlioli che giocavano spensieratamente sotto il portico. Avevano già dimenticato la sua partenza. Solo allora si sentì in pace e partì per la sua breve vacanza.
A Rose piacevano la poesia e la musica. Spesso stava ore seduta al pianoforte, ma il suo repertorio era molto modesto. Al piano erano legati i più bei ricordi della sua fanciullezza, quando seguiva il padre, il favoloso «Honey Fitz», nei suoi giri elettorali e pestava sui tasti mentre lui cantava le canzoni più in voga.
Già avanti negli anni, con un figlio presidente degli Stati Uniti, Rose ricordava con tenerezza il padre: «Sebbene spesso cantasse "dietro unanime richiesta popolare", non aveva bisogno di molti incoraggiamenti per farlo. Quando entrava in una sala di riunione o in uno stadio invariabilmente, ad accoglierlo, si levava un coro di voci che intonava con particolare vigore gli ultimi due versi del celebre ritornello: "You are the flower of my heart, Sweet Adeline" (Tu sei il fiore del mio cuore, dolce Adelina). Mio padre cantò la sua canzoncina anche nella residenza estiva del presidente Taft, e durante un viaggio nell'America centrale la intonò così spesso, con tanto sentimento e strappando tanti applausi, che, anni dopo, quando il presidente Franklin D. Roosevelt intraprese un viaggio di amicizia nell'America latina, la banda di un paese lo accolse al suono di Sweet Adeline, evidentemente scambiata per l'inno nazionale degli Stati Uniti».
La moglie del rosso irlandese si interessava poco del denaro che il marito accumulava. Un giorno che seppe che il suo conto in banca aveva raggiunto livelli astronomici, si permise di chiedergli come avesse fatto a diventare così ricco. Joe, dopo un lungo sospiro, mormorò: «Rose, non me
Luigi Barbara 12 1985 - John Fitzgerald Kennedy
lo domandare, non lo so nemmeno io».Talvolta Rose raccontava agli amici del suo incontro con Joe, del loro
matrimonio e di quando avevano deciso di salire all'altare.Nell'estate del 1914, nella lontana Europa, l'atmosfera era drammatica.
L'assassinio dell'arciduca d'Austria a Serajevo aveva generato una tempesta diplomatica prima, e poi aveva innescato il meccanismo che avrebbe portato al conflitto mondiale. Joe e Rose, innamoratissimi, erano pieni di speranze e di entusiasmo, e sebbene d'oltre Oceano arrivassero avvisaglie di tempesta, non esitarono a mettere su famiglia.
Si sposarono nell'ottobre del 1914, nella cappella privata del cardinale O'Connell, alla presenza dei familiari e degli amici più intimi: «Nessuno dei due voleva che la cerimonia si trasformasse in una specie di avvenimento mondano».
Dopo la luna di miele al Greenbriar di White Silphur Springs, nel West Virginia, i due coniugi si sistemarono nella casa che avevano scelto e ammobiliato per tempo, in Beals Street, nel quartiere di Brookline, alla periferia di Boston. Qui, il 29 maggio 1917, nacque John Fitzgerald Kennedy, che tutti chiamarono sempre Jack.
Luigi Barbara 13 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO IIVITA IN FAMIGLIA
John Fitzgerald Kennedy, detto Jack, diversamente dal fratello maggiore Joe jr., nato due anni prima, era di costituzione gracile e diede subito qualche pensiero a mamma Rose, che provvide letteralmente a supernutrirlo. Niente da fare. La bilancia sentenziava che non c'erano progressi. E non era finita... Di tutti i figli, Rose Kennedy teneva una scheda nella quale raccoglieva con cura i dati che le sembravano essenziali: giorno del battesimo e padrini, peso nel primo anno, malattie, medici curanti e così via, componendo per ciascuno un prezioso curriculum. Nella scheda di Joe jr. c'erano poche annotazioni, ma in quella di Jack si poté ben presto leggere: «Ha avuto la pertosse, il morbillo, la varicella...». Il momento peggiore, per la preoccupatissima mamma Rose, venne quando Jack si buscò la scarlattina. Fu nel 1920.
I Kennedy vivevano ancora nella casa di Beals Street, che incominciava allora a diventare stretta per la numerosa famigliola. In rapida successione erano venuti al mondo Joe, Jack, Rosemary e Kathleen, e Rose era di nuovo incinta. Al terzo piano c'erano altre due stanze, ma erano occupate dal personale di servizio: una cameriera tuttofare che cucinava, serviva in tavola, puliva, lavava e teneva in ordine la casa per 7 dollari la settimana e una nurse che aveva fatto pratica in ospedale e ne prendeva 6. La scarlattina di Jack creò un vero e proprio «stato di allarme». Lo spazio era scarso; la malattia contagiosissima; Kathleen aveva solo pochi giorni. C'era il rischio di un'epidemia. Si finì - anche per l'intervento del nonno materno, il famoso «Honey Fitz» - col ricoverare Jack in ospedale, dove le sue condizioni furono giudicate subito molto gravi. Suo padre, il freddo «lupo solitario» di Wall Street, era disperato, e giunse addirittura a far voto di dare in beneficenza metà dei suoi averi se il bambino fosse sopravvissuto.
Jack superò la crisi. Fu dimesso dall'ospedale e Joe Kennedy tenne fede al suo voto, donando un cospicuo assegno alla St. Appilonian Guild, un'istituzione che si occupava di accompagnare i bambini bisognosi da medici e dentisti ma che non riusciva a trovare il denaro per l'acquisto di un autobus con cui poterli trasportare. Il contributo di Joe, scrisse Rose Kennedy nel suo libro autobiografico Tempo di ricordare, fu di 3.700
Luigi Barbara 14 1985 - John Fitzgerald Kennedy
dollari, proprio la metà della fortuna che sino ad allora egli aveva accumulato. Costituzione debole a parte, Jack non era diverso dai bambini della sua età. «Gli piaceva giocare», disse una volta mamma Rose, «ed era terribilmente disordinato, specie per quel che riguardava il suo abbigliamento. Talvolta disubbidiva e quindi veniva sculacciato». Rose Kennedy voleva infatti che i suoi figli fossero sempre puliti e ordinati, e mal sopportava che Jack si ostinasse invece ad andare in giro trasandato.
Il piccolo Jack era anche insofferente della sua rigidissima nurse e non perdeva occasione per farle dispetti. Giunse a conficcarle una spilla da balia nelle gambe. E non fu, questo della spilla, un episodio sporadico se mamma Rose il 23 febbraio 1923 annotava nel diario, tra il divertito e il rassegnato: «Joe jr. e Jack hanno inventato una nuova canzone sulle cimici e sui pidocchi. Inoltre hanno creato un club: per esservi ammessi gli aspiranti devono lasciarsi conficcare nella carne degli spilli».
«A volte lo punivo», scriveva ancora la madre, «mandandolo a letto solo con pane e acqua. Ma lui sgattaiolava giù e riusciva a convincere la cuoca a dargli qualcosa da mangiare». Erano le prime avvisaglie delle sue capacità diplomatiche? Forse. Certamente Jack mostrò sempre, accanto a un carattere indomito e battagliero, modi accattivanti e sornioni, che apparvero in tutta evidenza nella singolare poesia che, vicino ai dieci anni, scrisse al padre per ottenere un piccolo aumento del suo «stipendio». Eccone il testo com'è riportato da Rose:
«Capitolo I / La mia ultima paga / è di 40 centesimi. Prima la spendevo in aeroplani / e in altri giochi infantili / ma ora sono uno scout / e tralascio le cose / da bambini. Prima solevo / spendere 20 dei miei 40 centesimi / e in cinque minuti / mi ritrovavo con le tasche vuote, / con niente da guadagnare e / 20 centesimi da perdere. Diventando / scout ho dovuto comperare / borracce, zaini, coperte di lana, / torce, ponchos: cose / che dureranno per anni / e che potrò sempre usare / mentre non posso usare / una caramella di cioccolato / o il gelato alla vaniglia e pertanto / inoltre rispettosamente una richiesta d'aumento di / trenta centesimi affinché possa / comperarmi il necessario e / sbarcare meglio il lunario. / Finis. John Fitzgerald Francis Kennedy».
A distanza di anni, la madre non sapeva spiegarsi perché il figlio avesse aggiunto alla sua firma quel «Francis». E, commentando l'episodio, diceva: «Forse lo fece per invocare la benedizione e l'aiuto di San Francesco. Suo padre, comunque, gli concesse l'aumento». Né, col tempo, a Jack sarebbe
Luigi Barbara 15 1985 - John Fitzgerald Kennedy
venuta meno la venerazione per il mite Santo di Assisi, i cui Fioretti furono una delle sue letture preferite anche in età matura.
Cattolici praticanti, Rose e Joe Kennedy non furono comunque mai particolarmente opprimenti nei confronti dei figli in fatto di religione. Per sua stessa ammissione, tuttavia, Jack non dimenticò di recitare le preghiere della sera e sua madre ricordò una volta che, quando egli era già divenuto presidente, entrata nel suo studio alla Casa Bianca, lo trovò inginocchiato a pregare. I primi anni di John Kennedy furono anche contrassegnati da un acceso antagonismo con il fratello maggiore Joe, che era più forte e che nei frequenti scontri aveva invariabilmente la meglio. Jack tuttavia non gli era da meno quanto a combattività, orgoglio e volontà di rivincita. Tra i due fratelli si accendevano spesso liti furibonde, che una volta giunsero a sfiorare la tragedia. Fu quando, nella casa al mare di Hyannis Port, Jack, che come sappiamo era un grande disordinato, si infilò il costume da bagno del fratello che pure gli stava grande e se ne andò tranquillamente verso la spiaggia. Joe si infuriò e lo inseguì sin lungo un frangiflutti che penetrava pericolosamente nell'oceano. Jack sarebbe finito sicuramente in acqua col rischio di essere travolto dalle onde se all'ultimo momento non fosse intervenuto un amico di famiglia a mettere pace tra i due, evitando così il peggio.
Joe jr. e Jack, comunque, si volevano un bene dell'anima. «Il padre era al corrente della rivalità esistente fra i due figli maggiori», scrive J. MacGregor Burns in un suo libro su John Kennedy, «ma interveniva soltanto quando essa degenerava. Era lui che voleva la competizione nella famiglia fin quando i ragazzi non si dovevano coalizzare per trattare col mondo esterno. Sapeva anche che Joe jr. compensava la sua rudezza con gesti generosi e gentili verso i fratelli e le sorelle minori. Lo stesso Jack, malgrado le prepotenze subite dal fratello maggiore, capì in seguito che i modi perentori di Joe furono una delle cause dei suoi successi all'università e in guerra».
Jack nutrì sempre grande affetto anche per la sorella Rosemary, la più vicina a lui per età e colpita da meningite. Rose e Joe Kennedy cercarono di curarla in ogni modo, ma giunta a una certa età la povera Rosemary dovette essere ricoverata in un istituto per giovani subnormali di Milwaukee. La compagna di giochi preferita da Jack divenne così Nick (Kathleen), che era agile e forte al punto da tenergli testa anche negli sport più rudi.
Luigi Barbara 16 1985 - John Fitzgerald Kennedy
In quegli anni papà Joe non aveva ancora raggiunto i grandi traguardi che ne avrebbero fatto l'uomo d'affari che abbiamo conosciuto e il patriarca indiscusso del «clan». Il grande lancio sarebbe avvenuto con la drammatica crisi del 1929. Intanto, Joe «il rosso» si accontentava di quello che riusciva a guadagnare... che non era poco. I figli crescevano, altri ne metteva al mondo Rose e spesso lui, a tavola, quando riusciva a ottenere un po' di silenzio, andava con i ricordi al passato della famiglia e ne raccontava le umili origini. «Così imparerete a dare valore anche a un centesimo di dollaro!», s'infervorava. E poi si soffermava a spiegare come tanto il nonno Fitzgerald che suo padre appartenevano alla prima generazione di irlandesi in America e quanto fosse stata dura e sofferta l'ascesa politica degli irlandesi a Boston, una città che per secoli era stata la roccaforte del puritanesimo protestante e anticattolico, dominio incontrastato degli yankees. «Per noi cattolici», aggiungeva Joe, «la vita a Boston era molto difficile. Tutti diffidavano di noi e con molta fatica un cattolico poteva conquistarsi un posto al sole. Bene, i Kennedy e i Fitzgerald sono riusciti a farsi strada, ma fra mille sacrifici, non dimenticatelo mai».
Durante quelle riunioni a tavola, i figli ascoltavano e imparavano che per un cattolico, in America, la strada sarebbe «sempre stata in salita». Una volta Jack si permise di interrompere il padre: «Ma tu hai avuto successo, non è vero papà?». Il padre lo accarezzò e quindi mormorò: «Sì, è vero, ma sapessi quanto fatica...». Certo, se il vecchio «Honey Fitz» era stato felicissimo quando il genero, spinto dalla moglie, aveva dato al secondogenito il suo nome - John Fitzgerald - lo sarebbe stato ancora di più se avesse intuito che quel bambino era destinato a completare la disfatta politica degli arroganti «bramini» di Boston, sconfiggendo per ben due volte il loro maggiore esponente, Henry Cabot Lodge.
Col passare del tempo papà Kennedy si faceva vedere sempre meno in casa. Era spesso assente per affari, ma ogni giorno non dimenticava di fare la telefonata di prammatica. Parlava prima con la moglie Rose, poi si faceva passare, uno dopo l'altro, i figli più grandi. Telefonò anche quel giovedì nero del 1929, quando gli Stati Uniti sfiorarono la bancarotta, e sintetizzò in due parole la sua situazione in mezzo al marasma: «Tutto bene». Il resto lo sappiamo. Mentre interi pacchetti azionari diventavano carta straccia e milioni di piccoli investitori finivano sul lastrico, lui riusciva a guadagnare quindici milioni di dollari.
Luigi Barbara 17 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Rose, accanto al caminetto, nelle fredde sere d'inverno, annotava sul diario i fatti quotidiani. Piccole cose, inezie, pensieri. Il 26 ottobre 1923 scriveva: «I ragazzi hanno visto, appeso sulla porta di un ristorante, un cartello con scritto: "Non sono ammessi i cani" e ci hanno aggiunto la parola hot». (In inglese cane si dice dog, ma hot dog equivale a panino imbottito con salsiccia e senape). Più avanti raccontava di come Joe e Jack avessero rubato dei baffi finti in un negozio o di come, un pomeriggio, li avesse trovati in cantina intenti a raccogliere bottiglie di latte per rivenderle. E subito dopo: «Jack ha detto: "Papà è un golosone, non è vero? Mi domando qual è il suo punto debole"». E ancora: «Jack dice: "A scuola me la cavo, ma chi troppo studia matto diventa"»; e per scuola intendeva un asilo cattolico dove i genitori lo mandavano per non vederlo sempre in strada.
Non si sa molto altro dell'infanzia di John Kennedy, e sono pochi ricordi su cui indugia mamma Rose nel suo libro di memorie. Era goloso e aveva una vera e propria passione per la «Boston cream pie», una torta gelato di cui la madre conservava gelosamente la ricetta. Amava stare all'aria aperta e per nessuna ragione al mondo avrebbe rinunciato a un pic-nic sull'erba.
In casa Kennedy gli orari erano tassativi. A pranzo e a cena ci si sedeva tutti contemporaneamente. O quasi. Jack infatti, nonostante i ripetuti rimproveri, era immancabilmente l'ultimo ad arrivare a tavola. Ai ritardatari non si concedeva il primo piatto e così Jack, il più delle volte, si alzava con lo stomaco mezzo vuoto. «Ma poi, al momento propizio», ricorda mamma Rose, «scivolava furtivamente in cucina e con la complicità della cameriera si rifocillava a piacimento. Io lo sapevo, e lui sapeva che io sapevo. Ma nonostante i miei principi lo lasciavo fare, perché, secondo me, quel bambino era talmente magro da aver più bisogno di cibo che d'imparare a essere disciplinato».
Quando Jack tornava dall'asilo, sua madre si faceva raccontare com'era andata la giornata. Rose voleva che i suoi figli parlassero e che si abituassero a comunicare con la gente. «È sin dall'infanzia», diceva infatti, «che si forma il carattere».
In casa Kennedy ogni occasione era buona per gare, scambi di idee e giochi istruttivi: i viaggi in treno, le serate in soggiorno o una gita in campagna e persino le ore dei pasti. Quando viaggiava in treno, per esempio, la famiglia noleggiava un'intera carrozza e i ragazzi avevano così modo di spostarsi da un capo all'altro del vagone, facendo a gara a chi
Luigi Barbara 18 1985 - John Fitzgerald Kennedy
vedesse più animali ai lati della strada ferrata. Poi, ricorda Rose, c'erano le sciarade e gli indovinelli, nei quali Jack era imbattibile.
Appena imparò a leggere, il piccolo John divenne un divoratore di libri per ragazzi. Uno in particolare gli piaceva: Billy Whiskers, che raccontava le avventure di una capra. A Rose, per la verità, questo libro non piaceva e, se ne parla, è per dirne male: «Mi sembrava illustrato in modo pessimo, con colori troppo vivaci e grossolani. Se non fosse stato un regalo di mia madre, quel libro non sarebbe mai entrato in casa mia».
Anche un brutto libro, tuttavia, può rivelarsi istruttivo. Un giorno, mentre Rose preparava una torta, Jack le domandò a bruciapelo: «Dove sono le isole Sandwich?» La brava donna gli rispose di non saperlo ma che si sarebbe informata. Fatta la ricerca, mostrò al figlio un atlante spiegandogli: «Ecco le isole Sandwich. Ora però il loro nome è cambiato: si chiamano Hawaii. Come mai la cosa ti interessa? State forse studiandole a scuola?». Jack, serissimo replicò che si era interessato alle Sandwich perché Billy Whiskers, durante un suo viaggio nel Pacifico, si era fermato proprio in quelle isole.
Un'altra delle letture preferite di Jack bambino erano i racconti sulla vita degli animali di Thornton Burgess, che per molti anni comparvero su diversi quotidiani. Jack non dimenticò mai il piacere che gli avevano dato durante l'infanzia e molti anni dopo, divenuto presidente degli Stati Uniti, volle che Burgess, in età ormai veneranda, fosse suo ospite a Hyannis Port.
Mentre in casa mamma Rose si prodigava perché tutto filasse per il meglio, suo marito andava sempre più in giro per gli Stati Uniti a tessere la sua ragnatela di affari. Boston stava diventando una città troppo piccola e conservatrice per le sue imprese finanziarie e Joseph Kennedy si lanciò nel mondo dei grandi affari di Wall Street, di Hollywood, della Florida, del Texas, estendendo i suoi interessi sino in Europa e in Asia.
Ma il suo sogno segreto restava la politica. Dovunque andasse, cercava di stringere amicizie con gli uomini più influenti e che fossero in grado di aiutarlo perché il suo sogno diventasse realtà. Quando gli Stati Uniti intervennero nella prima guerra mondiale, Joseph Kennedy si trovava alla direzione di una grande industria cantieristica. Lavorava sodo e, accontentandosi una volta tanto del suo solo stipendio, era riuscito a fare in modo che l'impresa divenisse insostituibile nel gran giro dell'economia bellica. Fu appunto in quel periodo che entrò in contatto con il sottosegretario alla marina del presidente Wilson, che era Franklin D.
Luigi Barbara 19 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Roosevelt, per il quale nutrì subito una profonda simpatia.Roosevelt, allora, non contava molto in America: il suo astro doveva
ancora sorgere. Ma il rosso Joe puntò su quel giovane tutte le sue carte e ancora una volta fece centro. Parlava spesso di lui con la moglie e Rose, a sua volta, lo incoraggiava a sostenere «quel politico di cui molti dicono un gran bene»; lo colmavano di gentilezze e in più occasioni lo accolsero in casa loro, Roosevelt tenne così sulle ginocchia il piccolo Jack, senza certo immaginare che entrambi erano destinati a salire sul massimo gradino della vita pubblica statunitense. Sono di quegli anni molte lettere e cartoline di Roosevelt ai Kennedy, sulle quali si può leggere anche: «Caro Joe, hai una famiglia magnifica, una moglie adorabile e due figli simpaticissimi»; i figli cui alludeva erano Joe jr. e il vivacissimo Jack, e più tardi anche per loro Roosevelt divenne un amico.
Intanto la famiglia cresceva. Nel 1928, un anno prima della grande crisi, i figli dei Kennedy erano già otto. Jack frequentava una scuola cattolica, la Canterbury School di New Milford, nel Massachusetts, dove peraltro non ebbe molto successo. Gli insegnanti, pur riconoscendogli ottime doti, rimproveravano la sua pigrizia e il suo disordine. Sua madre lo giustificava: «Che stesse facendo il compito di aritmetica, oppure raccogliendo i vestiti da terra», scrive nelle sue memorie, «spesso mi sembrava che Jack si occupasse solo per metà della realtà che lo circondava, e che l'altra metà della sua mente fosse remotissima, persa in un mondo di sogni. Aveva una forte vena romantica e idealistica, un temperamento piuttosto sognatore».
Jack dunque sognava e i risultati a scuola non lasciavano presagire la sua folgorante carriera. In quei sei mesi passati alla scuola cattolica seppe strappare appena la sufficienza, mentre il fratello maggiore Joe era portato in palmo di mano dai professori.
I Kennedy, seppure agiatissimi, erano molto restii ad allargare i cordoni della borsa con i figli: anche questo rientrava nel tipo di educazione che intendevano impartire loro. Volevano che i ragazzi si rendessero conto del valore del denaro, e soprattutto mamma Rose insisteva perché imparassero a loro spese quanto fosse sciocco sperperarlo «e quali dolorose conseguenze può avere un atto di sventata prodigalità».
Jack aveva una mancia di 40 centesimi la settimana e non aveva certo da scialare, tanto che continuò a sollecitare aumenti. Poiché adorava i dolci, era assiduo frequentatore di un negozietto di generi vari, a due isolati da
Luigi Barbara 20 1985 - John Fitzgerald Kennedy
casa, dove invariabilmente spendeva tutto quanto aveva in tasca; poi, per il resto della settimana, doveva stringere la cinghia.
Anche con i regali i genitori lesinavano: giocattoli pochi e non particolarmente costosi. «Mai ci sognammo», raccontò più tardi Rose, «di regalare ai nostri ragazzi uno di quei complicatissimi sistemi ferroviari in miniatura pieni di interruttori e di semafori, che occupano un intero tavolo, né quei serragli di animali di pezza che bastano da soli a riempire un armadio o un divano».
Il ritornello che Rose ripeteva di continuo ai figli era: «Non spendete mai più di quanto avete in tasca». E a poco a poco anche John lo fece suo. Anni dopo, infatti, nonostante i larghi mezzi di cui dispone, eccolo andare in giro con pochi dollari, lo stretto necessario, e a volte farsi prestare dagli amici anche i centesimi per la corsa in autobus. Il denaro sarà infine sempre l'ultima delle sue preoccupazioni e, anche quando deciderà di mettersi in politica, saranno i sostenitori a pagargli gli «imprevisti» ai quali va incontro ogni candidato a una carica pubblica.
Ai ragazzi Kennedy piaceva molto andare al cinema. Qui però erano privilegiati, giacché il padre aveva allestito nella residenza principe del «clan» una sala di proiezione attrezzata per accogliere ventiquattro persone. Quando veniva proiettato qualche film di successo, familiari e amici si stipavano come sardine. «Inutile dire», tiene comunque a precisare mamma Rose, «che i film proiettati per i nostri giovani spettatori erano raccomandati o controllati in anticipo da persone fidate. Se poi durante la proiezione giudicavamo una certa scena o situazione un po' troppo scabrosa, fermavamo il proiettore e invitavamo i ragazzi a uscire».
Una sera, a Hyannis Port, fu proiettato un film con Gloria Swanson, un'attrice per la quale i ragazzi dimostrarono subito una particolare ammirazione. Ed ecco che la Swanson - Jack aveva poco più di dieci anni - capitò proprio a Hyannis Port e vi si trattenne per un week-end. L'accoglienza che le fecero i ragazzi fu naturalmente delle più calorose. Più fredda, invece, fu quella di Rose, che, come già sappiamo, aveva avuto sentore del debole che il marito aveva per la diva.
Luigi Barbara 21 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO IIIIL PICCOLO «LEADER»
Quando Joseph Kennedy si mise in politica, il suo nome divenne ancor più noto. In casa cominciarono a piovere corrispondenti da tutti gli Stati Uniti e sui quotidiani e settimanali non fu difficile trovare articoli che raccontavano la storia del «multimilionario magnate del cinema e scaltro finanziere Joseph P. Kennedy». I giovani Kennedy, nel leggere quegli articoli, traevano le loro conclusioni: erano figli di un uomo che faceva notizia, un uomo molto ricco. E mamma Rose lo confermava: non solo «papà aveva accumulato milioni di dollari ed era estremamente facoltoso», ma al momento giusto «ciascuno di loro sarebbe entrato in possesso di un mucchio di dollari».
Rose ricorda che quando fece quel discorso ai ragazzi, il maggiore aveva subito manifestato soddisfazione per la posizione che scopriva di avere nella società, mentre John si era limitato ad alzare le spalle mormorando: «Io voglio diventare qualcuno con le mie capacità, non con i soldi di papà». (Per la verità, quando dovette battersi per conquistare la presidenza degli Stati Uniti, Jack attinse a piene mani anche dal patrimonio paterno e vien da chiedersi se sarebbe sortito a tanto - lui, un cattolico - senza il mare di dollari nel quale navigava).
Dopo aver frequentato la Canterbury School di New Milford, il piccolo Jack fu iscritto alla Choate School di Wallingford, nel Connecticut, l'istituto privato - e protestante - più ambito dalle famiglie ricche. Rose e suo marito erano preoccupati per il suo futuro. Alla scuola cattolica non aveva dimostrato di avere gran voglia di studiare e i risultati non erano stati entusiasmanti. Inoltre, con il suo carattere introverso e l'apparente incapacità di applicarsi con costanza ad alcunché, Jack non lasciava sperare che alla Choate School le cose sarebbero andate meglio.
E infatti, mentre suo fratello Joe jr. procedeva anche lì senza fatica e con esiti brillanti, lui sembrò non sapere far meglio che detestare l'istituto e i suoi insegnanti. Il suo tallone d'Achille erano l'inglese e l'ortografia, e questo irritava non poco sua madre. «La sua ortografia», nota la sempre puntuale Rose, «era a dir poco spaventosa, incerta e disseminata di inesattezze. La calligrafia, poi, un disastro»: quest'ultima, infatti, non progredì mai oltre lo scarabocchio. Nessuno, insomma, nemmeno Joe jr. e
Luigi Barbara 22 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Rose, avrebbe allora puntato un centesimo se qualcuno avesse scommesso che anni dopo alcuni degli scritti di Jack sarebbero stati paragonati - come effettivamente avvenne - a quelli di Abramo Lincoln.
A conclusione dei corsi, Jack risultò mediocre in latino e francese e appena sufficiente in inglese e storia; il suo diploma, sessantaquattresimo in graduatoria sui 112 del totale degli alunni. Così, quando durante la sua presidenza la Choate School mise in bella mostra nell'atrio il ritratto dell'illustre ex-allievo, John Kennedy scoppiò in una sonora risata e a un suo vicino collaboratore confidò: «È la "celebrazione" più ironica di cui io sia a conoscenza».
Se nello studio non si applicava, nello sport Jack si buttava con tenacia e ardore indiavolati, e questo nonostante non godesse proprio di una salute di ferro. L'apatia e la svogliatezza che mostrava in aula scomparivano per lasciare posto a un'aggressività sorprendente; Jack emergeva in numerose attività agonistiche, ma soprattutto nel football, tanto che entrò a far parte della squadra della scuola e ne divenne in seguito il capitano. A detta dei compagni «era una tigre in difesa», e lo rimase anche dopo la lesione alla schiena - per la quale fu ricoverato in ospedale - riportata durante una partita. (Quel male lancinante lo avrebbe accompagnato per il resto della vita, quando andò militare e quando si diede alla politica. Anche pochi giorni prima di essere assassinato a Dallas era rimasto due giorni a letto, in preda ai dolori).
«La cosa più notevole che riesca a ricordare di Jack», avrebbe detto in seguito il suo allenatore, «è che era un lottatore nato. Suo fratello Joe era quello che si dice un atleta, ma gli mancavano la grinta e lo spirito combattivo di Jack». «Ma a quanto pare», puntualizza lord Longford nella sua biografia di Kennedy, «riservava il suo spirito combattivo solo al football Sua madre ricorda infatti che lei e il marito in quegli anni erano preoccupati per la salute del figlio e abituati all'idea che di quando in quando fosse costretto a letto perché malato o infortunato. Erano altrettanto preoccupati, poi, per il suo rendimento negli studi».
Jack non era insensibile alle preoccupazioni dei genitori e cercava di darsi da fare per migliorare. «Capisco che sino a ora», scriveva al padre, «non ho fatto altro che prendermi in giro sulla reale entità dei risultati ottenuti a scuola»; e alla madre: «Papà pensa forse che io cerchi di crearmi un alibi, ma non è così. Mi sono preoccupato anche dei miei studi».
Un asso nella manica, tuttavia, anche se allora forse nessuno se ne
Luigi Barbara 23 1985 - John Fitzgerald Kennedy
rendeva conto, lo aveva: il suo amore per le letture. Jack era anzi l'unico della famiglia cui piacesse leggere. Nei molti giorni dell'anno che trascorreva a letto, continuava a leggere libri di storia, biografie, romanzi del ciclo di re Artù e, in seguito, Malborough di Winston Churchill. Si fece così, a poco a poco, una «personale e solida» cultura.
«Quanto alle letture, i suoi gusti si ampliarono», ricorda compiaciuta mamma Rose. «Cominciò ad apprezzare parecchi dei libri che pensavo dovesse leggere. Gli piacevano i romanzi cavallereschi e di avventura come Waverley di Walter Scott, le biografie di personaggi famosi o degni d'interesse e, in generale, i libri a sfondo storico, purché ricchi di azione e di colore. Ricordo che da ragazzo lesse e rilesse chissà quante volte Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda». E poi passa a elencare gli autori che quel suo difficile rampollo preferiva: R. Louis Stevenson, A.M. Hadfield, Thomas Macaulay, Kipling, Felix Salten, Beecher Stowe, J.M. Barrie, Anna Sewell, Thomas B. Aldrick, Fenimore Cooper, George MacDonald, Daudet.
Jack non trascurava nemmeno la saggistica e divorava tutto quanto poteva illuminarlo sugli eventi che a quell'epoca tormentavano l'Europa. Si interessò vivamente, per esempio, al fascismo italiano, mentre provava una viscerale repulsione per il nazismo di Hitler. (Più tardi avrebbe visitato l'Italia e nelle sue lettere al padre si sarebbe sempre espresso favorevolmente nei confronti di Mussolini).
Jack aveva sedici anni quando, dall'Europa, cominciarono a giungere notizie inquietanti. Il 30 gennaio 1933, Adolf Hitler aveva assunto il potere in Germania e aveva subito dimostrato la sua spietata e sanguinaria volontà di potenza. In Italia, con il fascismo all'apice della sua fortuna, Mussolini non dissimulava velleità imperialistiche, anche a costo di scatenare una guerra: l'Italia fascista si presentava al mondo come una nazione «militarista e guerriera».
Fu presto chiaro, in America, che il «duce» italiano e il «Fùhrer» tedesco, le cui dottrine avevano molti punti in comune, avrebbero finito con l'allearsi e che nel cuore dell'Europa si stava formando una situazione esplosiva.
Di tutto questo, in casa Kennedy, si parlava. Anzi, Joseph sr. (democratico per tradizione e decisamente favorevole a Roosevelt e al New Deal, e che aveva esercitato sui figli una profonda influenza in senso progressista, o come dicono gli americani, «liberale»), specie a tavola,
Luigi Barbara 24 1985 - John Fitzgerald Kennedy
incoraggiava le discussioni politiche, soprattutto tra Joe jr. e John. Lui, però, nonostante la sua inclinazione liberale, non si mostrava troppo avverso a Hitler e lo giudicava un «interlocutore possibile».
Questa disponibilità nei confronti del nazismo l'avrebbe mantenuta anche in seguito, quando Roosevelt l'avrebbe nominato ambasciatore a Londra. Le persecuzioni razziali in Germania lo lasciavano indifferente e ai suoi collaboratori si limitava a raccomandare la pazienza. «Vedrete che prima o poi anche Hitler entrerà nei ranghi», ripeteva loro. La sua miopia politica divenne presto proverbiale, specie allorché non batté ciglio di fronte alla proditoria occupazione della zona di Shanghai da parte del Giappone.
Mentre a New York si organizzavano manifestazioni contro i regimi dittatoriali d'Europa e Asia, il vecchio Joseph si cullava nell'utopistica visione di un mondo «in cui la democrazia e la tirannide sarebbero state equamente distribuite». Da ambasciatore avrebbe a tal punto «addolcito», nei suoi rapporti a Washington, i tragici misfatti di Hitler e della Germania nazista, che Churchill sarebbe stato costretto a comunicare direttamente con Roosevelt servendosi di un codice segreto.
Joe jr. e Jack ascoltavano le disquisizioni del padre, ma nell'intimo non le approvavano. Nell'intimo... perché le regole della famiglia erano ferree: il «vecchio» era il capo esclusivo del «clan» e non avrebbe tollerato la benché minima obiezione.
Nel frattempo, i rapporti tra i due fratelli s'erano andati incrinando. Joe jr. era aitante, estroverso e autoritario, se non prepotente. Jack ne subiva malvolentieri i soprusi e certo doveva provare dell'invidia per lui, che riusciva magnificamente a scuola, che era «un atleta», un ragazzo ordinato, riflessivo e chi più ne ha ne metta.
Ecco come Richard Whalen sintetizza la situazione che si era creata in famiglia: «Joe era paziente e dolce con i più piccoli, e ne diveniva l'idolo a mano a mano che insegnava loro a lanciare la palla, ad andare in bicicletta o a condurre la barca a vela. Ma con lo smilzo, esile Jack, l'unico che poteva insidiare il suo 'trono', era un maestro severo, beffardo e spaccone. Si azzuffavano spesso. Le loro risse di solito finivano con Jack sconfitto e umiliato».
Papà Joe, tanto assorbito dai suoi affari e che nelle rare comparse in casa non faceva che predicare tra i due la più accesa emulazione, poco si curava del complesso di inferiorità che si stava formando nel suo secondogenito.
Luigi Barbara 25 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Tutte le sue speranze erano chiaramente riposte su Joe jr., che andava bene a scuola, si vestiva sempre con proprietà e dimostrava quel forte attaccamento alle cose personali su cui lui tanto insisteva... Tutto il contrario di Jack, insomma, contestatore ante litteram che sembrava infischiarsi del buonsenso predicato dai genitori.
«Pareva che fosse sempre in lotta con qualcuno», dichiarerà molti anni dopo un compagno della Choate. «Il fatto che fossero tutti e due maschi», osserva mamma Rose nel suo libro di memorie, «fratelli e così vicini d'età aveva i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi. In generale erano ottimi compagni di gioco e condividevano ogni genere di avventure e di esperienze, compresa quella di cacciarsi insieme nei guai. Ma secondo me era inevitabile che fossero anche rivali e che, con due temperamenti così diversi, tale rivalità divampasse in zuffe a volte violente».
L'acrimonia esistente tra i due andò comunque attenuandosi con gli anni per lasciare spazio all'affetto e alla comprensione reciproci, tanto che alle soglie dell'università Joe jr. e Jack erano ormai legati da un profondo vincolo di amicizia, lealtà e confidenza. Quando Joe, più tardi, sarebbe morto da eroe in guerra (il suo aereo esplose, forse colpito dalla contraerea tedesca) Jack ne avrebbe assunto il ruolo di «primo uomo in famiglia dopo il padre», svolgendolo con saggezza e imponendosi con consapevole autorità sui fratelli minori. Non solo, ma con l'aiuto di quanti lo avevano conosciuto gli avrebbe dedicato un commosso libro di ricordi, tirato in poche centinaia di copie e destinato ai familiari e agli amici. Nell'introduzione, scritta da Jack, si possono leggere queste parole: «L'unica ragione per cui dapprima esitai a mettere insieme questi saggi è che dubitavo che Joe, se avesse potuto dire la sua, avrebbe approvato l'idea. Ma siccome mi era capitato già altre volte di non trovarmi d'accordo con lui, alla fine decisi di accantonare tutti i miei dubbi e i miei scrupoli e di mettermi al lavoro».
Con nove rampolli, tutti vispi, la casa di Kennedy era in continua effervescenza. Gli studi assorbivano buona parte della giornata e John si arrangiava alla meglio. Durante le vacanze pasquali del 1931, con la sua cronica sfortuna in fatto di salute, ebbe un attacco di appendicite e finì in ospedale per essere operato. L'anno scolastico andò così a monte e i suoi genitori furono costretti ad assumere un insegnante privato che seguisse il ragazzo, che zoppicava specialmente in latino.
La sua gracile costituzione doveva procurargli anche altri inconvenienti.
Luigi Barbara 26 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Sempre alla Choate School, Jack fu colpito da un forte raffreddore (o forse da un virus) che gli causò una grave infiammazione ghiandolare. E più tardi, ecco un'ansiosa mamma Rose scrivere alla moglie del direttore dell'istituto: «Gentile signora, Jack mi scrive che ora sta molto meglio e accenna all'intenzione di andare più spesso allo spaccio alimentare per 'metter su qualche chilo'. La cosa mi preoccupa perché alle mie orecchie 'spaccio alimentare' di solito suona 'dolci' e per quanto riguarda i dolci Jack non ha nessun discernimento; il fatto è che, secondo me, ha sempre mangiato troppa poca verdura».
Qualche mese dopo, rivolgendosi ancora alla stessa signora, Rose aggiungeva: «Ho ricevuto la sua lettera a proposito delle condizioni del piede di Jack. È probabile che tutto dipenda dal fatto che ha i piedi piatti. È un difetto ereditario, e lui lo ha aggravato insistendo negli ultimi due o tre anni a portare scarpe di poco prezzo con suole di gomma». (Quel difetto ai piedi diede parecchie noie a John Kennedy, il quale, anche da presidente, aveva un calzolaio che lo riforniva di scarpe con speciale plantare).
Poiché i suoi voti continuavano a essere insufficienti, i genitori lo facevano restare alla Choate anche nel trimestre estivo. Il signor Steele, direttore dei corsi di luglio e agosto, così scrisse una volta a papà Kennedy: «Contate su di noi. Faremo tutto il possibile per consolidare la preparazione di Jack e per renderlo consapevole non solo della necessità, ma anche dei vantaggi di un'applicazione costante ed equilibrata...».
Nemmeno in condotta le cose andavano per il verso giusto, se è vero che, ricevuto un cesto di arance dalla Florida, il futuro presidente degli Stati Uniti non trovò di meglio che bersagliare con i frutti i compagni che passavano sotto la sua finestra. Un'altra volta, poi, raccolse tutti i cuscini delle camerate e li ammassò nella stanzetta di un compagno che non gli era simpatico.
In entrambi i casi si buscò delle note di demerito. E alla fine dell'anno, il responsabile della sua camerata, il signor Maher, così scriveva al direttore dell'istituto: «Vorrei assumermi la responsabilità della persistente negligenza di Jack per quanto riguarda la pulizia e l'ordine della sua stanza e della sua persona, ma purtroppo devo confessare che, nonostante la buona volontà che ha dimostrato, tutti i miei sforzi sono stati vani». E la nota proseguiva: «Personalmente ritengo che questo tipo di negligenza, oltre a essere negativa in sé, abbia un valore paradigmatico. Il ragazzo è disordinato in quasi tutte le sue attività, studia all'ultimo minuto, arriva
Luigi Barbara 27 1985 - John Fitzgerald Kennedy
tardi agli appuntamenti, ha uno scarso valore delle cose e spesso le smarrisce».
Il giovane Kennedy, insomma, non pareva volerne sapere di adeguarsi alle regole dell'istituto e - secondo un'osservazione di sua madre, - «preferiva fare ciò che voleva, piuttosto che ciò che la scuola voleva da lui».
Di fronte ai disastrosi rendiconti che gli giungevano dalla Choate School, a un certo punto Joe sr. perse la pazienza. Prese da parte John e lo rimproverò per più di un'ora. Il ragazzo, il capo chino, promise che si sarebbe ravveduto, ma in realtà continuò la sua sottile opera di contestatore, facendosi numerosi seguaci tra i compagni. Jack, infatti, aveva una facilità impressionante nel farsi amici e nel renderseli fedeli. (Questa capacità si potenzierà in seguito, quando egli si darà alla politica, consentendogli di crearsi uno staff di collaboratori disposti a fare per lui qualsiasi sacrificio).
Durante le vacanze e in occasione del week-end, Jack era solito tornare a casa con un codazzo di quattro o cinque amici - ovviamente senza essersi preso la briga di preavvertire nessuno - che, sommati ai suoi otto fratelli, creavano non pochi problemi.
Erano le cosiddette «sorprese di Jack»: un eufemismo, quest'ultimo, che mal celava l'imbarazzo dei suoi, che non sempre erano disposti a sopportare quelle improvvisate.
Al di là di tutto questo, il direttore della Choate School si dimostrava fiducioso nelle possibilità del suo allievo. Ecco quel che scrisse una volta ai genitori di Jack: «Il fatto è che non mi riesce di sentirmi seriamente preoccupato per Jack. Quanto più vivo, lavoro e parlo con lui, tanto più cresce la mia fiducia. Sarei disposto a scommettere qualsiasi cosa che entro due anni sarete orgogliosi di Jack quanto ora lo siete di Joe». Così, dopo le sfuriate, suo padre cambiò metodo e preferì la strada della persuasione: «Ora, Jack, non voglio che tu abbia l'impressione di avere a che fare con un padre brontolone. L'esperienza mi ha insegnato a soppesare le persone, e sono sicuro che tu puoi andare lontano. Ebbene, non ti sembra sciocco non mettere a frutto ciò che Dio ti ha dato?».
Nell'ottobre 1935 arrivò, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che l'Italia fascista aveva iniziato l'occupazione dell'Etiopia. Il governo americano manifestò subito la sua solidarietà con il negus Ailè Selassiè, ma nei quartieri italiani disseminati negli Stati Uniti si assistette a scene di
Luigi Barbara 28 1985 - John Fitzgerald Kennedy
clamoroso entusiasmo. Era il tempo del consenso al fascismo, e Mussolini godeva di un vasto seguito anche nelle comunità italiane in America. Tutti i giornali stampati in italiano riportavano puntualmente i bollettini di guerra e scrivevano che quella era una campagna giusta, che l'Italia combatteva per il suo «posto al sole». A New York, nell'agglomerato della Little Italy, la gente cantava per strada Faccetta nera o l'altra canzone del regime il cui ritornello suonava: «Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò».
Papà Kennedy partecipò al giubilo degli italiani soprattutto perché sapeva che il loro voto poteva essere importante per chi, come lui, aveva ambizioni politiche. Jack invece, ormai alle soglie dell'università, approvò senza mezzi termini il passo di Mussolini e se ne congratulò con un compagno di studi, figlio di immigrati napoletani. Con lui appuntava le bandierine su una carta geografica nei punti corrispondenti alle località che le truppe italiane guidate da Emilio De Bono, Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani man mano conquistavano.
A quel tempo, il legame di Joseph Kennedy sr. con Franklin Delano Roosevelt s'era ormai consolidato. Roosevelt, però, era un politico troppo accorto per andare incontro ai desideri del «vecchio» Joe che reclamava per sé un posto nel governo. Di un posto al governo neanche parlarne. Roosevelt sapeva che l'amico si era compromesso troppo in affari non del tutto cristallini e temeva di essere criticato se lo avesse favorito fino a quel punto. Il suo New Deal aveva bisogno di uomini integerrimi e tali da suscitare il pieno consenso popolare.
Per Roosevelt, l'amicizia con Joseph Kennedy divenne dunque un peso, anche se non gli era possibile dimenticare l'aiuto che quello gli aveva dato durante la campagna per la conquista della presidenza.
Non era stato Kennedy ad avere un posto privilegiato sul suo treno elettorale che aveva percorso gli Stati Uniti da una costa all'altra? Era indispensabile trovargli un incarico di prestigio, ma fuori dai confini dell'Unione.
Luigi Barbara 29 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO IVGLI ANNI DI HARVARD
Jack Kennedy prese il sospirato diploma alla Choate School nel giugno del 1935. Doveva ora decidere quale strada intraprendere. Voleva iscriversi all'università di Princeton, nel New Jersey, «data la sua vicinanza a New York, dove si trovavano anche i medici che mi avevano in cura», spiegava. Ma questa sua scelta era dettata soprattutto dalla speranza di starsene lontano dal fratello Joe che studiava ad Harvard, dove, naturalmente, riscuoteva molto successo.
Suo padre, infine, stabilì che anche lui, come Joe jr., avrebbe dovuto andare a Londra per frequentare la London School of Economics e seguire le lezioni di Harold J. Laski. Il «vecchio» Joseph detestava le idee di Laski, ma voleva che i suoi figli conoscessero «l'altra faccia della storia», se non altro per combatterla più efficacemente.
Intanto la bufera della guerra già tormentava la Spagna. Lì, la repubblica sortita dalle elezioni municipali di Madrid della primavera del 1931 non era riuscita a trovare stabilità. Nel luglio del 1936, nelle guarnigioni del Marocco spagnolo era scoppiata una rivolta, presto diretta dal generale Francisco Franco e sostenuta dalla Germania e, soprattutto, dall'Italia. Era, per la Spagna, l'inizio di quella guerra civile che sarebbe terminata solo nel marzo del 1939 e che sarebbe stata il primo banco di prova dell'imminente secondo conflitto mondiale. Questi avvenimenti, comunque, non impedirono al giovane Kennedy di recarsi in Inghilterra e, infine, nella stessa Spagna.
Secondo J. MacGregor Burns, papà Joseph voleva che Jack frequentasse la cosmopolita London School of Economics perché venisse a contatto «con i laburisti britannici, i profughi europei, gli estremisti provenienti dalle colonie, i funzionari dell'amministrazione dell'India e altri». Il destino, tuttavia, aveva stabilito altrimenti. Poco dopo il suo arrivo in Inghilterra, infatti, Jack si ammalò di itterizia e fu costretto a tornare a casa, dove decise di iscriversi all'università di Princeton. Anche lì, però, i suoi studi durarono pochissimo e dopo l'ennesimo attacco di itterizia, nel Natale del 1936, si rassegnò a frequentare l'ateneo di Harvard, dove divise la stanza con Torbert MacDonald, un noto campione di foot-ball.
Durante il primo anno di università non vi furono novità di rilievo: Jack
Luigi Barbara 30 1985 - John Fitzgerald Kennedy
continuava a essere uno studente mediocre e agli esami se la cavò per il rotto della cuffia. Dai registri di Harvard risulta che egli ottenne il voto «C» - equivalente alla sufficienza - in tutte le materie tranne in economia, dove ebbe una classificazione migliore, «B». I vari professori lo trovavano una matricola brillante, ma poco «assidua». Il professor John K. Galbraith, il celebre economista che durante la presidenza Kennedy sarebbe diventato ambasciatore in India, lo descriveva come un giovanotto «allegro, simpatico, irriverente e di bell'aspetto ma tutt'altro che diligente»; Arthur Holcombe, suo professor of government (una cattedra che non ha corrispondenti negli atenei italiani e che riguarda la teoria dello Stato e la pratica dell'amministrazione pubblica), lo giudicava invece «molto promettente, con un interesse istintivo per le idee e le loro applicazioni pratiche».
Harvard, a quel tempo, era tutto un ribollire di fermenti e di proteste. Si bruciavano i ritratti di Hitler e di altri dittatori, si metteva sotto accusa il conservatorismo dei genitori, si protestava contro l'inerzia delle democrazie di fronte all'arroganza delle tirannie. Si comperavano riviste progressiste come «Nation» e «New Republic», e nelle camerate si improvvisavano tumultuose assemblee nelle quali si discuteva la situazione politica interna e internazionale.
Jack Kennedy disertava queste riunioni. Sembrava freddo, anche se era soltanto timido. Anni dopo, nel luglio del 1956, Irwin Ross avrebbe scritto sul «New York Post» che Jack - tutto d'un pezzo, sano, serio ma nient'affatto brillante, - considerava con distacco le avanguardie. Tutto giusto. Quanto al «sano», invece, Ross dimostrava di aver preso un granchio. Jack, infatti, anche ad Harvard continuò ad ammalarsi spesso.
Nel secondo anno alla Harvard, parve che il giovane Kennedy intellettualmente fiorisse. Già nel primo anno, per la verità, un certo cambiamento era avvenuto, tanto che uno dei professori che lo seguivano aveva manifestato un cauto ottimismo: «Per quanto la sua mente sia ancora indisciplinata e anche se probabilmente non sarà mai originale, il ragazzo ha estro e mi sembra che stia migliorando». Ma al secondo anno le sue «quotazioni» salirono decisamente. Un professore che lo seguiva allora, il dottor Bruce Hopper, avanzava ancora delle riserve, ma doveva riconoscere: «Jack è straordinariamente abile quando si mette al lavoro. La sua preparazione può presentare delle lacune, ma la sua elasticità mentale lo aiuta molto». Il «vecchio» Joe era alle stelle e nelle lettere al figlio non
Luigi Barbara 31 1985 - John Fitzgerald Kennedy
dissimulava il suo orgoglio: «Mi sembra che tu e Joe abbiate fatto grandissimi progressi riguardo ai voti. L'inversione di rotta che hai fatto tu in quest'ultimo anno mi ha sbalordito. Stai facendo colpo anche su quelli più grandi di te: sono impressionati dalla maturità dei tuoi ragionamenti e ti considerano molto». Come premio, papà Joe allargò generosamente i cordoni della borsa e regalò a Jack un viaggio in Europa.
Il giovane Kennedy, dunque, si mise per mare nell'estate del 1937, in compagnia del suo amico Lemoyne Billings, sbarcò in Francia. Parigi lo affascinò: «Ecco una città in cui mi piacerebbe vivere e morire!». (L'idea della morte era ricorrente in lui. Spesso recitava la sua poesia preferita: «Ho un appuntamento con la morte / a mezzanotte in una città in fiamme, / quando al nord con passo leggero tornerà la primavera / e io, fedele alla parola data, / non mancherò all'appuntamento». Questi versi di Alan Seeger li avrebbe ripetuti anche alla moglie Jacqueline, presago forse di un invincibile fato).
Dalla Francia, Jack mandava al padre accurate analisi della situazione politica di quel Paese, della cui democrazia prevedeva il tracollo sotto la potenza d'urto della dittatura nazista. «Qui non ci si prepara», scriveva, «i francesi non si armano, mentre i tedeschi non perdono tempo e si fanno sempre più aggressivi. Occorrerebbe un uomo di polso, ma per quanto mi guardi in giro non mi riesce di vederne». Lavai e Pétain non gli davano affidamento e la storia successiva non gli avrebbe dato torto.
Il padre era soddisfatto dei «rapporti» di Jack, e giunse anzi a pretenderne da lui uno a ogni tappa del viaggio, forse per saggiare la sua attitudine alla carriera politica. Jack aveva vent'anni quando da Roma inviò al padre un «rapporto» in cui elogiava il sistema corporativo fascista, «che tutti in Italia hanno l'aria di approvare», e dalla Spagna scrisse poi che auspicava, per il bene del Paese, la vittoria di Franco, «anche se all'inizio, almeno dal punto di vista morale, aveva ragione il governo repubblicano, il cui programma era simile a quello del nostro New Deal».
A Roma il giovane Kennedy, forte del prestigio della famiglia, poté avvicinare i più importanti gerarchi del regime. Provò subito simpatia per il ministro dell'Educazione nazionale, Giuseppe Bottai, e questi giunse a promettergli un incontro con il duce. Mussolini però, soffocato com'era dal fitto calendario dei suoi impegni, non poté riceverlo. Jack, rammaricato, inviò al padre un cablo: «Impossibile vedere Mussolini. Peccato. Avevo molto da chiedergli».
Luigi Barbara 32 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Da Aragno, un caffè romano alla moda, Jack conobbe molti intellettuali, giovani come lui, appena sfornati dalla fucina fascista dei ludi juveniles, parecchi dei quali, di lì a pochi anni, sarebbero diventati i fieri oppositori di un duce in declino. Jack viveva praticamente all'ambasciata americana, ma all'ora di pranzo era invariabilmente a piazza Navona, in qualche rinomata trattoria, dove imparò ad apprezzare gli spaghetti. E così, alla sempre preoccupatissima mamma Rose, in pena per la sua salute, poteva scrivere: «Qui mangio con molto appetito, e, se questo può farti piacere, ti informo che sono cresciuto di tre chili. La cucina italiana è ottima, a mio avviso migliore di quella francese».
Durante il soggiorno a Roma, il giovane Kennedy si invaghì della figlia di un addetto all'ambasciata americana, che frequentava un esclusivo collegio della città. Per un paio di settimane la incontrò tutti i giorni; poi, al momento della partenza, si staccò da lei senza particolari problemi. Anche in seguito, occorre dire, le sue infatuazioni avrebbero avuto durata breve, e spesso egli diede l'impressione di cambiare donna con la stessa facilità con cui comunemente ci si cambia la camicia.
Già a bordo della nave che lo riportava in patria, Jack s'incapricciò di una ragazza francese che andava in America per completare gli studi. L'amico Billings cercò invano di distrarlo, se non di raffreddarne gli ardori, ma Jack non se ne dette per inteso. A lui quella francesina piaceva molto e giunse addirittura a parlare di matrimonio. Non se ne fece nulla, comunque, e l'irruente Kennedy dimenticò anche questo secondo «grande» amore non appena rimesso piede a New York.
Alla fine del 1937, quando Jack era al secondo anno di università, Joseph Kennedy fu nominato da Roosevelt ambasciatore a Londra. Il presidente, così facendo, riconobbe i meriti del vecchio amico che tanto lo aveva sostenuto, ma al tempo stesso lo allontanò prudentemente da Washington. Una «sfumatura», questa, che Joe Kennedy, lì per lì, non comprese.
Per la prima volta, dunque, la famiglia Kennedy si trovò divisa. I figli minori furono sistemati nei migliori «college» americani, mentre Joseph e Rose si trasferirono all'ambasciata di Grosvenor Square a Londra, dove Joe jr. e Jack, appena possibile, andavano a visitarli.
Alla fine del secondo biennio universitario, - come sappiamo - Jack aveva ottenuto agli esami dei buoni risultati; l'anno successivo cominciò a destarsi in lui anche un vivo interesse per la politica. Era il periodo degli
Luigi Barbara 33 1985 - John Fitzgerald Kennedy
accordi di Monaco. Il 29 settembre 1938, nella città tedesca si erano riuniti Mussolini, Hitler, Daladier e Chamberlain: sul tappeto, la questione dei Sudeti. Chamberlain e Daladier, gli unici cui premesse di salvare la pace, subirono le pretese tedesche nei confronti della Cecoslovacchia, consegnando al Reich l'intero territorio dei Sudeti. Il governo di Praga non poté che piegarsi alle decisioni dei quattro «grandi», ma quel patto segnò anche il culmine dell'acquiescenza franco-inglese verso l'espansionismo nazista, che doveva condurre fatalmente alla seconda guerra mondiale. Da Monaco Hitler usciva trionfatore; le democrazie sconfitte. E da Londra, Joe Kennedy sr. mandava al suo presidente trionfali messaggi. «Ora non ci attende», scriveva, «che un lungo periodo di pace e anche il Terzo Reich potrà convivere con noi...».
Jack, dal canto suo, non condivideva l'ottimismo paterno e, per rendersi meglio conto di quanto accadeva in Europa, chiese e ottenne il permesso di non frequentare i corsi del secondo semestre per potervi compiere un altro viaggio. All'inizio della primavera del 1939 partì per Parigi, quindi soggiornò per una ventina di giorni in Polonia, da dove proseguì per l'Unione Sovietica, la Turchia, la Palestina. Infine andò a Berlino passando per i Balcani. Grazie alla posizione di suo padre, fu ospite a Parigi dell'ambasciatore Anthony Biddle e nella capitale russa di Charles E. Bohlen, che esercitava in quegli anni la funzione di secondo segretario d'ambasciata. L'Unione Sovietica doveva riservargli la più grande delusione. Suggestionato dai pur rarissimi marxisti americani, il giovane studente di Harvard pensava di visitare un Paese non molto diverso dal suo. La propaganda comunista lo aveva in parte convinto che con la caduta degli zar in Russia si fosse instaurato un regime progressista. I sovietici, invece, gli resero la vita difficile, condizionandolo nei suoi movimenti e obbligandolo a riempire un'infinità di moduli per ottenere anche le cose più banali.
Dopo aver soggiornato a Leningrado, a Mosca e in Crimea, il giovane Kennedy finì col descrivere l'URSS come «un Paese rozzo, arretrato, disperatamente burocratico». La burocrazia in cui soffocava quel Paese lo aveva, più di ogni altra cosa, impressionato e, fatto il raffronto, egli concludeva che gli Stati Uniti erano la nazione più libera del mondo. «La polizia qui è onnipresente; non ho potuto fare un passo senza il beneplacito di qualche commissario. Vi assicuro che per sopravvivere nell'Unione Sovietica occorre pazienza, moltissima pazienza. Solo in Crimea mi è
Luigi Barbara 34 1985 - John Fitzgerald Kennedy
parso che le misure di controllo fossero meno rigide. Ma può darsi che si trattasse di un'illusione». Quando lasciò la Russia, il giovane Kennedy tirò un sospiro di sollievo.
Passò poi a un altro scacchiere «caldo» del mondo: il Medio Oriente, dove gli inglesi facevano l'impossibile per tenere la situazione sotto controllo. E da Gerusalemme mandò un «rapporto» sulle relazioni fra inglesi, arabi ed ebrei nel quale definiva la politica britannica «una politica equa e corretta», ma aggiungeva che «qui non serve una soluzione equa e corretta, bensì una soluzione efficace, che funzioni».
Alla corte di San Giacomo, Kennedy padre continuava frattanto a fare sfoggio di ottusità politica. Non era per nulla in grado di comprendere i gravi avvenimenti che incombevano sull'Europa in quei giorni, e se i giornali fascisti ritraevano il premier britannico Chamberlain intento a ripararsi dalle bombe con un ombrello, l'ambasciatore americano a Londra avrebbe potuto benissimo essergli sistemato accanto. Pacifista e isolazionista a oltranza, il «vecchio» Kennedy continuava a credere nella coesistenza tra democrazie e stati totalitari. Non che fosse un filonazista, ma non v'è dubbio che il suo atteggiamento «compiacente» dovette contribuire a creare in Hitler la certezza che gli Stati Uniti non si sarebbero mai intromessi nelle faccende europee.
Favorevole a Chamberlain e da questi ricambiato, l'ambasciatore degli Stati Uniti era invece malvisto da un altro uomo politico che a quell'epoca avanzava a gran passi in Inghilterra: Winston Churchill, fiero assertore dei diritti degli uomini liberi. Churchill non faceva nulla per dissimulare il suo disprezzo per quel diplomatico che strizzava l'occhio ai dittatori europei e che faceva di tutto perché l'America si disinteressasse dei problemi del vecchio continente. Nelle sue memorie egli definì anzi il «vecchio» Kennedy «un pericoloso, abulico e infido figlio degli Stati Uniti».
Il disprezzo di Churchill per Joe Kennedy nel 1939 era comunque una vecchia storia che si accompagnava all'incapacità dell'ambasciatore di accettare la «sfumatura» cui abbiamo accennato; tant'è vero che quando nel 1938 Joe sr. era tornato in patria per festeggiare la laurea del primogenito, era stato convocato a Hyde Park dal presidente Roosevelt. «Il colloquio - riferì il «Chicago Tribune» - si svolse in un'atmosfera gelida: Roosevelt infatti aveva saputo che Kennedy intendeva servirsi della corte britannica come di un trampolino per entrare alla Casa Bianca». Ne erano prova anche alcune notizie confidenziali che Kennedy aveva passato ai
Luigi Barbara 35 1985 - John Fitzgerald Kennedy
giornalisti di Washington.Dimenticata Wall Street, il «lupo solitario» mirava in alto. Dopo il posto
di ambasciatore, voleva quello di presidente, come «coronamento della sua irresistibile ascesa». Roosevelt, in quell'incontro, aveva richiamato all'ordine il suo avido diplomatico, esortandolo a limitarsi a fare il suo dovere. E infine aveva aggiunto, acido: «So che Churchill si lamenta di lei. Non mi "disgusti" Churchill, che è un amico e un vero democratico». Poi aveva alzato la mano. Per quel che lo riguardava, il colloquio era finito.
Joseph Kennedy ripartì per Londra amareggiato. Tanto più che i leader del partito democratico gli avevano fatto capire che non lo volevano come candidato alla Casa Bianca e che tutta la loro fiducia andava ancora e solamente a Franklin D. Roosevelt.
Rientrato - come si dice - nei ranghi, nei suoi rapporti da Londra, l'ambasciatore Kennedy continuò tuttavia a mostrarsi favorevole alla politica di Chamberlain, cercando di far valere il proprio atteggiamento isolazionista verso il problema europeo. «Egli consigliava infatti gli Stati Uniti», dicono gli storici Langer e Gleason in Sfida all'isolazionismo, «di astenersi all'intervenire nel conflitto che stava per scoppiare in Europa e sollecitava sforzi che mettessero il Paese in condizione di difendersi da qualsiasi eventualità».
L'atmosfera europea, frattanto, si faceva sempre più cupa: a Hitler non era bastata l'annessione, senza colpo ferire, dei Sudeti. Mussolini, dal canto suo, gli faceva da spalla e tuonava contro le demoplutocrazie, responsabili, a suo dire, dei mali del mondo.
Quando, dopo Monaco, la situazione precipitò, Kennedy manifestò al suo governo l'opinione che si doveva far di tutto per evitare la guerra: essa, infatti, si sarebbe risolta con la vittoria di Hitler; diversamente - ipotesi per lui ancor peggiore -, la sconfitta della Germania avrebbe portato il comunismo al trionfo in tutta l'Europa. La sua idea, paradossalmente, doveva essere condivisa da Chamberlain, se è vero che dopo la garanzia franco-inglese alla Polonia e il clamoroso patto di non aggressione germano-sovietico del 23 agosto 1939, questi aveva telegrafato allarmato a Roosevelt chiedendogli di usare tutta la sua influenza perché i polacchi accettassero l'ultimatum di Hitler.
Il giovane Kennedy era frastornato da tutti questi avvenimenti che si succedevano a ritmo frenetico; non si orientava più. E alla madre Rose, riabbracciata a Londra, confidava: «Io non capisco più niente. Che cosa
Luigi Barbara 36 1985 - John Fitzgerald Kennedy
vogliono Mussolini e Hitler? Hanno il predominio sul continente eppure sembra che questo a loro non basti. Sono davvero confuso e avrei bisogno di riordinare le idee».
All'epoca del patto Hitler-Stalin, John si trovava a Berlino, ed era nella galleria della Camera dei comuni quando Chamberlain, il 2 settembre 1939, annunciò la decisione della Gran Bretagna di entrare in guerra contro la Germania. Le sue idee parvero d'un tratto chiarirsi. In una lettera al padre definì «infame» l'intesa tra il Terzo Reich e l'URSS, e «sensata» la decisione dell'Inghilterra di schierarsi a fianco della Polonia e degli altri popoli oppressi.
Ma le idee del giovane Kennedy si chiarivano, la stella del vecchio Kennedy si appannava. L'ambasciatore accolto con tanta simpatia alla corte di San Giacomo, ormai era malvisto dagli inglesi, tanto più ora che, impressionato dalla potenza della macchina bellica nazista, aveva cominciato a inviare rapporti al dipartimento di Stato in cui escludeva ogni possibilità di vittoria per la Gran Bretagna e la Francia e caldeggiava la più assoluta neutralità degli Stati Uniti. Lui stesso se ne rese conto. «La mia carriera come diplomatico è finita domenica mattina alle 11 (il momento della dichiarazione di guerra tra Gran Bretagna e Germania). Adesso mi resta soltanto la routine di un ufficio amministrativo... Invece di salire, sono sceso in basso». Queste furono le parole di Joe Kennedy senior, secondo Richard Whalen, quando in Europa divamparono alte le fiamme della guerra. L'Associated Press annotava che l'ambasciatore s'era troppo legato al cavallo perdente Chamberlain, ed era inevitabile che ne pagasse le conseguenze. Churchill, subentrato al debole predecessore, continuò a non nascondere la sua antipatia per l'ambasciatore americano, che definì senza mezzi termini «un disfattista», e Roosevelt finì per comunicare sovente col premier britannico senza informare il suo subalterno, anche perché il ministro del commercio Harry Hopkins gli aveva detto che «in certi ambienti si aveva l'impressione che egli (Churchill) non potesse soffrire né gli Stati Uniti, né Roosevelt.
Churchill si era indignato e aveva accusato Kennedy di essere il responsabile di tale impressione». Né Kennedy diede, in quei giorni, prova di maggior tatto diplomatico quando confidò al giornalista Louis Lyons: «Sono pronto a spendere tutto il mio patrimonio per tenerci fuori da questa guerra... Quale utile potremo ricavarne? Conosco l'Europa meglio di qualunque altro americano... La democrazia britannica è finita... La Gran
Luigi Barbara 37 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Bretagna non combatte per la democrazia, ma per la propria sopravvivenza».
Dopo questa intervista, i rapporti tra Roosevelt e Kennedy precipitarono, e il presidente non risparmiò di comunicare all'ambasciatore il suo profondo disappunto, al quale si aggiunsero anche le aspre critiche degli ebrei, vittime delle persecuzioni naziste. Bisogna dire, ciò nonostante, che al vecchio Kennedy non mancassero i sostenitori, primo dei quali il prestigioso editore Henry Luce, la cui rivista «Life» scrisse: «Se il piano Kennedy avesse successo, aggiungerebbe nuovo lustro a una reputazione che potrebbe benissimo portare Joseph Patrick Kennedy alla Casa Bianca».
Anche a questo proposito, tuttavia, la reazione di Roosevelt non si fece attendere: il presidente annunciò che l'unico diplomatico americano autorizzato a occuparsi dei profughi europei era Myron Taylor. Era l'ennesima, brusca censura fatta a Kennedy, questa volta perché non «pianificasse» la sorte di 600.000 ebrei tedeschi che egli, per attenuare le critiche suscitate dal suo piano di pace, avrebbe voluto trasferire in varie parti del mondo.
Saliva invece sempre più la stella di John. Il 4 settembre 1939 il transatlantico inglese Athenia, con trecento americani a bordo, venne silurato da un sommergibile tedesco. Dodici americani persero la vita e Jack fu inviato dal padre a confortare i sopravvissuti e a organizzare il loro ritorno in patria sulla nave Orizaba. Un compito che egli superò brillantemente.
Quando tornò ad Harvard, il giovane Kennedy era un altro: cominciò con il rivelarsi uno studente superiore alla media. Come tesi di laurea, scrisse un lungo saggio in cui analizzava le complesse ragioni per le quali l'Inghilterra non aveva proceduto al riarmo negli anni Trenta. Questo, oltre a ottenergli la lode, gli consentì di scrivere un libro: Why England slept (Perché l'Inghilterra dormiva), che fu accolto con vivissimi elogi dalla critica e in breve tempo divenne un best seller.
Luigi Barbara 38 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO VLA GUERRA SUL MARE DEL TENENTE
KENNEDY
Nella seconda metà del 1940, John Fitzgerald Kennedy è un baldo e promettente giovanotto che ha venduto ottantamila copie del suo primo libro, edito in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Il ricavato dell'edizione inglese lo devolve in beneficenza, a favore dei senzatetto di Plymounth, semidistrutta dalle bombe naziste; con il resto si compera la prima automobile: una scintillante Buick, che inaugura portando a spasso l'ultimo dei suoi ormai numerosi amori.
Eppure, questo disinvolto figlio di Harvard che con tanta acutezza ha saputo guardare nel cuore delle vicende che hanno nuovamente condotto l'Europa nell'inferno della guerra, è come spaesato. Solo qualche mese prima tutto gli appariva chiaro; ora invece non vede quale possa essere la via d'uscita della terribile situazione in atto. Nella sua tesi di laurea, Jack aveva messo sotto accusa la corsa agli armamenti, individuando in essa una possibile causa di conflitto e non un mezzo per consolidare la pace; ora però riconosce che le iniziative belliche della Germania di Hitler hanno reso inevitabili gli accordi di Monaco.
Grazie ad essi, infatti, le democrazie occidentali possono recuperare un po' del tempo perduto nel campo degli armamenti.
Né Jack mostrava di aver fiducia nell'ormai agonizzante Società delle Nazioni. Troppo spesso anch'essa s'era dimostrata poco decisa e impari ai suoi compiti, finendo fra l'altro col far sì che l'Inghilterra si lasciasse battere dai fascismi in quella corsa al riarmo che aveva vissuto solo come una scomoda necessità imposta dagli «obblighi contratti verso la Società delle Nazioni». Equivoci e incertezze che Jack aveva già visti giocare nella conferenza del disarmo del 1932-34, dalla quale egli riteneva che in fin dei conti fosse scaturita la tragedia europea.
Non solo: il giovane Kennedy, prevenendo quelli che sarebbero stati gli allora impensabili sviluppi del conflitto appena cominciato, aveva intuito che i maggiori pericoli per il suo Paese non dall'Europa sarebbero venuti, ma dal Giappone...
Jack, in altre parole, aveva una visione estremamente chiara del passato
Luigi Barbara 39 1985 - John Fitzgerald Kennedy
e «vedeva», se così possiamo dire, nel futuro: quel che gli sfuggiva, paradossalmente, era il presente, l'immediato. Quali erano le scelte più opportune per gli Stati Uniti?
Jack, questo sì, sente il bisogno di agire, anche se non sa bene in quale direzione. Per un po' pensa di fare il giornalista, ma presto cambia idea. In casa lo consigliano di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza di Yale, ma lui non ne vuole sapere. Anche Joe jr. intende fare l'avvocato, dice alla madre, lui quindi preferisce darsi agli affari. «Aveva tanta ammirazione per suo padre», ha spiegato Rose Kennedy, «che immaginava che se la vita di uomo d'affari e di finanziere era stata interessante per lui, doveva esserlo in assoluto».
Jack frequenta quindi per sei mesi i corsi di Economia e Commercio all'università di Standford, ma poi si ritira deluso. Il «vecchio» Joe, intanto, era rientrato negli Stati Uniti. Dopo l'ennesima bordata di Churchill e una terribile gaffe (a proposito della «first lady» d'America, Eleanor Roosevelt, aveva detto: «Ci ha importunati più lei a Washington che tutti gli altri insieme»), Kennedy padre aveva preferito rassegnare le dimissioni prima che fosse Roosevelt in persona a costringerlo a farlo. E in America, finalmente libero dalle «catene degli obblighi di un diplomatico», il «lupo solitario» di Wall Street cominciò a darsi da fare per organizzare le file dell'isolazionismo. Qualcuno scriveva per lui - che non aveva troppa dimestichezza con le lettere - accorati articoli pacifisti ed egli stesso teneva in diverse città delle conferenze, ripetendo quel leit-motiv - «l'America mai in guerra» - per il quale si prese un'ultima bordata da Winston Churchill, il quale gli diede del «codardo» e arrivò a dire che Joe Kennedy avrebbe subito il nazismo piuttosto che rinunciare a un centesimo.
I soldi, il patriarca del «clan» preferiva spenderli per divertirsi e per far divertire la moglie ed i suoi nove figli. E così, benché la guerra fosse incombente (le mire dei giapponesi non erano più un segreto per nessuno), Rose, le figlia Eunice e in seguito anche Jack, fecero un lungo viaggio nell'America latina, soggiornando negli alberghi più esclusivi. Si recarono dapprima in Brasile, quindi passarono in Argentina, in Cile, in Perù, Ecuador, Panama e Cuba, e solo a giugno inoltrato fecero ritorno a Hyannis Port «con molte cose da raccontare e giusto in tempo per passare l'intera estate a Cape Cod».
La minaccia della guerra non preoccupava minimamente la famiglia,
Luigi Barbara 40 1985 - John Fitzgerald Kennedy
dove tutti ritenevano che la propaganda antinterventista del «vecchio» Kennedy avrebbe tenuto l'America al riparo da un'infinità di lutti. Ma la situazione precipitava e anche negli USA cominciarono le chiamate alle armi.
Jack decise di entrare nell'esercito, ma alla visita medica fu scartato per via della lesione alla spina dorsale. Non si arrese. Caparbiamente, per cinque mesi si sottopose a cure ed esercizi fisici. «È il momento dell'azione», diceva, «e io non voglio stare alla finestra. Un Kennedy non può restarsene tranquillamente a casa mentre gli altri partono e si preparano a grandi imprese». Infine, grazie anche alle raccomandazioni» di suo padre, nel settembre 1941 riuscì a entrare in marina, dove tuttavia fu assegnato ai servizi sedentari. Ma poiché non era andato sotto le armi per finire dietro una scrivania, presto cominciò a scalpitare: si sentiva mortificato e se ne lamentò con papà Joseph, il quale gli promise che avrebbe fatto ulteriori pressioni sui suoi potenti amici al ministero della Difesa.
Giunse il 7 dicembre 1941 e con esso, come un fulmine a ciel sereno, il disastro di Pearl Harbor. Per Jack, che in quel mentre se ne stava immusonito in un ufficio a raccogliere dati sulla carriera degli ufficiali superiori della marina, la misura fu colma tanto più che Joe jr., mentre lui macinava lavoro come il più oscuro dei travet, si era già brillantemente imposto in aviazione. «Proprio non ce la faccio più a fare l'impiegato in un Paese in guerra», scrisse a suo padre. «Sai che ho sempre cercato di non importunarti, ma ora è il momento che faccia valere le tue influenze presso gli amici che contano. Spero tanto di essere destinato in una zona di operazioni». E firmò la lettera «John», come gli capitava quando erano in ballo problemi importanti.
Il «vecchio» Joe si rivolse questa volta all'ammiraglio James V. Forrestal, e finalmente ecco un autorevole fonogramma in cui si ordinava che John Kennedy fosse trasferito al centro d'addestramento per motosiluranti di Newport, nel Rhode Island. Al frustrato «passacarte» parve di toccare il cielo con un dito.
Jack fu assegnato all'addestramento delle reclute in un campo del South Carolina, dove andò a trovarlo l'amico del cuore Lem Billings, il quale in seguito scrisse: «Capitai lì che lui faceva il suo primo discorso in pubblico. Doveva parlare delle bombe incendiarie, di cui sapeva pochissimo, ma se la cavò egregiamente. Io ero stupito perché era la prima volta che lo
Luigi Barbara 41 1985 - John Fitzgerald Kennedy
sentivo parlare davanti a molta gente. Quando eravamo alla Choate School noi due evitavamo sempre di parlare in pubblico: una cosa che si può fare con successo se si è fatta almeno un'esperienza in teatro. Ma nessuno di noi era un buon attore. Finito il discorso alle reclute, Jack era così soddisfatto di sé che, rivolgendosi ai presenti, chiese: "Qualche domanda?" La prima fu questa: "Lei ci ha parlato di bombe di vario tipo, ognuna con caratteristiche differenti. Ma dica un po': se gliene piove una addosso, come fa a distinguere di che tipo è?" E Jack di rimando: "Sono contento che lei mi abbia fatto questa domanda. Prima di due settimane sarà qui uno specialista e questo è proprio il genere di cose di cui intende parlare". Quindi si allontanò lentamente, ma con estrema e ostentata disinvoltura».
Nell'estate del 1942, ottenuta una breve licenza, Jack capitò a Hyannis Port e, nell'autunno successivo, fu assegnato a un reparto di motosiluranti veloci e spedito nel Pacifico meridionale. Finalmente poteva confrontarsi con Joe jr. senza sentirsi inferiore. Voleva battersi con i giapponesi e naturalmente vincere; già immaginava per sé e per la sua motosilurante, la PT-109, strepitosi orizzonti di gloria.
La routine, invece, lo riassorbì, e per molti mesi rimase inattivo con il solo problema di come ammazzare la noia. «La vita a bordo della PT-109 e delle altre vedette statunitensi nelle acque delle Salomone è penosa e monotona», si legge ne Il destino dei Kennedy. «Per passare il tempo, si fanno gare di velocità tra le imbarcazioni: chi arriva primo al pontone di ancoraggio ha vinto. Un giorno la PT-109 di Kennedy acquista velocità sempre maggiore, sorpassa un "concorrente", arriva a pochi metri dal pontone, ma i tre motori non rispondono più ai comandi e il battello va a fracassare la diga di legno. Mai più in vita sua John Kennedy sentirà tanti rimproveri. L'avventura gli varrà l'appropriatissimo soprannome di "spaccalegna"».
In Europa, intanto, dopo il periodo plumbeo, le cose per gli alleati volgevano al meglio. A oriente i nazisti subivano la travolgente controffensiva dell'armata rossa; a occidente gli anglo-americani sbarcavano in Sicilia rafforzando il loro predominio nello scacchiere del Mediterraneo. Sorgevano qua e là le prima sacche di resistenza agli invasori tedeschi, le cui durissime repressioni non erano servite a scoraggiare chi mai si era sottomesso.
Giungevano anche le prime, agghiaccianti testimonianze sul massacro degli ebrei, deportati e torturati sino alla morte nei campi di sterminio. Il
Luigi Barbara 42 1985 - John Fitzgerald Kennedy
«vecchio» Kennedy scrollava le spalle e andava ripetendo che se si fosse dato retta lui, le cose avrebbero preso un'altra piega. Mamma Rose, invece, come quasi tutte le madri di allora, stava in pena per i suoi figli al fronte. «Travolta da fatti, forze e circostanze che sfuggivano al mio controllo», raccontò poi, «che altro potevo fare se non un buon viso a cattiva sorte, sperando e pregando?».
Ed ecco arrivare, anche per John, il momento infuocato della battaglia. La notte del 2 agosto 1943, durante un contrattacco aeronavale statunitense nel mare delle Salomone, la PT-109, la motosilurante da lui comandata, viene speronata e spezzata in due dal cacciatorpediniere nipponico Amagiri. Due dei tredici uomini dell'equipaggio rimangono uccisi sul colpo. Ma ecco la cronaca dell'episodio come apparve il 17 giugno 1944 sulle pagine del «New Yorker» a firma dello scrittore John Hersey, che riuscì a ricostruirlo quasi ora per ora sulla base della testimonianza degli undici sopravvissuti.
«Subito dopo la collisione, scaraventato sulla plancia, John Kennedy è paralizzato dall'orrore. "Capii in quell'istante", spiegherà in seguito a un intervistatore, "come ci si sente quando si è colpiti a morte". Ma è un attimo. Superato lo choc, Jack si rizza in piedi e comincia a organizzare il salvataggio dei sei uomini che sono finiti in mare. Si tuffa e riesce, con inenarrabili sforzi, a issarne due sul relitto che ancora galleggia. Passano tre ore, e infine Kennedy si lascia andare sfinito sul tavolato di ciò che resta della PT-109. Il marinaio Harris, ferito gravemente a una gamba, si lamenta: "Non ce la faccio più". John lo afferra per il giubbetto di salvataggio e gli grida: "Fatti forza! Bell'esemplare di bostoniano sei!"». Proseguiva Hersey nel suo resoconto: «Quando arrivò l'alba, gli undici uomini appollaiati sul relitto della PT-109 non videro alcuna imbarcazione amica nei paraggi. Molte delle isole vicine pullulavano di giapponesi e allora Kennedy domandò ai suoi ragazzi: "Che cosa volete fare se arrivano i giapponesi: combattere o arrendervi?" Qualcuno gli obiettò: "Combattere con che cosa?" Non avevano infatti che due fucili. "Che cosa intendete fare?" incalzò Kennedy. I marinai risposero: "Qualsiasi cosa lei ordini, mister Kennedy. È lei il boss". Kennedy, dopo breve riflessione, incominciò a impartire ordini, il primo dei quali fu quello di far calare in acqua gli uomini indenni per lasciare più spazio ai tre feriti. Poi il relitto cominciò a inclinarsi e Kennedy ordinò ai suoi marinai di raggiungere a nuoto un'isoletta tre miglia a sudest, Plum Pudding. Egli stesso
Luigi Barbara 43 1985 - John Fitzgerald Kennedy
"rimorchiò" il marinaio MacMahon aiutandosi con una corda stretta fra i denti. Nuotò per cinque ore».
Ma la disavventura del giovane Jack non era finita. Lui e i suoi uomini non sono ancora in salvo. Di nuovo il comandante della PT-109 si getta in mare e si dirige verso un isolotto attraverso il canale Ferguson, rotta abituale delle motosiluranti americane. Con in pugno la lanterna della sua imbarcazione affondata, raggiunge a stento un piccolo gruppo di scogli. Ma ecco, nella tenue luce del tramonto, avvicinarsi un grosso pesce. Di nuovo il terrore morde lo stomaco di Jack; gli tornano in mente le parole del suo timoniere: «Quei maledetti barracuda si accostano a un uomo che nuota per mangiargli i testicoli». Si fa forza e si dirige disperatamente sulla scogliera di corallo. Si ferisce e si graffia le gambe, ma finalmente arriva all'ingresso del canale e si mette pazientemente in attesa. Di motosiluranti americane neppure l'ombra. Decide allora di ritornare dai suoi uomini, ma è stanco morto e la corrente lo trascina in mezzo al canale. Resiste sino allo spasimo. Infine raggiunge l'isoletta di partenza, si accascia sulla battigia, vomita, e sussurra al suo terzo ufficiale: «Ross, stasera ci provi tu». Reclina il capo e si addormenta.
Ross non ha maggior fortuna, e così gli undici superstiti decidono di raggiungere a nuoto Olasana, un'isola che dovrebbe essere pattugliata da unità della marina statunitense. Sono assetati; leccano le foglie degli arbusti bagnate di rugiada e di pioggia. Li tormenta la fame, ma trovano solo delle noci di cocco. Ne bevono il latte con troppa avidità e si sentono tutti male. Il quarto giorno Kennedy e Ross, sempre a nuoto, raggiungono l'isola di Nauru, dove trovano due indigeni ai quali affidano un singolare SOS inciso con la punta del coltello sul guscio di una noce di cocco. Il messaggio dice: «Undici sono sopravvissuti. Gli indigeni conoscono la nostra posizione. Kennedy».
Quando finalmente i naufraghi vengono tratti in salvo, è passata una settimana dallo speronamento. Alla base delle motosiluranti, i tredici uomini della PT-109 erano stati dati per morti e alla loro memoria erano già stati celebrati i servizi funebri. L'ufficiale al quale spettava il triste compito di comunicare la notizia ai parenti aveva scritto alla madre di Ross che suo figlio «era morto per una causa in cui credeva più di chiunque di noi». E nel messaggio ai Kennedy così aveva concluso: «Colui che affermò che in guerra va persa la parte migliore della nazione non può essere accusato di avere esagerato».
Luigi Barbara 44 1985 - John Fitzgerald Kennedy
La provvidenziale noce di cocco del messaggio diventò il portafortuna di Jack, il quale, una volta eletto presidente, l'avrebbe sistemata sulla sua scrivania alla Casa Bianca. È ormai assodato che Kennedy, in quella tormentata avventura, si comportò da coraggioso, ma negli ambienti della marina sorsero subito dubbi sull'abilità del comandante della PT-109. Come mai Kennedy, che disponeva di un'unità mobilissima, non aveva saputo evitare il terribile impatto, oltretutto in acque controllate dagli americani?
I pareri in proposito sono discordi. Subito dopo la guerra, Kennedy rintracciò il comandante dell'Amagiri, Kohei Hanami, e lo pregò di rendere pubblica la sua versione dei fatti. L'ufficiale giapponese raccontò che quel giorno la sua nave era stata per molte ore sotto il pericolo di un attacco dell'aviazione e delle motosiluranti americane. Nonostante ciò, egli aveva mantenuto la sua posizione d'attacco e così, poco dopo la mezzanotte, avvistata a mezzo miglio una motosilurante nemica, aveva ordinato un fulmineo cambiamento di rotta per speronarla.
Secondo Hanami, il comandante Kennedy non aveva colpe, soprattutto perché non poteva prevedere la «dissennata» condotta dell'Amagiri. In seguito, tuttavia, nel 1977, lo stesso Hanami diede una versione diversa dell'accaduto: non aveva ordinato l'inversione di rotta, ma aveva speronato la motosilurante di Kennedy che gli veniva incontro con una manovra oltremodo «stravagante». Spiegò il comandante dell'Amagiri: «Non tentammo di evitare di urtare quell'unità, e non avremmo potuto farlo nemmeno volendo. La PT-109 fu spaccata in due e mandò in aria una colonna di fuoco; l'elica di destra, a dritta del cacciatorpediniere, riportò considerevoli danni. Con nostra sorpresa il capitano Kennedy sopravvisse; l'impatto fu così forte che pensammo che non ci fossero stati superstiti». Dal canto suo, il capitano Katsumori Yamashiro, che comandava la flottiglia di quattro unità di cui l'Amagiri faceva parte, contestò i fatti descritti da Kennedy e in parte confermati da Hanami. In un'intervista pubblicata poco prima della tragica morte del presidente americano, egli definì «totalmente inesatti» i fatti com'erano stati ricostruiti dal suo vecchio nemico, e ciò nonostante Fujio Onozeki, tesoriere dell'Amagiri, divenuto poi direttore di un teatro di prosa a Yokosuka, assicurasse che «Hanami, in quanto capitano dell'Amagiri, era nella migliore posizione per sapere che cosa stesse accadendo, e per dare ordini ai membri dell'equipaggio secondo le circostanze». Più tardi, un giornalista provò a
Luigi Barbara 45 1985 - John Fitzgerald Kennedy
intervistare i superstiti membri dell'equipaggio dell'Amagiri, ma pochi di loro ricordavano con precisione quanto era accaduto quella notte di tanti anni prima. Sull'avventura di guerra di Kennedy, del resto, non mancarono malignità neanche quando egli fu alle soglie della Casa Bianca. Robert Hartmann, per esempio, sosteneva che l'«eroica» vicenda della PT-109, su cui spesso Kennedy indugiava, era soltanto una montatura che faceva parte del vasto armamentario di espedienti elettorali del dinamico senatore del Massachusetts, e sul «Los Angeles Times» del 10 luglio 1960 scriveva: «La simpatia di cui Kennedy è largamente dotato non è mai tanto efficace come quando egli si abbandona ai ricordi di guerra insieme con un ben disposto reduce dalla campagna delle Salomone. Quella fu forse l'unica volta, in tutta la sua vita, in cui Kennedy dovette dipendere solo da se stesso, l'unica volta in cui tutti i suoi dollari non gli sarebbero serviti nemmeno per acquistare un bicchier d'acqua».
L'immagine di Kennedy eroe di guerra fu inoltre contestata in un libro i cui autori sostenevano che il presidente assassinato a Dallas era, in realtà,«un ufficiale di marina senza polso e un mediocre comandante di motosiluranti». In quel libro, scritto dal romanziere, nonché ex direttore del «Saturday Evening Post», Clay Blair jr. e da sua moglie Joan e pubblicato a puntate sul settimanale «National Enquirer» con una diffusione di oltre tre milioni di copie, si sosteneva addirittura che «nel primo incontro della sua motosilurante con unità nemiche di superficie, Kennedy disobbedì alla prassi regolamentare e lasciò la scena dell'azione senza nemmeno aver fatto fuoco». Sempre secondo i Blair, nel secondo contatto con i giapponesi avvenuto qualche ora più tardi, la PT-109 fu speronata perché non erano state adottate le normali misure di vigilanza per avvistare in tempo il nemico. «Come poté accadere», si chiedevano gli autori, «che un mezzo navale agile come la PT-109 venisse speronato da un grosso caccia nipponico? Non era mai successo prima e non sarebbe più accaduto. È chiaro che l'equipaggio non era sul chi vive». A detta di Blair, inoltre, due degli uomini dell'equipaggio, Charles Harris e Gerard Zinzer, avevano confessato che al momento dell'urto dormivano. Il che, se non altro, tagliava la testa al toro delle polemiche sull'abilità del comandante Kennedy.
Ufficialmente, comunque, la marina americana decorò John Kennedy con due medaglie al valore, la Purple Heart e la Navy and Marine Corps Medal, e lo onorò con una citazione all'ordine del giorno dell'ammiraglio
Luigi Barbara 46 1985 - John Fitzgerald Kennedy
William F. Halsey. Nella citazione infatti si diceva: «Il suo coraggio, la sua tenacia e le sue qualità di capo hanno contribuito a salvare numerose vite umane; egli si è dimostrato degno delle più alte tradizioni della marina degli Stati Uniti». E quando venne congedato, ai primi del 1945, ai superiori di John Kennedy rimase il ricordo di un giovane ufficiale simpatico, coscienzioso e intelligente, un po' scarso soltanto in «accuratezza e portamento militare».
Non altrettanto lusinghiero ricordo sarebbe rimasto invece a Kennedy della «sua» marina, se è vero che in una lettera al fratello Robert dal Pacifico meridionale aveva scritto: «Tienti in contatto con il tuo scassato fratello maggiore... Quaggiù chiunque riesca appena a respirare viene dichiarato abile e in grado di svolgere servizio attivo ovunque».
Per John Kennedy, comunque, la guerra si risolse tutta nella vicenda che abbiamo riferito. Soffriva sempre per la lesione alla schiena e in più si ammalò di malaria. Nel dicembre 1943 lasciò la sua squadra per far ritorno negli Stati Uniti, dove fu dislocato alla base di motosiluranti di Miami, con mansioni di istruttore. Sperava di raggiungere un'altra zona di operazioni, magari il Mediterraneo. Ma la guerra del tenente di vascello John Fitzgerald Kennedy doveva considerarsi finita.
Luigi Barbara 47 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO VIL'ESORDIO IN POLITICA
Il 2 agosto 1944, improvvisa e inattesa come un ladro nella notte arriva una tragica notizia. John sta lasciando l'ospedale per recarsi a Hyannis Port. È un giorno lieto per la famiglia Kennedy: giusto un anno prima Jack è scampato alla morte nel Pacifico. Bisogna far festa. Gli viene comunicato invece che suo fratello Joe jr. è morto, disintegrato con il suo aereo durante una missione sperimentale contro le basi tedesche sulla costa fiamminga.
Per Jack è una mazzata; non sa trattenere le lacrime. «Se n'è andato il migliore di noi», singhiozza. È la prima tragedia dei Kennedy. Il «vecchio» Joseph ne rimane annichilito: «Mio figlio... no!». Tutto s'era aspettato quando s'erano presentati quei due preti per parlare a lui e a Rose, ma non un colpo come la morte di Joe.
«Il "vecchio" Kennedy», ha raccontato Richard J. Whalen, «non si sarebbe più ripreso. I pochi secondi che servirono ai preti per dargli il triste annuncio lo cambiarono d'improvviso in un uomo umiliato e stanco».
Le cause della morte di Joe jr. non furono mai chiarite, anche perché «protette» dal segreto militare. Si sa che s'era offerto volontario per una missione sperimentale. Secondo alcuni, doveva pilotare il bombardiere Liberator PB4Y 32271, carico di tritolo e lanciarsi con il paracadute assieme al suo copilota, Wilford J. Willy, in prossimità dell'obiettivo, mentre un altro aereo avrebbe teleguidato il Liberator sino a farlo precipitare su una base di V2 in Normandia (o su una base di sommergibili sulle coste del Belgio, secondo altri). Il Liberator di Kennedy era invece esploso in volo (forse colpito dal fuoco di sbarramento della contraerea tedesca) quand'era ancora lontano dall'obiettivo. Il pilota del velivolo che seguiva quello di Joe, al suo rientro alla base, era riuscito soltanto a dire: «D'un tratto, il Liberator di Kennedy si è trasformato in una palla di fuoco ed è piombato giù, cadendo come un bengala». A Joe jr. venne concessa la Naval Cross alla memoria e anche la Air Medal. Prima che quel funesto 1944 se ne andasse, un altro lutto doveva colpire la famiglia Kennedy. Ai primi di settembre, il marchese di Hartington, figlio del duca di Devonshire e da appena quattro mesi marito di Kathleen, moriva sul fronte francese alla testa del suo reggimento (il Coldstream Guards). Toccò a
Luigi Barbara 48 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Jack, divenuto l'erede di Joe jr. in famiglia, accogliere a casa la sorella, vedova a soli ventiquattr'anni. La vittoria si profilava ormai su tutti i fronti e, nel gennaio del 1945, John F. Kennedy venne congedato. Era un reduce schivo e riservato, fiero delle sue medaglie. Non parlava però mai delle sue esperienze in guerra; già ventottenne, si preoccupava piuttosto del suo avvenire. Che fare? Il giornalista, forse. Ne parlò con suo padre, e il «vecchio» Joe lo raccomandò a un amico di antica data, l'editore William Randolph Hearst. Alla fine di aprile del 1945, John Kennedy era a San Francisco per la fondazione delle Nazioni Unite, in qualità di inviato speciale del «Journal American» di New York, e nell'estate a Londra per le elezioni britanniche.
La carriera giornalistica di Jack fu, comunque, di breve durata. Il lavoro di inviato non gli piaceva. Diceva: «Invece di agire, mi tocca riferire quello che fanno gli altri». E Victor Lasky ha spiegato: «Il successo di Jack come inviato era tutt'altro che travolgente e i collaboratori di Hearst si stavano convincendo, sebbene a malincuore, che Kennedy non sarebbe mai diventato un asso in quel campo». Jack, che sapeva cogliere anche le più riposte sfumature dei discorsi altrui, e che, per la verità, era entrato nel giornalismo senza vocazione, preferì a questo punto cambiare strada e dedicarsi alla politica: la sua vera passione.
L'esordio in questo campo, indubbiamente, non fu facile. Jack, infatti, era un giovane freddo e distaccato, politicamente indipendente; divenne democratico perché quella era la tradizione della famiglia. Subito le difficoltà si accavallarono. Benché fosse nato a Boston ed avesse frequentato l'università di Harvard, Jack in quella città si sentiva come un pesce fuor d'acqua. Cresciuto a New York, dove papà Joseph si era trasferito per seguire meglio la fitta ragnatela dei suoi mille affari, lì a Boston non conosceva quasi nessuno.
Qualcuno etichetta subito Jack come carpet-bagger (termine che in italiano suona «uomo che viaggia con un sacco sulle spalle», e che nell'Ottocento indicava gli avventurieri nordisti che dopo la guerra di secessione calavano al sud per far quattrini senza troppi scrupoli, tentando il colpo di fortuna. Il nomignolo carpet-bagger perseguiterà John per tutta la sua carriera politica). Ma il giovane Kennedy non si lascia impressionare. Dà invece incredibili prove di equilibrio e maturità, lasciando di stucco chi l'aveva giudicato soltanto un presuntuoso e inesperto avventuriero. È ormai l'erede di Joe jr. e vuole vincere.
Luigi Barbara 49 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Bisogna superare le primarie. Sono elezioni particolari e gli avversari di Kennedy costituiscono un singolarissimo campionario: ci sono quattro bostoniani di origine italiana (due di loro hanno lo stesso nome: Joseph Russo); una donna, Catherine Falvey, che in guerra è stata maggiore delle ausiliare del WAC (Women's Army Corps) e che ai comizi va in uniforme; Joseph Lee, un patrizio yankee che da anni si ostina a presentarsi in quel distretto a maggioranza cattolica, strappando scarsi consensi; uno squattrinato maestro di scuola che sogna di affermarsi per il suo idealismo, senza, per giunta, spendere un soldo. Ma ci sono anche rivali temibili, come l'ex sindaco Mike Neville e John F. Cotter, già segretario dell'ex rappresentante al congresso Jim Curley e che nell'undicesimo distretto è molto stimato.
Jack ha molta grinta politica, ma sa poco sulla gestione di una campagna «elettorale. Nel suo distretto, inoltre, il partito democratico ha un'organizzazione praticamente inesistente. E allora, ecco che si mette in moto quella potente «macchina propagandistica» che è il «clan» dei Kennedy. Neanche papà Joseph sa molto di queste cose. «Lui si sapeva disimpegnare bene in politica nazionale e internazionale», diceva sua moglie Rose. «Ma il suo interesse calava a mano a mano che si scendeva a livelli inferiori. Ciò valeva specialmente per Boston, un ambiente che aveva abbandonato da un pezzo, senza il minimo rimpianto».
Il «vecchio» Kennedy, però, uomo pratico e pieno di buon senso anche se poco brillante ambasciatore, non lesina sul denaro e stanzia somme favolose a favore del figlio. Il quale, in quell'agone politico, ha più bisogno di dollari che di consiglieri. Ecco dunque comparire una falange di esperti galoppini, gente che sa il fatto suo. «L'ultima parola sulle persone da iscrivere nei libri paga tocca pur sempre all'ambasciatore», scrive Victor Lasky. E l'ambasciatore ingaggia anche un cugino, Joe Kane, perché insegni al suo inesperto rampollo tutti i segreti dell'arte politica.
Kane, quarantenne, si mette subito all'opera. «In politica», dice al suo allievo come prima cosa, «non si hanno amici, ma solo compagni di cospirazione». Non è subito chiaro che cosa lui e Jack debbano fare, ma insieme sono un duo formidabile e azzeccano ben presto la chiave giusta. Jack ne è sorpreso, divertito e ammaestrato. Si infiamma e appare sempre più deciso a vincere, all'insegna dello slogan che Kane conia per la campagna: «La nuova generazione esprime un capo».
Dal canto suo, intanto, convoca uno stuolo di ex compagni di studio
Luigi Barbara 50 1985 - John Fitzgerald Kennedy
della Choate School e della Harvard University, e affida la direzione della campagna elettorale a Francis X. Morrissey, ex segretario del governatore Maurice Tobin. E poi c'è Dave Powers, reduce anch'egli come John (era stato aviatore in Cina), che lo accompagna ai comizi e gli rimarrà fedele sino alla tragedia di Dallas; e anche l'amico più caro, Lem Billings, lo stesso con il quale ha viaggiato a lungo in Europa prima della guerra, che tiene le redini della «base operativa» di Cambridge. Se all'inizio erano pochi a Boston a dar credito all'esile Jack, tornato malconcio dalla guerra, presto sono moltissimi quelli che si rendono conto di quanto valga.
Dà i suoi buoni frutti, ovviamente, anche la zampata di Kane. John detesta il cappello, che non porterebbe nemmeno sotto una pioggia torrenziale. Ma Joe Kane gli dice che senza cappello lui ha l'aspetto di uno studentello. Nessuno lo prenderebbe sul serio come aspirante al congresso. Con il cappello farà più presa sulla gente e otterrà ancor più voti. Non sono dettagli senza importanza. Jack, poi, pur così timido per natura, impara a fermare la gente sui marciapiedi del suo distretto, entra nei negozi e nelle officine. È un vulcano di piccole iniziative e fa di tutto per farsi conoscere.
A pranzo si ferma con i suoi collaboratori nelle tavole calde. Sempre lo stesso menù: una svizzera e un frullato con dentro il gelato. Nel pomeriggio, di nuovo in giro a far altre visite. Entra nelle sale per scommesse, nelle drogherie o nelle osterie, ovunque ci possano essere votanti; oppure va a qualche riunione importante, o nei circoli. Torna nell'albergo dove risiede - il Bellevue, dove ha un appartamento con stanza da letto, soggiorno e servizi - giusto il tempo per farsi un bagno caldo e cambiarsi, e poi via al lavoro per tutta la sera, dove capita.
Contatta ex combattenti, cavalieri di Colombo, cavalieri di Pizia e chi più ne ha più ne metta. Stringe un'infinità di mani, beve una Coca Cola o un frullato di frutta e, alla fine, regolarmente, assicura che farà gran conto del voto dei presenti. Al Bellevue possono entrare tutti. E lì ecco i vecchi amici di famiglia, quelli che hanno avuto rapporti con suo nonno, che se ne stanno a fumare sigari in continuazione. Jack non respinge nessuno: vuole conquistare tutti i voti possibili. Impara a sfruttare anche la sua «qualità» di reduce. Distribuisce migliaia di volantini con il racconto del suo «eroico» gesto alle Salomone. Fa tappezzare i muri con manifesti e circolare automobili con a bordo le persone più disparate (massaie, lavoratori portuali, reduci e funzionari), e tutti spiegano ai passanti perché daranno il loro voto a John Kennedy.
Luigi Barbara 51 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Anche le sue sorelle, suo fratello Bob e persino mamma Rose si impegnano in una propaganda diretta e capillare. Ted, che ha soltanto quattordici anni, si rende utile facendo piccole commissioni e curando il rifornimento di panini e caffè. Eunice, venticinquenne, risponde alle chiamate telefoniche e dirige il quartier generale al Bellevue Hotel. Bob, appena congedato, assume la direzione di East Cambridge e dedica alla campagna del fratello tutto il suo tempo. Quanto a Pat, ventidue anni, e a Jean, diciotto, sbrigano i più importanti lavori d'ufficio e suonano a migliaia di porte per dire alla gente stupefatta che sono le sorelle di Jack Kennedy, e che Jack sarà un grande parlamentare, e alla fine della chiacchierata distribuiscono i volantini elettorali.
Anche l'oratoria di Jack migliora. «Kennedy imparò a condurre la campagna elettorale a mano a mano che essa si svolgeva», osserva J. MacGregor Burns. «All'inizio il suo eloquio era nervoso ed esitante; mostrava scarsa ponderatezza e nessun magnetismo. Ma, poco alla volta, sviluppò uno stile di discorso diretto, informale, semplice, senza retorica, senza demagogia, senza esagerazioni trionfalistiche, che molti degli ascoltatori notarono perché contrastante con l'oratoria tribunizia dei politici di vecchio stampo».
Tutt'altro che trascurabile, poi, è il peso delle cosiddette «feste in famiglia». Eunice sfrutta il fascino che il fratello esercita sulle donne per organizzare ricevimenti ai quali invita un sacco di ragazze che sognano magari di diventare la signora Kennedy. Il «clan» prende addirittura in affitto una delle grandi sale pubbliche del Commander Hotel, a Cambridge. «Tutte le donne sono invitate», si legge nei manifesti che ammiccano dalle cantonate. A una di queste feste partecipano 1.500 persone, per lo più donne che sembrano tutte uscite dal parrucchiere per l'occasione. Ci sono momenti in cui la fila dei convenuti è così lunga che non solo riempie l'atrio dell'albergo, l'entrata, ma continua in strada.
Tutto marcia a gonfie vele, dunque... Anche se non mancherà qualche fastidiosa polemica. Dopo la vittoria elettorale, ci sarà infatti chi accuserà il «vecchio» Kennedy di aver manipolato l'elezione. L'ex «lupo solitario» di Wall Street è il responsabile della confusione creatasi in seguito alla candidatura dei quattro italo-americani: questi sono stati «convinti» da lui a entrare in lizza solo per disperdere i voti dei bostoniani d'origine italiana. L'avversario più temibile di Jack, Mike Neville, si rode il fegato perché ha perso, non avendo i mezzi per controbattere le costose iniziative dei
Luigi Barbara 52 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Kennedy. E un giorno entra nella sala stampa del parlamento dello stato del Massachusetts con un biglietto da dieci dollari che gli penzola dal taschino, tuonando: «Ecco il distintivo elettorale dei Kennedy».
Ma il suo, ormai, è un gesto che lascia il tempo che trova. I commentatori più imparziali sentenziano che non ci possono essere state manipolazioni dato l'esiguo numero - dieci - dei candidati in lizza; e che se il «vecchio» Joseph ha speso grosse cifre, queste non si possono certo definire «da capogiro». Sono affari suoi, del resto; e chi ha perso si limiti ad accettare la sua sconfitta.
Nel giugno 1946, nell'appartamento al Bellevue Hotel dove si trova il quartier generale di John Kennedy, si assiste a una scena da film western. Il vecchio «Honey Fitz» dimentica i suoi ottantatré anni, si arrampica su un tavolo e sotto lo sguardo divertito dei presenti, il fiato un po' grosso, si esibisce in un'impeccabile giga irlandese, cantando a squarciagola Sweet Adeline, la canzone che l'aveva accompagnato nelle tante battaglie, baruffe e trionfi della sua lunga carriera politica. Si fischia, si urla, volano cappelli e pagliette. È tutto uno stringere di mani e manate sulle spalle.
Joseph Kennedy sprizza soddisfazione da ogni poro. Ha gli occhialini bagnati di lacrime. E sono lacrime di gioia. Ha profuso a piene mani il suo denaro, ma ne è valsa la pena. Il «suo» Jack ha vinto le primarie con 22.183 voti. L'unico che non perde la calma è il consumato Joe Kane, il quale continua a borbottare che tutto sommato si poteva spendere un po' meno. Joe Kennedy «ha speso troppo perché non voleva assolutamente correre rischi», dice. «Tutto quello che aveva se l'era comprato. D'altronde chi può negare che la politica sia come la guerra? Per vincere, alla fine, occorrono tre cose: denaro, denaro e denaro».
È fatta, comunque. Arriva novembre e John, ventinove anni, è eletto al congresso con il doppio dei suffragi raccolti dal suo avversario Lester W. Bowen. Alla cerimonia del giuramento è con lui un altro esordiente: un giovane avvocato repubblicano eletto in California, anch'egli reduce dalle Salomone e ufficiale di marina, di nome Richard Nixon. Tempo dopo, udendolo parlare a un incontro della commissione normativa della camera a Washington, John avrebbe sussurrato all'amico Mark Dalton, seduto accanto a lui: «Guarda bene quel giovanotto; diventerà un personaggio importante. Si chiama Dick Nixon». Senza immaginare che sarebbe stato proprio Nixon a sbarrargli sino all'ultimo la via per la Casa Bianca. Jack si trasferisce a Georgetown (Washington), assieme alla sorella Eunice, allora
Luigi Barbara 53 1985 - John Fitzgerald Kennedy
impiegata al ministero della giustizia. In casa, i due fratelli hanno una governante e un cameriere nero, che spesso porta al giovane deputato la colazione in ufficio. Se però John ha vinto, non altrettanto è avvenuto per il suo partito, che al congresso ha perduto la maggioranza dei seggi che deteneva da vent'anni. Dal tempo della morte di Roosevelt, avvenuta poco prima della fine della guerra, si auspicava un profondo rinnovamento nella vita politica nel paese. Profittando di quell'atmosfera, i repubblicani, diretti dal vecchio senatore dell'Ohio Robert Taft, erano riusciti a capovolgere la loro situazione e a strappare ai democratici la maggioranza dei seggi.
Questo non facilita certo le cose a Jack. Timido, con un aspetto «troppo giovane», il ciuffo ribelle sulla fronte, egli non sembra proprio un congressista. Qualcuno lo scambia per un lift. Ed O'Neal gli si rivolge chiamandolo laddie (ragazzino). Jack pare brancolare. È alla ricerca di una linea di condotta e per mesi fa la figura del pesce fuor d'acqua.
Entra nella commissione educazione lavoro. Serve, nel frattempo, gli interessi locali del suo distretto. Vota in favore delle leggi sull'edilizia popolare, sul rinnovamento urbanistico, sulle pensioni per gli ex combattenti, sulla sicurezza sociale e sulla pesca...
Per i problemi di più ampia portata, invece, dimostra scarso interesse. Non disdegna la vita sociale e partecipa a molti ricevimenti... dove non sempre brilla per eleganza. È una vecchia storia anche questa, ma il giovane parlamentare non s'è dato cura di risolverla. Così, eccolo presentarsi a un party di Perle Mesta - vedova ricchissima, nonché finanziatrice della campagna presidenziale di Truman - «in smoking e mocassini marrone». Spesso diserta il congresso, e non solo quello. «Il giovane Kennedy si asteneva sovente dalle riunioni del nostro comitato e accadeva che non lo si vedesse per dei mesi», dirà più tardi uno dei suoi colleghi. «Ciò, d'altra parte, aveva poca importanza perché la sua presenza non sarebbe stata di grande utilità... ma eravamo stizziti perché sapevamo che egli si divertiva con un mucchio di belle ragazze».
Luigi Barbara 54 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO VIIVITA E POLITICA
Al carnet di Jack Kennedy è zeppo di nomi femminili. Per lui impazziscono, letteralmente, decine e decine di donne. Una in particolare, che si chiama Durie Kerr Malcolm. Chi è costei? Facile e difficile insieme saperlo, perché il suo nome e la vicenda cui esso è legato sono rimasti l'«imbarazzo» dei Kennedy.
Durie era una bella e ricca ragazza che d'inverno abitava a Long Island e passava l'estate a Palm Beach, in Florida, dove i suoi familiari possedevano una lussuosa residenza a un passo da quella dei Kennedy. Aveva conosciuto John a Palm Beach qualche settimana dopo la fine della guerra, e i giornali locali avevano cicalato a lungo su quella «stupenda coppia», che si faceva vedere dovunque «mano nella mano». Durie è maggiore di Jack di due anni. Ma per lui questo non ha importanza. Durie gli piace molto, e anche ora che è parlamentare tutte le occasioni sono buone per lasciare Washington e correre a Palm Beach.
Dai giornali locali, la notizia passa al «New York World Telegram», dove il 20 gennaio 1947 Charles Ventura, pettegolissimo e velenoso cronista mondano dell'alta società americana, scrive: «Un comitato di Palm Beach si propone di dare al figlio di Joseph F. Kennedy l'Oscar dell'amore per le sue gesta di Cupido. Il giovane Kennedy, infatti, si è aperto la strada in una giungla di divorzi per correre in soccorso di una donna che ha perduto la fede nel fascino della Florida e nel romanticismo delle notti di luna. Durie Malcolm Desloge, una delle ragazze più carine di Palm Beach, era minacciata dalla prospettiva di concludere la stagione su un banco di tribunale, dove aveva appena ottenuto il divorzio, e incominciava già a considerare tale prospettiva. Ma Jack ha salvato la situazione facendole una corte spietata. Ha dovuto rientrare a Washington, ma Durie riceverà l'Oscar al posto suo. I due sono inseparabili. Li si vede ovunque: alle corse, ai ricevimenti, ballano guancia a guancia, si baciano...».
Che cosa sia accaduto poi, non si è mai saputo con precisione. Il «vecchio» Joseph sente odore di bruciato e pone il veto su quella relazione che disapprova. Non ha nulla da eccepire sulla condizione sociale della ragazza, ma non tollera che il suo secondogenito divenga il criticato spasimante di una donna divorziata due volte. Jack e Durie, allora - così
Luigi Barbara 55 1985 - John Fitzgerald Kennedy
almeno scrive il giornalista Nerin E. Gun -, prendono un aereo per New York e si rifugiano a Long Island. Non basta. Vanno a Oyster Bay, un grappolo di case sperdute nell'isola e abitate da gente che si fa i fatti propri: chiedono, in municipio, una licenza di matrimonio, si recano infine da un giudice di pace e si sposano. È il marzo del 1947.
Quando il patriarca Kennedy viene a sapere di quel colpo di testa del figlio succede il finimondo: per lui, irlandese e cattolico, quelle nozze sono quasi sacrileghe. Se se ne divulgasse la notizia, per giunta, John avrebbe ben poche speranze di continuare con successo la sua carriera politica e di potere, un domani, dare la scalata alla presidenza. A Joseph Kennedy e a mamma Rose è questo che sta a cuore, non è un segreto per nessuno. È dunque credibile che Joe sr. abbia ingiunto a Jack di rientrare immediatamente in famiglia, e grazie alle sue potenti conoscenze abbia trovato il modo di fare annullare il matrimonio.
Unico strascico, la vendetta di Durie Malcolm, che per far pagare a Jack il «tradimento», si sposa una quarta volta pochi mesi dopo, l'11 luglio 1947, con Thomas H. Shelvin. La cerimonia si svolge a Fort Lee, nel New Jersey, ed è officiata dal giudice J. William Aronsohn. La scelta del luogo è obbligata. Essendo coniugata nello stato di New York, Durie Malcolm rischierebbe altrimenti un processo per bigamia o per falso giuramento.
A quel tempo, John Fitzgerald Kennedy non era ancora un personaggio molto in vista e sull'« incidente» del matrimonio calò in breve il sipario. L'argomento sarebbe stato ripreso all'arrivo di Jack alla Casa Bianca, ma con tutte le cautele del caso. Infatti, se un giornalista conosciuto per il suo coraggio come Drew Pearson dedica al tema una scottante e documentata inchiesta, ecco che dall'alto qualcuno ne vieta la pubblicazione; se il 24 luglio 1962 l'agenzia di stampa United Press conferma la notizia, ecco che tre ore dopo la stessa agenzia invia ai giornali un secondo comunicato: «Non riprodurre questa informazione; dopo una minuziosa indagine abbiamo stabilito che è falsa». La faccenda è tabù anche per l'autorevole Henry Taylor, già ambasciatore USA a Berna.
La notizia, tuttavia, seguita a circolare. Walter Winchel, per esempio, scrive: «Circola una voce su un primo matrimonio di un uomo molto importante... Egli dice che non è vero. Ma come si fa a provare, negli Stati Uniti, che non si è mai stati sposati?». Poi, ecco che «The Realist» mette le mani su un libro uscito qualche anno prima e ne pubblica una certa pagina. Il libro, un grosso volume del 1957, lussuosamente rilegato e che si intitola
Luigi Barbara 56 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Genealogia della famiglia Blauvelt, contiene la storia completa degli oltre dodicimila diretti discendenti di un povero contadino olandese, emigrato nel 1638 nel nuovo mondo, dove si era messo a lavorare per un coltivatore di tabacco che viveva sulle rive dell'Hudson. E a pagina 884 - quella, appunto, pubblicata da «The Realist» -, ecco delle note relative a Durie (Kerr) Malcom (sic!), che dicono: «Figlia di Isabel O'Cooper, discendente numero 11.304. Non abbiamo data di nascita. È nata Kerr, ma ha adottato il nome di famiglia del patrigno. Ha sposato prima Firmin Desloge IV. Hanno divorziato. Durie ha sposato poi F. John Bersebach. Hanno divorziato anche loro e lei ha sposato in terze nozze John F. Kennedy, figlio di Joseph P. Kennedy, ex ambasciatore USA in Gran Bretagna. Non sono nati figli né dal secondo né dal terzo matrimonio».
L'articolista di «The Realist» si limita ad aggiungere che è impossibile rintracciare un documento qualsiasi riguardante quel matrimonio o il suo annullamento e conclude ironicamente: «I Kennedy stanno "riscrivendo" la storia?».
Questa volta la bomba scoppia. Non resta, alla Casa Bianca, che smentire: ma leggete come e con quali argomenti. L'ufficio stampa della Presidenza emana questo comunicato: «È falso. L'autore della genealogia, inoltre, si è sbagliato: ha citato come primo marito quello che in realtà è il secondo e ha scritto il nome Malcolm in modo errato. Esso si scrive infatti con una l prima della m finale e non Malcom, come nel testo. Abbiamo inoltre un atto notorio dell'associazione della famiglia Blauvelt che dichiara che nei dossier della suddetta famiglia non c'è alcun documento comprovante il preteso matrimonio di John Kennedy con la signorina Malcolm».
Qualcuno arriva sino a Durie, ma la donna è evasiva e sarcastica insieme: « Tutti sanno che il presidente Kennedy si è sposato una sola volta. Non chiedetemi di più». «Non mi sembra che abbia peso la dichiarazione dell'associazione dei Blauvelt in cui si afferma che non si trova alcuna prova del matrimonio nei dossier della famiglia», obietta intanto Nerin E. Gun. «E perché mai dovrebbe esserci? I documenti di un matrimonio vengono conservati in municipio, negli uffici dell'anagrafe. Non sono in possesso di chi si mette a redigere una genealogia. A quell'epoca, Louis Blauvelt non aveva alcun sospetto che le sue indicazioni sarebbero state al centro di una controversia nazionale. Logico che egli non si sia riempito di prove». A questo va aggiunto che il diligente
Luigi Barbara 57 1985 - John Fitzgerald Kennedy
compilatore della genealogia non tralasciava di aggiungere, nei casi dubbi: «Di questo non sono sicuro», e che questa annotazione manca a proposito delle nozze Kennedy-Durie Malcolm.
È un ginepraio... e, alla fine, tale resterà, anche se sfrondato. Della questione, che interessava tutto il «clan» dei Kennedy, si occupò infatti personalmente il patriarca. Aveva a disposizione sufficienti mezzi per mettere a tacere anche le lingue più sciolte e per fronteggiare, con pugno di ferro, tutti gli inconvenienti che gli procurava la numerosa famiglia. Probabilmente li adoperò, e su quella scabrosa faccenda calò di nuovo il silenzio.
«Don John», come lo definisce la copertina di una grande rivista americana sulla quale splende il volto sorridente di Jack Kennedy, torna a essere lo scapolo più ambito d'America, l'uomo per il quale le elettrici perdono la testa e fanno votare mariti o fidanzati. Privo ancora di una precisa matrice politica, Kennedy appoggia dapprima il Fair Deal, il programma di riforme che Truman ha varato il 5 gennaio 1949, ispirandosi al New Deal di Roosevelt. Questo piano si propone di «mantenere l'economia americana in movimento» e di consentire che «ogni americano abbia un'equa parte della crescente abbondanza del paese». I risultati sono notevoli: del provvedimento benefica un milione e mezzo di operai. Decisi interventi si hanno anche nel campo dell'assicurazione della vecchiaia. Nello stesso anno, una legge - la legge Taft-Ellender-Wagner (legge Tew) - dispone la costruzione di 810.000 alloggi con sovvenzioni governative e impone l'abbattimento «dei tuguri» entro il termine di cinque anni.
La famiglia Kennedy, intanto, veniva colpita da un nuovo lutto: nel 1948 Kathleen, vedova del marchese di Hartington, perdeva la vita in una sciagura aerea sulla Costa Azzurra. Aveva ventotto anni. Anche questa volta Jack resta sconvolto. Kathleen era la sorella che più aveva amato; la cara Kick che gli aveva tenuto testa nei giochi di ragazzo. Ma la sua capacità di ripresa ha il sopravvento.
Il suo mandato sta per scadere. John, però, non ha rivali, né alle primarie democratiche né alle elezioni di novembre. Riconfermato deputato dell'undicesimo distretto di Boston, Kennedy continua ad appoggiare Truman. Approva il piano Marshall (il programma di aiuti economici all'Europa occidentale per la rinascita postbellica) e i finanziamenti alla Grecia e alla Turchia. A quel tempo, soprattutto in Germania e in Italia, le distruzioni operate dai bombardamenti a tappeto degli alleati erano ancora
Luigi Barbara 58 1985 - John Fitzgerald Kennedy
lì, come ferite purulente. A migliaia i senzatetto. Si temeva che in quei paesi senza pace, dove abbondavano solo lo sconforto e la disperazione per una rinascita che sembrava impossibile, potesse affermarsi il comunismo.
Ecco poi il giovane Kennedy partire lancia in resta nella «battaglia» per gli stanziamenti per l'educazione. Cattolico, Kennedy si schiera con coloro che propongono di estendere gli aiuti agli istituti religiosi e ha un memorabile scontro con Elmer E. Rogers, il cui cavallo di battaglia è la presunta dipendenza dei cattolici dal papa di Roma. Jack si alza: «Lei ha detto che i cattolici sono sudditi del papa». Rogers insiste: «Certo! I cattolici sono legati a una duplice obbedienza: al loro paese e al Vaticano. A quale dei due obbediscono di più?». Pronta la replica di Kennedy: «C'è un vecchio detto, a Boston, secondo il quale noi accettiamo la nostra religione da Roma, mentre la nostra politica ce la facciamo a casa nostra. Ed è così che la pensa la maggioranza dei cattolici».
I massoni, che hanno sempre contato molto nella vita politica americana, fanno quadrato intorno a Rogers. Kennedy rischia la testa, ma tiene duro e la spunta ottenendo la sua prima importante affermazione politica.
Kennedy incomincia quindi a mostrare una certa insofferenza per la linea Truman, che sino a quel momento ha appoggiato. Non si muove a caso, ma scegliendo attentamente le occasioni. Si schiera in favore della riduzione degli aiuti economici all'Europa occidentale e al Medio Oriente. Non perché sia un isolazionista, ma perché ritiene giunto, per i paesi europei e per quelli arabi, il momento di contribuire maggiormente alla propria rinascita con le loro risorse.
Le scelte di politica estera della Casa Bianca lo trovano più volte in disaccordo. Quando Mao Tze-tung conclude vittoriosamente l'interminabile guerra contro le forze nazionaliste di Chang Kaishek, Kennedy denuncia quelli che ritiene gli errori dell'amministrazione democratica. Parla di catastrofe per gli Stati Uniti e per la Cina. Né Jack risparmia i suoi strali a Truman quando il 10 novembre 1950 parla agli studenti e ai professori di Harvard. Non vede per quali motivi gli americani stiano combattendo in Corea; aggiunge che il governo non fa abbastanza per contrastare il comunismo, che lui personalmente ha il più grande rispetto per Joe McCarthy e che non tiene in gran conto né il segretario di stato Dean Acheson né la maggior parte degli altri membri del governo.
Quali motivi hanno determinato quella improvvisa presa di posizione
Luigi Barbara 59 1985 - John Fitzgerald Kennedy
contro il presidente, che appartiene al suo stesso partito? Victor Lasky pensa che «la ribellione personale di John contro l'amministrazione Truman fosse ispirata da più alte ambizioni politiche. Kennedy sapeva bene (grazie ai risultati dei sondaggi finanziati dal padre) che la politica di Truman, specie in campo internazionale, diventava sempre più impopolare; le sue ambizioni lo portavano perciò a staccarsi dal presidente».
Ai primi del 1951, mentre al congresso si dibatte la questione della difesa dell'Europa occidentale, John Kennedy preferisce documentarsi e compie un viaggio di sei settimane in Gran Bretagna, Francia, Italia (dove viene ricevuto da papa Pacelli), Spagna, Germania occidentale e Jugoslavia (dove si incontra con Tito). Al suo rientro in patria, sentenzia che «bisogna salvare l'Europa occidentale, ma gli Stati Uniti non possono farlo da soli, né pagare un prezzo troppo alto». Come suo padre, anche lui sogna un'America chiusa in se stessa, ricca, potente e che ignori quanto succede nel mondo?
In autunno visita il Medio Oriente, il Pakistan, l'India, la Malesia, l'Indocina e la Corea. Sono con lui sua sorella Patricia e suo fratello Robert. E quando torna, attacca alla radio la politica statunitense in Indocina, sostenendo che gli americani si erano alleati allo sforzo disperato dei francesi per conservare il relitto di un impero. È ancora l'isolazionismo di suo padre?
La realtà è diversa. Se Truman si fosse domandato dove volesse arrivare John Fitzgerald Kennedy, questi avrebbe potuto rispondergli che mirava più in alto ancora che al senato: alla Casa Bianca.
Luigi Barbara 60 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO VIIILE BATTAGLIE DEL SENATORE
L'occasione propizia per il grande balzo viene nell'aprile del 1952. Il governatore democratico del Massachusetts, Paul Dever, rinuncia alla candidatura, considerando imbattibile il rivale repubblicano Henry Cabot Lodge jr. E subito Kennedy presenta la propria. Un atto temerario, dicono tutti. Cabot Lodge appartiene a quella ristrettissima aristocrazia americana costituita dai discendenti dei primi puritani immigrati nel nuovo mondo. Senatore dal 1936, uno dei più rispettati «bramini» di Boston, è alto, bello, simpatico e intelligente; è in grado di parlare agli elettori di origine francese nella loro lingua madre e ha una bella cognata, una nobile Biaggiotti, che quando lo accompagna ai comizi nei quartieri italiani gli prepara la strada rivolgendosi all'auditorio in italiano.
Jack non ha questi vantaggi, e per di più si presenta all'elettorato senza una precisa etichetta politica. È un liberale o un conservatore? un isolazionista o un internazionalista? Nessuno lo potrebbe dire. Ma in assenza di convinzioni profonde, Kennedy ha la formidabile capacità di assimilare la tendenza politica del momento. In realtà, il divario tra lui e Cabot Lodge è praticamente inesistente: definiti dalla stampa come «politicamente irregolari», entrambi sono belli, si sono laureati ad Harvard, hanno combattuto eroicamente in guerra e sono ricchi. Kennedy, però, lo è di più.
Con notevole anticipo su quella di Cabot Lodge, la «macchina» propagandistica del «clan» dei Kennedy si avvia, sostenuta, dietro le quinte, dal denaro del «vecchio» Joseph. Nel Massachusetts, per entrare nella lista elettorale, il candidato deve presentare domanda di iscrizione ed è necessario che tale domanda sia accompagnata dalle firme di 2.500 persone, qualificate come «garanti». Le firme raccolte a favore del deputato Kennedy sono 262.324 e riempiono un fascicolo di diecimila cartelle. Alla fine, l'elenco delle persone che aiuteranno Jack a conquistare il posto di senatore sarà così lungo «da avere le dimensioni della guida telefonica di una grossa città».
Già si sente nell'aria quale sarà il candidato baciato dalla vittoria... o dalla fortuna. Durante la bagarre elettorale, infatti, nasce un nuovo Kennedy: Joseph, figlio di Bob e di Ethel Skakel. Anche questo
Luigi Barbara 61 1985 - John Fitzgerald Kennedy
avvenimento giova alla causa di John, tanto che un luogotenente di Lodge mormora sconsolato: «L'arcivescovo Cushing ha battezzato il figlio di Bob e di Ethel durante una cerimonia speciale in un giorno lavorativo, proprio prima delle elezioni. Non abbiamo più speranze». E il «New Republic», per la penna di John Mallan, azzarda qualche pronostico: «Pare assai probabile che il Massachusetts e gli Stati Uniti vedranno quanto prima un repubblicano irregolare sostituito da un democratico a sua volta irregolare».
Lo scrutinio vede 1.211.984 voti per Kennedy contro 1.141.247 per Cabot Lodge. Il margine non è esaltante, ma, sia come sia, il 3 gennaio 1953 John F. Kennedy presta giuramento come senatore degli Stati Uniti e prende posto, visibilmente emozionato, nell'ultima fila dei banchi riservati ai democratici. Nell'edificio degli uffici del senato, gli vengono riservate quattro stanze, e lui ordina che la porta che dà sul corridoio rimanga sempre aperta. «I miei elettori possono entrare e uscire a loro piacimento. Non ho segreti per loro e sono sempre a loro disposizione». Entra a far parte della commissione lavoro e previdenza e della commissione operazioni di governo, presieduta dal senatore del Wisconsin Joseph R. McCarthy, il «grande inquisitore» delle attività antiamericane. Durante il macartismo, il suo comportamento è ambiguo; molti liberali del partito democratico non glielo perdoneranno mai.
Per John, quel periodo resterà una «macchia» sulla quale eviterà sempre e accuratamente di pronunciarsi. Intanto continua - tanto più ora che è senatore - a essere al centro dei pettegolezzi mondani; per i cronisti, sempre a caccia di «colpi» sensazionali, lo scapolo d'oro di Washington, con migliaia di donne che smaniano per lui, è un personaggio che fa notizia. È un re con una sterminata corte femminile; un senatore il cui ufficio assiste a un continuo, e nemmeno discreto, andirivieni di donnine delle più svariate estrazioni: c'è la ricca e la povera; l'ereditiera e la semplice dattilografa. Nemmeno le impiegate degli uffici senatoriali resistono al fascino di Jack e fanno a gara per esaudire i desideri di quell'impenitente dongiovanni.
Nella ricca messe di giornali e riviste che si occupano di lui, scegliamo il «Saturday Evening Post» del giugno 1953, che a milioni di copie, destinate soprattutto alle lettrici, dedica un lungo servizio a questo glamour boy, idolo delle feste - il senatore Kennedy, appunto - la cui foto di copertina, degna del più osannato divo di Hollywood, già assicura un successo di
Luigi Barbara 62 1985 - John Fitzgerald Kennedy
vendite eccezionale. Non si fa parola del misterioso matrimonio con Durie Malcolm.
Si dice che «il giovane e allegro scapolo del senato», a trentasei anni, è considerato il partito più ambito nella capitale. Le foto dell'articolo lo ritraggono al ballo offerto dalla duchessa di Windsor a New York, in compagnia di Maria Attolico, figlia dell'ambasciatore italiano.
Curiosamente, il giornale trascura la notizia più importante: il fidanzamento di John con Jacqueline Lee Bouvier, che lui chiama familiarmente Jackie. Benché sia stato proprio un giornalista, Charles Bartlett, corrispondente da Washington del «Chattanooga Times» a combinare il loro incontro.
«Ci eravamo conosciuti nel 1952 a casa degli amici Bartlett che da un anno cercavano spudoratamente di trovarmi marito», avrebbe confermato più tardi Jacqueline. A quel tempo, infatti, la bella Bouvier aveva appena visto sfumare il suo fidanzamento con John Husted, rampollo di una delle famiglie più aristocratiche d'America. Figlio di un banchiere, Husted aveva viaggiato moltissimo e fatto la guerra nel corpo scelto dei marines. La vigilia di Natale del 1951 aveva donato a Jacqueline un anello con brillante di tre carati e mezzo. Lei era scoppiata in lacrime di gioia. Era felice, e due o tre volte la settimana andava in aereo a New York per incontrare il suo innamorato. C'erano tutte le premesse perché la ragazza diventasse la signora Husted.
Il fidanzamento era stato annunciato ufficialmente il 21 gennaio 1952 e la data del matrimonio fissata per il successivo 14 giugno.
Già nelle cronache mondane dei giornali si preannunciava il «matrimonio dell'anno». Se tutto fosse andato liscio, nessuno avrebbe mai più poi sentito parlare di Jacqueline - Jacqueline Husted - e, molto probabilmente, parecchie tragedie le sarebbero state risparmiate. Ma, quasi all'improvviso, c'era stato invece da parte di Husted un raffreddamento: alla fine di aprile, Jacqueline non portava più al dito l'anello di fidanzamento e non parlava più di matrimonio.
In preda a una grave crisi depressiva, la giovane e orgogliosa Jackie per un po' se ne rimase chiusa in casa. Sfogandosi con le amiche, giurava che non avrebbe mai perdonato a Husted quell'avvilente voltafaccia (e qui fu di parola, perché dopo l'assassinio di Kennedy a Dallas, incontrato per caso l'ex fidanzato, non volle neanche porgergli la mano). Poi incominciò a reagire e riprese a vedere gente. Ed eccoci all'incontro con il senatore John
Luigi Barbara 63 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Fitzgerald Kennedy in casa del giornalista Charles Bartlett, la cui moglie aveva deciso di presentare alla depressa Jacqueline il giovane congressista che, diceva, «aveva davanti a sé una sfolgorante carriera». È un bel giorno di maggio del 1952. John rimane subito affascinato dalla voce flautata, dai serici capelli e dallo sguardo di quella ragazza di ventun anni, dalla «erre» francese e che ripete continuamente terrific (magnifico). A un certo punto, si sporge «sul piatto di asparagi» e le chiede un appuntamento.
Secondo la versione ufficiale, subito dopo il pranzo, Jacqueline offre a Jack un passaggio sulla sua Ford. Escono accompagnati dai Bartlett, ma, giunti che sono alla macchina, il cane degli amici si mette ad abbaiare furiosamente: nell'auto di Jackie c'è un uomo addormentato. Di fronte all'«intruso», Jack si sente rodere dalla gelosia.
Decide che quell'uomo è un intimo amico di Jacqueline, che l'aspetta per finire la serata in allegria, sibila un acre good-bye e volta le spalle alla ragazza, che resta lì, imbarazzata e delusa. Quell'uomo è sì un amico di Jackie.
Ma è solo passato di là per caso, ha riconosciuto l'auto della ragazza e vi è salito per farle una sorpresa.
Jackie, in ogni caso, ha fatto breccia nel cuore di John. Dapprima, i due non si vedono per sei mesi. Lei va in Europa per conto del «Washington Post» e Jack passa l'estate e parte dell'autunno nel Massachusetts a preparare la campagna elettorale. Quando tornano a Washington, lui trascorre metà di ogni settimana nel Massachusetts, da dove le telefona per invitarla «al cinema il mercoledì successivo a Washington». La gente non fa molto caso alla bella Jacqueline, che con il suo lavoro di fotoreporter al giornale guadagna sì e no una cinquantina di dollari, veste con semplicità - seppur studiata - e non fa sfoggio di pellicce o gioielli.
Anche i pochi intimi che sanno della corte serrata del senatore alla giovane fotografa, non pronosticano un matrimonio imminente.
C'è fra i due una differenza d'età di dodici anni: troppi, giudicano gli amici, perché quel legame abbia qualche probabilità di concludersi davanti a un altare. «È l'ennesima avventura di Jack», dicono.
«No, quell'incallito dongiovanni non resterà intrappolato neanche questa volta. E poi già si è messo di mezzo il "vecchio" Joe». Inevitabile che lo faccia. Le voci sul nuovo flirt di suo figlio sono giunte fino a lui: «Non saremo mica di fronte a un'altra Durie Malcolm?». E si incomincia a frugare nel passato della Bouvier, nella speranza - forse - di scovare
Luigi Barbara 64 1985 - John Fitzgerald Kennedy
qualche zona d'ombra e di mettere la parola «fine» anche a questa storia.Chi erano, in definitiva, i Bouvier? Secondo il dossier su di loro, i
genitori di Jacqueline appartenevano alle famose «quattrocento», ossia all'élite delle famiglie americane.
Suo padre, John Vernou Bouvier III, più noto come «Black Jack», aveva trentasei anni quando aveva incominciato a fare la corte a Janet Lee, terza figlia di James T. Lee. Uomo gioviale e di larghi mezzi, Bouvier III discendeva da un certo André Eustache Bouvier, che a venticinque anni aveva lasciato la natia Grenoble per seguire Lafayette nel nuovo mondo e combattere per la causa americana. Dopo la conclusione vittoriosa della guerra di indipendenza, André era ritornato in Francia; suo figlio Michel, invece, aveva seguito in America Giuseppe Bonaparte, stabilendosi infine a Borden Town, nel New Jersey, dove aveva sposato Louise Vernou, figlia di un aristocratico fuggito dalla Francia durante il «terrore», sul quale pendeva una taglia fissata nientemeno che da Robespierre.
Nelle vene di Jacqueline, dunque, scorreva sangue francese e aristocratico, mentre gli antenati di Kennedy erano gente che aveva camminato scalza e che era fuggita dall'Irlanda per fame.
Jacqueline aveva avuto un'infanzia felice. Suo padre e sua madre erano una coppia ammirata e invidiata. Tuttavia, quando aveva solo dieci anni, la bimba apprese che i genitori avrebbero divorziato. Restò con la madre; il padre, per il quale aveva una vera adorazione, da allora poté vederlo solo la domenica.
Le compagne di scuola ritenevano Jackie scostante e capricciosa, addirittura crudele. Non legava molto con la madre, che le preferiva Caroline, la minore. Così, appena ebbe l'età, fece in modo di frequentare come «interna» le più esclusive scuole private di New York.
Si distingueva nella pittura e in letteratura; a diciott'anni scriveva versi che i suoi professori giudicavano «sobri e suggestivi».
Nel frattempo sua madre si era risposata con Hugh Auchincloss, un avvocato e agente di cambio ricchissimo, che viveva in un castello della Virginia e aveva proprietà sparse un po' dovunque. Era già due volte divorziato e aveva tre figli (Yusha, Nina e Tommy), per i quali, a dire il vero, Jacqueline nutrì sempre scarsa simpatia.
Difficili, dunque, i rapporti della giovane Jacqueline con la madre, difficili con il patrigno, difficili, se non peggio, con i fratellastri (durante la campagna presidenziale di Kennedy, Nina, per farle dispetto, girerà con un
Luigi Barbara 65 1985 - John Fitzgerald Kennedy
cartello con su scritto a caratteri cubitali: «Votate Nixon. Dimenticate l'irlandese Kennedy»).
Con Auchincloss, che Jackie preferiva chiamare «zio Hugh», sua madre ebbe due figli: Janet e Jamie. Nemmeno per le nuove sorelline Jacqueline nutrì particolare affetto; le erano indifferenti, punto e basta. Si sentiva, invece, affettuosamente legata al drammaturgo Gore Vidal, che in seguito avrebbe spesso invitato alla Casa Bianca. (Tra di loro c'era una remotissima parentela: Gore era, infatti, figlio di primo letto di Nina Oldes Vidal, che aveva sposato in seconde nozze Hugh Auchincloss).
Dopo le scuole medie e le superiori, nel 1947, Jacqueline era entrata al Vassar College, il massimo per le ragazze ricche americane, e in quel periodo aveva fatto le sue prime comparse in società.
E dovette essere una «debuttante» deliziosa se, nel 1948, il celebre cronista mondano Cholly Knichkerbocker, alias Igor Cassini, scrisse di lei: «L'America è il paese delle tradizioni. Noi eleggiamo un presidente ogni quattro anni, ma scegliamo ogni anno una regina delle debuttanti. La nostra regina sarà dunque Jacqueline Bouvier, questa brunetta deliziosa che pare una statuetta di porcellana di Dresda».
Sentendosi a disagio tra i suoi, Jacqueline preferì, a un certo punto, recarsi in Francia, dove era stata ospite di una famiglia di Grenoble, la città dalla quale i suoi avi si erano mossi per cercare miglior fortuna nel nuovo mondo. Si era poi trasferita a Parigi, dove aveva seguito dei corsi alla Sorbona, frequentando, in pratica, le lezioni aperte a tutti gli stranieri che possedessero regolare passaporto e il denaro necessario per iscriversi, e migliorando, così, il suo francese. Aveva, nel frattempo, visitato più volte l'Italia e imparato anche l'italiano.
Tornata in patria, aveva lasciato il Vassar College e si era recata a studiare a Washington, senza, per altro, approdare mai alla laurea. Era una ragazza piena di iniziativa e, dopo la famosa (e frustrante) rottura con Husted, aveva deciso di rendersi indipendente. Aveva studiato giornalismo e optato per quella professione. Il posto gliel'aveva trovato suo padre, John V. Bouvier, che doveva di lì a poco morire. Jacqueline era scrupolosa e paziente. Si diceva, anzi, che avesse stazionato (e non inutilmente) per un giorno intero davanti alla Casa Bianca per fotografare i nipotini del presidente Eisenhower. (Ciò non toglie che, quando sarà «first lady», si lamenterà più d'una volta per l'invadenza dei giornalisti e dei fotografi, sempre pronti a bersagliare con i flashes i suoi bambini).
Luigi Barbara 66 1985 - John Fitzgerald Kennedy
I colleghi del giornale la consideravano un'eccentrica, una milionaria che «giocava a fare la giornalista», e non l'avevano in simpatia.
Ma, ostracismo o no, l'amore tra Jackie e John non conosce ostacoli. Nel giugno 1953 i due si fidanzano e il matrimonio viene fissato per il settembre successivo.
La cerimonia sarà celebrata a Newport, in chiesa, e la sposa avrà l'abito bianco con lo strascico, secondo le migliori tradizioni.
«Un giorno», racconterà Jacqueline, «mia madre invitò quella di Jack per il week-end, e io trovavo la situazione divertente. Jack aveva allora trentasei anni, era un uomo autorevole, un senatore, ma non aveva attribuito particolare importanza all'occasione e se ne stava lì, con una camiciola e un paio di zoccoli perché voleva andarsene in spiaggia con me a fare un bagno. Sua madre arrivò tutta in ghingheri; mia madre invece indossava un vestitino estivo; io qualcosa di meno alla buona, ma sempre roba di tutti i giorni. Ricordo che Rose Kennedy aveva un abito di seta azzurro chiaro e un grande cappello, e che rimase male nel vedere com'era "conciato" suo figlio. Quando andammo in macchina alla spiaggia, le due signore si sedettero davanti, mentre noi due dovemmo sistemarci dietro, come bambini cattivi».
Il 12 settembre, l'arcivescovo di Boston, Richard J. Cushing, celebra le nozze nella chiesa di Santa Maria a Newport. È un festoso convegno di ex compagni di scuola, d'università e d'armi di Jack. Ci sono Lem Billings, Torb MacDonald, Red Fay, Charles Bartlett e tanti altri: tutti in giacca a coda di rondine e calzoni a righe.
Il «clan» fa muro presso l'altare. Testimone dello sposo è un compassato e compresissimo Robert Kennedy. L'arcivescovo, dopo il fatidico «sì», legge la benedizione speciale mandata dal papa. In chiesa, tra invitati, notabili e personalità varie, ci sono ottocento persone; e tutte ammirano Jacqueline nel suo vestito di taffettà color avorio. Poi, via, al fastoso ricevimento nella tenuta della madre di Jacqueline sulla baia di Narragansett, dove gli invitati diventano milleduecento.
Le macchine fanno una «coda» lunga un chilometro e passano quasi due ore prima che tutti i presenti siano riusciti a salutare la coppia. «Non credo di esagerare se ti dico che Jackie si stancherà parecchio con tutti i sorrisi e le strette di mano che deve fare», sussurra dietro il ventaglio mamma Rose alla consuocera, «ma non penso che ci possa essere occasione migliore per introdurla nel nuovo genere di vita che l'aspetta come compagna e moglie
Luigi Barbara 67 1985 - John Fitzgerald Kennedy
di una personalità politica».Jack è raggiante, felice di essersi legato a quella ragazza dai grandi occhi
penetranti. E la sua gioia chiude la bocca a chi sino a un attimo prima pensava che lui non fosse pronto per il matrimonio.
Non è facile, per la giovane sposa, affiatarsi con i Kennedy, che sono un chiassoso reggimento tutto preso dalla politica. I suoi gusti sono lontani dai loro. Come può lei, che ama leggere Baudelaire e Wilde, sentirsi di casa a Hyannis Port, dove non c'è quasi nessuno che legga un libro e dove pare che, dopo la politica, esistano soltanto le partite di foot-ball, le corse in macchina o a cavallo lungo la spiaggia, e le nuotate?
Quando il «clan» si raduna attorno alla tavola per la cena, è ancora la politica che fa la parte del leone. Le discussioni sono sempre animatissime. E a Jackie e ai suoi genitori non resta che far circolo a parte, conversando in francese. Alla fine, la nuova signora Kennedy rifiuterà di partecipare quotidianamente ai pranzi serali in casa del suocero: «Una volta alla settimana è piacevole; tutte le sere no».
Il matrimonio e la consuetudine con Jacqueline sono, per molti aspetti, determinanti per il Kennedy politico. Contribuiscono a far maturare il suo carattere e a far emergere le sue doti. Dopo la vittoria su Cabot Lodge, egli ha confermato come proprio assistente amministrativo Ted Reardon e ha assunto come assistente per le ricerche e la corrispondenza Theodore C. Sorensen. Quest'ultimo diverrà, col passare degli anni, un collaboratore preziosissimo, del quale John giungerà a fidarsi ciecamente. E anche al sodalizio con Sorensen si deve il venir sempre più in luce delle qualità di statista di Kennedy (è di Sorensen, per altro, una biografia attenta e precisa, che racconta le tappe luminose della carriera di Jack, da senatore a presidente, sino alla tragedia di Dallas). Felice il 1953; terribile invece, per Jack, il 1954. I disturbi alla schiena si erano riacutizzati, costringendolo di nuovo a camminare con le stampelle. Era necessario ricorrere a un intervento chirurgico; diversamente sarebbe rimasto storpio per il resto della vita. L'operazione era tuttavia molto rischiosa. C'era, poi, l'insufficienza corticosurrenale di cui soffriva dal tempo in cui aveva contratto la malaria.
Circolavano, in proposito, velenose insinuazioni diffuse dagli avversari politici; si era giunti a dire che la perenne abbronzatura di Kennedy non era dovuta al sole di Cape Cod o della Florida, o ai raggi delle lampade al quarzo, bensì dal morbo di Addison (che in italiano si chiama anche «mal
Luigi Barbara 68 1985 - John Fitzgerald Kennedy
bronzino» per la colorazione che dà alla pelle), conseguenza, appunto, dell'insufficienza surrenale. Ciò non deve sorprendere se si pensa quanto, negli USA, la carriera di un uomo politico dipenda dal suo stato di salute.
John, per la verità, non desiderava falsificare le notizie sulle condizioni delle sue ghiandole surrenali, che certo non erano in ordine; s'inalberava però quando se ne divulgavano di imprecise. Una volta che un giornalista gli chiese a bruciapelo se il colorito abbronzato che manteneva tutto l'anno non fosse in realtà dovuto a quel male, arrivò (lui, di solito molto pudico) a replicare mostrandogli una parte della propria anatomia che non era stata rosolata dal sole.
Era, dunque, necessario «prendere il toro per le corna». Il 21 ottobre, ecco che Kennedy entra nel reparto chirurgia speciale del Manhattan's Hospital per sottoporsi all'operazione (doppia fusione di dischi spinali). Per poco, però, quell'intervento non causa la tragedia. Per due volte i medici mandano a chiamare i familiari, temendo per la vita del senatore, e per due volte gli viene somministrata l'estrema unzione. Ma come già in guerra, anche questa volta Jack vince la sua battaglia contro la morte. Quel primo intervento chirurgico non dà i risultati sperati; così nel febbraio 1955 ne segue un altro. E questa volta il decorso operatorio è felicissimo; il malato può ripartire, finalmente guarito, per una lunga convalescenza in Florida. Al suo fianco, sempre premurosa e sorridente, c'è Jacqueline. La giovane sposa resta per ore al capezzale del marito; gli rinnova la fasciatura - che deve essere cambiata più volte al giorno - sulla ferita, che continua a spurgare. Si mantiene calma e gentile; non si lamenta mai.
Da quei mesi di forzata immobilità per la malattia, nasce il secondo libro di Kennedy: quel Profiles in Courage che sarà tradotto in moltissime lingue e che nel 1957 otterrà il premio Pulitzer. L'opera è un saggio su otto esponenti politici che, nel corso della storia americana, avevano dimostrato un coraggio esemplare nella difesa di posizioni che li avrebbero resi impopolari presso l'elettorato. (Dei contemporanei, vien preso in considerazione il repubblicano Robert Taft che, benché possibile candidato alla presidenza del 1948, aveva espresso un'opinione decisamente negativa sul processo istruito per giudicare i nazisti accusati di crimini di guerra: «Su questo tribunale (Norimberga. N.d.R.) aleggia uno spirito di vendetta, e la vendetta raramente è sinonimo di giustizia. L'impiccagione degli undici uomini condannati costituirà una colpa nella storia americana di cui ci pentiremo a lungo»). Nel libro, Kennedy sostiene la tesi che l'elettorato
Luigi Barbara 69 1985 - John Fitzgerald Kennedy
americano non chiede semplicemente che i suoi rappresentanti al congresso si adoperino per gli interessi limitati e locali dei loro stessi elettori, ma desidera che essi siano uomini coraggiosi, che pongano gli interessi del paese al di sopra di qualsiasi cosa.
C'è subito chi dubita che il libro sia farina del sacco di Kennedy. Qualcuno, come il notissimo columnist Drew Pearson, dice chiaro e tondo in televisione che Profiles in Courage non è di Kennedy. E Jack parte al contrattacco. Nella stesura dell'opera si è valso dell'aiuto di Sorensen, che certo ci ha messo del proprio, ma Profiles in Courage è suo; suo e basta. Vuol ricorrere a vie legali. Ecco i testimoni in suo favore: le stenografe di Palm Beach, che hanno battuto a macchina il testo da lui dettato al magnetofono; il bibliotecario del congresso, che gli ha spedito circa duecento volumi e numerose raccolte di giornali; Theodore C. Sorensen, Jules Davids e James M. Landins, che l'hanno aiutato nelle ricerche. Alla fine, la rete televisiva che ha dato spazio alle bordate di Pearson si ritira in buon ordine, e altrettanto fa quest'ultimo. La polemica si spegne. L'ultima pietra sopra ce la butta Eleanor Roosevelt con il suo celebre: «Kennedy avrebbe dovuto mostrare meno profilo e più coraggio».
Luigi Barbara 70 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO IXLA «NUOVA FRONTIERA»
Dopo sette mesi di assenza (tanto erano durate la sua malattia e la convalescenza), il 23 maggio 1955 Kennedy rientrava al senato. Si sentiva in forma e voleva un ritorno esemplare. Rifiutò carrozzina e stampelle, e nel salire la gradinata del Campidoglio si mostrò disinvolto, nonostante il dolore che gli dava una gamba. La lunga convalescenza lo aveva fatto maturare; la sua mente era vivace e affilata come il rasoio di un barbiere. Prese posto come un leader fra i democratici del nord, occupandosi di ogni progetto importante all'ordine del giorno.
Al principio del 1956, Kennedy si batté per osteggiare il progetto di legge presentato dal senatore democratico-conservatore del Texas, Prince Daniel, e dal repubblicano del South Dakota, Karl Mundt, con il quale si intendeva modificare in senso proporzionale il sistema maggioritario. Kennedy condusse la battaglia contro quel progetto di legge quasi da solo e, infine, riuscì a impedire che fosse approvato. Era come se tutto facesse parte di un disegno prestabilito. Qualche anno più tardi, infatti, egli avrebbe beneficiato dei vantaggi assicurati dal vecchio sistema elettorale, conquistando la massima carica del paese e sconfiggendo l'amico-rivale Richard Nixon.
Il 1956 era anche anno di elezioni presidenziali. I democratici non sapevano bene chi opporre a Eisenhower, il candidato dei repubblicani che si ripresentava con la quasi sicurezza di vincere. Kennedy, come già nel 1952, dava il suo appoggio ad Adlai Stevenson, al quale avrebbe voluto assicurare, alla convenzione democratica che doveva svolgersi a Chicago alla metà di agosto, i voti del Massachusetts. Il comitato democratico del suo stato intendeva però presentare, almeno alla prima votazione, la candidatura di John McCormack, acerrimo rivale di Stevenson. Se non voleva perdere il prestigio acquisito con la vittoriosa battaglia sul criterio delle elezioni presidenziali appena condotta al senato e perdere la faccia di fronte a Stevenson, Kennedy doveva gettarsi in una zuffa interna di partito, prestandosi anche alle meschine manovre e alle volgarità che tale lotta comportava. Decise di farlo... anche sporcandosi le mani. Ricorrendo a intimidazioni, minacce ricattatorie e pressioni finanziarie e politiche su tutti i membri del comitato democratico del Massachusetts, riuscì, infine, a
Luigi Barbara 71 1985 - John Fitzgerald Kennedy
liquidare i due uomini che lo dominavano: William H. Burke e il re della carta stampata di Boston nonché editore del «Boston Post», John Fox.
Nel gennaio 1957 il senatore George, ormai avanti negli anni, lasciava il suo posto alla commissione senatoriale per gli affari esteri; Kennedy si sentiva adatto a sostituirlo, e si fece avanti. Durante i suoi viaggi di studio in tutto il mondo, aveva acquisito l'esperienza che gli avrebbe permesso di ricoprire degnamente quella carica. Per la verità, quel posto sarebbe spettato di diritto a Kefauver, che come senatore vantava un'anzianità di quattro anni superiore a quella di Kennedy; ma il comitato democratico, presieduto da Lyndon Johnson, designò Kennedy.
John incominciò subito col criticare la scelta del dipartimento di stato di nominare ambasciatori uomini il cui unico merito era quello di aver finanziato la campagna elettorale repubblicana e ai quali i paesi dove si sarebbero recati erano completamente estranei. Nel mese di luglio, la sua polemica con il segretario di stato John Foster Dulles si spostò sulla questione nordafricana. Ecco la risoluzione presentata dal senatore John Fitzgerald Kennedy:
«Dopo aver preso atto dello stato di guerra esistente in Algeria, della repressione che tale situazione comporta, delle legittime aspirazioni nazionalistiche, della crescente opera di contaminazione esercitata da tale situazione sui buoni rapporti fra i paesi dell'Africa settentrionale e le nazioni occidentali, dell'erosione sempre più ingente subita, in conseguenza di tutto ciò, dalle forze effettive della NATO e della preoccupazione internazionale destata in seno all'ONU, invito il congresso ad autorizzare il presidente degli Stati Uniti e il segretario di stato ad appoggiare gli sforzi intesi a ricercare, sia per mezzo dell'ONU, sia attraverso i buoni uffici del primo ministro tunisino e del sultano del Marocco, una soluzione che riconosca la personalità indipendente dell'Algeria e stabilisca le basi per un regolamento indipendente con la Francia e i paesi vicini».
La presa di posizione provocò un vero putiferio, sia negli Stati Uniti sia in Europa. Gli arabi residenti in America e le comunità nere del paese erano tutti per Kennedy, che divenne ancor più popolare. Il «New York Times» lodava il suo coraggio nel denunciare gli ultimi sussulti del colonialismo, di contro al segretario di stato che invitava seccamente il senatore del Massachusetts a pensare «all'Europa orientale invece che all'Algeria». Nei paesi baltici e in quelli dell'Europa orientale, sosteneva
Luigi Barbara 72 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Foster Dulles, si erano create situazioni ben più gravi e allarmanti che in Africa settentrionale! Irritatissimi e allarmatissimi anche gli ambienti politici francesi, che vedevano nel discorso di Kennedy un tentativo o una tendenza a internazionalizzare un problema considerato di carattere esclusivamente interno.
La vita a due con Jacqueline, frattanto, procedeva. Non senza ombre. Lei non si adattava facilmente a essere la moglie di un uomo politico tanto impegnato. Lui era capace, alle undici del mattino e con l'aria più naturale del mondo, di chiederle che cosa potesse preparare «per l'una alle quaranta persone» che aveva invitate. E Jackie con un sorriso e un sospiro si metteva all'opera; il pranzo veniva servito in orario e i convenuti non mancavano di complimentarsi con la «perfetta padrona di casa». Ma queste erano inezie se paragonate alla malattia di John, ai due aborti che Jacqueline aveva avuto nel volgere di pochi mesi e a certe profonde incomprensioni che incominciavano a venire a galla.
Jacqueline era incantata da tutto ciò che era cultura. Dall'arte, soprattutto. Che invece annoiava a morte Jack. Se a un pranzo la conversazione verteva sull'arte, lui si mostrava insofferente e, con una scusa, il più delle volte se ne andava. Era a suo agio fra molta gente, mentre la moglie preferiva piccoli gruppi di amici. Jack leggeva libri di storia americana; Jacqueline romanzi: ed erano quattro o cinque la settimana, di Collet, Kerouac... Spesso Jackie lamentava di essere trascurata: «Ero sola quasi ogni fine settimana, mentre John viaggiava per il paese a tenere discorsi». Lei, infine, si sentiva ferita dalle continue voci sulle «scappatelle» del marito. In casa Kennedy si parlò di divorzio. E quando i due - mentre papà Kennedy tentava, a modo suo, di ammansire l'irritatissima nuora coprendola di regali e staccando per lei addirittura un assegno da un milione di dollari - decisero di affrontare i loro problemi e di cercare una via d'intesa che servisse a dissipare le nuvole che s'erano addensate sul loro ménage, che era ormai vicino al terzo anniversario.
Si scambiarono promesse piene di buona volontà. Lui giurò che avrebbe smesso di sfarfallare. Jacqueline si disse disposta ad avvicinarsi di più agli interessi e alle esigenze del marito. Uscirono anche dalla stretta soffocante del «clan». E se capitava di andare in crociera con lo yacht di famiglia, Jacqueline, suo marito e i Radziwill se ne stavano a poppa, pasteggiando a oeufs en gelée e vino rosato; gli «altri» Kennedy a prua, «banchettando» con panini imbottiti.
Luigi Barbara 73 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Nei momenti di serenità, Jackie aiutava il marito traducendogli testi francesi e studiando i libri di storia che lui le consigliava. Sembrava che tutto si fosse avviato per il meglio e che il matrimonio avesse finalmente trovato il tono giusto. «Jack è molto più serio di quanto lo avessi giudicato prima di sposarlo», confidava Jacqueline sempre più spesso alle amiche. Poi, quasi d'improvviso, gli screzi e le incomprensioni tornarono ad affacciarsi. E con essi le chiacchiere sulle infedeltà di Jack e la crisi del suo matrimonio. Al punto che il «vecchio» Joe, preoccupato per i riflessi negativi che quelle indiscrezioni avrebbero potuto avere sulla carriera politica di Jack, decise di assumere un fotograto e di affidargli il compito di riprendere i momenti sereni di Jackie e di John. Piacesse o non piacesse alla nuora, il matrimonio di Jack doveva continuare ad apparire come una fiaba popolata da fate, un'eterna luna di miele.
Il 29 novembre 1957 nacque Caroline, la primogenita dei giovani Kennedy. La famigliola allora lasciò la Virginia e si stabilì a Georgetown, nella grande casa che sarebbe diventata il quieto rifugio sognato da Jacqueline. «La quale», dice MacGregor Burns, «la arredò e decorò in modo da riflettere più la propria personalità e i propri interessi che quelli di Jack: vecchie stampe francesi appese ai muri del salotto, libri d'arte sparsi sui tavoli, mobili raffinati, eleganti. Ma anche in questa tranquilla dimora Kennedy rimase un ciclone. Detestava perdere tempo; appena alzato, leggeva una rivista, facendo il bagno e nello stesso tempo radendosi...».
Nel solo 1957, Kennedy si spostò 150 volte in aereo, raggiungendo ogni parte del paese. I discorsi e le conferenze erano all'ordine del giorno. Parlava dappertutto e a gente d'ogni estrazione sociale: contadini, sindacalisti, giovani democratici, industriali, universitari. Valanghe di lettere che invitavano il senatore a tenere un discorso o anche a fare una chiacchierata alla buona, si abbattevano sulla scrivania del suo ufficio.
«Quando si vede un senatore che fa tanti discorsi fuori del suo stato, occorre fare due ipotesi», scrisse l'«Evening Post»: «O che abbia bisogno di denaro, o che miri a un incarico ben più alto». Di denaro, Kennedy ne aveva già parecchio.
La mattina del 28 ottobre 1959, un mercoledì, a Hyannis Port, nel Massachusetts, sedici persone si incontravano nella casa di Robert Kennedy per una riunione decisiva. Da tre anni, da quando Stevenson era stato battuto da Eisenhower, era in atto la lotta di Jack per la presidenza. Si
Luigi Barbara 74 1985 - John Fitzgerald Kennedy
presero importanti decisioni. Sorensen sarebbe diventato il responsabile delle politica nazionale e Bob avrebbe diretto la campagna elettorale. Gli altri due membri-chiave erano Kenneth O'Donnell, già capitano della squadra di foot-ball ad Harvard, e Lawrence O'Brien, l'esperto di politica di Springfield, nel Massachusetts.
Qualcuno sentenziò che quel gruppo di uomini avrebbe «rivoluzionato il corso della politica americana». Lord Longford, rifacendosi alla cronaca di quei giorni, scrisse: «Le tecniche pubblicitarie di Madison Avenue, la tecnologia del calcolatore, i sistemi scientifici per il sondaggio dell'opinione pubblica, la collaborazione di società specializzate in relazioni, lo sconcertante impatto della televisione, le tecniche di elaborazione dati, tutto ciò venne utilizzato da Kennedy in maniera nuova e con straordinaria efficacia». In quell'ottobre del 1959 si mise a punto un piano dettagliato per la vittoria alla convenzione del luglio dell'anno successivo.
All'inizio del 1960, cinque politici avevano la possibilità di divenire candidati del partito democratico: Kennedy, Hubert Humphrey, Stuart Symington, Lyndon Johnson e Adlai Stevenson. Si scelse come banco di prova il Wisconsin. Essendo di uno stato vicino, Humphrey e Kennedy stanziarono una cifra elevata per la campagna elettorale e il patriarca non batté ciglio quando gli fu recapitato il conto spese, veramente astronomico. Le sorelle e i fratelli del «clan» scesero una volta ancora sul sentiero di guerra, facendo una propaganda capillare in tutto lo stato. Ebbe a dire Humphrey: «Ero come un droghiere in concorrenza con una catena di grandi magazzini». Nonostante il massiccio impiego di mezzi i risultati non furono esaltanti. Infatti Kennedy aveva perduto nei quattro distretti a maggioranza protestante e si era imposto in quattro aree decisamente cattoliche. I grandi «boss» che tiravano le fila del gioco ebbero la sensazione che, ancora una volta, un cattolico non potesse aspirare alla presidenza.
Nel dicembre 1959, il londinese «Economist», uno dei giornali più autorevoli del Regno Unito, pubblicava una corrispondenza dagli Stati Uniti in cui si diceva: «Il senatore Kennedy è veramente un bell'uomo, ma dietro la sua maschera giovanile si cela una personalità assai complessa e involuta... Egotismo e sfrenato desiderio di successo sono le sue caratteristiche principali. Scaltro e freddo calcolatore, non è però ipocrita, anzi la schiettezza è forse il suo aspetto più simpatico... Le sue capacità
Luigi Barbara 75 1985 - John Fitzgerald Kennedy
intellettuali sono il maggior punto a suo vantaggio. È il più letto di tutti i candidati ed è molto abile nella scelta degli esperti che tiene sempre al suo fianco». James Reston, del «New York Times», sostenne la tesi che Kennedy si presentava al momento giusto, poiché le personalità degli altri concorrenti erano limitate e opache.
Alla vigilia della convenzione i sondaggi Gallup davano Kennedy favorito, sia a livello statale sia nazionale, e la sua posizione si rafforzava sempre più grazie ai continui viaggi sul suo aereo, ai discorsi, agli interventi al senato. Si tornò a parlare del gran denaro profuso da Kennedy per accaparrarsi consensi. L'inviato del «Baltimore Sun» arrivò a sostenere di avere assistito a una consegna di denaro da parte di un collaboratore di Jack in cambio di voti.
Poco prima della convenzione democratica, un affare internazionale guastò i rapporti già precari fra Stati Uniti e URSS. Il 1° maggio 1960, un aereo spia del tipo U-2 veniva abbattuto sugli Urali da un missile sovietico. Il pilota Francis Gary Powers, salvatosi col paracadute e fatto prigioniero dai russi, confessava di aver fatto un volo di ricognizione e scattato fotografie per conto del servizio segreto americano.
Il caso Powers si prestava a essere sfruttato dalla propaganda sovietica, che imbastì un vero e proprio processo internazionale. Kruscev scagliò feroci invettive contro Eisenhower, definendolo «ipocrita» e «bugiardo». L'affare dell'U-2 rappresentò un duro colpo per la politica di Eisenhower, che si era definito il «pellegrino della pace», e la Tass diramò dispacci con confessioni che di volta in volta gli 007 russi strappavano al pilota americano. Dal canto suo, la Casa Bianca mantenne, in quell'occasione, un atteggiamento ambiguo e arrivò infine alla ridicola dichiarazione di ignorare le missioni degli U-2. Eisenhower appariva reticente, mentre il suo interlocutore russo alzava sempre più la cresta, spalleggiato dai comunisti di tutto il mondo.
Intervistato da un giornalista, Kennedy fu impietoso col generale che aveva vinto la battaglia d'Europa e disse che al suo posto si sarebbe affrettato a chiedere scusa a Kruscev, promettendogli che incidenti del genere non si sarebbero verificati più. Lyndon Johnson rincarò la dose e con la vicenda dell'U-2, si ripiombò nel clima di aspra guerra fredda, dopo le timide schiarite che si erano registrate negli ultimi anni. Kruscev insistette per settimane sulla collusione fra Casa Bianca e servizi segreti a proposito degli aerei spia.
Luigi Barbara 76 1985 - John Fitzgerald Kennedy
L'11 luglio 1960 si aprì la convenzione democratica al Memorial Sports Arena di Los Angeles, uno stadio coperto della capienza di 22.400 posti. La convenzione comprendeva i 1.520 delegati e per ottenere la nomination occorreva la maggioranza assoluta, cioè la metà dei voti più uno: 761. Si scatenarono i giochi di potere e Kennedy si diede da fare per conquistare il quoziente necessario, sollecitando i consensi degli incerti e vincendo al primo scrutinio con 806 voti, cioè 45 in più dei 761 richiesti, davanti a Johnson (406), Symington (86) e Stevenson (79 e mezzo).
Subito dopo emerse un risultato inatteso. Lyndon Johnson non solo si sentì chiedere da Kennedy di presentarsi come suo candidato di lista per la vicepresidenza, ma accettò di farlo. Un collaboratore di Kennedy precisò: «Era scontato che avremmo offerto la nomina a Lyndon; quel che non avremmo mai dato per scontato era che lui accettasse».
In realtà Kennedy si era comportato da politico sagace e nuovamente aveva voluto dare ascolto ai consigli del padre. Il patriarca, che aveva buon fiuto, aveva esortato il figlio a offrire la vicepresidenza a Johnson per rimarginare le ferite che il suo scontro con il rivale aveva creato all'interno del partito e per evitare alle elezioni di novembre, quelle decisive, il risentimento del sud, dove era molto forte la resistenza contro un candidato presidenziale cattolico. Il binomio Kennedy-Johnson avrebbe costituito un valido argine all'ondata repubblicana che puntava su Nixon. È opportuno ora citare qualche passo del discorso pronunciato da Kennedy durante la cerimonia di accettazione. Il suo viso appariva stanco e teso per le fatiche di un anno di notti insonni; il tono della sua voce era vibrante e, al tempo stesso, venato di malinconia. «I tempi sono troppo difficili, la sfida troppo grave, la posta in gioco troppo alta per permettere che si scatenino le abituali passioni del dibattito politico. Non siamo qui per maledire le tenebre, ma per accendere la candela che ci guidi attraverso quelle tenebre a un avvenire sicuro e tranquillo. Come disse Winston Churchill nell'accettare l'incarico di primo ministro una ventina d'anni fa: se scateneremo un conflitto tra presente e passato rischieremo di perdere il futuro».
Seguiva quindi un periodo destinato a passare alla storia: «Ci troviamo oggi ai margini di una nuova frontiera, una frontiera degli anni Sessanta, una frontiera di ignote opportunità e pericoli, una frontiera di irrealizzate speranze e minacce. La nuova frontiera cui mi riferisco non è costituita da una serie di promesse, ma da una serie di impegni. Non esprime ciò che io
Luigi Barbara 77 1985 - John Fitzgerald Kennedy
voglio offrire agli americani, bensì ciò che io esigo da loro».Domandarono a Kruscev chi preferisse dei due candidati e il premier
moscovita rispose che conosceva bene Kennedy e che Nixon era un noto anticomunista. Entrambi, continuò Kruscev, erano, tuttavia, i rappresentanti del grande capitale e dei monopoli. E concluse: «Chi sia migliore è difficile comprendere. C'è un proverbio russo che dice: due stivali sono un paio, ma quale sia migliore, il destro o il sinistro, è difficile capire. Nixon è come Eisenhower e se diventerà presidente non sarà migliore di Eisenhower. Quanto a Kennedy mi astengo dal dire se sia migliore o peggiore. Ma ho visto il programma democratico e si differenzia poco da quello repubblicano, perché è ugualmente anticomunista». Dapprima, durante la campagna presidenziale, le azioni di Kennedy ebbero un'entusiasmante impennata, ma in agosto, per motivi illogici e mai chiariti, divennero quasi carta straccia. I sondaggi di opinione cominciarono a dare Nixon in testa e tra i sostenitori di Jack serpeggiò il pessimismo. Anche Kennedy era di cattivo umore e per di più si era compromesso la voce per un'infezione alla laringe. Le polemiche sulla sua fede religiosa si erano riaccese: i pastori battisti predicavano contro la Chiesa di Roma e invitavano l'elettorato a preferire il candidato repubblicano. Mediatrice della corsa alla Casa Bianca fu indubbiamente la televisione. Dieci anni prima, soltanto l'undici per cento delle famiglie americane possedeva un televisore. Nel 1960 la percentuale era salita all'88 per cento.
I dibattiti fra Kennedy e Nixon furono quattro: il 26 settembre, il 7, il 13 e il 21 ottobre. Le schermaglie televisive si risolsero in un trionfo per Kennedy. Scrisse un giornalista: «Nixon, reduce da una malattia, con aria incerta, apparve debole e indeciso. Kennedy, azzimato, in buona salute, parlò con vigore impressionando gli spettatori per la sua padronanza delle statistiche. In quelle sere Nixon perse buona parte del vantaggio che aveva». Si può dire che fu la televisione a decretare la vittoria di Jack.
Luigi Barbara 78 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XIL FATIDICO SBARCO ALLA «BAIA DEI PORCI»
Non fu solo la televisione ad attribuire il successo a Kennedy. La sera del 25 ottobre, consigliato dai suoi collaboratori, Kennedy compì un gesto destinato a procurargli molti voti dei neri, mai come in quell'elezione determinanti. Martin Luther King era stato arrestato e condannato a quattro mesi di lavori forzati da scontare nel penitenziario dello stato della Georgia. Kennedy chiamò al telefono la moglie di Martin Luther King, Coretta, e le promise il proprio interessamento. Bob, il fratello, si rivolse a sua volta al giudice della Georgia, sollecitando il rilascio del leader nero, il quale venne in effetti messo in libertà dietro cauzione in attesa del processo d'appello. Gli interventi dei Kennedy suscitarono l'entusiasmo in molte comunità nere. Il padre di King, pastore battista, che fino a quel momento aveva sostenuto Nixon, cambiò rotta. «Visto che quest'uomo ha cercato di asciugare le lacrime di mia nuora, io, che ho una valigia piena di voti, andrò dal signor Kennedy e gliela vuoterò in grembo». In tutto il Paese molti capi neri seguirono l'esempio di King.
Martedì 8 novembre 1960, il senatore e Jacqueline (che di lì a pochi giorni avrebbe dato alla luce un maschietto, John jr. o John-John) votarono a Boston, quindi si concessero un po' di riposo a Cape Cod, in casa loro e in quella di Bob. L'esito fu a lungo incerto e i dati elaborati dai calcolatori sembravano dare una maggioranza, pur ristretta, a Nixon. Verso le diciannove, Bob Kennedy, rivolto al fratello, commentò: «Ce le stanno suonando!». Jack era scuro in volto e rifiutò da quel momento di rispondere al telefono.
Verso le ventidue, Nixon e Kennedy parevano pressoché alla pari, ma il repubblicano poteva contare sui voti del Mid-West. Sorensen se ne stava muto e accigliato, sorseggiando un doppio whisky. Verso le 3 del mattino, l'esito finale dipendeva dai risultati di quattro stati: il Michigan, il Minnesota, l'Illinois e la California. Nel cuore della notte giunse la notizia che Nixon avrebbe fatto una dichiarazione al Paese. Per dirsi vincitore o sconfitto? Alle quattro meno venti del mattino, Jack salutò tutti e andò a dormire.
Kennedy si svegliò verso le nove e Sorensen lo informò che era il presidente degli Stati Uniti, il trentacinquesimo. La sua era stata una
Luigi Barbara 79 1985 - John Fitzgerald Kennedy
vittoria di strettissima misura, avendo ottenuto 34 milioni 221.463 voti popolari, con un margine di appena 112.463 voti su Nixon; in percentuale, il 49,7 contro il 49,6.
I membri del nuovo governo, non furono, per volere di Kennedy, particolarmente brillanti. C'era bisogno di uomini che sapessero far quadrare le cose e si uniformassero ai desideri del loro capo. Ecco qual era lo staff di Kennedy: O'Donnell, assistente per l'amministrazione; Pierre Salinger, capo ufficio stampa; Arthur Schlesinger jr., assistente per il programma politico. Hoover e Dulles furono riconfermati rispettivamente all'FBI e alla CIA. La scelta dei ministri fu lunga e difficile, e occorsero dieci settimane per formare il nuovo governo, ossia il tempo massimo concesso dal sistema americano.
Dopo estenuanti trattative, il presidente varò questa compagine: segretario alla difesa, Robert McNamara; segretario di stato, Douglas Dillon; ministro della giustizia, Bob Kennedy; segretario di stato, Dean Rusk; segretario al lavoro, Arthur Goldberg; segretario all'agricoltura, Orville Freeman; segretario al commercio, Luther Odges; alla sanità, istruzione e previdenza, Abraham Ribicoff (che si dimise quasi subito); agli interni, Stewart Udall; ministri delle poste, Day e Gronouski. Pierre Salinger, nel suo libro su Kennedy, scrisse: «Davvero un inverosimile miscuglio il gruppo dei collaboratori personali del presidente. Eravamo cattolici, israeliti e protestanti. Venivamo dalla costa orientale, dal Middle West e anche dal Far West; uscivamo da ambienti familiari modesti e facoltosi. Tra noi vi erano intellettuali idealisti, ma anche uomini politici di professione, e poi storici e giocatori di rugby... In comune avevamo lo stipendio, ventunmila dollari l'anno e l'assoluta fedeltà al presidente».
Il 30 gennaio, nel suo primo «messaggio sullo stato dell'Unione», Kennedy esponeva il suo dinamico programma. Era deciso a essere un presidente forte e attivo. La situazione all'interno non era delle più rosee: bisognava fronteggiare la recessione economica, il disavanzo nella bilancia dei pagamenti, la carenza nel settore degli alloggi, dell'istruzione e in quello sanitario, la segregazione razziale e gli squilibri nel settore della difesa. L'amministrazione Eisenhower aveva anche lasciato un intricato groviglio in politica estera, con pericolosi disordini nel Laos, in Congo e nell'America latina, per non parlare delle croniche difficoltà a Cuba e a Berlino. Il programma della «nuova frontiera» esortava gli americani a un'energica azione volta a stimolare la ripresa economica e auspicava il
Luigi Barbara 80 1985 - John Fitzgerald Kennedy
progresso in ogni campo.Relativamente all'estero, Kennedy sconfessava in gran parte le decisioni
prese in passato da Eisenhower, il quale fornì aiuti militari, tecnici e finanziari per sostenere stanche oligarchie o governi amici in imbarazzo. I primi atti ufficiali del nuovo presidente furono il varo del programma Food for Peace (cibo per la pace), che prevedeva l'invio delle eccedenze agricole a quei Paesi che più ne avevano bisogno.
Uno dei primi alleati da «guadagnare» alla causa della nuova presidenza era il generale De Gaulle, e Kennedy ci provò. Il 31 maggio, insieme con Jacqueline, sbarcò a Parigi, ricevendo l'entusiasta accoglienza di una folla strabocchevole. Il successo personale di Jacqueline sopravanzò quello ottenuto dal pur popolarissimo marito. Ed era cominciato subito, quando milioni di telespettatori la videro scendere dal Boeing 707, assieme a Jack, col suo cappottino azzurro e il cappellino posato sui capelli un po' ribelli.
Jacqueline aveva fatto colpo e lo ammise con molto spirito anche il marito, nella conferenza al circolo della stampa di Parigi, dove l'avevano invitato per fare il punto sulla situazione internazionale. Kennedy esordì dicendo: «Ritengo che non sia inutile presentarmi: io sono l'uomo che ha accompagnato Jacqueline Kennedy a Parigi».
I colloqui ufficiali fra De Gaulle e Kennedy si svolsero in un clima di viva cordialità, ma dal punto di vista politico non ottennero risultati concreti. Ci furono scambi di idee, manifestazioni di reciproca simpatia, ma i due statisti rimasero arroccati sulle loro posizioni. Da parte sua, De Gaulle brindò con insolito calore all'«intelligenza e al coraggio» di Kennedy, fu galante con Jacqueline e si disse fiero che essa fosse di origine francese, ma soprattutto si commosse per il dono recatogli dagli ospiti americani: una lettera originale della corrispondenza fra Washington e Lafayette.
Le vedute di De Gaulle e Kennedy rimasero, si è visto, contrastanti. I due uomini politici si trovarono d'accordo solo sulla ferma posizione da adottare di fronte alle minacce sovietiche su Berlino; ma sui problemi del Laos e specialmente della NATO il disaccordo fu palese, e di lì a pochi anni avrebbe condotta alla clamorosa ed inaspettata uscita della Francia dall'alleanza atlantica. Kennedy andò a riversare il suo disappunto sul premier britannico MacMillan e subito dopo si interessò attivamente alla situazione italiana, inviando a metà marzo Harriman a Roma per una serie di sondaggi politici e ricevendo a Washington il presidente del consiglio
Luigi Barbara 81 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Amintore Fanfani (il 13 giugno 1961), con il quale si dichiarò favorevole al primo governo di centrosinistra in Italia. Kennedy disse in privato a Fanfani che riteneva il centrosinistra una buona idea: gli americani avrebbero guardato con simpatia agli sviluppi dell'iniziativa.
Il 15 febbraio 1961, Kennedy, in una conferenza stampa, faceva il punto sulla crisi congolese. «Contro la minaccia di intervento unilaterale (dell'URSS) negli affari interni della repubblica del Congo, noi abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere la presenza dei caschi blu dell'ONU. Gli Stati Uniti considerano che la sola autorità legale che possa rappresentare il Congo, è un governo formato sotto la presidenza del capo dello stato, Kasavubu». La situazione peggiorò ulteriormente con l'assassinio di Patrice Lumumba, il quale, nel suo testamento spirituale, scriveva: «Noi siamo fieri, fin nell'intimo della nostra anima, di aver condotto una lotta che è stata di lacrime, di sangue e di fuoco, perché era una lotta nobile e giusta, necessaria per mettere fine all'umiliante schiavitù che ci era stata imposta con la forza».
Il groviglio di interessi nel Congo si faceva letteralmente inestricabile; contro il presidente «ufficiale» Kasavubu, installato a Léopoldville, agiva Antoine Gizenga, il successore di Lumumba, al quale i sovietici non facevano mancare massicci aiuti in armi e derrate alimentari.
A complicare maggiormente le cose, Moisè Ciombe, spalleggiato da paracadutisti belgi e mercenari bianchi, proclamò la secessione del Katanga. Una schiarita si sarebbe avuta soltanto due anni dopo, con il crollo del regime di Ciombe.
Intanto la Casa Bianca si trasformava in un'autentica reggia. Non era più un semplice ufficio amministrativo come ai tempi di Eisenhower. John Kennedy si volle dimostrare un illuminato «monarca», aprendo il suo mondo a un numero ristretto di uomini di corte. Jacqueline cambiò l'arredamento e persino le tappezzerie della più famosa dimora d'America e mamma Rose vi si installò praticamente in permanenza. Ricorderà nelle sue memorie: «Nei primi tempi, quando ero in visita alla Casa Bianca, alloggiavo nella "stanza della regina" e poi, solitamente, nella stanza di Lincoln. Con alcuni svantaggi, ambedue avevano pregi e interessi diversi. Nella "stanza della regina" c'è (o almeno c'era allora) un letto a baldacchino di chintz e taffettà; anche gli altri mobili e i drappeggi erano coperti di taffettà: il tutto con un'armonia di forme e di colori che rendeva l'ambiente gradevole e molto femminile. Per quel che ricordo, era stata
Luigi Barbara 82 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Jackie a volerla così. Nel soggiorno c'era anche un bel sofà che, in caso di bisogno, si poteva trasformare in letto per un bambino, o una bambinaia o un ospite inatteso». E Jacqueline e mamma Rose divennero vere esperte nel cosiddetto protocollo di quella singolare reggia, sorta come per incanto in un paese democratico, nel ventesimo secolo. Contemporaneamente alla crisi del Congo, un'altra se ne profilava nel sudest asiatico. Un senso di ansietà e di allarme per lo sviluppo dell'offensiva dei ribelli comunisti nel Laos dominava Washington, dove non si nascondeva che la crisi si stava avvicinando al momento decisivo della chiarificazione e si cominciava a parlare del pericolo imminente di una nuova Corea. Il Laos era (ed è) uno strano paese di forse due milioni di abitanti, incuneato tra il Vietnam e la Thailandia. A Luang Prapang risiedeva una famiglia reale, ma le tribù montanare, indenni dai nuovi fermenti, neppure si preoccupavano di sapere chi fossero i loro governanti. Erano bravi buddisti e amavano la contemplazione; la loro unica cura era di essere lasciati in pace a godersi la vita. Nella sua prima conferenza stampa, Kennedy espresse la speranza che il Laos «divenisse un paese pacifico e non dominato da nessuna delle due parti». I sovietici, da parte loro, soffiavano sul fuoco e appoggiavano apertamente i guerriglieri con sostanziosi aiuti militari. L'attività del presidente americano si fece frenetica: il problema Laos gli stava molto a cuore. Ricevette il ministro degli esteri dell'URSS Gromyko e gli strappò concessioni di grande rilievo. Infatti, il primo aprile, il Cremlino dichiarò in una nota ufficiale di accettare il principio della neutralizzazione del Laos e di essere pronto ad acconsentire a una cessazione del fuoco. Kennedy conseguì un grande successo politico e le sue azioni in patria salirono vertiginosamente. Negli Stati Uniti, la crisi del Laos diede molta materia ai giornali per sollecitare la supremazia americana nel mondo. Non era tempo di parole, ma di fatti. Il «Washington Post», commentando la presa di posizione di Kennedy, scriveva: «Finalmente Kennedy ha messo le carte in tavola. Una decisione del genere è divenuta opportuna, sia per preparare il paese alle eventuali misure da prendere, sia per dimostrare a Kruscev come il governo degli Stati Uniti intende fare sul serio e non limitare le sue proteste a espressioni verbali».
Il 12 aprile, una notizia scosse l'America e il mondo intero: il sovietico Yuri Gagarin aveva compiuto il primo volo orbitale intorno alla Terra. La formidabile impresa ebbe l'effetto di una bomba in America, poiché era testimonianza di un'inferiorità tecnologica che gli Stati Uniti dovevano a
Luigi Barbara 83 1985 - John Fitzgerald Kennedy
tutti i costi annullare. Nere nubi intanto si profilavano sull'orizzonte del nuovo presidente. Cuba aveva spazzato via il dittatore Batista, politico cinico e corrotto, che si era illuso di poter continuare a comandare e a uccidere nell'isola con il tacito appoggio degli Stati Uniti. Gli uomini di Fidel Castro, il nuovo leader cubano, si erano cementati nelle operazioni di guerriglia e costituivano ora una forza di primissimo ordine. I russi, cui non pareva vero di accendere un focolaio di rivolta proprio alle soglie dell'America, inviarono armi, munizioni e perfino aerei e missili terra-aria.
Già alla fine di novembre del 1960, prima della cerimonia dell'insediamento e nella confusione dell'interregno, Kennedy era stato informato di un piano della CIA che prevedeva lo sbarco di esuli cubani nella località della baia dei Porci. Il progetto prevedeva l'impiego di circa 800 uomini, mentre attacchi aerei in partenza dal Nicaragua avrebbero neutralizzato l'aviazione castrista. Le informazioni dal Guatemala parlavano di morale alle stelle della brigata degli esuli che, appena sbarcata, sarebbe stata pronta ad accogliere tra le sue file anche un numero molto elevato di disertori di Castro. Ma a dispetto delle relazioni entusiastiche che la CIA riceveva a Washington, nella brigata di invasione serpeggiava il malcontento, tanto che in gennaio scoppiò una rivolta e molti anticastristi abbandonarono il campo.
Falchi e colombe si diedero aspra battaglia. Fra le colombe figurava il senatore Fulbright, che partecipò alla riunione decisiva del 4 aprile, che si tenne al dipartimento di stato in una saletta posta accanto all'ufficio di Dean Rusk. Fulbright pronunciò un discorso coraggioso, senza peli sulla lingua, sollecitando nei confronti di Cuba una semplice azione di arginamento. Kennedy chiese il parere a tutti gli intervenuti. Schlesinger ricordò: «McNamara si disse favorevole all'operazione. Secondo Berle, l'importante era che la brigata cubana sbarcasse a Cuba ma non insistette sulla necessità di un'operazione su vasta scala... Ancora una volta Kennedy volle conoscere le possibilità di effettuare un'infiltrazione che facesse poco scalpore, abbandonando l'idea di uno sbarco. La discussione si fece generale prima che fosse completato il giro della tavola e presto la riunione si sciolse». Mentre ministri e dignitari se ne andavano, il presidente richiamò presso di sé Schlesinger e gli domandò la sua opinione. Schlesinger rispose che era contrario a quello sbarco. Comunque, sabato mattina, Kennedy aveva preso la sua decisione. Lo sbarco si sarebbe fatto, così come volevano gli agenti della CIA. A pochi giorni dal via
Luigi Barbara 84 1985 - John Fitzgerald Kennedy
dell'operazione, Robert Kennedy diede una festa per il compleanno di sua moglie Ethel, un ricevimento rumoroso, con un gran numero di invitati, di bambini e di cani. Nel pieno dell'allegria, il padrone di casa prese in disparte Schlesinger dicendogli: «Ho sentito che non sei entusiasta della cosa. Torto o ragione che tu abbia, il presidente ha deciso. Non insistere più su questo punto. È tempo che ognuno faccia tutto quello che può per aiutarlo». Il 10 aprile, i cubani furono trasferiti con camion dalla base in Guatemala al punto di imbarco di Puerto Cabezas, in Nicaragua. Il 13 aprile, gli uomini cominciarono a imbarcarsi e il giorno dopo gli americani rivelarono infine il piano di invasione, che consisteva nell'impadronirsi di tre punti lungo sessanta chilometri di costa nella zona della baia dei Porci con simultanei lanci di paracadutisti all'interno col compito di controllare le strade che, attraverso gli acquitrini, conducevano sino al mare. Gli istruttori dissero (e ne erano colpevolmente convinti) che l'aviazione di Castro sarebbe stata messa fuori combattimento in precedenza. Mentre le sette navi con gli esuli avrebbero salpato per Cuba, secondo il piano, otto aerei B-26, camuffati, dovevano attaccare i tre aeroporti di Castro. Secondo la CIA, l'aviazione castrista era composta da una quindicina di B-26 e una decina di Sea-Furies, ma i cosiddetti esperti ignoravano la presenza di quattro aviogetti T-33, che dovevano rivelarsi decisivi nel culmine della battaglia. Nella zona dello sbarco, inoltre, era segnalata l'attività di cinquecento guerriglieri che si tenevano nelle vicinanze, pronti a intervenire. La faciloneria dei responsabili oggi sbalordisce, ma, nell'aprile 1961, può ben dirsi che contagiò un po' tutti, dal presidente al più umile funzionario. Secondo i rapporti che quotidianamente giungevano a Washington, il regime di Castro aveva ormai le ore contate e dall'America sarebbe stato asportato il «bubbone comunista». Il pomeriggio del 14 aprile, mentre le sette navi degli esuli erano alla fonda a Puerto Cabezas, sulla banchina, scortato dalle guardie del corpo, arrivò Luis Somoza, il dittatore del Nicaragua, il quale gridò baldanzoso: «Portatemi due peli della barba di Castro!». Poi le navi salparono verso un incerto destino.
All'alba di lunedì 17 aprile, la brigata di esuli cubani effettuò uno sbarco nell'isola, si batté con coraggio e abilità finché ebbe munizioni, infliggendo pesanti perdite alle forze castriste. Castro, svegliato nel sonno, andò immediatamente alla stazione radio dell'Avana per dare il drammatico annuncio al Paese e al mondo: «Reparti di truppa, sbarcati per via mare e
Luigi Barbara 85 1985 - John Fitzgerald Kennedy
per via aerea, si accingono ad attaccare diversi punti del territorio nazionale nella parte meridionale della provincia di Las Villas, appoggiati da aerei e da navi da guerra. I gloriosi soldati dell'esercito rivoluzionario e della polizia nazionale combattono contro il nemico in tutti i punti dove questo è sbarcato, per difendere la patria sacra e la rivoluzione contro un attacco di mercenari, organizzati dal governo imperialista degli Stati Uniti». All'Avana, intanto, la polizia castrista arrestò duecentomila persone. La prima notte seguita allo sbarco, Jacqueline fu quasi sempre vicina al marito, che dormicchiò soltanto un paio d'ore. I responsabili della CIA e i capi di stato maggiore, mentre si susseguivano le notizie pessimistiche, scongiurarono Kennedy di revocare l'impegno preso pubblicamente e di far entrare in azione i mezzi aerei e navali, apertamente. Ma il presidente non volle recedere. Via radio si comunicò a Washington che i carri armati di Castro avevano raggiunto la testa di ponte prima del previsto. Per di più non si era verificata alcuna sommossa a Cuba e anzi nelle città si erano svolti numerosi cortei inneggianti al «compagno Fidel» e di aspra rampogna all'imperialismo statunitense.
Nonostante le cattive notizie, Kennedy si mantenne sereno e calmo; si lamentò solo di avere dato troppo ascolto a Dulles. «Probabilmente ho sbagliato a tenere Dulles. È certamente un uomo di grandi capacità, ma non ho mai lavorato con lui e non so fare esattamente la tara delle cose che dice». In quella notte insonne, il presidente si rimproverò di non aver messo il fratello Robert alla CIA, invece di affidargli il dicastero della giustizia. Aggiunse: «Il posto di Bobby è alla CIA. È uno schifoso sistema per fare esperienza, ma in tutta questa storia una cosa l'ho imparata, che dovremmo occuparci della CIA perché finora nessuno l'ha fatto».
A Washington la febbre era salita alle stelle. Alla Casa Bianca, la sera dopo lo sbarco, doveva svolgersi l'annuale ricevimento in onore dei membri del congresso e Kennedy, benché sconvolto dalla piega degli avvenimenti, si presentò sereno.
Anche Jacqueline doveva subire un contraccolpo negativo a causa della tormentata vicenda della baia dei Porci. A una manifestazione di protesta a New York, il 21 aprile, una poetessa intervenne portando un cartello con la scritta: «Jacqueline, hai perduto i tuoi artisti!». Per Jackie quello fu un colpo durissimo, perché si era sempre dichiarata amica e protettrice degli artisti, frequentando le gallerie e comperando dipinti per far quadrare i «bilanci» dei suoi amici. Ora quell'operazione a Cuba le sottraeva un gran
Luigi Barbara 86 1985 - John Fitzgerald Kennedy
numero di simpatie.Per salvare il salvabile e cercare di calmare gli esuli inviperiti, Kennedy
mandò a Miami Schlesinger e Adolf Berle, il cui viaggio fu circondato dal massimo segreto. Arrivati in Florida, i due inviati del presidente dovettero salire su un'auto blindata, che si fermò dopo qualche chilometro affinché prendessero posto su un'altra macchina. La trasferta ebbe come meta la base aerea di Opa-Locka, dove in una casa di legno, ai margini del campo, si radunarono a discutere i due plenipotenziari di Kennedy, Ray, Justo Cardilo, Carlos Hevia, Mirò Cardona e Antonio Maceo, che avevano un figlio alla baia dei Porci, e Tony Varona, che vi aveva un figlio, due fratelli e due nipoti.
Schlesinger e Berle non trovarono argomenti per replicare alle sacrosante aspettative degli esuli. Erano pesci fuor d'acqua e non sapevano a che santo votarsi. Alla fine si convinsero che solo il presidente Kennedy, con la sua autorità, avrebbe potuto uscire vittoriosamente da quel vicolo cieco. Così, dopo una telefonata alla Casa Bianca, fu deciso di trasferire i membri del consiglio rivoluzionario a Washington. Da Kennedy finalmente!
Il presidente era molto abbattuto, ma sempre sicuro di sé. Schlesinger fece una relazione sulla situazione a Opa-Locka e riferì che i membri del consiglio erano là praticamente agli arresti e che alcuni di loro, profondamente amareggiati, avevano in animo di muovere una pubblica denuncia. Kennedy, più che mai sorpreso, disse che dalla CIA non aveva saputo nulla di tutto questo. «Fatemi riflettere un quarto d'ora, poi fate entrare pure i cubani». Quel quarto d'ora, in realtà, il presidente lo passò accanto a Jacqueline e alla figlioletta Caroline. Dopo quella parentesi dedicata agli affetti familiari, tornò agli affari del giorno e ricevette i cubani. I quali si accomodarono su due divani davanti al caminetto, mentre il presidente rimase seduto sulla sedia a dondolo, che era il suo posto preferito.
Il colloquio fu introdotto da un rapporto preciso e scarno del comandante Tazewell Shepard, aiutante militare, che sintetizzò la situazione venutasi a creare a Cuba dopo lo sbarco alla baia dei Porci. Quindi prese la parola Kennedy, che, lentamente, quasi soppesando il suo dire, espresse il suo profondo rammarico per gli avvenimenti delle ultime quarantotto ore. Egli spiegò il perché del suo rifiuto a un diretto intervento americano e perché considerava l'operazione in corso esclusivamente di
Luigi Barbara 87 1985 - John Fitzgerald Kennedy
pertinenza delle forze cubane. D'altra parte, si giustificò, i rapporti provenienti dal Nicaragua davano non soltanto la speranza, ma anche la certezza che le truppe degli esuli erano state ottimamente addestrate ed erano capaci da sole di abbattere il regime di Castro.
Kennedy, senza mezzi termini, ridiede fiducia ai membri del consiglio, dando loro la più vasta autonomia, come se fossero cittadini americani, ospiti graditi di un grande Paese. Dopo una breve pausa, il presidente tornò a parlare con i cubani, assicurando loro che sarebbe stato fatto l'impossibile per evacuare i resti del contingente sbarcato alla baia dei Porci. Cacciatorpediniere americane, disse, perlustrano la costa antistante lo sbarco e possono contare sull'appoggio dell'aviazione. «Ho dato ordine alle nostre navi e ai nostri aerei», annunciò, «di rispondere al fuoco se attaccati».
I cubani lasciarono la Casa Bianca terrei in viso e con la sicurezza di essere stati traditi da un governo che non vedeva l'ora di sbarazzarsi di loro. Varona mormorò: «È un'infamia. Noi non dimenticheremo mai».
Ma Kennedy era stato sincero. Era profondamente addolorato per la piega presa dagli eventi e il pensiero di tanti patrioti uccisi o imprigionati lo ossessionò per parecchi mesi.
Il 20 aprile, giovedì, era il novantesimo giorno dell'amministrazione Kennedy. Passata l'ora dell'euforia, era subentrata la delusione. Picchetti di dimostranti manifestavano davanti alla Casa Bianca e gli echi degli slogan arrivarono fino alle orecchie del presidente, il quale si gettò anima e corpo a risalire la china.
È qui il caso di riportare un brano di Schlesinger: «Il primo problema al quale Kennedy fu posto di fronte fu quello di contenere le conseguenze politiche della disfatta. Egli si mosse con istinto sicuro e con notevole destrezza, mostrando di possedere, come già vent'anni prima alle Salomone, la forza di accettare la cattiva sorte, di lasciare da parte le recriminazioni e di darsi da fare per riguadagnare le posizioni perdute».
La fallita missione contro Castro, pare incredibile, aumentò la popolarità di Kennedy negli Stati Uniti e sembrò certo che, se il presidente avesse rischiato di più, gli americani lo avrebbero amato maggiormente.
Quando gli mostrarono i primi risultati del nuovo sondaggio Gallup, Kennedy non nascose un sorriso compiaciuto. Esclamò: «Mi è favorevole l'82 per cento della popolazione. Dicono che sia un limite mai raggiunto prima. Mi capita proprio come a Eisenhower: peggio faccio, più popolare
Luigi Barbara 88 1985 - John Fitzgerald Kennedy
divento».Dopo questa battuta scherzosa, il presidente rivelò ai suoi collaboratori
la decisione di creare una commissione incaricata di indagare le ragioni del fallimento dello sbarco alla baia dei Porci. Kennedy capiva che era giunto il momento di drastici cambiamenti.
Luigi Barbara 89 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XI
E IL PAPA IMPLORÒ «PACE, PACE...»
I cambiamenti ci furono. Kennedy scelse Maxwell come suo consigliere personale per le questioni militari; poi, quando si sentì abbastanza forte, lo nominò capo di stato maggiore. E per fortuna del presidente, il 23 aprile l'attenzione del mondo fu distolta dalla baia dei Porci dalla clamorosa rivolta dei generali francesi Challe, Jouhaud, Zeiler e Salan, che fecero occupare Algeri e Orano dai paràa. La questione africana francese calamitò l'interesse di tutti i circoli politici internazionali e la questione cubana passò in seconda linea. Kennedy respirò, mentre si preannunciava per lui un calendario fitto di gravosi e prestigiosi impegni.
Il 12 maggio arrivò un inatteso ma gradito messaggio di Kruscev che accettava la proposta di un incontro a Vienna per i primi di giugno. Kruscev, sebbene ben fermo a proposito degli avvenimenti cubani, era dell'opinione che fosse necessario riaprire il dialogo per migliorare i rapporti tra est e ovest. Tre erano gli obiettivi del premier russo: la crisi del Laos, l'accordo sul disarmo e la questione tedesca. Kruscev si riprometteva una facile vittoria di prestigio sul contendente americano, che, specie dopo i fatti della baia dei Porci, considerava un giovanotto sprovveduto, incapace di prendere decisioni drastiche sul tipo di quella da lui presa in Ungheria.
Kennedy, che non sottovalutava il suo avversario, per capirne meglio il carattere e la natura si rivolse a un gruppo di psichiatri e psicologi che elaborarono per lui un rapporto completo sulla psicologia del premier russo. La rivelazione fu fatta sette anni dopo dal dottor Bryant Wedge, che dirigeva l'istituto per lo studio del comportamento nazionale nell'università di Princeton, nel Massachusetts. Wedge riferì che nel 1961, su invito della CIA, si svolse un congresso segreto di 20 psichiatri avente un tema preciso: chi è Nikita Kruscev. Kennedy lesse con profonda attenzione il rapporto degli psichiatri e lo imparò a memoria quando si preparò a partire per Vienna per incontrare Kruscev.
Il 3 giugno avvenne lo storico incontro. Alle 12,45 una grande auto nera a quattro porte si fermò davanti alla scalinata dell'ambasciata americana di Vienna. Kruscev ne scese e fece un paio di brevi passi con le sue gambe corte. Kennedy, finalmente viso a viso con il suo avversario, uscì dalla hall
Luigi Barbara 90 1985 - John Fitzgerald Kennedy
e si fermò in cima ai pochi gradini. Sorrise e tese la mano a Kruscev chiedendogli: «Come sta? Sono lieto di vederla!».
La schermaglia fra i due statisti continuò durante tutti i colloqui. Kennedy accusò i russi di volere soffocare i regimi democratici, ma Kruscev controbatté che l'URSS non aveva alcuna intenzione di imporre il suo punto di vista ad altri Paesi e aggiunse che il comunismo avrebbe trionfato, così com'era accaduto al capitalismo quando subentrò al feudalesimo. Il leader sovietico dichiarò: «È inevitabile che i sistemi sociali mutino; ma ciò avverrà soltanto per la volontà dei popoli». Kennedy replicò che i popoli devono avere libertà di scelta e disse: «Quando minoranze comuniste s'impadroniscono del potere in aperto contrasto con la volontà popolare, lei lo considera un'inevitabilità storica; noi no, ed è questo che mette in conflitto le nostre due nazioni».
La crisi arrivò, come previsto, su Berlino, la città spezzata in due che rappresentava, e tuttora rappresenta, il punto focale del conflitto est-ovest. Kruscev, dopo una fitta serie di schermaglie, annunciò quella che definì una decisione irrevocabile: l'Unione Sovietica avrebbe firmato a dicembre un trattato di pace in base al quale l'intera Berlino sarebbe stata incorporata nel territorio della Germania orientale. Se le truppe alleate di occupazione non si fossero ritirate, sarebbero state ricacciate da Berlino. In una parola, si minacciava la guerra.
L'argomento spazio e Luna trovò Kruscev battagliero e chiuso come un riccio: se gli Stati Uniti avevano in animo di mandare un uomo sulla Luna, avanti, padronissimi, ci andassero da soli. Senza il disarmo, continuò, non è possibile collaborare in questo settore, perché gli stessi razzi usati a scopi scientifici vengono impiegati anche a scopi militari.
Un'altra porta si chiudeva in faccia al presidente Kennedy, il quale volle, in extremis, giocare la sua ultima carta. Chiese a Kruscev di parlare con lui a quattr'occhi, presenti soltanto i rispettivi interpreti. Così racconta Schlesinger: «Confido - esordì Kennedy - che nell'interesse dei rapporti tra i nostri due Paesi lei non vorrà mai pormi di fronte a una situazione che metta a repentaglio la sicurezza nazionale americana, com'è la situazione di Berlino. Quanto alla Repubblica democratica tedesca, naturalmente lei è libero di fare ciò che vuole. Dappertutto nel mondo avvengono mutamenti e nessuno può dire come si risolveranno. In un momento come questo non si possono prendere decisioni alla leggera». Kruscev si dimostrò inamovibile. Ripeté per l'ennesima volta: «Io voglio la pace, ma se lei
Luigi Barbara 91 1985 - John Fitzgerald Kennedy
vuole la guerra è affar suo». Anni più tardi, nelle sue memorie, l'uomo del Cremlino dimostrò simpatia e comprensione per il suo antagonista di Vienna. Ecco un brano dei suoi ricordi: «Diversamente da Eisenhower, Kennedy aveva un'opinione precisamente formulata su ogni problema. Anche se non giungemmo a nessun concreto accordo, mi accorsi che egli era interessato a trovare una pacifica soluzione ai problemi del mondo e a evitare conflitti con l'Unione Sovietica. Era un uomo ragionevole e penso sapesse che non c'era alcun motivo di iniziare una guerra sul problema di Berlino». Il 21 dicembre, alle Bermude, Kennedy doveva incontrarsi con il premier britannico MacMillan, ma due giorni prima ricevette un durissimo colpo: il grave, improvviso malore del padre, il «lupo solitario» di Wall Street che aveva creato dal nulla la fortuna della famiglia. Jack era stato a trovare il padre a Palm Beach e il vecchio l'accompagnò all'aeroporto perché in serata doveva essere a Washington. «Jack, torna presto a trovarmi. Sai, divento vecchio e la fine per me è sempre in agguato. Oggi sono qui, e domani...». Pareva avesse un presentimento. Joe tornò a casa con Caroline e giocò mezz'ora con i nipotini riuniti a Palm Beach per il Natale. Poi andò al vicino campo di golf e fece nove buche con la nipote preferita Ann Gargan, lamentandosi di sentirsi un po' fiacco. Mormorò: «È questo maledetto raffreddore. Nulla di serio, ma intanto...».
Stava maturando la tragedia. Arrivato alla sedicesima piazzuola, dovette sedersi. «Sto molto male, non capisco che mi succede. Non ce la faccio a continuare...». Fu riportato a casa in auto dalla nipote Ann, che chiamò immediatamente il medico, sebbene il vecchio non ne volesse sapere. Da quel preciso momento ebbe inizio la fine del «lupo solitario».
Sul problema di Berlino, Kennedy fu di un tempismo eccezionale. Il 20 agosto aveva dato il via a una colonna motorizzata sull'autostrada che conduce a Berlino, soltanto per rivendicare un diritto: e mai come in quel momento l'Europa fu sull'orlo del disastro. Tuttavia, da un punto di vista operativo, quella mossa rappresentò un successo strepitoso. Kruscev commentò che l'America giocava con il fuoco e che l'URSS se ne infischiava di queste sfide di prestigio perché amava soprattutto la pace. E aggiunse: «Kennedy farà bene in avvenire a misurare le sue mosse e a non mostrarsi isterico perché i russi sono pronti a prendere le inevitabili contromisure». Kennedy reagì con una pubblica dichiarazione: «Ho chiaramente detto al signor Kruscev che la sicurezza dell'Europa occidentale, e pertanto la nostra stessa sicurezza, è legata alla nostra
Luigi Barbara 92 1985 - John Fitzgerald Kennedy
presenza e ai nostri diritti di accesso a Berlino ovest; che tali diritti sono basati sulla legalità e siamo decisi a mantenerli».
La strategia della tensione subì un'impressionante escalation. Il 30 agosto i russi riprendevano gli esperimenti nucleari sotterranei. La moratoria atomica era rotta. Ma Kennedy diede un'altra prova di buona volontà. Parlando con James Wechsler del «New York Post», asserì che solamente dei pazzi (e sottolineò «pazzi») potevano sperare di vincere una guerra atomica. Aggiunse però che non disperava di poter giungere a un punto in cui sia l'URSS sia gli Stati Uniti avrebbero accettato l'idea che l'unica scelta era quella fra il negoziato sincero o il reciproco annientamento. Egli, tuttavia, per non restare indietro rispetto ai russi, decretò la ripresa degli esperimenti nucleari. Bob Kennedy confidò in seguito: «Avemmo l'impressione che la guerra fosse molto probabile in quel momento».
Quando ormai si temeva il peggio, i sovietici, misteriosi come sempre, si mostrarono disposti a un compromesso. Il ministro degli esteri sovietico Gromyko, durante i suoi colloqui con Dean Rusk, lasciò capire che il suo Paese desiderava discutere piuttosto che ricorrere, almeno per il momento, alla forza. Era un segnale positivo dopo mesi di autentica angoscia, e pertanto gli americani ricavarono l'impressione che la grave tensione per Berlino stesse per allentarsi.
In un discorso pronunciato all'assemblea generale delle Nazioni Unite, il 23 settembre 1961, Kennedy ribadì che gli Stati Uniti e i loro alleati intendevano mantenere gli impegni presi verso Berlino e affermò che il disarmo era ormai una questione «di vita o di morte». Egli sollecitò l'Unione Sovietica a partecipare «non a una corsa agli armamenti, ma a una corsa verso la pace». Il rischio era gravissimo. E fatto è che, in quell'estate 1961, si arrivò a un passo dalla guerra. Schlesinger, che era nella stanza dei bottoni e viveva quell'atmosfera da incubo, scriveva a un amico: «Dall'estate del 1939 mai mi sono sentito così pessimista sulla situazione internazionale».
Per buona ventura le due parti in causa decisero di dare il via a seri negoziati. Per la pace nel mondo la Germania doveva rimanere spaccata in due, secondo le posizioni raggiunte dalle armate alleate e sovietiche nell'aprile del 1945. Dichiarò Kennedy: «È stato Hitler a volere questa assurda scissione. Se solo avesse dato via libera agli alleati, anziché resistere come un ossesso, oggi non saremmo qui a dover sciogliere un
Luigi Barbara 93 1985 - John Fitzgerald Kennedy
nodo inestricabile. Tuttavia non bisogna dimenticare lo scoramento che la costruzione del muro ha prodotto nella Germania occidentale e non bisogna acuirlo legittimando il regime di Pankow e stimolando il riaffiorare di sentimenti nazionalistici nella Germania di Bonn. È necessario che l'URSS mantenga la Germania divisa com'è ora».
La crisi di Berlino pareva superata quando il 17 ottobre 1961, Kruscev, parlando al XXII Congresso del PCUS, annunciò che «le potenze occidentali hanno mostrato una certa volontà di accordo e sono disposte a ricercare una soluzione della questione tedesca e del problema di Berlino ovest. Così noi non insisteremo per la firma di un trattato di pace prima del 31 dicembre 1961». È il caso di dire che il mondo intero tirò un sospiro di sollievo. La tensione est-ovest si allentò, al punto che Kruscev inviò negli Stati Uniti il genero Adjubei, direttore delle «Izvestija», a intervistare il presidente americano. Così Pierre Salinger, nel suo Con Kennedy, descrisse le fasi di quella memorabile intervista: «Uomo di incredibile vanità, Adjubei anteponeva a ogni domanda un'apologia propagandistica del punto di vista sovietico prima di invitare il presidente a esprimere la sua opinione in proposito... John Kennedy, spazientito, già fin dalle prime battute dell'intervista lo accusò di essere al tempo stesso un giornalista e un uomo politico. Adjubei ne fu sconcertato solo fugacemente. "Nel nostro Paese", dichiarò, "ogni cittadino è anche un uomo politico, in quanto noi amiamo moltissimo il nostro Paese. Ai giovani così come ai vecchi è caro il sistema socialista da cui viene governato il nostro Paese e di conseguenza siamo disposti a combattere per esso fino alla vittoriosa conclusione"».
Subito dopo, Kennedy architettò una mossa propagandistica invitando il fratello Robert, che occupava il dicastero della giustizia nella sua amministrazione, a recarsi a Berlino ovest. Bob con la moglie Ethel arrivò a Berlino con un tempo da lupi: freddo, vento e neve. Mentre scendeva dall'aereo, una banda intonò un inno marziale; ad attenderlo ai piedi della scaletta erano Brandt, Clay e Allan Lightner, il console americano. Migliaia di persone sfidarono il gelo per assieparsi lungo le strade a dare il benvenuto al fratello del presidente Kennedy. Agitavano bandierine statunitensi, gridavano, alcuni piangevano.
Nella piazza del Rathaus, davanti a oltre centomila persone, Bob, intirizzito dal freddo polare, improvvisò un discorso. A un tratto, dal settore orientale arrivarono centinaia di palloni con bandierina rossa, quasi
Luigi Barbara 94 1985 - John Fitzgerald Kennedy
un atto di sfida. Robert Kennedy alzò la voce: «I comunisti lasceranno passare i palloni, ma non gli uomini». E la folla esplose in un urlo, agitando freneticamente le braccia. Si gridava: «Viva Kennedy». La sera Bob pronunciò un discorso alla Libera Università di Berlino: studenti e corpo insegnante gremivano la sala fino all'inverosimile. Eccone un brano, a lungo concordato col fratello presidente: «Noi non siamo qui a Berlino soltanto perché siamo contro il comunismo. Noi siamo qui perché abbiamo una concreta e avanzata visione delle possibilità di una società libera, perché noi consideriamo la libertà uno strumento di progresso e di giustizia sociale, perché lo stesso comunismo altro non è che il sintomo e la conseguenza dei mali supremi, l'ignoranza e le malattie, la fame e il bisogno, mentre la libertà ha dimostrato di essere il mezzo più efficace per sconfiggere questi, che sono i secolari nemici dell'umanità».
Schlesinger, che faceva parte del gruppo di notabili in quella missione berlinese, scriveva in seguito: «Dopo colazione andammo a vedere il muro. Era uno spettacolo ancora più barbaro e sinistro di quanto avevamo potuto immaginare: i blocchi grigi di calcestruzzo grezzo, le finestre delle case lungo la linea di demarcazione murate con mattoni, gli insidiosi trabocchetti preparati per i carri armati, le alte palizzate erette per impedire agli abitanti del settore orientale di salutare anche di lontano i parenti e gli amici di Berlino ovest, le croci bianche che segnavano i punti in cui avevano trovato la morte coloro che avevano tentato la fuga, ai piedi delle quali Robert Kennedy deponeva ora dei fiori...». La sera Bob si mise in contatto telefonico col fratello e gli fece un'ampia relazione, ricevendone un caloroso plauso.
La crisi precipitò. Da Cuba arrivavano notizie allarmanti sugli «aiuti» inviati dall'URSS. E il 22 ottobre Kennedy lanciò un grido d'allarme: «Abbiamo le prove che si stanno installando a Cuba numerose rampe per il lancio di missili a testata nucleare. Alcune rampe sono idonee a scagliare razzi capaci di percorrere 1.850 chilometri: possono colpire Washington, il canale di Panama, Cape Canaveral e qualsiasi città del sudest degli Stati Uniti. Altre basi sono destinate a missili di gittata doppia, che sono quindi in grado di distruggere la maggior parte delle grandi città dell'emisfero occidentale... Per porre termine all'installazione di quel dispositivo di aggressione, ho deciso di istituire intorno a Cuba uno strettissimo sistema di quarantena destinato a intercettare qualsiasi imbarcazione in rotta verso Cuba con un carico di armi. E se necessario la quarantena sarà applicata
Luigi Barbara 95 1985 - John Fitzgerald Kennedy
anche ad altri tipi di carico. Mi rivolgo al presidente Kruscev per chiedergli di porre fine a questa minaccia così vile, temeraria e intollerabile per la pace del mondo».
La risposta non si fece attendere. Fidel Castro disse che il blocco annunciato costituiva una misura di guerra che nessuno stato può adottare nei confronti di un altro in tempo di pace. Sostenne che si trattava di un rischio calcolato che poteva portare a conseguenze tragiche per il mondo intero. E concluse: «Noi siamo sicuri che non ci sarà una nuova Monaco e che l'Unione Sovietica non farà come la Francia di Daladier o come l'Inghilterra di Chamberlain, quando queste si sono piegate davanti alle minacce di Hitler. Facciamo vedere a Kennedy di che legno sono fatti i cubani».
Durante la crisi di Cuba, Norman Cousins, direttore del «Saturday Rewiew», propose che Giovanni XXIII pubblicasse un appello per la pace. Il presidente rispose: «La situazione è ormai incontrollabile. Nelle prossime sei ore potrei essere costretto a premere il bottone e si avrebbe un miliardo di morti. Approvo, approvo senz'altro l'iniziativa».
Il Papa Buono, per la verità, aveva già pensato per conto suo di levare la sua voce per scongiurare la tragedia internazionale.
Non è da escludere tuttavia che egli abbia tenuto nel debito conto il desiderio di Kennedy, tanto è vero che dal fatidico balcone di piazza San Pietro lanciò un appello agli uomini di buona volontà. «Quanti sentono responsabilità di potere, con la mano sulla coscienza, ascoltino il grido di angoscia che sale verso il cielo: pace! pace! Scongiuriamo tutti i governanti di non rimanere insensibili a questo grido dell'umanità. Facciano tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace; così eviteranno al mondo gli orrori di una guerra di cui nessuno può prevedere le spaventose conseguenze. Perseverino dunque a trattare. Promuovere, favorire, accettare trattative è norma di saggezza e prudenza, che propizia le benedizioni del cielo e merita quelle degli uomini».
Forse Papa Giovanni non parlò invano.
Luigi Barbara 96 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XIIUN RESPIRO DI SOLLIEVO
Le parole di Giovanni XXIII ebbero un risalto internazionale e i governanti, ai quali si rivolgeva, le assimilarono e le compresero. Se non fu subito pace, certamente il messaggio del papa indusse i responsabili a una maggiore consapevolezza dei rischi di una guerra totale. Non per nulla Kennedy aveva preannunciato che se fosse scoccata la scintilla della guerra ci sarebbe stato non meno di un miliardo di morti. Giovanni XXIII si era fatto il portavoce di tanta umanità inerme e il suo messaggio aveva fatto sì che le parti antagoniste tornassero a considerare valido il contributo di un negoziato. La crisi di Cuba aveva portato il mondo vicinissimo alla catastrofe.
Il primo passo verso una possibile distensione lo compì il segretario dell'ONU, U Thant, che propose all'URSS di sospendere l'invio di armi a Cuba e agli USA di cessare la cosiddetta «quarantena». Fra tanti nuvoloni di tempesta fu uno spiraglio di luce, che apriva la possibilità a un negoziato. Kruscev accettò subito con evidente compiacimento la proposta di U Thant, mentre molti politici americani invitavano Kennedy a non mostrarsi rigido in proposito e a lasciare una via di uscita al leader sovietico. Averell Harriman sostenne che si doveva andare incontro a Kruscev e aggiunse: «Se invece faremo il contrario, rischiamo l'escalation e una guerra nucleare». Il pensiero di Harriman colpì profondamente il presidente Kennedy, il quale peraltro si ostinò perché i sovietici ritirassero le armi che avevano installato a Cuba.
Nei Caraibi lo spiegamento di forze navali americane era eccezionale: uno dei cacciatorpediniere che parteciparono all'operazione portava il nome del fratello del presidente, Joseph, morto disintegrato sul suo aereo durante la seconda guerra mondiale. Una sola petroliera sovietica poté rompere il blocco e a Washington ci fu chi era del parere che bisognasse attaccarla e silurarla. Ma Kennedy oppose il suo rifiuto: era necessario che la nave rientrasse in patria spontaneamente senza essere attaccata. Né l'URSS minacciò rappresaglie su Berlino, sicché parve profilarsi all'orizzonte l'idea di una soluzione pacifica della vertenza. Ma i missili, a Cuba, rimanevano sulle basi di lancio.
Il mondo fu tranquillizzato e anche Kennedy poté finalmente dormire
Luigi Barbara 97 1985 - John Fitzgerald Kennedy
senza i consueti incubi. Così il presidente cominciò a occuparsi anche delle sue questioni familiari. Jackie spendeva troppo. Un'amica disse che aveva le mani bucate e che non c'era somma che le bastasse per tirare la fine del mese. Un giorno, un terribile mal di denti impedì a Kennedy di partecipare alla parata del St. Patrick's Day. Non avendo altro da fare e in assenza della moglie, Jack entrò nell'ufficio della segretaria di Jacqueline, la signora Mary Barelli Gallagher, e cominciò una sua piccola inchiesta. Lanciando un'occhiata a un mucchio di buste contenenti molti assegni pronti per la firma di Jackie, cominciò immediatamente a porre domande, sparpagliando le buste sulla scrivania per esaminarle meglio. Sembrò sorpreso e infastidito dalle numerose spese della moglie. «D'ora in poi, Mary, faccia in modo che io abbia una lista completa degli assegni spediti; e mi faccia sapere esattamente per che cosa sono», disse severamente. Al momento la segretaria pensò che si trattasse di un'impennata momentanea e che si sarebbe presto stancato di guardare i conti di casa, ma si sbagliava. Jacqueline poco si curò delle «lamentele» del marito. Una delle attività che le portava via più tempo era riordinare il suo guardaroba, ordinare vestiti, guardare modelli o dettare delle lunghissime lettere che davano da fare ai suoi «scopritori» di abiti per settimane. Gli scopritori, ai quali si rivolgeva sempre di più alla Casa Bianca, erano per la maggior parte amici che avevano la supervisione dei modelli e dei tessuti. Jackie stessa teneva sott'occhio ciò che i sarti di Parigi e di Londra facevano. Spesso entrava in contatto con i suoi scopritori per ordinare degli abiti attraverso loro, in modo che nessuno sapesse che erano per la «first lady». La sorella di Jackie, Lee Radziwill, che vantava il titolo di principessa, si serviva di alcuni dei medesimi scopritori europei, ma la moglie di Kennedy diede loro un ordine tassativo: dovevano dare in precedenza a «lei» e non a Lee le ultime notizie sulla moda. Voleva essere la prima, in senso assoluto.
I vestiti di Jacqueline attiravano sempre l'attenzione dei pettegoli che si interessavano a quanto avesse potuto spendere per il suo guardaroba. Quando scrissero che la «first lady» sperperava 30.000 dollari all'anno, soltanto per gli abiti, Jackie ebbe un moto di ribellione: «Dovrei indossare biancheria di zibellino per spendere tanto». L'amico dei Kennedy, Benjamin Bradlee, giornalista e scrittore, fu partecipe delle diatribe fra Jack e Jackie proprio a proposito di spese eccessive. Non erano veri e propri litigi, ma quasi. Bradlee annota: «Jackie aveva appena saputo che suo marito dava il suo intero stipendio a opere di carità e lei aveva
Luigi Barbara 98 1985 - John Fitzgerald Kennedy
replicato che avrebbe potuto spenderlo di sua iniziativa quel denaro. Era seguita, naturalmente, una serie di domande, che finirono con una richiesta del presidente sullo stato delle finanze familiari. Aveva ricevuto i ragguagli in una lettera che aveva con sé e che lo faceva letteralmente bollire... non tanto di collera quanto di meraviglia e di indignazione. Una "voce" soprattutto lo esasperava: grandi magazzini... 40.000 dollari. Kennedy annunciò che aveva fatto venire Carmine Bellino, un esperto contabile, perché mettesse un po' d'ordine». La segretaria Mary Gallagher, di cui si è accennato, fece un po' i conti in tasca a Jacqueline, che, nel solo 1961, aveva profuso oltre 40.000 dollari in abiti e biancheria. Una somma da capogiro. L'esperto contabile ebbe un gran daffare, ma pare che, a conclusione del suo lavoro, si sia limitato a mormorare: «In questa casa si spende molto. Nessuno ruba. È necessario solo non avere eccessiva dimestichezza con i dollari. Ho fatto quello che dovevo e ora posso andarmene. Vi raccomando soltanto una cosa: spendere meno, risparmiare di più». Jacqueline non ascoltò le sagge parole di Carmine Bellino e continuò imperterrita a gettare al vento una valanga di denaro. In proposito ebbe anche degli attriti con la suocera, la signora Rose, che vedeva di malocchio quella «intrusa» che faceva da padrona. Le due donne arrivarono alla rottura. Mamma Rose si lamentava della trascuratezza della nuora, la quale in casa faceva vita per conto suo. Addio belle tradizioni dei Kennedy! Jackie usciva raramente dalla sua stanza per partecipare ai pranzi patriarcali. Se ne stava rintanata in camera sua e la cameriera le portava i pasti a letto. Una volta la vecchia Kennedy avvicinò la segretaria Mary Gallagher: «Sapete se Jackie si è alzata oggi?». Erano quasi le undici del mattino. Quando la signora Gallagher le rispose che non ne era sicura, aggiunse: «Bene, potreste ricordarle che oggi avremo degli ospiti importanti per pranzo. Sarebbe carino che fosse con noi». Diamo la parola alla fedele segretaria: «Andai immediatamente a riportare il messaggio a Jackie, ma lei lo prese scherzosamente. Imitò la voce e il modo di parlare di sua suocera e poi si limitò a canticchiare. Gli ospiti arrivarono e se ne andarono senza che Jackie li vedesse. Secondo me le cose non furono più le stesse tra Jackie e sua suocera dopo di ciò».
A un collaboratore, un giorno Kennedy ebbe a dire: «Con Kruscev a volte si poteva anche ragionare, con Jackie mai». Una cosa è certa: la vita coniugale dei Kennedy non era quel che si dice un sogno in technicolor e non c'è da meravigliarsi che lui cercasse insistentemente la compagnia di
Luigi Barbara 99 1985 - John Fitzgerald Kennedy
altre donne. Era, si è accennato in precedenza, un dongiovanni impenitente e collezionava avventure come un filatelico francobolli. Anche il 20 febbraio 1962, una data importante per gli Stati Uniti, ebbe un rapporto intimo con una segretaria della Casa Bianca. Quel giorno, il colonnello John Glenn viveva la prima grande avventura americana nello spazio. Alle 15.47, la telescrivente della Casa Bianca diede l'annuncio che Glenn era stato lanciato in orbita da Cape Canaveral e un funzionario salì precipitosamente al primo piano per informare Kennedy. Questi, letto il dispaccio, divenne rosso di piacere e ordinò che lo tenessero informato di tutte le fasi del lancio. Così alle 20.42, un'altra comunicazione raggiunse il presidente ancora a tavola per la cena: dopo tre rivoluzioni intorno alla Terra, Glenn era sceso nel mar dei Caraibi. Kennedy pregò Jacqueline di sturare una bottiglia di champagne e un goccetto fu fatto bere anche alla piccola Caroline. «Oggi è giorno di festa per noi americani. In poche ore abbiamo annullato il distacco che ci aveva inflitto l'Unione Sovietica. Spero che stasera si brindi in ogni casa degli Stati Uniti». Il presidente era su di giri e, cosa che non faceva quasi mai, si piazzò nell'ufficio delle telescriventi, ansioso di avere i particolari di quella straordinaria avventura. Solo all'una di notte decise di andare a dormire, «felice come un bambino col giocattolo nuovo», come commentò in seguito Schlesinger. Fra un dispaccio e l'altro, ebbe anche il tempo, si è visto, di fare all'amore con una remissiva segretaria, cui non pareva vero di essere stata scelta dal suo «padrone». Ma delle avventure galanti del presidente parleremo più avanti.
La mattina dopo, verso le nove, Kennedy ricevette un gradito messaggio da Kruscev così concepito: «Stimato signor presidente, a nome del popolo sovietico e mio personale, mi congratulo con lei e il popolo americano per il riuscito lancio nello spazio. Se i nostri popoli unissero i loro sforzi scientifici, tecnici e materiali per l'esplorazione dello spazio cosmico, ciò porterebbe un grande vantaggio al progresso della scienza e sarebbe salutato entusiasticamente da tutti i popoli che vorrebbero le conquiste scientifiche messe al servizio dell'uomo e non utilizzate per la corsa alle armi». Quello stesso anno registrò vari altri successi spaziali americani, tra i quali il volo nello spazio di Walter Schirra, il volo oltre Venere di un razzo con strumenti scientifici a bordo e il lancio del satellite «Telstar» per collegamenti televisivi.
Ma il 1962 doveva riservare a Kennedy anche molte amarezze sul piano
Luigi Barbara 100 1985 - John Fitzgerald Kennedy
della politica interna. Gli industriali dell'acciaio, in un primo momento, si erano impegnati a non ritoccare il prezzo del prodotto; poi, all'improvviso, il 1° aprile avevano deciso di aumentarlo di sei dollari per tonnellata. Kennedy ebbe parole assai dure per gli uomini d'affari. «Mio padre era solito dire che gli uomini d'affari sono tutti figli di porci (sons of a pig), però ho dovuto attendere il 1962 per crederlo». Dopo questa sparata, la prima grossa compagnia ritirava l'aumento, subito seguita da tutte le altre. Era una grande vittoria per Kennedy, che riuscì a tamponare l'inflazione strisciante che mortificava il paese. Ma i petrolieri di Dallas reagirono: «Gliela faremo pagare». Kennedy si fece nemici mortali. La sua fine fu probabilmente decretata dopo quell'infelice «figli di porci». Uno scrittore rivelò anni dopo: «I produttori di petrolio del sud, quelli del Texas in particolare, accusavano il presidente di voler uccidere il principio motore dell'America: lo spirito di libera iniziativa, il regno del profitto onestamente guadagnato con l'aiuto e la volontà di Dio. A Dallas, Harold Lafayette Hunt, il petroliere di quattro miliardi di dollari, sostenne che il comunismo in America era cominciato il giorno in cui il governo si era incaricato della distribuzione della posta». Quel «figli di porci» doveva costare la vita al presidente Kennedy.
Luigi Barbara 101 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO X IIITUTTE LE DONNE DEL PRESIDENTE
«Se sto troppo tempo senza una donna, mi viene il mal di testa». Il primo ministro britannico Harold Macmillan si fermò di botto sentendo il presidente John Kennedy fargli questa confidenza.
Biografi, non si sa quanto qualificati, hanno affermato che Kennedy cambiò donna ogni settimana dai sedici ai quarantasei anni. Un record amatorio che difficilmente potrà essere superato. Dive del cinema, belle ragazze, signore della buona società pur sempre piacenti, dilettanti o professioniste pare si alternassero nelle alcove della Casa Bianca col ritmo frenetico di una commedia da boulevard. Un giornale americano, dopo la tragedia di Dallas, fece una cifra francamente impressionante: milleottocento sarebbero state le donne amate dal presidente, dai tempi della scuola media fino all'apice del suo successo politico. Se si volessero rileggere le memorie di quel famoso amatore che fu Giacomo Casanova, si arriverebbe alla cifra di 260, piuttosto scarsetta se riferita a una carriera ultraquarantennale. Jacqueline, alla sorella, che era la sua più stretta amica, confidava quando era la «first lady» e abitava alla Casa Bianca: «Sì, va bene, Jack ha una passione per le donne. Del resto io ne sono stata attratta anche per questa leggenda. Ma fra questo e trasformarlo in una specie di maniaco sessuale ci corre». Jackie, al massimo, quando le riportavano delle «voci», si limitava a sospirare, alzava le spalle e mormorava: «Va bene, un'altra di più». Non risulta che facesse scenate di gelosia perché sapeva che Jack, passata l'infatuazione, sarebbe tornato da lei. Kennedy, nei suoi amori, non metteva radici; amava la varietà, non la perseveranza. Collezionava donne, ma non le amava veramente. Forse non fu legato profondamente nemmeno a Jacqueline, la madre dei suoi figli. E non era schizzinoso: conquistava stelle del cinema, signore della buona società, ma anche semplici stenografe e hostess.
Già quando era entrato alla Casa Bianca, Kennedy continuò una sua romantica relazione con Judith Campbell Exner, una bella bruna che seppe mantenere l'anonimato fin dopo la tragedia di Dallas. Ma i circoli ben informati di Washington erano al corrente della «cotta» fin dagli inizi degli anni sessanta. L'FBI fece allora un rapporto riservato in cui si segnalava che l'amante del presidente aveva pure rapporti con un famoso gangster,
Luigi Barbara 102 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Sam Giancana, che sarebbe poi rimasto ucciso in una faida della malavita. Judith, dopo la morte del presidente, aprì il vorticoso rubinetto delle sue memorie, vendendole a un settimanale scandalistico e poi raccogliendole in un libro, che fruttò non meno di due milioni in diritti d'autore. Due milioni di dollari, naturalmente. I rapporti avuti con John Kennedy per più di due anni vengono descritti da Judith come «passionali, sessuali ed emotivi»: divennero «seri» durante un soggiorno all'hotel Waldorf Astoria di New York dal 12 al 16 marzo del 1960 e continuarono per due anni con incontri più o meno segreti a Palm Beach, Los Angeles, Chicago e Washington. Nella capitale, durante le numerose assenze di Jacqueline, Judith frequentò spesso la casa del candidato presidenziale a Georgetown e dopo la sua vittoria lo visitò una ventina di volte alla Casa Bianca. Con aria divertita, la Campbell raccontò che era suo il reggiseno che Jacqueline trovò sotto un cuscino e che la «first lady» quasi scagliò in faccia al marito sibilando che «non era della sua misura».
La Campbell contribuì, alla sua maniera, al successo televisivo di Kennedy, contrapposto al suo spietato avversario Richard Nixon. Il 13 ottobre 1960, John, secondo quanto rivelò poi il columnist Jack Anderson, appariva più teso del solito e un collaboratore gli consigliò di rilassarsi con la sua amica preferita prima di affrontare il suo avversario davanti alle telecamere. Con la futile scusa di dover ritirare della biancheria personale, il futuro presidente interruppe una riunione politica con i suoi consiglieri e raggiunse al Waldorf Astoria la sua amante. Durante uno dei suoi frequenti convegni, John Kennedy, sempre secondo le dichiarazioni di Judith, aveva confidato che il suo matrimonio «faceva acqua da tutte le parti» e che Jacqueline aveva manifestato ripetutamente l'intenzione di divorziare.
Ma la «ragion di stato» e i milioni di dollari del patriarca Kennedy avevano avuto il potere di scongiurare quel passo che poteva essere dannoso alla carriera di Jack. Jacqueline, a quell'epoca, versò sul suo conto corrente personale oltre due milioni di dollari in contanti.
Judith Campbell, in seguito, non esitò ad ammettere di avere intrecciato, un mese dopo aver incontrato Kennedy, un rapporto amoroso con il gangster Sam Giancana, che, assieme all'altro capo mafioso John «Don Giovanni» Roselli, doveva collaborare con la CIA a diversi complotti per assassinare Fidel Castro.
Successivamente dopo la tragedia di Dallas, l'ineffabile Judith, oltre a scrivere ben remunerate memorie, arrivò anche a organizzare conferenze
Luigi Barbara 103 1985 - John Fitzgerald Kennedy
stampa. «Posso dire che il mio rapporto con Jack Kennedy», dichiarò la donna leggendo un comunicato concordato con il suo avvocato, «è stato di natura strettamente personale e che in esso non sono entrati sotterfugi cospiratori di alcun genere».
Parlando a posteriori della sua amicizia sia con Kennedy sia con Giancana (onnipresenti l'avvocato e il marito Dan Exner), la Campbell spiegò sempre che fu Sinatra a presentarle i due amanti. «Incontrai la priva volta Jack Kennedy ai primi di febbraio del 1960, a Las Vegas, tramite Sinatra che, qualche tempo dopo, doveva farmi conoscere Giancana». In vena di confessioni, confermò di avere ricevuto dalla Casa Bianca diverse telefonate: «Parlai l'ultima volta con Jack alla fine del 1962. Il mio ultimo colloquio con Giancana risaliva invece al dicembre del 1964 e, nonostante le informazioni contrarie, non telefonai mai alla Casa Bianca dall'abitazione di Giancana a Chicago». La Campbell volle precisare, a scanso di spiacevoli equivoci - disse -, che «per quanto riguardava i miei rapporti con Sam Giancana e quelli con Johnny Roselli essi furono di natura personale e in nessun modo collegati alla mia amicizia con Jack, né io parlai mai all'uno degli altri e viceversa». La Campbell ricordò inoltre di avere conosciuto Jacqueline e di averla trovata antipatica. Si rifiutò tuttavia di dire se avesse conosciuto qualche altro esponente del «clan» e assicurò che non avrebbe mai rivelato alcun particolare sul rapporto avuto con John Kennedy.
Judith Campbell, sposata Exner, aveva aspirazioni di fare l'attrice cinematografica e quindi non si può neppure escludere che sperasse di essere chiamata a interpretare la parte di se stessa in un possibile film sulla sua vita. «Ma ho paura. Qualcuno potrebbe farmi tacere per sempre», esclamò durante un'altra conferenza stampa. E aggiunse: «Ci sono anche segreti per cui temo di essere ammazzata. Solo allo scopo di proteggermi ho trascritto, documentato e messo in posto sicuro tutti i fatti della mia relazione prima con Kennedy e poi con Giancana e Roselli». L'amante di un presidente e di due boss mafiosi soggiunse con un sorriso sardonico che i fatti sarebbero stati pubblicati in modo appropriato a tempo e luogo. Tutti gli intimi di Kennedy erano al corrente della relazione, eppure passarono degli anni prima che si cercasse di appurare la verità. Si interrogarono così parecchie persone che facevano parte dell'entourage dell'ex presidente per sapere se erano informate di Judith Campbell Exner. Il generale Godfrey MacHugh, aiutante di Kennedy quando questi era presidente, ammise che
Luigi Barbara 104 1985 - John Fitzgerald Kennedy
poteva aver visto la Campbell alla Casa Bianca agli inizi degli anni sessanta. « Credo che la sua faccia e il suo nome mi siano vagamente familiari. Ma era una delle tante signore, almeno una trentina, che frequentavano il "palazzo" con diverse mansioni».
Ma in quel tempo, nei primi mesi della sua presidenza, non c'era soltanto Judith nella vita sentimentale di Kennedy che, assieme a lei, riceveva in gran segreto alla Casa Bianca anche un'attrice, Mary Meyer, un'esponente della buona società di Washington. La relazione tra il presidente Kennedy e l'attrice Mary Meyer durò dal gennaio 1962 alla tragica fine di Dallas.
Mary aveva una debolezza: annotava quotidianamente tutti gli avvenimenti della giornata sul suo diario, un'indelicatezza che forse le procurò una morte prematura. Quando il 12 ottobre 1964, anche miss Meyer veniva assassinata su un sentiero nei pressi di casa sua, la polizia affermò che era stata uccisa da un killer solitario. La pratica finì nel gran mucchio dei casi insoluti. Dopo la morte di Mary, vennero trovati nel suo studio il diario personale, che conteneva accenni al presidente Kennedy, e diverse lettere d'amore scritte da lui, ma i documenti furono consegnati alla CIA. La Meyer non era più giovanissima quando cominciò l'idillio, era sulla quarantina, ma ancora molto attraente. Sua sorella, Toni Bradlee, confermò la distruzione del diario, ma non volle fare altre dichiarazioni; tuttavia secondo il settimanale «The National Enquirer», fu James Angleton, che era amico dell'artista e capo dei servizi di controspionaggio della CIA, a recarsi a casa dell'assassinata per distruggere il diario e le lettere a firma «Jack». Le guardie del corpo del presidente sapevano e tacevano. Sapevano anche dell'esistenza della signora Lundberg Hitchcock, che apparteneva alla società più in vista di San Francisco e avrebbe avuto rapporti sentimentali col presidente americano per quasi tre anni.
Poi, come si è visto, comparve sull'orizzonte di Kennedy anche Judith Campbell. Mary completò il terzetto di quei mesi frenetici, nei quali il presidente cercava svago perché stanco di un matrimonio che faceva acqua da tutte le parti. Arrivò anche il turno di una bibliotecaria di Boston, che asserì di essere rimasta vittima di quel famoso ladies killer.
Oggi, a distanza di tanti anni, si può dire che le avventure extraconiugali del presidente hanno inferto un durissimo colpo all'ipocrisia puritana di gran parte dell'America. Si instaurò un vero e proprio processo, durante il quale la figura di Kennedy apparve seriamente ridimensionata, sia per la
Luigi Barbara 105 1985 - John Fitzgerald Kennedy
sua bramosia di avventure, sia per la visione cesarea che egli ebbe del potere. Fu Kennedy il primo presidente a modificare i caratteri della Casa Bianca, trasformandola dal modesto centro amministrativo della nazione federale che era ancora ai tempi di Eisenhower in una vera e propria corte reale, sofisticata e misteriosa. Fu proprio Kennedy il primo a dare al potere di Washington una struttura «imperiale», esautorando il senato e portando invece al vertice un ristretto gruppo di consiglieri personali non scelti dal popolo ma da lui stesso. Fu il primo presidente spavaldamente «nepotista», il primo che diede poteri alla sua famiglia, fratello, moglie e cognati. E fu il primo che ammise alla corte quella colorata congrega di favorite, che magari dimenticavano qua e là qualche pezzo della loro biancheria intima.
Ma c'è da porsi una domanda. Quante di queste donne contarono veramente nella sua vita? Ecco allora che l'elenco si restringe e «don John» rientra nelle medie degli uomini qualunque.
Indubbiamente Kennedy non era nato con la vocazione della monogamia, ma rimaneva nel profondo pur sempre un cattolico. E pertanto un ruolo di primissimo ordine rivestiva per lui il matrimonio. Un sacramento. Per «don John» sempre, anche nei momenti più tumultuosi della sua vita di libertino, al primo posto ci fu la moglie, alla quale lo legava un vincolo sancito dalla Chiesa. Eccoci di conseguenza nuovamente a Jacqueline Bouvier, la bella, sofisticata consorte che il mondo intero gli invidiava. Dopo Eleanor Roosevelt, Jacqueline fu la «first lady» più discussa, criticata e ammirata. Proprio la Roosevelt, abilissima nel giudicare le persone, scrisse di lei: «C'è più di una cosa in Jacqueline che attira l'attenzione».
Jacqueline era una bella donna, più alta del normale, snella, ben proporzionata, il sorriso cordiale, la voce melodiosa. Non amava le campagne elettorali, nelle quali il marito invece si gettava con giovanile entusiasmo, ma in breve si adattò al ruolo di moglie di un «uomo politico». Cresciuta in una famiglia repubblicana giustificava la metamorfosi dicendo: «Bisogna essere repubblicani per capire com'è bello essere democratici». E, con questa battuta, metteva a tacere le malelingue che l'accusavano addirittura di diserzione. Ella scoprì di avere molto in comune col marito: erano entrambi sportivi e buoni nuotatori. Si cimentava con gioia nello sci d'acqua mentre il presidente era un appassionato di vela. Jacqueline cominciò a giocare a golf per far piacere al marito, ma rinunciò allo sport preferito dai Kennedy, il touch football,
Luigi Barbara 106 1985 - John Fitzgerald Kennedy
dopo essersi rotta una caviglia al primo tentativo di intraprendere quella nuova disciplina. Con le lacrime agli occhi, rivolta a John che la consolava, mormorò: «Io pratico gli sport. Ma questo non è sport, è un passatempo da spaccapietre».
John amava la gente, mentre Jacqueline era ombrosa e introversa. Spesso, nei raduni pubblici, il presidente richiamava al dovere la moglie con discrete gomitate. Allora lei si apriva al sorriso e aveva grande successo, del quale spesso il marito era inconsciamente geloso.
Quanto al cibo, John e Jacqueline erano separati da un abisso. Lui era di gusti semplici: carne, patate, zuppa di pesce e frutti di mare. Lei era, al contrario, una buongustaia, amante della haute cuisine; amava i raffinati piatti francesi, era un'intenditrice e pretendeva il caffè ristretto all'italiana, non quell'intruglio annacquato che si consuma in tutte le case degli Stati Uniti d'America.
Prima del matrimonio, John era sempre stato alquanto trasandato nel vestire. Fu Jacqueline a imporsi e a obbligarlo a essere sobrio, ma elegante. Certo non gli capitò più di mettere con lo smoking i mocassini marroni e diventò famoso come uomo «dai tre vestiti al giorno». Jacqueline invece era raffinata e sfoderava sempre il suo innato buongusto. Scrisse un giornalista: «Anche se si trovasse in una stalla con un forcone in mano e i capelli tutti scarmigliati sugli occhi, sembrerebbe sempre miss America». Si serviva dai grandi sarti di Parigi, Londra e Roma, spendendo somme astronomiche.
Ma bisogna riconoscere che non cadde mai in pacchiane ostentazioni.Nonostante le frequenti scappatelle, John era molto innamorato della
moglie e a volte partivano insieme per brevi e lunghi fine settimana a Hyannis Port e Newport, nel Rhode Island, dove i genitori di lei avevano una casa per l'estate, oppure a Camp David, il ritiro ufficiale del presidente sulle colline del Maryland, o a Glen Ora, una casa presa in affitto in Virginia. Nel 1963, poco prima della tragedia di Dallas, i coniugi Kennedy costruirono la loro casa in quella zona, ma Jack vi mise piede soltanto due volte. Il mare era la gioia del presidente, il quale non dimenticava di essere stato in marina per vocazione. E il suo più grande gioiello era la sua barca a vela, fatta varare sotto gli auspici dei tecnici più competenti, quegli stessi che sovrintendevano alle imbarcazioni delle regate internazionali. Lei sorrideva, compiacente, per quella che definiva una mania. «Che idea andare a zonzo, fidandosi soltanto dei capricci del vento». Una volta, per
Luigi Barbara 107 1985 - John Fitzgerald Kennedy
divertirlo, gli regalò una bussola che a Jack non serviva proprio a nulla. Il presidente la sistemò sul suo tavolo di lavoro. Certo Jacqueline rappresentò un punto fermo nella tumultuosa vita sentimentale di John, che peraltro non volle mai rinunciare al suo gusto per l'avventura. Per trovare un'altra donna che abbia esercitato un'analoga influenza su Kennedy, bisogna andare molto a ritroso nel tempo, quando il presidente non era che un semplice deputato, per di più assenteista. Agli inizi della carriera ebbe una lunga relazione con l'attrice Gene Tierney, che apparteneva a una ricca famiglia di banchieri. Gene ebbe una carriera di grande star nel cinema, cominciata con un film di successo accanto a Gary Cooper. Era ancora giovanissima. Dopo una lunga serie di matrimoni andati male e di amori sfortunati, la Tierney si ammalò di una profonda depressione che la obbligò a una lunga degenza in clinica. Kennedy, quando la conobbe, si dichiarò disposto a sposarla subito, ma il matrimonio andò in fumo, sacrificato alla «ragion di stato». Gene infatti era divorziata e questo avrebbe nuociuto alla popolarità del giovane e ambizioso uomo politico. La pruderie tipicamente anglosassone, ereditata da buona parte degli americani, ne sarebbe rimasta offesa. Così i due amanti dovettero lasciarsi, anzi fu proprio lei a prendere la drastica decisione, partendo per l'Europa col cuore infranto. Si consolò comunque abbastanza presto con il figlio dell'Aga Khan, Alì, ma si ripresentò lo stesso dilemma: una divorziata non sarebbe potuta entrare come regina nel regno degli ismailiti. La nuova delusione sembra abbia condotto la già instabile Gene ai limiti della follia. La Tierney, ormai avanti negli anni, scrisse un memoriale sulle sue disavventure amorose, in cui un capitolo era dedicato a John Kennedy, che un giornalista avrebbe definito, pesantemente, il «presidente materasso». Gene Tierney non fu un amore passeggero per Kennedy, che conservò per lei un'affettuosa, duratura amicizia. Gene era sposata e divorziata dal sarto Oleg Cassini, che doveva poi diventare il «patron» personale di Jacqueline, l'elegante ragazza di Boston che John aveva preso in moglie dopo essere diventato senatore. Un'altra donna che contò nella vita del presidente fu Mary Pinchot Meyer, moglie divorziata di un alto funzionario dei servizi segreti americani. Qualcuno sostiene che Mary fu l'amante di Kennedy fino a quando fu ucciso.
Ma il legame più clamoroso fu quello che legò Kennedy alla meravigliosa Marilyn Monroe: un amore appassionato che naufragò nella morte e nel mistero. John conobbe Marilyn in casa del cognato Peter
Luigi Barbara 108 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Lawford, anch'egli attore a Hollywood e fu il colpo di fulmine. Lei aveva il numero telefonico privato dell'amante alla Casa Bianca e gli telefonava anche due, tre volte al giorno. L'insistenza non sfuggì a Jacqueline che rimproverò il marito di metterla decisamente in imbarazzo.
Il presidente promise di troncare quell'ingombrante «amicizia», ma la relazione seguì ugualmente il suo corso. Il 18 maggio 1962, al Madison Square Garden di New York, la Monroe fu invitata ai festeggiamenti per il compleanno di Kennedy e intonò il fatidico Happy Birthday. Il festeggiato commentò: «Ora che Marilyn ha cantato per me, posso anche ritirarmi dalla vita politica». Ma era soltanto una battuta, perché Kennedy, se la morte non lo avesse falciato prematuramente, sarebbe ancora oggi sulla breccia. Le voci si infittirono e a Washington si creò un certo imbarazzo. La Monroe non era persona discreta e a volte parlò del presidente chiamandolo Jack, un nome usato soltanto nell'entourage dei Kennedy. Era inoltre una donna possessiva e, sotto certi aspetti, asfissiante, così che riuscì ad accendere la miccia di mille pettegolezzi.
Marilyn continuò a frequentare il presidente sia alla Casa Bianca, sia nella sua casa di Los Angeles e spesso era ospite sull'aereo personale di Kennedy che si spostava da un capo all'altro del paese per ragioni del suo mandato. Il pilota aveva la bocca cucita, ma qualcosa trapelò se Jackie decise di far ricorso alla mediazione del suocero, il quale ci rimise altro denaro ma riuscì a placare l'indomita nuora. Il vecchio Joe, rivolto alla moglie Rose, tuonò: «Questi figli mi porteranno alla rovina». Tuttavia, per amore di pace, attingeva al suo immenso patrimonio per ricucire le lacerature dei legami familiari. Lo scrittore Richard Condon, che fece accurate indagini sulla famiglia Kennedy, scrisse un libro in cui si legge: «John fu un seduttore insaziabile. Incominciò a quattordici anni e continuò imperterrito fino al giorno in cui fu ucciso a Dallas. Quando entrò nella camera dei rappresentanti, aveva già collezionato quattrocentosettanta femmine. Quindi con un'accelerazione fantastica nei cinque anni che gli servirono per diventare senatore, riuscì a innalzare il totale a novecentotré. Ma tutto ciò è nulla a paragone di quanto avvenne in seguito. Dopo tre anni alla Casa Bianca poteva vantarsi di aver posseduto non meno di milleseicento donne. Cioè in circa trent'anni di attività amatoria ebbe una donna diversa ogni settimana della sua vita».
Marilyn era una delle tante conquiste, il fiore all'occhiello, quella per la quale valeva la pena di patire i rimbrotti della moglie. Ma, bisogna
Luigi Barbara 109 1985 - John Fitzgerald Kennedy
aggiungere, un fiore che Kennedy si tolse fulmineamente quando la relazione stava diventando di pubblico dominio. Qualche pagina dopo, lo stesso Condon rivela ancora: «L'appetito sessuale del presidente americano non era diverso da quello di Enrico VIII e di tanti altri personaggi importanti del passato. C'è spesso un forte nesso fra l'ambizione politica e il bruciante desiderio di conquistare il maggior numero possibile di donne. La sfrenatezza sessuale di John e degli altri fratelli Kennedy si manifestò negli anni dell'adolescenza, sotto l'esempio del padre che fu un incorreggibile libertino. L'amore, per loro, era una ginnastica, senza sentimenti o emozioni, un hobby come il tennis. Jacqueline sapeva tutto delle avventure extraconiugali del marito: le donne che John Kennedy si sceglieva facevano di tutto perché la "first lady" degli Stati Uniti sapesse di essere stata tradita». Fece così anche Marilyn. Un giorno, il potente Edgar Hoover, capo dell'FBI, chiese udienza al presidente, al quale con molta discrezione fece rilevare che la relazione con la Monroe poteva seriamente danneggiarlo. «Se ne comincia a parlare e non soltanto a Washington. Sarebbe bene che lei non la frequentasse più per troncare i pettegolezzi». Se si era mosso Hoover, si disse Kennedy, voleva dire che quella sua «scappatella» poteva diventare pericolosa e mettere a repentaglio la sua carriera. John, però, non se la sentiva di troncare così all'improvviso ed ebbe un lampo di genio. Si servì del fratello Robert per far capire a Marilyn che non era più possibile continuare. La grande attrice se l'ebbe a male e minacciò rappresaglie. Ma Robert seppe essere molto convincente e la Monroe s'innamorò di lui. Nella sua vita entrava un altro Kennedy, che doveva renderla felice e disperata a un tempo. Robert, che a quell'epoca era ministro della giustizia, diede a Marilyn il numero privato del suo telefono al dicastero, e fra i due fiorì un idillio che sembrava nato sotto una buona stella. Spesso l'«altro Kennedy» andava a far visita all'amica nella casa di Los Angeles. I vicini osservavano e diffondevano la notizia. Marilyn era su di giri, anche se, in quei giorni, aveva noie con il lavoro: la sua casa cinematografica l'aveva licenziata perché, durante le riprese di un film, era stata assente venti giorni su ventidue. Lei raccontò a Robert la sua disavventura. L'uomo scoppiò a ridere e replicò: «Tu sei unica, Marilyn. Se ti hanno messo alla porta, vedrai che torneranno col capo chino e ti chiederanno anche scusa. Sono loro che hanno bisogno di te, non tu di loro».
John venne subito a sapere della «sbandata» del fratello e se ne rallegrò.
Luigi Barbara 110 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Robert gli aveva risparmiato le lamentele dell'amante che si sentiva abbandonata e mortificata. C'è da aggiungere che, passata la prima infatuazione, il presidente si era stancato dell'attaccamento, anche troppo asfissiante, di Marilyn e si guardava intorno in cerca di nuove prede. Ora era Robert a essere alla mercé della possessiva Monroe che, quando si innamorava, lo faceva sul serio, senza mezze misure, e pretendeva dal suo nuovo uomo affetto illimitato e soprattutto fedeltà. John era soddisfatto di quel distacco indolore e fece sapere a Robert tutta la sua riconoscenza. Marilyn sperava di sposare il secondo Kennedy, che aveva moglie e ben otto figli.
Ethel, venuta a conoscenza della tresca, andò a sfogarsi col suocero, il vecchio Joe, il patriarca della famiglia.
A questo punto, il romanzo rosa si tinse di giallo. Robert, che non avrebbe mai disobbedito alla volontà del padre, prese le distanze da Marilyn.
Per prima cosa fece cambiare il suo numero telefonico per mettere l'amica nell'impossibilità di raggiungerlo.
Per la diva cominciarono i giorni della frustrazione e dell'umiliazione. Telefonava al ministero e lasciava a tutti il medesimo messaggio: «Sono la Monroe, dite al ministro che ho urgente bisogno di parlargli». Inasprita, Marilyn riuscì alla fine a mettersi invece in comunicazione con il presidente, il quale finse di cadere dalle nuvole. Ma, disse in sostanza, lui che cosa poteva farci? Gli eventi precipitarono. Marilyn, indispettita, minacciò di indire una conferenza stampa e si confidò con l'amico Robert Slatzer (che disse di essere stato sposato sia pure per pochi giorni con la Monroe) che le consigliò prudenza. Non poteva mettersi contro una famiglia potente come quella dei Kennedy. Slatzer la convinse a non radunare i giornalisti e la esortò a dimenticarsi di Robert e del fratello presidente. Si arriva così al 5 agosto 1962, un sabato, quando Marilyn Monroe fu trovata cadavere nel suo letto. Suicidio per eccesso di barbiturici fu il responso della polizia. Ma Robert Slatzer indagò alcuni anni per dimostrare che la diva non si era tolta la vita, suscitando polemiche e l'interesse di molti investigatori.
Luigi Barbara 111 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XIVIL PICCOLO PATRICK KENNEDY MUORE
Dopo la parentesi sulle donne del presidente ritorniamo al Kennedy uomo di stato, spesso alle prese con problemi scottanti. Uno di questi problemi fu senza dubbio quello dei diritti civili e gli Stati Uniti furono letteralmente lacerati da prodromi di guerra civile. I neri rivendicavano una parità che i bianchi, specie negli stati del sud, respingevano. Kennedy, che era al timone, dovette affrontare la terribile bufera. Eletto anche e soprattutto coi voti dei neri, il presidente aveva più di un motivo di riconoscenza nei loro confronti e in più era mosso da insopprimibili ragioni di giustizia. Fu Kennedy in persona a intervenire in favore del nero James Meredith, che aveva avuto il coraggio (o l'impertinenza, secondo i razzisti) di iscriversi all'università del Mississippi, dove scoppiarono disordini nel campus. Il governo inviò truppe per sedare i tumulti, mentre il presidente rivolse un appello molto ispirato agli studenti dell'università: «Avete una grande tradizione da mantenere, una tradizione di onore e di coraggio». Ma le colpe degli studenti erano relative al cospetto di quanto riuscivano a suscitare i sobillatori di professione. Sorensen racconta infatti che: «Attaccabrighe e razzisti provenienti da tutto il Mississippi e dal sud avevano cominciato a raggrupparsi portando randelli, sassi, tubi, mattoni, bottiglie, mazze, bombe incendiarie e fucili. Quella notte, nell'infuriare dei disordini, perdettero la vita un giornalista e un cittadino. Duecento guardie rimasero ferite. I danni furono ingenti». Kennedy passò una notte agitata e si rimproverò di non avere fatto intervenire prima le truppe. Comunque la folla fu dispersa e l'ordine ristabilito. «Riconosco che quest'episodio ha provocato molto risentimento nei miei confronti», commentò Kennedy, «ma non so proprio quale altro atteggiamento potevano aspettarsi dal presidente degli Stati Uniti. Si aspettano che io tenga fede al giuramento di rispettare la costituzione, e questo è quanto intendo fare».
Nel gennaio 1963 Martin Luther King e due colleghi si incontrarono col presidente Kennedy e col fratello Robert sollecitando che entro l'anno l'esecutivo prendesse le misure necessarie sul problema dei diritti civili. I Kennedy si dimostrarono molto disponibili, ma dissero che nel 1963 non avrebbero presentato un progetto di legge sui diritti civili, adducendo come scusa che altri progetti di legge, in questo caso, sarebbero stati messi in
Luigi Barbara 112 1985 - John Fitzgerald Kennedy
pericolo. King se ne ebbe a male e avvertì il presidente che non rimaneva che scendere in piazza. «Tanto le dico perché lei non sia colto di sorpresa». Kennedy capì che King non parlava invano e decise allora di stringere i tempi. Il 28 febbraio, dopo la deludente risposta data a Luther King, presentava al congresso un progetto di legge per i diritti civili. Il messaggio iniziava così: «Il bambino nero nato oggi in America ha circa metà delle probabilità di portare a termine la scuola superiore rispetto al bambino bianco nato nello stesso posto in quello stesso giorno; un terzo di probabilità di terminare l'università; un terzo di probabilità di diventare un professionista; il doppio delle probabilità di trovarsi disoccupato; un settimo di guadagnare diecimila dollari l'anno; una durata media dell'esistenza inferiore di sette anni; e la prospettiva di guadagnare solo la metà». Ma le cose restarono più o meno come prima, sollevando grave malcontento nelle comunità dei neri.
Per risolvere il caso dello studente nero James Meredith si dovettero infatti pronunciare ben tre gradi dell'ordine giudiziario. Alla fine, tuttavia, il giudice della corte suprema Hugo Black, nativo dell'Alabama, dovette confermare che Meredith era stato respinto dall'università «soltanto perché era un nero». I razzisti scatenarono una violentissima reazione alla sentenza e Ross Barnett, governatore del Mississippi, gridò in pubblico: «Anche se quella di ammettere un nero nella nostra università è una decisione della corte suprema, noi non ci arrenderemo. Non cederemo le armi di fronte alla perversione e alle forze illegali della tirannia. Ritengo che i tribunali dello stato del Mississippi siano di grado altrettanto elevato di quello di qualsiasi altra corte e molto più capaci, e io intendo obbedire alle leggi del Mississippi». La replica del senatore Robert Kennedy, ministro della giustizia, fu secca: «Il mio compito è di far rispettare le leggi e ve le farò rispettare». Unanimi furono i commenti della stampa illuminata degli Stati Uniti. Ecco un passo del «New York Herald Tribune», all'indomani del caso Meredith: «Il popolo americano deve essere grato al presidente Kennedy tanto per le sue parole quanto per le sue decisioni. Il presidente ha fatto quel che doveva essere fatto in una situazione in cui si cercava di prendersi gioco dell'autorità, delle corti federali e dello stesso governo centrale. Certo, adesso il ritorno alla calma nel Mississippi sarà lungo e difficile. Ma è stato dimostrato che, negli Stati Uniti, la legge è più forte di coloro che vorrebbero ignorarla». E il «Daily Telegraph»: «È stato versato del sangue nell'amara controversia per i diritti
Luigi Barbara 113 1985 - John Fitzgerald Kennedy
di uno studente nero nell'università di stato del Mississippi, ma alla fine il signor Barnett ha permesso allo studente di immatricolarsi... Questa è una vittoria per la legge e un titolo di credito per il presidente Kennedy». Ma certamente fu questa presa di posizione sul caso dello studente nero ad alienare gran parte delle simpatie al presidente, specialmente nel profondo sud, dove, a Oxford, gli studenti marciavano intorno al campus cantando «Glory, Glory Segretation». L'intervento a favore di Meredith, forse, segnò l'amara condanna a morte dei fratelli Kennedy. Cominciarono a circolare manifestini, i quali alimentavano l'odio: «Attenti! Kennedy vi sta rovinando. Abbasso i fratelli Kennedy, Kruscev e King», e un biplano sopra il campo trainava un nastro bellicoso con la scritta: «Coesistenza uguale a resa».
Due giorni dopo il pugno di ferro fra i legalisti e Ross Barnett, in America si celebrò il primo centenario del proclama di emancipazione. Il presidente, in un messaggio rivolto dal Lincoln Memorial, mise in risalto il ruolo svolto dai neri per l'uguaglianza dei diritti dopo l'abolizione della schiavitù. Kennedy disse fra l'altro: «Lo sforzo essenziale, la lotta più lunga fu sostenuta dai neri, da soli, con dignità e fede risoluta... Si può dire, penso, che Abramo Lincoln emancipò gli schiavi, ma che nel secolo successivo i nostri concittadini neri hanno emancipato se stessi... Come l'emancipazione che noi commemoriamo, questo rito deve essere considerato non come un traguardo, bensì come un inizio». Il problema dei diritti civili era una spina nel suo cuore: avrebbe voluto fare di più, ma al tempo stesso era frenato da considerazioni di ordine pratico. Aveva bisogno dell'appoggio dei sudisti, per non giocarsi in un fiato quella lieve maggioranza con la quale aveva strappato il suo mandato presidenziale. Il caso Meredith aveva fatto precipitare il suo fascino e ora le inchieste lo davano soccombente di fronte a qualsiasi concorrente repubblicano. Kennedy però non si arrendeva e coraggiosamente si presentò alla televisione per dichiarare che Meredith era entrato sano e salvo nel campus. Aggiunse: «Se in questo paese si dovesse giungere a un punto tale che un uomo o un gruppo di uomini, con la forza o con la minaccia della forza, potesse permettersi di sfidare gli ordini della nostra corte suprema e della nostra costituzione, allora nessuna legge sarebbe più stabile, nessun giudice sarebbe più certo di vedere rispettato un suo ordine e nessun cittadino potrebbe sentirsi sicuro del proprio vicino». E, rivolto agli studenti dell'università incandescente, esclamò: «L'onore della vostra
Luigi Barbara 114 1985 - John Fitzgerald Kennedy
università e del vostro stato sono in gioco, sono certo che la grande maggioranza degli studenti difenderà tale onore». A Oxford gli studenti levarono grida di scherno e, rivolti a Meredith che intrepidamente era presente, gridarono: «Valeva la pena di sacrificare due vite, negro?». Per mesi le guardie federali accompagnarono Meredith nelle diverse aule; rappresaglie furono tentate contro la sua famiglia, ma egli, annota Schlesinger «continuò nella strada che aveva scelto». E Robert Kennedy, ministro della giustizia, commentava: «Hanno sparato contro la casa di suo padre, non è ancora accettato dai suoi compagni, ha avuto intorno a sé 400 o 500 fra soldati e guardie. Io, per quanto mi riguarda, ho trovato la vita universitaria già abbastanza dura senza tutto questo».
Verso la metà del 1963, quando fu effettuato un sondaggio chiedendo alla popolazione di colore chi avesse fatto di più per i diritti dei neri, la gran massa degli intervistati fece due nomi, quello di Martin Luther King e del presidente Kennedy. E davvero Kennedy mostrò sino in fondo la sua profonda umanità, quando, il 19 giugno 1963, presentava al congresso il progetto di legge per i diritti civili più completo e di più vasta portata mai immaginato. A questo proposito Longford puntualizza: «Ora si era veramente impegnato e non avrebbe più fatto marcia indietro. Fece tutto il possibile per mettere la nazione al corrente dei punti salienti e nello stesso tempo cercò di raggiungere lo scopo con una serie eccezionale di incontri alla Casa Bianca con persone influenti e selezionate».
Ma i neri mordevano il freno e minacciarono una marcia su Washington, prospettiva che mise Kennedy in gravi angustie. I repubblicani e i democratici del sud ammonirono il presidente che altre concessioni non sarebbero state tollerate e il presidente optò per una via di mezzo che era nello stesso tempo decisa e duttile. Kennedy prese le distanze dai neri oltranzisti dichiarando: «La violenza non è mai giustificata. E mentre pacifici scambi di vedute, dibattiti e istanze di protesta possono continuare, desidero mettere in guardia contro dimostrazioni che possono sfociare nella violenza».
Intanto nell'Alabama, e precisamente a Birmingham, si andava profilando una nuova crisi. Sotto la guida di Luther King i neri stavano conducendo una campagna per porre fine alla discriminazione nei negozi, nei ristoranti, negli impieghi. E si arrivò presto ai ferri corti. Allorché King annunciò un'altra marcia per il 12 aprile (era un venerdì santo), intervenne il capo della polizia Eugene Connor, che proibì il corteo e diede ordine di
Luigi Barbara 115 1985 - John Fitzgerald Kennedy
lanciare addosso ai (manifestanti i cani poliziotto. E andò oltre: contro ogni aspettativa fece arrestare King e altri leader del movimento.
Poiché stava per entrare in carica una più moderata amministrazione cittadina, da Washington si esortarono i capi dei neri a portare pazienza. Una volta silurato Connor era possibile permettere quello che oggi veniva vietato. Ma ormai la marea era in movimento e King fece sapere a Robert Kennedy che i neri aspettavano da più di un secolo e non li si poteva più fermare. Il 28 agosto ci fu la marcia dei 250.000 a Washington, una pacifica protesta che impressionò i cronisti più sensibili. La moglie di King, Coretta, così descrive quell'imponente raduno: «Verso le dieci, le persone riunite erano circa novantamila, e, quando arrivammo noi, il grande viale verde era affollato da una massa di duecentocinquantamila persone. Erano arrivati a Washington da ogni angolo del paese, in aereo, in treno, in autobus, in macchina, in bicicletta e alcuni persino a piedi. Quasi un quarto dell'immensa folla era costituito da bianchi. Era uno spettacolo meraviglioso».
Durante quel raduno prese la parola Martin Luther King. La sua voce era accorata a tratti, ma più spesso vibrante e come indignata. «Invece di onorare i suoi sacri impegni, l'America ha dato ai neri un assegno a vuoto. Noi siamo venuti oggi qui per incassare questo assegno e non accetteremo che ci si dica che non c'è denaro nella banca della giustizia. Io sogno il giorno in cui i figli degli ex schiavi e degli ex proprietari di schiavi potranno sedersi assieme alla tavola della fratellanza. Io sogno il giorno in cui anche lo stato del Mississippi sarà trasformato in un'oasi di libertà e di giustizia. Io sogno il giorno in cui i miei quattro figli potranno vivere in questo paese nel quale non saranno giudicati dal colore della pelle, ma dalle loro doti personali».
È certo che la rivoluzione nera divampò in quel 1963 senza che nessuno potesse mettervi un freno. Non era stato John Kennedy ad avviarla, né avrebbe potuto far niente per fermarla. Ma, commenta Sorensen, «Kennedy ne favorì e chiarì le elevate aspirazioni». Richard Rovere sul «New Yorker» scriveva: «Per essere stato il primo presidente convinto che nessuna forma di segregazione è moralmente sostenibile o tollerabile, Kennedy fu venerato in molte famiglie nere e detestato in molte famiglie bianche del sud».
Jacqueline frattanto era in attesa del terzo figlio e i Kennedy avevano dovuto annullare un programmato viaggio di riposo in Europa. Purtroppo
Luigi Barbara 116 1985 - John Fitzgerald Kennedy
il parto fu prematuro e il piccolo Patrick jr. morì quasi subito nell'ospedale pediatrico di Boston. Kennedy passò l'intera nottata all'ospedale, dove il neonato, sistemato in una speciale «camera respiratoria», lottava tenacemente per sopravvivere al male che aveva colpito i suoi polmoni. Ci fu un momento in cui i medici parvero riprendere un certo ottimismo, ma nella notte si produsse un improvviso aggravamento e il cuore del piccino venne progressivamente a indebolirsi.
Il presidente, che era andato a dormire a mezzanotte, fu svegliato alle due e dieci e si recò subito presso il suo bambino. Fino all'ultimo istante, attraverso un oblò di vetro che dava nella camera a ossigeno, Kennedy dovette assistere, impietrito, agli sforzi dei medici per salvare il neonato. Il 9 agosto 1963, alle 4.04 del mattino, il piccolo Parick spirò dopo un'esistenza terrena di trentanove ore e dodici minuti.
Alle nove del mattino, il presidente, silenzioso e affranto, con sul viso un'espressione aperta di angoscia, lasciò l'ospedale di Boston per adempiere a una serie di tristi compiti: comunicare prima la notizia alla moglie Jacqueline, che si trovava all'ospedale di Camp Otis, a Cape Cod, e recarsi poi alla sua casa di Squaw Island per spiegare agli altri due suoi figlioli, Caroline e John jr., che il fratellino, di cui essi con tanta ansia attendevano la venuta, non sarebbe arrivato mai.
Kennedy arrivò in elicottero da Boston a Camp Otis alle nove e mezzo e si recò immediatamente al capezzale della moglie. Ma Jacqueline sapeva già. Alle sei e mezzo del mattino aveva ricevuto l'annuncio della morte di Patrick dal suo ostetrico, dottor Walsh, ed era scoppiata in una crisi di pianto, che si ripeté alla vista del marito. «Jack, no, non è possibile», mormorò Jacqueline fra i singhiozzi. Jack amorevolmente cercò di consolarla, ma anche lui tratteneva a stento le lacrime. Per un'ora i due coniugi rimasero chiusi nel dolore; poi, a loro, si unirono gli altri familiari accorsi all'ospedale di Camp Otis: i due fratelli del presidente Robert e Ted, la sorella Jean e la madre della signora Kennedy. Due ore dopo, Kennedy ripartì, sempre in elicottero, per la sua casa di Squaw Island, dove, ancora ignari di tutto, lo aspettavano gli altri due bambini. «Patrick non verrà mai da noi. Se ne è andato, lontano». Con queste parole, il padre fece capire ai figli che il fratellino era morto. Poi, dopo averli abbracciati teneramente, il presidente tornò da Jacqueline.
Cominciavano intanto ad arrivare sia alla Casa Bianca a Washington, sia a Boston e a Cape Cod telegrammi e messaggi di condoglianze da ogni
Luigi Barbara 117 1985 - John Fitzgerald Kennedy
parte degli Stati Uniti e del mondo. Fra i primi, la telescrivente portò un messaggio personale al presidente di papa Paolo VI.
Un'atmosfera di lutto si diffuse in tutta l'America, che aveva seguito con ansia negli ultimi due giorni il dramma del piccolo Patrick e dei suoi angosciati genitori. Il portavoce della Casa Bianca, Pierre Salinger, annunciò che i funerali del «baby Kennedy» si sarebbero svolti l'indomani a Boston, nella più stretta intimità. Solo i familiari presenziarono alla messa funebre, celebrata dall'arcivescovo di Boston, cardinale Richard Cushing, nella sua cappella privata. Fu cantata la «messa degli angeli» e la salma venne infine tumulata nella tomba di famiglia dei Kennedy nel cimitero di Brookline.
Un giornalista di New York, che fu vicino a Kennedy in quei momenti di dolore, così scrisse al suo giornale: «Un uomo ancora giovane, vestito di scuro, che da due notti non dorme e ha gli occhi rossi di pianto. Trentacinque minuti fa, questo padre disperato ha firmato quattro decreti legge; ora allunga una mano e per qualche secondo, in silenzio, la tiene sulla bianca cassetta che racchiude il suo bimbo. Qui sta cominciando l'autunno e una grande nuvola passa attraverso il cielo mentre il feretro di Patrick Kennedy scende nella terra».
Jack strinse i denti e tornò al suo posto di lavoro. Jacqueline, invece, preferì partire, da sola, per dimenticare. La sua meta era Atene, dove arrivò il 2 ottobre 1963. Ad attenderla all'aeroporto c'era la sorella, principessa Lee Radziwill, che l'accompagnò in crociera nell'Egeo, verso le isole Cicladi, sul panfilo Christine dell'armatore greco Aristotele Onassis, il quale le fece una calorosa accoglienza. Onassis non era sconosciuto ai Kennedy. Alcuni anni prima, infatti, essi erano stati ospiti del chiacchieratissimo armatore e una sera avevano cenato con lui sul panfilo in compagnia di un ospite illustre, il vecchio Winston Churchill, ormai decisamente sul viale del tramonto.
Luigi Barbara 118 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XVHA INIZIO L'ULTIMO VIAGGIO
Vi furono parecchie polemiche per la crociera di Jacqueline con Onassis, che approdarono addirittura in parlamento. Kennedy, comunque, tagliò corto. «È meschino polemizzare su queste cose. Io non intendo nemmeno star lì a controbattere. Lei piuttosto», fece il presidente rivolgendosi a Schlesinger jr., «ha continuato a scrivere la cronaca del mio viaggio a Berlino?».
Schlesinger rispose che aveva già ultimato il suo resoconto e, recatosi nel suo studio, tornò dopo cinque minuti con il manoscritto. Lo sfogliò e fermò la sua attenzione sulle fasi culminanti della missione di Kennedy a Berlino. E cominciò a leggere: «Quindi a Berlino, per l'accoglienza più entusiastica di tutte, con i tre quinti della popolazione di Berlino ovest nelle strade, ad applaudire, a gridare, ad agitarsi, a osannare, come se si trattasse del secondo avvento. Dopo la normale visita al municipio e la firma del libro d'oro, Kennedy compì la sua prima ispezione al "muro", che colpì e sconcertò a tal punto il presidente che era ancora amareggiato quando uscì dal municipio e affrontò la folla in ebollizione nella Rudolf Wilde Platz, compressa in una sola massa eccitata e sconvolta. Le sue parole furono sincere ma insolitamente dure». Schlesinger, a questo punto, fece una pausa e disse: «E ora, signor presidente, riferisco le sue parole. Le ricorda?». Kennedy fece cenno di continuare l'esposizione e Schlesinger, con tono più alto e solenne, ripeté un passo del discorso: «Ci sono molti al mondo che non capiscono o dicono di non capire quale sia il grande problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino! Ci sono alcuni che dicono che il comunismo rappresenta il futuro. Vengano a Berlino! E ci sono alcuni che dicono, in Europa e altrove, che potremmo collaborare con i comunisti. Vengano a Berlino! E ci sono perfino coloro che dicono che è vero che il comunismo è un pessimo sistema sociale, ma che permette di compiere progressi economici. Lass sie nach Berlin Kommen! Vengano a Berlino. Tutti gli uomini liberi, dovunque vivano, sono cittadini di Berlino, e perciò, come uomo libero, sono fiero di dire Isch bin ein Berliner».
L'avventura berlinese era stata esaltante, ma nuvoloni neri si profilavano sull'orizzonte del presidente. La questione vietnamita andava male, anzi
Luigi Barbara 119 1985 - John Fitzgerald Kennedy
malissimo, e gli Stati Uniti ne erano irrimediabilmente coinvolti. Il Vietnam doveva rivelarsi per Kennedy una delle più pesanti eredità dell'amministrazione Eisenhower.
Nonostante le critiche che in passato aveva rivolto alla politica francese e americana in Indocina, appena eletto presidente Kennedy si era visto costretto a sposare e a proseguire la politica dei suoi predecessori. Ma non era convinto di questa scelta e, a un collaboratore, domandava quale fosse la maniera più onorevole per sganciarsi dal Vietnam senza perdere la faccia. Il presidente conosceva personalmente e stimava moltissimo il cattolico Diem, il padrone di Saigon e del Vietnam del sud, anche se non approvava il suo viscerale antibuddismo e respingeva con sdegno i sistemi terroristici di governo di suo fratello Ngo Dinh Nhu, capo della polizia segreta del regime di Diem. Si arrivò al colpo di stato del 1° novembre 1963, che segnò la fine di Diem e del dispotico fratello Nhu. Schlesinger annota: «Era quasi inevitabile che, una volta o l'altra, i generali si rivoltassero contro un regime così dispotico e irrazionale come quello di Diem». E aggiunge: «Vidi Kennedy poco dopo che aveva saputo che Diem e Nhu erano morti. Non lo avevo visto così depresso dai tempi della baia dei Porci. Senza dubbio si rendeva ora conto che il Vietnam rappresentava il suo grande fallimento in materia di politica estera e che non vi aveva mai prestato veramente l'attenzione che meritava. Il fatto che i vietnamiti sembrassero pronti a combattere gli aveva fatto supporre che ci fosse una ragionevole possibilità di successo; dopo, l'ottimismo del 1962 l'aveva indotto a continuare».
Intanto, mentre la fatale meta di Dallas si avvicinava, si ripropose negli Stati Uniti il problema di Cuba e della forzata convivenza con Castro, il quale non smetteva di lanciare appelli rivoluzionari all'America latina. Il dittatore cubano disse, in un'occasione: «Noi non neghiamo la possibilità di una transazione pacifica, ma siamo ancora in attesa che questo si verifichi per la prima volta... Il dovere del leader e delle organizzazioni rivoluzionarie è di mettere in moto le masse, lanciarle nella battaglia. È ciò che hanno fatto in Algeria. È ciò che i patrioti stanno facendo nel Vietnam del sud». Eppure Castro era tutt'altro che malevolo nei confronti di Kennedy se arrivò a dichiarare in una pubblica intervista che poteva diventare un presidente anche più grande di Lincoln. E proseguì: «So, per esempio, che per Nikita Kruscev Kennedy è un uomo con cui si può parlare. Ho avuto quest'impressione da tutti i miei colloqui con Nikita
Luigi Barbara 120 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Kruscev. Personalmente, lo considero responsabile di tutto, ma voglio dire questo: in questi ultimi mesi è giunto a capire molte cose; e poi, in ultima analisi, sono convinto che chiunque altro sarebbe peggiore. Come uomo e come statista è mio dovere indicare quali potrebbero essere le basi per un accordo».
Fra Castro e Diem, fra l'incudine e il martello, a Kennedy non restavano che poche ore da dedicare alla famiglia e allo svago. Due mesi prima di Dallas i coniugi Kennedy si permisero un lungo weekend a Newport. Si servirono dell'Air Force One, l'apparecchio presidenziale, che era dotato di un lussuoso appartamentino privato. Il presidente, quel giorno, teneva in mano un cappello di feltro, lui che andava sempre a capo scoperto. Disse sorridendo a un uomo della scorta: «Bisogna che ne porti uno con me di tanto in tanto... Mi hanno detto che sto per uccidere l'industria cappelliera». A Newport Jacqueline appariva ancora demoralizzata per la perdita del piccolo Patrick e il marito le fu vicino con particolare affetto.
Durante quel weekend, Kennedy cercò in tutti i modi di distrarsi, giocando con Caroline e John-John, oppure facendo dei giri in elicottero. Durante uno di questi voli egli scorse l'equipaggio di una nave da trasporto allineato sull'attenti in suo onore. Ordinò allora al pilota di descrivere un cerchio a bassa quota per segnalare che aveva visto questo segno di rispetto e che l'apprezzava. Aveva sempre nel cuore la marina, che gli ricordava i tempi ormai lontani della giovinezza, allorché, semplice guardiamarina, si batteva per il suo Paese nel Pacifico.
Kennedy decise di affrontare il viaggio nel Texas perché lì il suo partito, quello democratico, si stava frantumando per i contrasti interni fra il governatore Connally e il senatore Yarborough. Il dissidio fra i due uomini politici rischiava di fargli perdere i 25 voti elettorali dello stato. Pertanto egli si propose di andare di persona, in loco, per appianare le cose, in un giro di anticipata campagna elettorale con tappe in alcuni centri importanti come Houston, San Antonio, Fort Worth e Dallas. Proprio Dallas, nell'imminenza dell'arrivo del presidente, era stata tappezzata di un manifesto con le foto di Kennedy di faccia e di profilo, come si usa coi gangster ricercati. Una vistosa scritta diceva: «Ricercato per tradimento» e sotto c'era un elenco di accuse.
«Quest'uomo è ricercato per attività proditorie contro gli Stati Uniti; 1) avendo tradito la costituzione (che egli aveva giurato di difendere) col sottoporre la sovranità degli USA all'ONU, controllata dai comunisti; col
Luigi Barbara 121 1985 - John Fitzgerald Kennedy
tradire i nostri amici (Cuba, Katanga, Portogallo); 2) affrontando male innumerevoli problemi concernenti la sicurezza degli USA (ONU, il "muro" di Berlino, rimozione di basi missilistiche, Cuba, il bando nucleare, ecc.); 3) trascurando di rafforzare le leggi per la schedatura dei comunisti; 4) invadendo illegalmente uno stato sovrano avvalendosi di truppe federali; 5) dando aiuto e incoraggiamento ai disordini razziali ispirati dai comunisti; 6) assegnando costantemente mansioni federali a degli anticristiani (negli uffici federali abbondano noti comunisti e gente estranea); 7) essendo stato colto a raccontare al popolo americano madornali menzogne, tra le quali alcune sulla sua vita privata, tacendo le sue precedenti nozze con relativo divorzio». Le accuse erano del tutto insincere e dettate da un odio profondo, il manifesto non essendo nulla più che un vile invito all'assassinio.
Il 21 novembre era un giovedì. Prima di colazione il presidente si infilò il busto, si allacciò le scarpe, la sinistra delle quali aveva una suola ortopedica dello spessore di circa sei millimetri. Indossò un abito sceltogli dal cameriere e fermò la cravatta con un fermaglio d'oro a forma di motosilurante: un ricordo della sua guerra nel Pacifico. Mise in tasca il portafogli contenente 26 dollari, una somma decisamente modesta, e la patente, dalla quale risultava abitante in Bowdoin Street, Boston. La patente aveva validità fino al 29 maggio 1965 e riportava le caratteristiche somatiche del possessore: statura metri 1,83, capelli castani, occhi grigi, data di nascita 29 maggio 1917. Il presidente non aveva con sé altri documenti. Si guardò allo specchio e si accorse che i suoi capelli erano ingrigiti. Ma Eisenhower continuava a chiamarlo «ragazzo», anche se, a quarantasei anni, aveva già superato l'età dello sviluppo. «Grazie, Ike», mormorò sorridendo e quindi intonò fischiettando un motivo allora di successo. Poi, battendo le mani, gridò: «Caroline! John!» e i bambini arrivarono di corsa, persino un po' affannati. John-John indossava un paio di pantaloncini scozzesi e Caroline era vestita con un abitino di velluto blu. Maude Shawa, la nurse, avevano detto ai piccini che i genitori andavano nel Texas. Il ragazzino restò indifferente, ma Caroline corse subito in camera sua per prendere l'atlante. Voleva sapere dove erano diretti papà e mamma. Poi, il presidente si mise a tavola, imitato dai figli. Jacqueline, nella sua stanza, si faceva pettinare e così Kennedy fece colazione solo con i figli, e intanto sfogliava i giornali e telefonava istruzioni al sottosegretario alla difesa Ross Gilpatric. Poi Caroline si alzò per andare a
Luigi Barbara 122 1985 - John Fitzgerald Kennedy
scuola. «Ciao, papà», e via di corsa inseguita dalla nurse che aveva il compito di scortarla sino alla macchina. Kennedy successivamente si recò nel suo ufficio, dove passò un'ora ricca di impegni: congedò due ambasciatori che partivano per remote destinazioni (Alto Volta e Gabon), telefonò al fratello Bob e quindi scrisse personalmente ai parenti di cinque militari caduti nell'adempimento del loro dovere. Mandò a due bambini texani il seguente messaggio: «Desidero sappiate che vostro padre era un bravo soldato, il quale diede ripetute dimostrazioni della sua obbedienza e della sua dedizione al dovere. Queste virtù gli hanno guadagnato il rispetto e l'ammirazione di coloro con i quali ha prestato servizio. Quando sarete più grandi capirete tutta l'importanza del servizio che vostro padre ha reso al suo Paese e sarà per voi motivo di orgoglio e di conforto sapere che i suoi compatrioti gli sono profondamente grati per il contributo da lui dato alla sicurezza della nazione. La signora Kennedy si unisce a me nell'inviarvi i sensi della nostra vivissima comprensione per la perdita di vostro padre». Quindi Kennedy ricevette Ted Sorensen con il quale doveva concordare i discorsi che avrebbe tenuto nel Texas. I testi furono approvati, ma mancavano di un pizzico di umorismo, che costituiva l'arma segreta del presidente. «Non c'è qualche buona storiella sul Texas?», domandò e Sorensen lo assicurò che sarebbe andato immediatamente a consultare lo schedario delle barzellette.
Via Sorensen, il presidente volle che si controllassero le previsioni meteorologiche. Nel Texas i prossimi due giorni sarebbero stati caldi e Kennedy chiamò al telefono la cameriera di Jacqueline per dirle di mettere nelle valigie qualcosa di leggero. Ma era troppo tardi: i bagagli erano già stati caricati sull'elicottero. Il presidente imprecò sottovoce; poi, rivolto ad un segretario, mormorò con una smorfia: «Se la immagina mia moglie nel caldo del Texas, tutta sudata, in quel tailleur rosa che ha scelto per il viaggio?». Poi trovò il tempo per fare una ramanzina al responsabile del servizio meteorologico che, a suo parere, non ne azzeccava mai una. «D'ora in avanti chiederò le previsioni alla mia segretaria. Caldo, caldo e la roba che Jackie ha messo nelle valigie va bene per il freddo. Tutta roba che non va!». C'erano i piccoli dilemmi da risolvere, come quello che gli proponeva Ted Reardon, un fedelissimo, che faceva presente a Kennedy, che, quell'anno, le feste di Natale e capodanno cadevano a mezza settimana. Durante l'amministrazione Eisenhower, in un caso simile, si era stabilito di assegnare mezza giornata di vacanza a tutti i dipendenti del
Luigi Barbara 123 1985 - John Fitzgerald Kennedy
governo, la vigilia di ciascuna festa. Il presidente, piuttosto seccato, fece presente a Reardon che si facevano già ventisei giorni di festa ogni anno. «E le truppe?», insistette l'interlocutore, «niente vacanze neppure per loro?». Kennedy si arrese a pregò Reardon di preparare il documento, che avrebbe firmato più tardi.
Era quasi giunta l'ora della partenza. Kennedy domandò dove fosse il figlio. Voleva portarlo con sé fino all'elicottero per averlo vicino il più a lungo possibile. Fuori pioveva, un'acquerugiola sottile ma insistente, e la nurse, la signora Shaw, riteneva opportuno che John-John non uscisse. Ma il padre fu irremovibile; ordinò che gli si mettesse la mantella e il berretto impermeabile a larghe tese. «Lo voglio con me», sibilò tra i denti e, in quei casi, era meglio non discutere.
Quando tutti furono sistemati sull'elicottero si notò l'assenza di Jacqueline. «Mai una volta in orario!», borbottò il marito che incaricò un suo collaboratore di andarla a cercare. Dopo dieci minuti, finalmente Jackie salì a bordo con due pezzi di lana bianca e un soprabito. L'abbigliamento adatto per la temperatura di Washington ma non per il Texas, dove avrebbe trovato il caldo.
L'elicottero decollò e Don Ellinger, un visitatore texano, mormorò: «Questo è un viaggio che al presidente non può portare nulla di buono, qualunque cosa accada». Dodici minuti dopo, l'elicottero si posò ad Andrews accanto all'Air Force One, l'apparecchio del presidente. Il piccolo John dichiarò che voleva partire anche lui per il Texas, e quando il padre gli rispose che non era possibile, scoppiò in pianto. Così Kennedy decise di lasciarlo sull'elicottero, perché il bambino in lacrime avrebbe attirato come cavallette i fotografi che erano in attesa e l'immagine di John-John sarebbe apparsa l'indomani sui quotidiani, in prima pagina, magari con il titolo: «Piccola tragedia infantile».
«L'aereo 26000», racconta William Manchester, «partì da Andrews alle 11.05, ora della costa orientale, pilotato dal colonnello Jim Swindal che, per volare, aveva a disposizione una macchina eccezionale di cento tonnellate, con un arredamento squisito e cabine dotate di isolamento acustico e aria condizionata. Sulla parete della lussuosa cabina del presidente, al centro della carlinga, sulle federe e sul vasellame, e su ogni telefono, c'erano riproduzioni dell'aureo sigillo di Kennedy».
A quella stessa ora, Jacqueline preparava un breve discorso da tenere in spagnolo alla lega dei cittadini uniti latinoamericani. Jackie voleva fare
Luigi Barbara 124 1985 - John Fitzgerald Kennedy
bella figura parlando l'idioma dei suoi ascoltatori e cominciava: «Estoy muy contenta de star en el grande estado de Texas». Poi, durante il volo la «first lady» si cambiò d'abito indossando un fresco abito bianco con cintura di pelle nera. Nel corridoio esterno comparve Joe Ayres, capo steward del 26000, il quale annunciò: «Stiamo per atterrare, signor presidente». A terra, intanto, fervevano i preparativi per organizzare una degna accoglienza a Kennedy, e il vicepresidente Lyndon Johnson si dava da fare per stabilire i posti da occupare e le rigorose precedenze. Quando si aprì lo sportello posteriore, Jacqueline comparve per prima, col suo sorriso timido e smagliante insieme. Dalla folla si levò un lungo evviva. Quando uscì il presidente ci fu un boato. Dopo i convenevoli di rito, si formò il corteo, preceduto da una macchina civetta della polizia locale che controllava il percorso. Kennedy prese posto su una Lincoln da quattro tonnellate, con Greer al volante, Kellerman vicino a lui, il governatore Connally con la moglie sugli strapuntini. I Kennedy erano dietro.
Ci furono screzi causati dal posto che ogni personaggio eminente avrebbe occupato nella comitiva e il senatore Yarborough rifiutò di salire sulla decapottabile di Lyndon Johnson.
Fra i due non correva buon sangue. Uno striscione ammoniva: «Signor presidente, lei si trova in una città segregata». Kennedy si chinò verso Connally per chiedere spiegazioni di quella scritta, ma le sue parole furono coperte dal rumore di un elicottero della polizia che si aggirava sopra.
C'era molta gente lungo il percorso, più di centomila persone e molti agitavano una copia del «Light», quotidiano di San Antonio, che recava in prima pagina un «hurrah» per il presidente e Jacqueline. Le prime parole dell'articolo, composte in neretto, suonavano: «Il presidente John F. Kennedy, in visita per la prima volta alla città dell'Alamo, è atterrato oggi a San Antonio fra l'entusiasmo della popolazione».
Le scuole avevano fatto vacanza, i negozi avevano esposto le decorazioni natalizie con sensibile anticipo, impiegati e operai erano tutti per le strade. I fedeli del partito democratico, convocati dai capi, facevano un chiasso infernale. Un grande cartello svettava sugli altri: «Benvenuto J. F. K. Bienvenido, señor presidente». Un altro era perentorio: «Jackie, vieni a fare lo sci d'acqua nel Texas». Quindi il corteo raggiunse il centro medico Brooks, che Kennedy doveva inaugurare con un breve discorso. «Noi siamo sull'orlo di una nuova grande era piena di crisi e di occasioni, un'era che sarà caratterizzata da conquiste e da sfide. È un'era che richiede
Luigi Barbara 125 1985 - John Fitzgerald Kennedy
azione, e gli sforzi migliori di tutti coloro che intendono sfidare l'ignoto e l'incerto in ogni fase dell'umana ricerca. È il momento degli esploratori e dei pionieri...». Nel reparto riservato alle autorità, un uomo vestito da prete, con una borsa nera, applaudiva anche a sproposito finché non venne afferrato per la collottola da un agente che aveva riconosciuto in lui un malato di mente.
Poi, l'aereo del presidente volò a Houston, dove l'accoglienza non fu così calorosa come a San Antonio. A Houston la maggioranza votava per i repubblicani e la destra locale aveva fatto erigere parecchi cartelli ostili lungo il percorso del corteo presidenziale. «Attenti, Kennedy vi sta rovinando. Abbasso i fratelli Kennedy, Kruscev e King» e intanto un biplano sopra il campo trainava un nastro bellicoso con la scritta: «Coesistenza uguale a resa». Il presidente arrivò accaldato al Rice Hotel. Il direttore dell'albergo, Max Peck, li scortò cerimoniosamente fino all'ascensore, che condusse Kennedy e Jacqueline fino al quarto piano, dove avrebbero occupato l'appartamento internazionale da 150 dollari al giorno.
Finalmente un attimo di respiro. Jack si tolse la giacca e la camicia umidiccia e si mise a sfogliare i giornali locali. Poi i Kennedy cenarono da soli prima del pubblico banchetto, dove fra un sorriso e l'altro non avrebbero certo avuto il tempo di mettere qualcosa sotto i denti. Seguì un tempestoso colloquio con Johnson, il loro ultimo colloquio.
In quell'occasione Jackie si aprì col marito e gli disse che il governatore Connally le era antipatico. «Non riesco a sopportarlo per tutto il giorno. Non riesco a sopportare quel suo star là seduto a dire tutte queste grandi cose sul suo conto. E poi sembra che non faccia altro che punzecchiarti tutto il giorno». Kennedy alzò le spalle e le rispose che non era il caso di farne una tragedia: lui era venuto nel Texas per aggiustare le cose non per complicarle. E Jacqueline si chiuse a riccio in se stessa. Rimase lì immusonita e le parve che il marito avesse torto, ma non arrischiò una parola in più.
Il presidente aveva ancora una sola giornata di vita e quelle ultime ventiquattr'ore non le dedicò alla moglie. Chiese invece di comunicare con Washington per salutare Caroline e John-John. Poi la grande comitiva presidenziale si rimise in viaggio per raggiungere Fort Worth: era ormai prossima la mezzanotte e la lunga giornata doveva ancora finire. Jacqueline era bersagliata dai flashes dei fotografi, ma seppe sempre darsi
Luigi Barbara 126 1985 - John Fitzgerald Kennedy
un contegno e, tramite un'amica, fece sapere agli scatenati «paparazzi» che quel giovedì «era stata una magnifica giornata e che la cordialità del Texas non è stata inferiore alla sua fama». In realtà era stremata e, approfittando di un attimo di pausa, si avvicinò al marito e sussurrò: «Jack, non ce la faccio più!». Kennedy le strinse affettuosamente una mano e le replicò di aver pazienza, che tutto andava per il meglio. «Oggi sei stata grande», lui disse. E tornarono in albergo.
Luigi Barbara 127 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XVIL'UOMO ALLA FINESTRA
Allo spuntare dell'alba del 22 novembre, un uomo si alzò prima del tempo e cominciò a preparare un grosso pacco prima di recarsi al lavoro. Senza dubbio non era la colazione poiché l'involto era troppo voluminoso. La sera prima, la signora Michael Paine, proprietaria della casa, aveva notato la luce accesa nell'autorimessa. L'uomo vi teneva alcuni suoi oggetti e una volta, la moglie, vi aveva veduto avvolto un fucile e lo aveva pregato di disfarsene. Ma lui non ne volle sapere. «Che cosa hai lì dentro?», domandò il diciannovenne Wesley Frazier, un collega di lavoro, quando l'uomo passò a prenderlo: «Oh, sono solo bastoni per le tende», rispose Lee Harvey Oswald. Chi era Oswald? Di lui si può dire che era nato il 18 ottobre 1939, a New Orleans, in Louisiana, ultimo di tre fratelli. Suo padre morì, per collasso cardiaco, due mesi prima che egli nascesse. La vedova, Marguerite, allevò malamente il figlio. Faceva l'infermiera e aveva poco tempo da dedicare al ragazzo, che marinava la scuola e passava le giornate a guardare la televisione o a leggere fumetti. All'età di tredici anni, per il suo vizio di disertare le lezioni, Lee e la madre furono convocati da uno psichiatra scolastico, il quale arrivò a queste conclusioni: Marguerite non capiva che l'appartarsi di Lee era una forma di «protesta contro la sua trascuratezza e rappresenta la sua reazione a una completa assenza di qualunque vita familiare». Il quoziente d'intelligenza di Lee era alto (118), ma le sue pagelle erano un disastro e, dopo aver finito la nona, abbandonò gli studi. Sulla scia del fratello Robert, si arruolò nei marines, ma fu una scelta poco appropriata per un giovane che non amava la disciplina. Comparve due volte davanti alla corte marziale e infine tentò di rifarsi una verginità riparando in Russia, dove chiese invano la cittadinanza.
Militando nei marines, Lee si era distinto nel tiro al bersaglio con fucile M-1, al poligono di San Diego. Nel 1961 sposò Marina Nicolaevna Pruskoca, dalla quale ebbe due figlie, Jane e Rachel. Dopo molti lavori e altrettanti licenziamenti, Oswald trovò un posticino sicuro al Texas School Book Depository, il cui sovrintendente, Roy S. Truly, gli assegnò una paga di un dollaro e venticinque l'ora. Fu un colpo di fortuna per colui che, a torto o a ragione, si considerava l'uomo più respinto degli Stati Uniti, il paria di una società ingiusta. Dati i precedenti, i suoi potenziali datori di
Luigi Barbara 128 1985 - John Fitzgerald Kennedy
lavoro alzavano le braccia al cielo e lo liquidavano con un secco: «Non fai per noi». Era povero, mortificato, rifiutato e - annota Manchester - «diametralmente l'opposto di John Fitzgerald Kennedy». E proprio questo giovane disadattato e reietto doveva appostarsi sulla strada luminosa del presidente per fulminarlo a colpi di fucile, in un cieco desiderio di rivincita.
Lui si sentiva sprecato in quel magazzino di libri ad annotare le ordinazioni che quotidianamente arrivavano; «doveva» emergere e decise di farlo anche a costo di un assassinio a sangue freddo.
A un certo momento, probabilmente durante il pomeriggio, si era introdotto di nascosto nel reparto spedizioni del Book Depository e aveva preparato un sacchetto di carta da pacco nel quale nascondere una carabina Mannlicher-Carcano calibro 6,5 con caricamento a manubrio. Dai giornali aveva saputo che il corteo del presidente sarebbe passato sulla strada sotto il magazzino. Era la sua occasione, era arrivato il momento di dimostrare che aveva fatto tesoro dell'addestramento nei marines. Soldato semplice, aveva acquisito il diritto di fregiarsi del distintivo di tiratore scelto. Aveva comperato la carabina per corrispondenza, sborsando ventun dollari e quarantacinque centesimi, dalla Klein's Sporting Goods Inc. di Chicago: in cambio di quel denaro gli era stato spedito il fucile col numero di serie C2766, con mirino telescopico a quattro ingrandimenti. Aveva firmato l'ordinazione col nome fittizio di Alek J. Hiddell. Anche il matrimonio di Lee andava a rotoli e gli screzi erano all'ordine del giorno, fomentati da un'amica di famiglia che mostrava un morboso attaccamento per Marina, la quale si lamentava che il marito, a letto, era un'autentica frana: «Non si comporta come un uomo». All'amica, che si chiamava Ruth, la signora Oswald fece le sue confidenze, ma tacque del fucile che il marito aveva a disposizione, dotato di cartucce militari corazzate con una velocità iniziale di 66.032 centimetri al secondo. Lee Oswald, senza farne parola alla moglie, aveva deciso di passare, a suo modo, alla storia, mettendo in atto un gesto tanto folle quanto criminale. Sì, il reietto Lee avrebbe ucciso il presidente e tutti i giornali avrebbero dovuto parlare di lui. Forse anche la televisione si sarebbe occupata «dell'impiegato» Oswald e questa prospettiva gli dava un intimo fremito di piacere.
Alla vigilia di arrivare a Dallas, Jacqueline prese in disparte il marito e gli fece un discorso serio. «Qui nel Texas tutti hanno le mani adunche, ti afferrano, non ti lasciano un attimo di respiro. Io ho paura per me, ma
Luigi Barbara 129 1985 - John Fitzgerald Kennedy
soprattutto per te». Kennedy, irritato, alzò le spalle e disse a voce vibrante: «Se qualcuno vuole uccidere il presidente degli Stati Uniti non è affatto difficile: non ha che da appostarsi all'interno di un palazzo a due piani, con un fucile munito di mirino telescopico». Poi fece cadere il discorso, facendo capire che non gli piaceva discutere di eventuali attentati.
Se la maggior parte della popolazione di Dallas si apprestava ad accogliere con calore il presidente, c'erano tuttavia notevoli frange di dissenso. All'ingresso del Trade Mart, dove si doveva tenere la colazione in onore dell'ospite, c'erano picchetti di studenti che inalberavano cartelli con le scritte: « Yankee go home», e, a caratteri rossi, «Ave, Caesar». Erano tutti appartenenti al consiglio dei cittadini bianchi indignati di Dallas e, ironicamente, si erano tappate le bocche con nastro adesivo per dimostrare, come scrisse un dimostrante su un foglio di carta consegnato a un cronista del «Times Herald», che «siamo imbavagliati». Uno degli studenti, che si era tolto quella sorta di sigillo, disse allo stesso cronista, scandendo le parole: «Noi non vogliamo qui il presidente. Qualunque cosa succeda è lui che l'ha voluto. Se ne torni a Washington. Noi del Texas non lo approviamo».
Alle 7.30 di quel 22 novembre 1963, a Fort Worth, il cameriere svegliò Kennedy e gli comunicò che pioveva.
Il presidente si lasciò sfuggire un «accidenti», mentre George (questo era il nome del cameriere) gli preparava l'abito per la giornata: un completo blu-grigio a due bottoni, una cravatta blu scuro e una camicia a righine grigie. La camicia era un capo che era stato appositamente ordinato da Cardin.
Kennedy lasciò la sua camera d'albergo e scese al pianterreno, dove ad attenderlo c'erano Johnson e gli altri notabili. La folla, davanti all'albergo, appena sulla porta si profilò la figura del presidente, cominciò ad applaudire freneticamente. Vi furono grida isolate: «Dov'è Jackie?». Il presidente indicò in alto, sulla facciata dell'albergo, e disse: «La signora Kennedy si sta organizzando. Le occorre un po' più di tempo, ma si capisce. Lei è molto più bella di noi».
Quando Jacqueline arrivò, si scatenò la bagarre: tutti montarono in piedi sulle seggiole per poterla vedere. I riflettori e le false candele dei lampadari emanavano una luce accecante, e per un attimo Jacqueline ebbe veramente paura. Non aveva mai affrontato situazioni del genere da sola;
Luigi Barbara 130 1985 - John Fitzgerald Kennedy
temeva di inciampare da un momento all'altro. Poi, in fondo alla sala, vide il marito che le sorrideva e si rinfrancò.
Una valletta portò i doni agli ospiti: un paio di stivaletti per Jacqueline, un largo sombrero per John. Quindi il presidente prese la parola. «Due anni fa a Parigi, mi presentai dicendo che ero l'uomo che aveva accompagnato in Francia la signora Kennedy. Provo un po' la stessa sensazione durante questo viaggio nel Texas. Nessuno mai si domanda che cosa indossiamo Lyndon e io».
Intanto a Dallas la pioggia era cessata. Oswald sorrise. Col bel tempo il presidente avrebbe viaggiato su un'auto scoperta. Proprio in quel momento Jacqueline, in un sussurro, ripeté al marito: «Jack, sii prudente. Qui la gente è cattiva. Non ti festeggia, non ti accarezza, ma ti artiglia. Non rischiare, il Texas non mi piace». Kennedy alzò gli occhi al cielo e mormorò: «Jackie, anche a me il Texas non piace, ma ora ci sono e devo sopportarlo. Presto torneremo a Washington e quest'incubo sarà finito».
Dallas, l'ultima tappa, era ormai vicina. I Kennedy si imbarcarono sull'aereo 26000, mentre l'autista che li aveva accompagnati fino alla pista dichiarava solennemente a un collaboratore del presidente: «Ma vuole proprio andare a Dallas? Quello è il peggior buco della terra».
Ed ecco Dallas. Simile a un grande gabbiano che si posa nel nido, l'aereo presidenziale, l'Air Force One, si abbassò sibilando verso la pista. Il comandante regolò i comandi perché soffiava un pericoloso vento di fianco e le ruote di sinistra toccarono la pista con uno stridio e una nuvola di fumo. L'apparecchio, dopo la vigorosa frenata, si diresse verso l'area di stazionamento dove la folla salutava agitando le braccia. Aspettando la scaletta, Kennedy scambiò qualche frizzo col suo cameriere, George Thomas.
Quando Jacqueline comparve al fianco del marito un boato si levò dalla folla che aveva invaso l'aerostazione Love. Erano le 11.37 antimeridiane, ora di Dallas. Ai piedi della scaletta il vicepresidente Johnson e la moglie attendevano pazientemente.
Gli uomini del servizio segreto erano sul chi vive, specie dopo che, meno di un mese prima, Adlai Stevenson, ambasciatore delle Nazioni Unite, era stato malmenato da un gruppo di dimostranti.
Oswald era solo al quinto piano del Texas Book Depository. Un suo collega, Charles Givena, lo vide e gli domandò sorpreso: «Ehi, ragazzo, non vieni giù? Fra poco passa il presidente!». Oswald rispose che non si
Luigi Barbara 131 1985 - John Fitzgerald Kennedy
sarebbe mosso da lì, perché a lui il corteo non interessava. Disponeva di una mezz'ora per gli ultimi preparativi. Fra pochi minuti l'oscuro e frustrato impiegatuccio sarebbe comparso sulle prime pagine dei giornali. Era la notorietà, se non la fama.
All'incrocio di Lemmon Avenue e di Lomo Alto Street, un gruppo di studentesse agitò freneticamente un cartello: «Signor presidente, si fermi, per favore, e ci stringa la mano». Il presidente sorrise, la limousine in cui si trovava - che seguiva l'auto che apriva il corteo su cui viaggiava il capo della polizia Curry - si arrestò, le ragazze protesero convulsamente le mani, quindi si ritirarono in buon ordine sul marciapiedi. Jacqueline cominciava ad avvertire il caldo e sudava. La colonna di mercurio di un termometro davanti a un impianto per l'imbottigliamento della Coca Cola era spaventosamente alta.
Jacqueline si mise gli occhiali, ma il marito la pregò subito di toglierli: la gente era venuta per vederla e quelle lenti scure le mascheravano il viso. La Lincoln presidenziale si fermò un'altra volta e Kennedy scese per stringere le mani a un gruppo di suore. A Dallas, il grande orologio della Merchantile National Bank segnava pochi minuti dopo mezzogiorno. Il presidente sorrideva, voltandosi a destra e a sinistra. Grida e applausi echeggiavano e riecheggiavano tra le facciate delle case, assieme al rauco rombo della scorta di motociclisti e agli scoppi degli scappamenti che si udivano di quando in quando, mentre i veicoli rallentavano o acceleravano per mantenere la stessa velocità del corteo.
Mentre stava per compiersi il drammatico destino di Kennedy, la moglie del governatore, la signora Connally, seduta sullo strapuntino di sinistra accanto al marito, si rivolse verso il presidente e disse: «Nessuno può affermare che Dallas non l'ami e non la rispetti, signor presidente». Parole che parvero ironiche nell'ambito degli eventi successivi. Ecco infatti profilarsi l'anonima costruzione del Texas Book Depository, un edificio tipico di periferia che stonava con le case di marmo e metallo che lo circondavano. Lee Oswald, ormai appostato, era perfettamente visibile agli spettatori sottostanti. Solo che nessuno levò gli occhi in alto, lungo la facciata della casa. Il corteo stava per arrivare e nessuno voleva perdere la visione, sia pure fuggevole, del presidente e della sua bella moglie. Un giovanotto vide Oswald col fucile spianato, ma non ebbe sospetti perché lo ritenne uno degli uomini disseminati per proteggere il presidente.
Erano le 12.30 e fra pochi minuti il corteo avrebbe dovuto arrivare al
Luigi Barbara 132 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Trade Mart per il banchetto.Oswald era sulle spine, rivoli di sudore gli colavano sulla fronte, mentre
sentiva il rombo delle motociclette che precedevano l'auto di Kennedy. Diede un'ultima occhiata alla sua arma. Non doveva tradirlo. Lui si sentiva pronto, anche se, a tratti, qualcosa nella mente vacillava. L'impresa era troppo grande per lui? No. Lui era grande. Il più grande di tutti. Non lo aveva mai capito nessuno. Nessuno al mondo si era accorto di lui. Tra qualche attimo il mondo avrebbe trattenuto il fiato. Il suo nome sarebbe comparso su tutti i giornali.
La televisione, il mondo intero - anche la Russia - avrebbero parlato di lui. Il suo nome avrebbe fatto notizia. Ecco il presidente, visibilissimo, sorride: saluta con la mano, ignaro che la morte sta per ghermirlo. Un altro passante alza gli occhi sulla facciata del Depository e vede il fucile spianato. «Perdinci», mormora a un vicino, «certo non si può dire che il servizio segreto non stia di guardia». Oswald prende la mira. È arrivato il momento. Si asciuga col dorso della mano il sudore sulla fronte. Una frazione di secondo prima delle dodici e trenta, Kennedy sta rivolgendo un ampio sorriso alla folla.
Luigi Barbara 133 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XVIIUN MINUTO LUNGO UN'ETERNITÀ
Quel sorriso di Kennedy fu l'ultimo. Poi ecco uno schianto secco e improvviso. Il presidente quasi certamente non udì lo sparo e non comprese che cosa l'avesse colpito. Era un pezzo di metallo sottile come una comune matita, che gli si era conficcato alle spalle, penetrando per sei o sette centimetri. Kennedy fu trafitto mentre si voltava a destra per salutare la folla e, istintivamente, si portò le mani alla gola. «Oh, no, no, buon Dio!», mormorò mentre si reclinava verso la moglie seduta alla sua sinistra sul sedile posteriore. «Oh, no, no, buon Dio!», furono le ultime parole del presidente che, da buon cattolico, invocava la protezione divina. Intanto, sul seggiolino, davanti a Kennedy, il governatore John Connally si voltò di scatto e una seconda pallottola lo colpì alla schiena, lo trapassò, gli ferì il polso destro e si conficcò nella coscia. Il terzo e ultimo colpo raggiunse il presidente alla nuca, all'altezza dell'orecchio, mentre era piegato in avanti. L'agente James M. Chaney, in sella a una motocicletta che procedeva a un metro e ottanta dalla Lincoln presidenziale, pensò che un'altra macchina avesse avuto un ritorno di fiamma o che fosse scoppiato un petardo. Frattanto John Connally si accasciava sullo strapuntino, come se qualcuno gli avesse vibrato un terribile colpo di maglio nella schiena. Si piegò su se stesso e vide le sue ginocchia coperte di sangue. Si avvicinò freneticamente alla moglie Nellie, alzò lo sguardo e vide le facce stupite di Kellerman e di Greer a pochi centimetri da sé. «No, no, no, no! Vogliono ammazzarci tutti e due», urlò, poi perse i sensi. In preda a una crisi isterica, Jacqueline gridò: «Oh, Dio mio, hanno ucciso mio marito. Jack! Jack!». Kennedy aveva alzato il braccio per toccarsi la volta cranica. Il sangue copioso si riversò in grembo alla moglie, su quel tailleur rosa, che oramai fa parte della storia.
«Un agente in motocicletta», scrisse un giornalista, «sterzò verso il marciapiedi e per poco non cadde dal veicolo... Un altro agente si gettò a terra estraendo la rivoltella... Un uomo, su una delle piccole aiuole erbose che fiancheggiano Elm Street, batteva selvaggiamente i pugni sulla terra... Un tizio spinse giù una donna per proteggerla... Altre donne fuggivano... Gli agenti del servizio segreto dietro l'automobile presidenziale impugnarono fucili e mitragliatori evocandoli, si sarebbe detto, dal nulla,
Luigi Barbara 134 1985 - John Fitzgerald Kennedy
come prestigiatori... Un uomo prese in braccio la sua bimbetta e si mise a correre, inseguito da un poliziotto... Altri si lasciavano sfuggire ansiti di costernazione... Che cos'era accaduto, in nome di Dio?... Poi, in un attimo, l'intera scena, che era parsa paralizzata, esplose come fosse animata da un movimento frenetico».
«Ci hanno colpiti. Presto, filiamo all'ospedale», gridò il capo della polizia, Curry, poi comunicò per radio al motociclista portaordini: «Va' all'ospedale, all'ospedale Parkland. Avvertili di tenersi pronti».
La Lincoln del presidente balzò avanti con uno stridio e, a oltre cento chilometri all'ora, si avviò verso il Parkland Memorial Hospital, distante poco più di cinque miglia. La signora Kennedy e la signora Connally stavano chine tenendo fra le braccia i mariti coperti di sangue. Un agente, che era saltato dentro la macchina mentre Jacqueline invocava aiuto, li accompagnava assieme a un altro agente che aveva occupato il posto accanto all'autista sul sedile anteriore. Qualcuno pregò di moderare l'andatura. «Se non è ancora morto, non vogliamo ucciderlo adesso».
La Lincoln del presidente raggiunse il Parkland alle 12.36, l'ospedale non era pronto. La signora Connally aveva udito dei singhiozzi soffocati venire dal sedile posteriore. Con voce arrochita Jacqueline stava dicendo: «È morto... L'hanno ucciso. Oh, Jack, oh, Jack, ti amo». Il cappellino a tamburello, preso da un vortice di vento, le scivolò sulla fronte e, con un gesto violento, Jackie se lo tolse e lo gettò per terra. Lo spillone le strappò una ciocca di capelli, ma Jacqueline non avvertì nemmeno il dolore.
All'una meno venti arrivava trafelato all'ospedale un umile sacerdote, padre Oscar L. Huber, settantenne, pastore della chiesa di Santa Trinità a Dallas. Il religioso aveva assistito, all'angolo di Lemmon Street e Regan Street, al passaggio del presidente, in mezzo a un gruppo di suore e bambini della scuola. Rientrato alla canonica, si era appena messo a tavola quando fu comunicata la notizia che avevano sparato a Kennedy e che veniva ora portato all'ospedale di Parkland. Di scatto l'anziano sacerdote si affrettò a salire al piano superiore per prendere la stola viola, il libro di preghiere e l'olio santo per amministrare l'estrema unzione. Quindi partì velocemente in macchina assieme al reverendo James Thompson. Il Parkland faceva parte della parrocchia di padre Huber, ed egli ritenne che potesse esservi bisogno di lui. E non si sbagliava. Fu lui a impartire l'ultimo sacramento al primo presidente cattolico degli Stati Uniti.
Il dottor Perry, strappato dal tavolo della mensa dal perentorio STAT, si
Luigi Barbara 135 1985 - John Fitzgerald Kennedy
diresse correndo verso il reparto chirurgico di emergenza. Una infermiera gli indicò la sala operatoria numero uno. Kennedy giaceva nella piccola stanza piastrellata in grigio e senza finestre su un lettino a rotelle di alluminio. Era denudato fino alla vita, senza scarpe e portava ancora il busto di sostegno per la sua imperfezione alla colonna vertebrale. Il chirurgo Charles James Carrice stava già intervenendo su di lui. Carrice, quando vide Perry, scosse la testa desolatamente. Disse: «Non c'è proprio nulla da fare. Il presidente è già morto». Cionondimeno il dottor Perry gettò a terra la giacca sportiva e un'infermiera lo aiutò a infilarsi i guanti di gomma. «Ecco qui l'uomo più importante del mondo», pensò fra sé e sé, «peccato che i medici non possano oramai fare più nulla per lui». Il dottor Carrice aveva già sistemato la cannula dell'ossigeno nella bocca del presidente, mentre il dottor Perry ne inserì un'altra attraverso un'incisione praticata nella gola. C'erano quindici medici accanto al lettino di alluminio. Uno dei medici notò a questo punto Jacqueline che si trovava lì vicina, come impietrita. «Preferirebbe uscire, signora?», domandò il dottor Kemp Clark, un neurochirurgo. «Possiamo sistemarla più comodamente fuori». Jacqueline rispose che voleva rimanere dov'era e, istintivamente, si mise in ordine la gonna del tailleur macchiata di sangue. Sebbene il dottor Carrice avesse già decretato l'inevitabile sentenza, lo staff dei medici non si diede per vinto. Si praticò una trasfusione di sangue di tipo 0 negativo al braccio sinistro e alla gamba sinistra del presidente; una sonda fu introdotta nel torace per impedire ai polmoni di afflosciarsi; fu inserito un apparecchio per accertare i battiti del cuore: un tracciato verde a zig zag avrebbe segnalato la vita, una linea retta la morte. Il dottor Clark vide soltanto la linea retta. Davanti all'ospedale era il pandemonio. Quando sull'uscio si profilò la sagoma di un poliziotto, i giornalisti gli si assieparono intorno trafelati. Tutti con una sola domanda: «Come sta?». L'agente, pallido in viso come un morto, rispose che il presidente era spacciato.
Intanto nella sala operatoria numero uno i medici si arresero di fronte al terribile verdetto: un miracolo era impossibile. Il dottor M.T. Jenkins chiuse le valvole delle bombole dell'ossigeno, mentre il dottor Charles Baxter, un chirurgo, si procurò un lenzuolo pulito e lo distese sul corpo del suo paziente, oramai senza vita. Jacqueline si fece avanti, si chinò e baciò il piede del marito; poi prese una mano di lui nella sua.
Gli agenti del servizio segreto si riversarono in massa attorno a Johnson,
Luigi Barbara 136 1985 - John Fitzgerald Kennedy
che era divenuto il nuovo capo dell'esecutivo. Tutte le precauzioni dovevano essere rivolte al nuovo presidente. Il vicecapo dell'ufficio stampa della Casa Bianca, Kilduff, si schiarì la voce e disse: «Signor presidente, bisogna fare una dichiarazione». Era la prima volta che qualcuno lo chiamava così; Johnson si voltò e, ricorda Kilduff, «mi guardò come se fossi un fantasma». Johnson replicò di aspettare per la dichiarazione, perché ancora non si sapeva se era una congiura comunista o no. Poi aggiunse, frettolosamente: «Farei meglio a uscire di qui e a tornare sull'aereo. Sono pronti ad accompagnarmi?». Kilduff rifletté, poi disse a Johnson: «Farò la dichiarazione appena sarà andato via lei».
E così fece, esattamente all'1.33 Kilduff convocò una conferenza stampa di emergenza, si inumidì le labbra e, sotto un fuoco di fila di flashes, prese a parlare: «Il presidente John F. Kennedy è morto oggi qui a Dallas verso l'una, ora legale centrale». I giornalisti non aspettarono altro e fuggirono precipitosamente in cerca di un telefono. All'1.35 i campanelli dell'UPI squillarono sulle telescriventi di tutto il mondo: «Il presidente Kennedy è morto». Kilduff di fronte ai pochissimi rimasti aggiunse in fretta: « È morto di una ferita d'arma da fuoco alla testa. Non ho altri particolari sull'assassinio del presidente. La signora Kennedy non è stata colpita. Il governatore Connally è stato colpito. Il vicepresidente non è stato colpito». Qualcuno della stampa domandò se Johnson avesse già prestato il giuramento e Kilduff disse di no. «No, Johnson è andato via».
Il dispaccio lampo interruppe al Pentagono una riunione che doveva occuparsi delle spese militari. La presiedeva il segretario alla difesa Robert McNamara, che rimase nella centrale delle comunicazioni che lo collegava con le forze armate americane in tutto il mondo. Le unità militari, dislocate nei continenti, ricevettero disposizioni di stare all'erta contro possibili attacchi esterni o sollevazioni interne. Alla Casa Bianca, l'assistente del presidente, Bundy, trasmise un radiomessaggio a un aereo che sovolava il Pacifico con a bordo il segretario di stato Dean Rusk, cinque altri membri del gabinetto e i loro assistenti. Rusk doveva incontrarsi con i ministri del gabinetto giapponese a Tokyo. Bundy si mise quindi a preparare documenti riassuntivi per il nuovo presidente. L'America non poteva fermarsi.
Luigi Barbara 137 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XVIIIL'AMERICA NON SI PUÒ FERMARE
Ci fu un febbrile scambio di cablogrammi e ovunque, nel mondo, fu diffusa la tragica notizia. Ora il nuovo presidente era Johnson e tutte le cure dovevano essere rivolte su di lui.
Lyndon Johnson si diresse all'aeroporto un quarto d'ora prima che arrivasse il bianco carro funebre con Jacqueline e le spoglie del presidente defunto. Conscio del suo nuovo ruolo, Johnson salì a bordo dell'Air Force One.
L'aereo era rimasto per oltre due ore sotto il sole cocente del Texas e a bordo non si respirava. O'Donnell disse a McHugh di far partire l'apparecchio e subito i motori si misero in moto ruggendo. Poi, d'improvviso, tacquero. Qualcuno corse nella cabina di pilotaggio per chiedere cosa fosse avvenuto. Il pilota, colonnello James Swindal, spiegò: «L'assistente stampa della Casa Bianca, Malcolm Kilduff, ha ordinato di fermare l'aereo per aspettare la signora Johnson e un giudice federale, il quale viene per far pronunciare il giuramento di insediamento a Lyndon Baines Johnson».
Soltanto allora la signora Kennedy e gli intimi di Jack seppero che a bordo c'era anche Johnson e che occupava a buon diritto il privatissimo sancta sanctorum presidenziale, con lo scrittoio, le poltrone e i due lettini. L'America non si fermava, non poteva fermarsi. Johnson si serviva già del telefono di bordo che gli consentiva di afferrare fulmineamente le redini del governo. Parlò per una decina di minuti ma tenne lontano i suoi più stretti collaboratori e pertanto nessuno saprà mai quali furono le prime disposizioni impartite dal nuovo presidente.
Passarono trenta minuti prima che «lady Bird» Johnson arrivasse all'aeroporto assieme al giudice distrettuale degli Stati Uniti, Sarah T. Hughes, di sessantasette anni, una donna minuscola, dal viso dolce, nominata da Kennedy nel 1961. Johnson si portò a passo svelto nel retro dell'apparecchio e invitò la signora Kennedy a seguirlo nella grande sala delle conferenze rivestita in oro, al centro dell'Air Force One. Disse: «Signora, vorrei che lei fosse presente alla cerimonia del giuramento». Il solo McHugh rimase a vegliare la salma, mentre Jacqueline si portò avanti con O'Donnell, Powers e O'Brien.
Luigi Barbara 138 1985 - John Fitzgerald Kennedy
Nella cabina si accalcavano ventisette persone e il caldo era insopportabile. Johnson aveva appena parlato al telefono con Robert Kennedy, il quale era tuttavia del parere che il giuramento avrebbe dovuto essere prestato al ritorno a Washington. Johnson replicò: «Il membro del congresso Thomas pensa che debba prestare giuramento qui».
Poche e semplici le sue parole. Queste: «Io giuro solennemente e affermo che assolverò fedelmente i miei doveri di presidente degli Stati Uniti». Stringendo in mano la piccola Bibbia rilegata in cuoio, che John Kennedy conservava nella sua camera da letto, Johnson alzò il braccio destro e ripeté con voce sommessa la formula e la coronò con un accorato: «Che Dio mi aiuti!». Erano esattamente le 14.38 di venerdì 22 novembre 1963. Il suo predecessore era morto da 98 minuti.
Il neopresidente si voltò verso la moglie in lacrime e la baciò sulla fronte, poi mise un braccio sulle spalle di Jacqueline e la baciò lievemente su una gota. Con voce rotta dai singhiozzi «lady Bird» prese la mano destra della vedova fra le sue e mormorò: «L'intera nazione piange suo marito». Tre minuti dopo aver giurato, Johnson impartì il suo primo ordine come capo dell'esecutivo: «E ora decolliamo».
Che faceva frattanto Lee Harwey Oswald? Qualcuno ha voluto ricostruire, minuto per minuto, i suoi movimenti dalle 12.30 di quel funesto venerdì 22 novembre 1963, dopo aver sparato contro Kennedy dal quinto piano del Book Depository. Alle 12.31 viene fermato dall'agente Marrion Baker, che impugna la rivoltella sul pianerottolo del primo piano. Truly, il direttore del Depository, spiega che Oswald è un suo dipendente e l'agente lo lascia andare. Il direttore rivolge la parola a Lee: «Non è terribile quanto è accaduto?». Il giovane borbotta una risposta e si avvia all'ingresso, dove si imbatte in Robert McNeil, un giornalista che gli chiede ansiosamente dove può trovare un telefono. Alle 12.40 Lee sale su un autobus tra Elm Street e Murphy Street, nel centro di Dallas, a sette isolati dal deposito. Alle 12.44 abbandona l'autobus bloccato dal traffico. Alle 12.47 sale su un taxi alla stazione degli autobus di Greyhound; resta silenzioso accanto all'autista, che lo giudica un «alcolizzato» rimasto senza bere per due giorni. Alle 12.54, dopo un percorso di quattro chilometri, scende dal taxi a cinque minuti di distanza dalla sua pensione. Si sente braccato ma è felice. All'una arriva alla pensione e non risponde al saluto della proprietaria. All'1.03 torna a uscire dalla pensione: si è armato di una pistola, che nasconde sotto la giubba. Al deposito, intanto, il signor Truly
Luigi Barbara 139 1985 - John Fitzgerald Kennedy
nota la sua assenza. All'1.15 Oswald è ormai scatenato. Viene fermato dall'agente Tippit, vicino a un drugstore. Reagisce e uccide Tippit, scaricandogli addosso quattro rivoltellate. In seguito verrà riconosciuto da nove testimoni.
All'1.16 viene dato l'allarme da un camionista, che si serve del telefono dell'autopattuglia di Tippit. All'1.22, con la pistola in mano, attraversa Patton Street; arriva a un parcheggio e vi lascia cadere la giacca. All'1.40 entra nel Texas Theatre, a atto isolati dal cadavere di Tippit, senza comprare il biglietto. All'1.50 viene arrestato nel cinema-teatro, dopo una lotta durante la quale tenta di uccidere un secondo agente. Grida: «Be', ormai è finita!». E poi, mentre viene trascinato via, urla come un ossesso: «Protesto contro la brutalità della polizia».
Alle 2.30, nella stanza 317 del comando centrale della polizia, cominciò l'interrogatorio di Oswald. Erano presenti Sorrels del servizio segreto e Hosty dell'FBI. Oswald tentò una timida difesa: «Il presidente morto? L'agente Tippit morto? Io non ho sparato a nessuno», mentre ancora non gli erano state sfilate le manette.
Un'autopattuglia, a sirene spiegate, corse al magazzino di libri e al sesto piano gli agenti trovarono un fucile, nascosto dietro un mucchio di libri, accanto alla finestra, attraverso la quale l'assassino aveva sparato. Vicino alla finestra rinvennero tre bossoli vuoti; erano dello stesso calibro del fucile, un Mannlicher-Carcano 6,5. Le indagini della polizia divennero allora febbrili: si accertò la provenienza del fucile, risalendo a un importatore di New York, che l'aveva spedito a una società di vendite per corrispondenza, la Klein.
Tutti gli agenti investigativi di Dallas furono mobilitati e il poliziotto A. Temper accertò che Lee Oswald era sposato con una russa, Marina, che fu rintracciata nella casa della signora Paine. Presa alla sprovvista, la signora Oswald vuotò il sacco: «Sì, mio marito ha un fucile. L'ha comperato mesi fa per corrispondenza». Oswald, meditando da tempo il suo piano, aveva cercato e trovato un recapito d'emergenza in una pensione, presso la quale si era registrato come O.H. Lee. Nella sua stanza gli agenti trovarono la pianta di Dallas (gliela aveva regalata la signora Paine perché avrebbe potuto essergli utile per trovare un impiego); una serie di X segnava il percorso del corteo presidenziale. La X più grande era stata tracciata davanti al magazzino di libri, il Book Depository, da una finestra del quale l'omicida avrebbe esploso i colpi mortali. Sulla mappa era tracciata anche
Luigi Barbara 140 1985 - John Fitzgerald Kennedy
una linea che indicava approssimativamente la traiettoria delle pallottole che avevano ucciso il presidente e ferito il governatore. Per di più, nella stanza si trovava una fondina, che si adattava perfettamente alla pistola calibro 38 sequestrata a Oswald. Nel suo rifugio nella pensione c'era anche una fotografia di Lee, armato con un fucile italiano e una rivoltella calibro 38. Ma gli investigatori rinvennero anche sul calcio del fucile una fibra marrone identica a quella del tessuto della giacca di Oswald.
Alle 14.47 l'Air Force One decollò dall'aeroporto Love di Dallas. Salito alla quota di quattordicimila metri, il colonnello James Swindell mise in orizzontale il grande apparecchio e si diresse sulla rotta di Washington alla velocità di oltre mille chilometri l'ora. Nella camera da letto presidenziale, Johnson si mise subito al lavoro per preparare un breve discorso che avrebbe letto al suo arrivo nella capitale. Riportiamo qui uno stralcio di una cronaca del tempo: «Più avanti, in un'altra cabina, il maggior generale Chester Clifton, l'aiutante militare di Kennedy, trasmetteva dispacci impartendo disposizioni sul cerimoniale dell'arrivo alla base aerea di Andrews e sul trasporto della salma all'ospedale navale di Bethesda. La signora Kennedy sedeva allo scrittoio al lato opposto del passaggio rispetto alla bara del marito, nella minuscola sezione di coda. Kenny O'Donnell, Dave Powers, Larry O'Brien e Godfrey McHugh le stavano intorno in piedi, piccola guardia d'onore di fedelissimi, frugandosi disperatamente la mente in cerca di qualcosa da dirle. A un certo momento la signora Kennedy indicò la sedia vuota accanto a sé e invitò O'Donnell ad accomodarsi. Egli accettò, ma solo per breve tempo. Il sibilo incessante dei motori a reazione invadeva il silenzio imbarazzato, soffocando pietosamente i singhiozzi trattenuti e i sospiri di dolore». Jacqueline aveva gli occhi pieni di lacrime.
Luigi Barbara 141 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XIXGLI ULTIMI QUATTRO GIORNI
Jacqueline cominciò a parlare a bassa voce e con commozione di suo marito. Disse: «Era un uomo meraviglioso e un padre eccezionale». Istintivamente parlò delle cose che bisognava fare nei prossimi giorni. «Jack dev'essere orgoglioso di me. I funerali devono essere dignitosi, ma imponenti, semplici e pur confacenti all'alta carica della presidenza, onoranze funebri che avrebbero incontrato l'approvazione di mio marito». C'erano anche le visite di condoglianze delle quali dover tener conto. Sull'aereo i Johnson vennero a trovare Jacqueline: lui rimase silenzioso e lasciò che la moglie esprimesse i motivi del loro cordoglio. La signora Johnson era una donna e la signora Kennedy la trovava simpatica. Col viso bagnato di lacrime, la nuova «first lady» disse singhiozzando: «Oh, Jackie! Sa, non ci abbiamo mai tenuto a essere vicepresidente e ora, buon Dio, si è arrivati a questo!». Jacqueline rispose che avrebbe preferito non aver accompagnato il marito nel Texas. «È terribile, ero così contenta di essere qui».
La signora Johnson notò che Jacqueline aveva ancora gli abiti e i guanti sporchi di sangue e propose: «Vuole che chiamiamo qualcuno per aiutarla a mettersi della roba pulita?». Jacqueline si schernì: forse più tardi si sarebbe cambiata.
A meno di un'ora da Washington, Johnson si servì dello speciale radiotelefono dell'apparecchio e chiamò la signora Rose Kennedy a Hyannis Port. Le disse: «Vorrei, in nome di Dio, poter fare qualcosa. Desideravo solo farle sapere questo». Poi passò il ricevitore alla moglie. «Lady Bird» singhiozzò: «Ci sembra che ci sia stato strappato il cuore. Il nostro affetto e le nostre preghiere sono con lei».
Una piccola falce di luna stava salendo nel cielo nuvoloso quando l'Air Force One atterrò alla base aerea di Andrews: a bordo c'erano due presidenti, l'uno morto in un vile attentato, l'altro subentratogli a norma della costituzione.
In quel momento gli operatori della televisione spensero i loro riflettori per non abbagliare il pilota, mentre un autocarro giallo con una piattaforma di sollevamento si dirigeva verso l'area di stazionamento. D'un tratto i riflettori si riaccesero, avvampando nella sera incipiente. Bob Kennedy salì
Luigi Barbara 142 1985 - John Fitzgerald Kennedy
di corsa la scaletta, mentre la guardia d'onore, irrigidita sull'attenti, aspettava la grigia autoambulanza della marina.
Ecco il passo di una cronaca di quel giorno: «Otto uomini salirono per reggere la bara, ma i giovani che avevano accompagnato da Dallas le spoglie mortali del presidente decisero altrimenti. Sarebbero stati loro la guardia d'onore; loro avrebbero sorretto la bara. John Kennedy poteva contare su di loro un'ultima volta. E così fu che i più intimi dei vecchi amici, Kenny O'Donnell, Larry O'Brien, Dave Powers e Godfrey McHugh, sollevarono e trasportarono con tenerezza il corpo del loro compagno caduto fino alla piattaforma del montacarichi. La bara pesava più di mezza tonnellata, ma bastarono due militari per aiutarli.»
«Come sempre, Jacqueline Kennedy decise di rimanere al fianco del marito. Discese con la bara sulla piattaforma del montacarichi, e rifiutò l'offerta di un'automobile in attesa. Assieme a Bob e McHugh salì senza alcun aiuto sull'autoambulanza, dopo la bara. Non v'erano posti a sedere nell'angusto compartimento posteriore dell'ambulanza e così tutti e tre percorsero il tragitto fino all'ospedale di Bethesda seduti sul pavimento con le braccia appoggiate al feretro del presidente defunto».
Lyndon Johnson scese a sua volta dall'aereo e scambiò frettolose strette di mano con i funzionari che erano venuti ad accoglierlo. Poi, con passo misurato e solenne, si diresse verso i microfoni e lesse il messaggio che aveva scritto in volo. Il messaggio fu breve, scarno, implorante: «Farò del mio meglio. È tutto quello che posso. Chiedo il vostro aiuto e quello di Dio». Poi il neopresidente con la moglie salì su un elicottero, che lo portò sul prato sud della Casa Bianca. Frattanto nel gelido obitorio con piastrelle bianche dell'ospedale di Bethesda, la salma di John Kennedy venne sottoposta a una penosa autopsia. Il cadavere venne completamente esaminato ai raggi X per individuare qualsiasi altra pallottola o scheggia, e gli organi vitali furono studiati allo scopo di determinare la causa precisa della morte.
Un impresario di pompe funebri preparò la salma per la sepoltura, e le spoglie imbalsamate vennero deposte in una nuova bara di mogano. Infatti, alcune maniglie e certe decorazioni di bronzo della bara nella quale il cadavere era venuto da Dallas erano rimaste danneggiate durante il viaggio. Jacqueline, in quel momento, ricordò una conversazione avuta con Jack alla fine del loro primo anno alla Casa Bianca. Erano appena rientrati, dopo il funerale di Tony Biddle, e lei aveva accennato alla loro
Luigi Barbara 143 1985 - John Fitzgerald Kennedy
possibile morte: «Dove ci seppelliranno, quando saremo morti, Jack?». Il marito aveva risposto: «A Hyannis, penso. Saremo tutti là». E Jacqueline: «Secondo me, tu non dovresti essere sepolto a Hyannis, ma ad Arlington. Tu appartieni a tutto il Paese». Il presidente aveva poi interrotto quel dialogo funereo con una risata spontanea e liberatrice.
Riportiamo un brano di un cronista dell'epoca: «Jacqueline, sola con il suo dolore in un appartamento al diciassettesimo piano dell'ospedale, pensava all'avvenire. Suo marito aveva vissuto in un mondo di eroi. La storia significava per lui gli uomini, non gli eventi, ed egli aveva fatto affettuosamente il ritratto dei suoi eroi prediletti in un libro, vincitore del premio Pulitzer, nel quale erano descritte le solitarie figure che avevano osato opporsi all'opinione pubblica. Jacqueline decise che la sua morte doveva essere ricordata come quella di un eroe. Le sue onoranze funebri dovevano essere quelle di un eroe; la sua tomba quella di un eroe».
Dall'ospedale Jacqueline telefonò al pittore William Walton per pregarlo di cercare un certo volume nella biblioteca della Casa Bianca, volume che conteneva disegni e fotografie dei fastosi funerali di Abramo Lincoln. Arthur Schlesinger jr., storico e consigliere della Casa Bianca, e Richard Goodwin, del Peace Corps, andarono immediatamente nella biblioteca del congresso per altre ricerche sui riti funebri di Lincoln. Anche Paul C. Miller, l'esperto di onoranze funebri del Pentagono, fu mobilitato; egli si preoccupò di portare alla Casa Bianca una copia riveduta di recente del Regolamento dei funerali di Stato, militari e speciali. Jacqueline era come invasata; voleva onoranze imponenti. Nella notte una berlina della Casa Bianca arrivò all'ospedale di Bethesda e l'autista salì al diciassettesimo piano con una valigetta per la notte sulla quale figuravano le iniziali J.F.K. e un beauty case della signora Kennedy, ma Jackie non si cambiò. Per lei era come se il tempo si fosse fermato alle 12.30 di quel drammatico venerdì, laggiù nella calda Dallas, migliaia di chilometri lontano.
Johnson, dal canto suo, andava prendendo un po' alla volta coscienza del nuovo stato. Ora era presidente e bisognava affrontare le prime decisioni per superare il periodo pericoloso dell'«interregno». In elicottero arrivò alla Casa Bianca col segretario alla difesa McNamara e con il sottosegretario di stato George Ball. Attraversò a passi veloci il prato sud e, davanti alle porte finestre per le quali si accedeva allo studio ovale del presidente, sostò un attimo in silenzioso raccoglimento. Poi, quasi facendo forza a se stesso, entrò nello studio, da solo. Per la prima volta si trovava lì
Luigi Barbara 144 1985 - John Fitzgerald Kennedy
come presidente degli Stati Uniti, già assillato dal cumulo di responsabilità della carica. Le segretarie di Kennedy, in lacrime, avevano già sgomberato la scrivania di tutti i ricordi personali: la noce di cocco sulla quale era stato scritto l'SOS quando la sua motosilurante era stata affondata da un cacciatorpediniere giapponese nel Pacifico meridionale; il calendario d'argento che ricordava le date della crisi cubana; le fotografie in cornice di Jackie e dei bambini.
Nell'attigua sala del gabinetto, gli assistenti avevano già sistemato taccuino e matite per la riunione dell'indomani, spostando la sedia di Johnson a un'estremità del lungo tavolo, al posto del dirigente numero uno. La vita scorreva in fretta e gli uomini si erano già fatti una ragione. Ora c'era un nuovo capo e occorreva mettersi ai suoi ordini, dimenticando, sia pure col pianto in gola, il predecessore.
Johnson rimase, quella sera, ben poco alla Casa Bianca, perché aveva deciso di lavorare nel suo ex ufficio al secondo piano dell'Executive Office Building. Per prima cosa, telefonò agli ex presidenti Harry Truman e Dwight Eisenhower per chiedere (e lo ottenne) il loro appoggio nel difficile periodo di transizione. Truman, ormai avanti negli anni, parlò con lui una decina di minuti e spesso la comunicazione fu interrotta dai singhiozzi. «Non posso credere, non posso credere», continuava a ripetere il vecchio presidente. Subito dopo, Johnson chiamò al telefono il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, e gli ordinò di impegnarsi a fondo per raccogliere tutte le prove contro l'assassinio di Kennedy. «I suoi uomini devono considerarsi mobilitati finché il killer non sarà messo con le spalle al muro». Hoover replicò: «Faremo il possibile e l'impossibile. Non dormiremo finché il caso non sarà risolto». Johnson ricevette poi i leader di entrambi i partiti al congresso, i quali gli assicurarono caldamente l'unità in quel terribile frangente. Un cameriere filippino servì la cena su un vassoio alla scrivania del presidente, che frattanto conferiva con alcuni suoi vecchi amici: George Reedy, Bill Moyers e Walter Jenkins. Alle 21.24 Johnson uscì dall'ufficio e fu accompagnato in macchina a «The Elms» (gli olmi), la sua residenza nel quartiere Spring Valley di Washington.
Quella notte Johnson scrisse le sue prime due lettere come presidente degli Stati Uniti. Erano dirette a Caroline e John-John Kennedy. Le lettere erano brevi e commosse: i due bambini le avrebbero capite anni dopo, quando la madre gliele fece rileggere perché comprendessero «chi era stato
Luigi Barbara 145 1985 - John Fitzgerald Kennedy
il loro papà».Il presidente convocò poi a casa sua il capo del servizio segreto Jim
Rowley e gli disse dell'eroismo dell'agente Rufus Youngblood, che aveva fatto da scudo ai Johnson con il proprio corpo. «Voglio che lei faccia tutto il possibile, il massimo che si possa fare per quel ragazzo», disse Johnson a Rowley. Prima di andare a coricarsi, il presidente si trattenne con alcuni amici intimi nel suo studio, guardando la televisione. Ma quando sullo schermo apparvero film di John Kennedy che stringeva centinaia di mani tese, a Dallas, ordinò di spegnere il televisore. «Credo proprio di non poter resistere a vederlo», disse. E così quel venerdì, il 22 novembre 1963, si concluse infine, se Dio volle.
Luigi Barbara 146 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XXIL MOMENTO DELL'ESTREMO ADDIO
A Dallas la polizia tratteneva Oswald con una certezza che andava crescendo di ora in ora. «Questo è il nostro uomo», dicevano. Ma il destino di Oswald era già segnato: contro di lui non sarebbe mai stato intentato un regolare processo. La scena fu brutale e fulminea. Verso le 11.20, dalla centrale di polizia uscì il capitano Fritz. Dietro veniva Oswald, ammanettato. L'agente Leavelle lo teneva per il braccio destro, l'agente L.C. Graves per il sinistro. Lee indossava un maglione nero e un paio di calzoni di cotone: sul viso recava ancora i segni della zuffa immediatamente precedente il suo arresto. Uno dei molti giornalisti presenti, François Pelou, avrebbe poi raccontato: «Oswald socchiudeva un po' gli occhi a causa dei riflettori abbaglianti, ma uscì calmissimo, con un'ombra di sorriso. Poi un uomo con un vestito marrone e il cappello, che si era tenuto quasi rannicchiato, gli si avventò contro».
Il poliziotto B.H. Combest intravide il movimento fulmineo dell'uomo che subito riconobbe. Urlò come un ossesso: «Jack, figlio di un cane!». Ma non riuscì ad agguantarlo. L'aveva riconosciuto, questo sì: era Jack Ruby, di cinquantadue anni, proprietario di equivoci locali notturni. Così il capitano Fritz tratteggiò il ritratto di Ruby: «Amico marginale della polizia, un individuo nervoso, invadente, che alimentava la fornace del suo io vantandosi di essere sempre a conoscenza delle segrete cose». Riferiamo qui un brano assai efficace di una cronaca del tempo: «Ruby sparò un solo colpo. Quasi simultaneamente alla detonazione della sua corta rivoltella calibro 38, si udì il grido acuto e animalesco di Oswald. Oswald batté le palpebre e abbassò le braccia incrociate, come per proteggersi, alla vita. Ma troppo tardi. Il proiettile era andato a segno un paio di centimetri sotto il cuore. Lee stramazzò a terra. E, esattamente quarantasette ore dopo che John Fitzgerald Kennedy era stato assassinato, a Dallas scoppiò di nuovo il pandemonio». Si assisté a una specie di amara comica, con gli agenti che cercavano di trascinare indietro Oswald. Fritz e i suoi uomini balzarono addosso a Jack Ruby, lo immobilizzarono rapidamente e gli tolsero l'arma. Bob Jackson, fotografo del «Times Herald» di Dallas, scattò una fotografia proprio nell'istante in cui Oswald veniva raggiunto al petto, una smorfia di dolore e quasi di incredulità sul
Luigi Barbara 147 1985 - John Fitzgerald Kennedy
viso. Quella fotografia sarebbe diventata «storica». Milioni di americani assistettero in diretta alla drammatica scena, trasmessa dalla NBC sull'intera rete nazionale.
Oswald fu portato all'ospedale Parkland, lo stesso in cui era morto Kennedy e giaceva, ancora in gravissime condizioni, il governatore Connally.
Privo di sensi, bocca spalancata, il colorito terreo, Oswald scuoteva la testa a destra e a sinistra, a ritmo lento, come in un presagio di morte. Molti dei medici, che si erano prodigati invano per salvare la vita al presidente, erano ora attorno al suo assassino. Il proiettile sparato da Ruby aveva perforato la milza, il pancreas, un rene e il fegato, ledendo la più grande vena e la più grande arteria del corpo. I chirurghi riuscirono a bloccare l'emorragia. «Eravamo quasi riusciti a salvarlo», dichiarò uno di essi a un giornalista.
Alle dodici e quaranta, tuttavia, il cuore di Lee Harvey Oswald cessò di battere e inutile risultò un estremo tentativo di massaggio cardiaco.
Al comando di polizia Jack Ruby, imputato di omicidio, fu rinchiuso in carcere. I reporter gli gridarono: «Perché l'hai fatto, Jack?». Jack li fissò, battendo le palpebre, e non rispose.
Rimangono così ansiosi interrogativi. E se Ruby avesse agito per conto di altri? Se non era che la tessera di un mosaico più vasto? Se avesse voluto che Oswald non parlasse? Sono domande alle quali l'inchiesta non saprà dare una risposta soddisfacente.
Domenica 24 novembre 1963 fu una giornata memorabile e non soltanto per gli Stati Uniti: i fastosi funerali del presidente Kennedy, la nera figura dell'impietrita Jacqueline, i due bambini, una folla strabocchevole, la telecronaca diretta di un omicidio. Il tempo si era rasserenato, a Washington. Rullavano i tamburi lungo Pennsylvania Avenue, dalla Casa Bianca al Campidoglio. Il corteo funebre ricorreva tristemente a ritroso l'itinerario seguito da John Kennedy durante la parata trionfale dell'insediamento. La bara era stata sistemata su un affusto di cannone (lo stesso che era stato usato per i funerali di Roosevelt) trainato da sette cavalli grigi. C'era tanta gente, ma un fatto meravigliò in particolare gli spettatori adulti: per la grande maggioranza quegli improvvisati immigrati di fine settimana erano sui vent'anni. Kennedy aveva quarantasei anni, ma la gioventù, ora ammassata sotto gli alberi spogli, l'aveva giudicato il
Luigi Barbara 148 1985 - John Fitzgerald Kennedy
leader della propria generazione. Kennedy era stato il presidente della giovinezza e ora tanti ragazzi lo piangevano in silenzio.
Rullavano i tamburi in Pennsylvania Avenue in un pomeriggio malinconico di domenica: la bella e giovane vedova guardava davanti a sé sotto il velo di pizzo nero con accanto Caroline e il piccolo John che schiacciavano il naso contro il finestrino, con il nuovo presidente degli Stati Uniti e la nuova «first lady» sui seggiolini ribaltabili. I capi di stato maggiore marciavano alti e impettiti, mentre un unico marinaio reggeva fieramente la bandiera presidenziale. Dietro la macchina di Jacqueline seguivano tutti i giornalisti accreditati presso la Casa Bianca. Lady Jean Campbell telegrafò all'«Evening Standard» di Londra che la vedova aveva «dato agli americani, da oggi in poi, l'unica cosa che era loro sempre mancata: la maestà». Portava il suo dolore, pensò un altro spettatore, «come una bandiera di coraggio». In riga per dodici, la delegazione straniera era formata da sedici file. De Gaulle, Hailé Sellassié, re Baldovino, la regina Federica, Ludwig Erhard, Ciung Hi Park della Corea del Sud e Diosdado Macapagal delle Filippine erano bene in vista nelle prime file. La parola a Manchester: «Gli spettatori, impressionati, credevano che i duecento uomini intorno a loro fossero anch'essi sovrani o capi di stato in lutto. In realtà, più di metà erano guardie del corpo armate, che sorvegliavano le finestre delle case. Circondavano Lee Radziwill e le sorelle Kennedy, ed erano così fitte intorno a Mikojan da nasconderlo completamente».
Il rappresentante sovietico, per ordine dell'esecutivo, aveva una protezione dieci volte superiore agli altri capi di stato estero. Al dipartimento di stato si dissero che la prudenza, dopo gli eventi di quei giorni, non era mai abbastanza.
Sulla scalinata di St. Matthew, a mezzo isolato da Connecticut, il cardinale Cushing attendeva sotto i paramenti neri e rossi e con un'alta mitria bianca. Jacqueline, quando lo vide per la prima volta, lo trovò «così... enorme». L'alto prelato, appena aveva visto il feretro del suo presidente svoltare in Rodhe Island Avenue, si era messo a piangere, asciugandosi gli occhi con mano tremante. Da anni il cardinale sapeva di essere condannato, poiché un tumore maligno gli aveva già intaccato la prostata e un rene, il tutto aggravato da una forma virulenta di asma e di enfisema. Eppure non mancava di mostrare una certa energia nei momenti di emergenza. La sua era una figura ieratica. Quando la fanfara
Luigi Barbara 149 1985 - John Fitzgerald Kennedy
dell'esercito finì il Saluto al capo e attaccò l'inno Pregate per i defunti, il cardinale accolse a braccia aperte la signora Kennedy e i suoi figli. La baciò e le permise di inginocchiarsi davanti a lui. Poi, come disse la signora Kennedy, «mi guidò, come un pastore, verso la chiesa». Il cardinale tornò indietro, seguito da un chierico che reggeva un crocifisso per la tradizionale antifona e il salmo in onore dei defunti cantato all'ingresso della chiesa. Diamo qui brani di una cronaca: «Lungo la Pennsylvania Avenue e la Costitution Avenue e nei giardini del Campidoglio sfilò il corteo, mentre le radioline a transistor, proprio in quel momento, gracidavano la notizia che anche Lee Harvey Oswald era morto. "Ben gli sta", avrebbero voluto dire, e taluni lo dissero davvero, ma non vi fu un grido universale di vendetta a diluire il dolore nelle vie sgomente. Le spoglie di John Fitzgerald Kennedy venivano trasportate per essere esposte sulla grande rotonda del Campidoglio sopra lo stesso catafalco che aveva accolto Abramo Lincoln. Nulla avrebbe potuto sminuire la solennità di quella scena. Il grido di vendetta si spense nelle gole, soffocato dall'eco luttuoso del rullare dei tamburi. A quelli che si assiepavano lungo la strada, la primitiva violenza di Dallas parve un mondo remoto».
Mai cerimonia era stata più suggestiva. Mentre nove uomini, i rappresentanti di tutte le armi e le specialità delle forze armate, portavano a spalle la pesante bara di mogano su per i trentasei scalini del Campidoglio, un coro di guardiamarina intonava a bassa voce l'inno della marina militare. Seguiamo ancora una cronaca dell'epoca: «Con gli occhi fissi nel vuoto, la signora Kennedy seguì i soldati su per la scalinata, conducendo per mano Caroline e John. Presero posto dietro i cordoni di velluto che separavano la bara e la guardia d'onore dai dignitari, dai senatori e dai rappresentanti, dai membri del gabinetto e dai giudici della corte suprema, dai diplomatici stranieri e dai consiglieri della Casa Bianca che si affollavano sotto la cupola. Carolina rimase impettita e immobile durante la lunga cerimonia, ma il piccolo John cominciò ad agitarsi irrequieto, a tirare il cappotto della madre, a fissare il soffitto, e poi a correre rumorosamente tra i militari e i dignitari. Una governante lo condusse nell'ufficio dello speaker, dove egli vide una bandierina sulla scrivania. "Voglio la bandiera. Voglio la bandiera", cominciò a gridare e dovettero dargliela. Più tardi, quando ricomparve nella rotonda, stringeva la bandierina nella mano guantata di bianco».
Esauriti gli elogi funebri, Jacqueline condusse Caroline verso la bara e la
Luigi Barbara 150 1985 - John Fitzgerald Kennedy
invitò a inginocchiarsi. Poi baciò la bara con commovente affetto, mentre la bimbetta toccava il legno duro e lucente.
Il presidente Johnson avanzò per rendere omaggio alla salma preceduto da un soldato che recava una grande corona di garofani rossi e bianchi con la scritta: «Dal presidente Johnson e dalla nazione». Poi i vari dignitari cominciarono a sfilare davanti alla bara: re Baldovino non tratteneva le lacrime. È il caso di fare un passo indietro. Nella cattedrale, pavesata a lutto, il cardinale Cushing distinse nettamente la fragile figura della madre di Jack ferma in disparte. Le si fece incontro e mormorò: «Rose, mia cara», e l'abbracciò. La madre del presidente, che, troppo sconvolta, non aveva partecipato alla processione, era giunta con Ann Gargan e Bobby Fitzgerald, un cugino. Fisicamente era prossima a un collasso, però si era fatta forza e non aveva vacillato. Nelle sue memorie, mamma Rose ricorderà: «Ho un ricordo assai vago di quei momenti. Ero come in trance. Vedevo mia nuora, alta, asciutta, forte, e mi facevo coraggio. Quello fu per me il giorno della mia prima morte».
Dal primo banco della cattedrale il piccolo John vide Ailé Sellassié: un amico. Ricordò che pochi mesi prima era venuto alla Casa Bianca portando alcuni doni: una pelliccia di leopardo per la mamma e un guerriero per lui. Il bambino gli sorrise e il negus si chinò su di lui e lo baciò. Due antichi amici si incontravano e il vecchio avvertì un affetto sincero per quel bambino che lo guardava con ammirato rispetto. Per il figlioletto del presidente tutta la cerimonia non aveva alcun senso. A un certo punto lo sentirono chiedere: «Dov'è il papà?». Il bambino alzò le mani: «Chi mi prende in braccio?», chiese. L'agente Foster, che si trovava poco discosto, lo condusse in fondo alla chiesa.
Manchester ricorda: «Secondo le previsioni, la salma del presidente avrebbe dovuto varcare la soglia della cattedrale alle 12.13. La decisione di Bob Kennedy di entrare nella rotonda aveva mandato all'aria i programmi degli ufficiali che correvano qua e là in macchina col cronometro in mano, ma la vedova, staccandosi rapidamente da Charles De Gaulle, aveva permesso al corteo di riguadagnare il tempo perduto, tanto che il feretro varcò la soglia della chiesa alle 12.14». La commozione si diffuse in tutto il mondo con le immagini che la televisione diffondeva da Washington. Il canale di Panama fu chiuso al traffico. Intorno al globo le bandiere di una novantina di Paesi scesero lentamente a mezz'asta. Le navi in alto mare gettarono corone fuori bordo. Settemila pezzi di
Luigi Barbara 151 1985 - John Fitzgerald Kennedy
artiglieria spararono ventun colpi di cannone in settemila basi militari americane, comprese quelle nel Vietnam, dov'era mezzanotte e quattordici minuti.
Un momento di grande commozione si ebbe quando Jacqueline, che fino ad allora era rimasta impietrita, quasi assorta in pensieri lontani, ebbe un lungo tremito e scoppiò in singhiozzi. Un amico le porse un fazzoletto: Caroline le strinse la mano come a volerla consolare. Poi il violento tremito cessò e la vedova si accinse a fare la comunione. A questo punto il cardinale Cushing, fra la sorpresa dei presenti, passò dal latino all'inglese. Fu, disse poi, «un'ispirazione come quando papa Giovanni indisse il concilio ecumenico. Prima non ci avevo mai pensato, ma a un tratto compresi la necessità di un moto umano». L'alto prelato, affaticato, improvvisò un'invocazione: «Possano gli angeli, caro Jack, condurti in paradiso. Possano i martiri accoglierti all'arrivo. Possa lo spirito di Dio abbracciarti e possa tu, come tutti coloro che hanno fatto il supremo sacrificio di morire per gli altri, ricevere l'eterno riposo e la pace. Così sia». Dicendo queste parole il cardinale piangeva.
Il viso di Jacqueline si inondò di lacrime e Caroline le strinse ancora una volta la mano. La signora Kennedy sentì la figlia dire: «Sta' tranquilla, mammina. Non piangere. Avrò cura di te». Ma Jackie si chinò sul piccolo John e gli mormorò: «John, ora puoi salutare papà e dirgli addio». La messa era finita. Ora cominciava l'ultimo atto della solenne cerimonia: il trasporto della salma al cimitero di Arlington.
Per tutto il viaggio le telecamere rimasero puntate sull'affusto di cannone e sulla fossa in attesa a cinque chilometri di distanza. E fu un bene, perché, altrimenti, si sarebbe potuto notare il caos che seguì l'uscita dei dignitari dal tempio. De Gaulle e Hailé Sellassié non trovarono subito le loro automobili e furono fatti salire su una macchina tenuta sgombra dalla polizia per i casi di emergenza. Ci fu una ventata di interesse, sui marciapiedi formicolanti di gente, quando all'angolo della Diciassettesima con State Place la terza berlina disertò la processione: Caroline e John-John tornavano alla Casa Bianca senza dovere assistere alla dolorosa sepoltura del loro babbo. Ad Arlington, in attesa della processione, c'erano i fucilieri, il trombettiere, i suonatori di cornamuse dell'aviazione, i cadetti irlandesi, un plotone per ciascuna delle armi americane. Un uomo era appollaiato su un albero e, dopo che ebbe ignorato quattro inviti a scendere, fu tirato giù con la forza. Manchester annota: «Era abbastanza
Luigi Barbara 152 1985 - John Fitzgerald Kennedy
ironico che John Kennedy, in cui il mondo aveva visto soprattutto un uomo di pace, e i cui successi più clamorosi erano stati il trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari e la felice soluzione, senza spargimento di sangue, della crisi cubana, dovesse venire sepolto come un guerriero, ma non c'era effettivamente altro modo. Se doveva finire in gloria, e chiaramente doveva essere così, le truppe erano inevitabili. Non c'erano né splendide tradizioni né sontuosi addii, per un eroe di pace». Gli F-105 sfrecciavano su Arlington, riempiendo col loro frastuono la quiete del cimitero e anche l'aereo di Kennedy, l'Air Force One, arrivò planando sul luogo della sepoltura. Il colonnello Jim Swindal, che per tre anni aveva accompagnato in ogni parte del mondo Kennedy, aveva un groppo alla gola ma non riuscì a piangere. Era troppo impegnato a eseguire il volo d'addio per il suo presidente. «Plotone, pronti per sparare tre salve!». Ai piedi del colle il sergente William Malcolm gridò: «Pronti!». Una squadra della vecchia guardia eseguì un dest-riga, percosse il terreno col calcio dei fucili, che poi spararono verso il cielo azzurro. Qualcuno disse: «Le secche detonazioni echeggiarono nei boschi cedui e nelle vallette di Arlington com'era accaduto, per questa squadra, in occasioni di altri quattromila funerali. Questa volta, però, ci fu una differenza. Altre due volte il sergente ordinò: "Puntate... fuoco!" e dopo la terza salva, mentre la squadra s'irrigidiva nel present'arm, un bimbo tra la folla cominciò a piangere. Alla signora Kennedy venne offerta una bandiera degli Stati Uniti. Con gli occhi pieni di lacrime prese in silenzio quel drappo che rappresentava la patria e per un attimo se lo strinse al petto. Non disse nulla: in quel momento la povera donna non era in grado di parlare».
Nessuno era in grado di far discorsi in quel momento. Né Bob né Ted se la sentivano. Stando a Jacqueline Kennedy, «fu durante il Silenzio, credo o subito dopo, che Ted, Bob e io ci guardammo e ci leggemmo negli occhi lo stesso pensiero; e Ted scrollò il capo come per dire "no" e Bob e io annuimmo; e siccome io ero la più vicina al cardinale, quando lui si rivolse a me, dissi: "No, eminenza"».
Un po' disorientato, Cushing fece di nuovo per prendere Ted a braccetto e Jacqueline ripeté in tono fermo: «Ho detto di no, eminenza». Manchester, al quale si deve la più fedele ricostruzione degli ultimi giorni del presidente, riporta: «Allora il cardinale si tirò indietro e abbracciò la moglie di Joseph Kennedy. "Arrivederla, mia cara. Il Signore sia con lei". Intanto il maggiore Converse aveva preso il suo posto. "Questo è il
Luigi Barbara 153 1985 - John Fitzgerald Kennedy
momento più triste della mia vita", disse a Jacqueline, e lei alzò lo sguardo al suo viso lungo e contratto e non poté non credere alle sue parole. Converse le porse lo stoppino e la guidò fino alle fronde di abete. Chinandosi sui rami, Jacqueline accostò l'estremità fiammeggiante al beccuccio della torcia, che subito prese fuoco. Poi passò lo stoppino a Bob, che ripeté il gesto e si rivolse alla madre, con l'intenzione di passarglielo a sua volta. Mamma Rose non lo vide. Nessuno le aveva parlato della fiamma perpetua. Stava a capo chino, in preghiera, e allora il figlio si voltò dall'altra parte per darlo a Ted. Ted non si aspettava quel gesto, ma accostò anche lui lo stoppino alla guizzante fiammella giallo-azzurra. Gli ufficiali del genio attendevano di vedere se il nuovo presidente si sarebbe fatto avanti. Ma Johnson non poteva. Era dalla parte sbagliata della fossa, bloccato dalle guardie del corpo, e il maggiore prese lo stoppino dalle mani di Ted e lo spense. La piccola cerimonia era finita».
Luigi Barbara 154 1985 - John Fitzgerald Kennedy
CAPITOLO XXILA COMMISSIONE WARREN
Scrive Longford nel suo libro su Kennedy: «L'assassinio di John Kennedy fu un'enorme tragedia per lui, per la sua famiglia, per tutti coloro che l'amavano e per l'umanità in generale. Ma per molti, forse per la maggior parte della gente, nel terribile incidente resterà sempre una parte di mistero». Mistero è la parola esatta, perché molte ombre sulla morte del presidente nemmeno l'inchiesta ufficiale è riuscita a dissipare completamente. Chi aveva armato la mano di Oswald? Perché Oswald fu assassinato proditoriamente da Jack Rubinstein, detto Ruby, che si era mescolato ai giornalisti mentre il «giustiziere» del presidente usciva ammanettato dalla caserma della polizia per essere trasferito nel carcere della contea?
Il 14 marzo 1964, Ruby fu condannato a morte e nel 1966 il tribunale del Texas riaprì il processo a suo carico. Ma Ruby morì poco dopo in carcere di cancro. Subito dopo l'arresto aveva dichiarato di essere stato spinto al suo gesto disperato proprio dalle condizioni della sua salute che non gli davano scampo. Sapeva di dover morire e così aveva ritenuto giusto agire contro Oswald per punire l'onta che aveva procurato alla città di Dallas.
Una cronaca apparsa otto anni dopo la morte di Kennedy poneva inquietanti interrogativi: «Era veramente Oswald l'assassino di Kennedy? Aveva agito da solo? Era il capro espiatorio di un misterioso complotto?». Per rispondere a questo fuoco di fila di domande, sette giorni dopo la morte di Kennedy, venne istituita una commissione presidenziale d'inchiesta sotto la direzione di Earl Warren, presidente della corte suprema degli Stati Uniti.
Come si divise il lavoro la commissione presieduta dal giudice Earl Warren? Il gran giurì d'inchiesta era articolato in sei gruppi. Il primo doveva accertare che cosa avesse fatto Oswald nella giornata del 22 novembre. Il secondo aveva il compito di portare alla luce la storia personale e i precedenti di Oswald. Il terzo doveva raccogliere e coordinare tutto il materiale possibile sulla permanenza dell'indiziato nell'Unione Sovietica e sul suo servizio militare nel corpo dei marines. Il quarto gruppo doveva far luce sull'assassinio commesso da Jack Ruby. Il
Luigi Barbara 155 1985 - John Fitzgerald Kennedy
quinto lavorava ai retroscena e ai precedenti dell'ineffabile proprietario di night, assurto al ruolo di vendicatore. E al sesto gruppo infine spettava di analizzare quali sforzi, precauzioni e decisioni erano stati adottati per proteggere la vita del presidente. La mole di lavoro svolto fu enorme. Tutti i possibili testimoni vennero ascoltati e taluni furono persino messi a confronto. Fu un'indagine lunga e difficile. Furono ascoltati 552 testimoni e raccolti più di tremila rapporti inviati dalle Law Enforcement Agencies che avevano fatto ventiseimila interviste. Le deposizioni riempirono ventisette volumi, dai quali risultava che Kennedy era stato effettivamente ucciso da Oswald e che l'ex marine aveva agito da solo. Anche Ruby, come Oswald, avrebbe agito senza la complicità di terzi. Il 28 settembre 1964, la commissione pubblicava il risultato dei suoi lavori. Nell'introduzione al rapporto Warren (pubblicato a New York dalla casa editrice Boutan Book), il giornalista Harrison E. Salisbury scrisse: «La ricerca della verità sull'assassinio di Kennedy è stata prolissa e ardua. La commissione Warren per quasi un anno ha svolto un'indagine esauriente su ogni minimo elemento di prova che è riuscita a scoprire. Per quanto riguarda la morte del presidente, gli elementi di prova che identificano in Lee Oswald l'unico colpevole sono indubbiamente schiaccianti».
Di questo parere non fu il filosofo Bertrand Russell, che criticò il rapporto dichiarando: «Il lavoro della commissione Warren è vergognoso. Le azioni e il comportamento della commissione sono simili ai processi contro i trotzkisti in Russia o al processo Dreyfuss in Francia». Ma che fondamento aveva l'ipotesi, peraltro assai vaga, di un complotto? Il giornalista Roberts, in proposito, cita le parole di un membro del servizio segreto: «Se questa è una congiura, è veramente grossa. Devono aderirvi i medici di Parkland, tutti i medici dell'ospedale Bethesda, l'intera commissione Warren, il ministero della giustizia e infine il ministro stesso della giustizia (Robert Kennedy), altrimenti non potrebbe funzionare». La fantasia galoppava. Si incolpavano gli americani ritenuti ostili a Kennedy, incluse le autorità di Dallas e la CIA; i leader sudvietnamiti che avrebbero agito per vendicare l'assassinio di Diem e del cognato; i comunisti russi alla ricerca del potere mondiale; Castro passato alla controffensiva dopo i presunti tentativi dei fratelli Kennedy di liquidarlo. Quest'ultima ipotesi venne avallata, in seguito, dal presidente Johnson.
Ma Longford è tassativo: «Contro questa teoria esistono vari elementi per ritenere che, se Kennedy fosse vissuto, lui e Castro avrebbero potuto
Luigi Barbara 156 1985 - John Fitzgerald Kennedy
cominciare a cercare un'intesa. In tal caso i cubani ostili a Castro sarebbero gli assassini più probabili». L'uccisione del presidente fu impressionante, ma quella di Oswald, perpetrata davanti alle telecamere sotto gli occhi di settanta poliziotti, può considerarsi addirittura sbalorditiva. Chi permise a Ruby, cittadino ben noto e per nulla rispettabile, di entrare nel seminterrato della polizia per sparare a un detenuto davanti a una fitta schiera di agenti? Qualcuno, non c'è alcun dubbio, doveva essere favorevole a quella straordinaria incursione.
Ufficialmente si accusò di negligenza la polizia di Dallas, ma resta il dubbio che esistessero moventi più segreti. Sono i misteri di quella città, che un periodico italiano così sintetizzò a posteriori, due anni dopo la tragedia. Il giornale elencò dieci misteri: 1) Quanti colpi furono sparati, tre o quattro? Quanti davanti a Kennedy e quanti dietro? 2) I medici affermarono che la ferita alla gola fu provocata da un colpo proveniente dal davanti. Allora ci fu un secondo tiratore. 3) C'è confusione sul fatto se, dopo l'assassinio, si siano trovati uno o due fucili. 4) Come fece Oswald a lasciare il deposito di libri se questo era bloccato dalla polizia? 5) Un'auto della polizia andò a prendere Oswald a casa sua e lo chiamò col clacson. 6) I verbali degli interrogatori di Oswald sono spariti. 7) Ruby riuscì a penetrare nel quartiere generale della polizia a dispetto della sorveglianza, in tempo adattissimo per uccidere Oswald alla presenza di settanta agenti. 8) Per due ore la polizia di Dallas non si preoccupò di perquisire il presunto omicida. 9) Sebbene fossero stati avvisati che qualcuno avrebbe tentato di uccidere il prigioniero, il capo della polizia di Dallas, Curry, e il capitano Fritz insistettero nel volerlo trasferire in pieno giorno davanti a una piccola folla e per la via più pericolosa. 10) Due mesi dopo il delitto, Warren Reynolds, che assistette alla fuga di Oswald dopo l'uccisione dell'agente Tippit, fu gravemente ferito.
Un attento americanista, il giornalista Ruggero Orlando, inviò da New York una corrispondenza nella quale, fra l'altro, scriveva: «L'uccisione di Kennedy è stata filmata da un dilettante, Abraham Zapruder. Con le pellicole c'è poco da barare. La velocità è di 18 fotogrammi e un terzo al minuto secondo. Tutto l'evento delittuoso ha impressionato 89 fotogrammi, esattamente dal 225° al 314° della pellicola. Ciò significa che il delitto si è svolto in meno di cinque secondi. Per l'esattezza in quattro secondi e otto decimi. In quattro secondi e otto decimi non si spara, per tre volte, ricaricandolo, riprendendo ogni volta la mira a quasi 300 metri, con un
Luigi Barbara 157 1985 - John Fitzgerald Kennedy
fucile Mannlicher-Carcano, residuato di guerra, non automatico. Senza tenere conto che il mirino telescopico è risultato fallace (spostava in alto a destra), che Oswald era un tiratore mediocre e fuori allenamento. È assolutamente impossibile, insomma, che un uomo solo abbia potuto uccidere Kennedy e ferire il governatore Connally».
Fra coloro che sono contrari alle risultanze della commissione Warren, c'è anche Michael Eddowes, che giunge alla conclusione che l'assassino fu un agente russo che si faceva passare per Lee Oswald, che Ruby era a conoscenza del complotto e che liquidò Oswald per impedire che durante il processo la verità venisse a galla. Louis Heren, recensendo il libro di Eddowes sul «Times», sottolinea un'enorme pecca: l'autore vorrebbe indurci a credere che i cinesi si erano accordati con i russi per assassinare Kennedy avviato alla conquista del mondo. Ma nel 1963 l'idea di una simile collaborazione tra Cina e Russia era inconcepibile. Analizzando il libro di Eddowes, Longford scrive: «Secondo me, comunque, la tesi di Eddowes non è subordinata al mito della partecipazione cinese. Bisogna leggere il suo libro per farsi un'idea esatta. Personalmente non posso accettare la tesi di uno pseudo Lee Oswald che, tornato in America, riesce a ingannare la famiglia per un anno e mezzo. Partirò quindi dal presupposto che abbiamo a che fare col vero Lee Oswald e non con un impostore, senza voler negare che Eddowes muova delle critiche molto valide alla commissione Warren. Persino Louis Heren, che non apprezza il suo libro, né un altro uscito in seguito di Robert Sam Anson, ritiene che sia venuto il momento di condurre a fondo una nuova inchiesta. Diversamente i dubbi e le spiegazioni sempre più contorte continueranno a circolare in eterno». Oggi i risultati dell'inchiesta Warren sono ancora i più probabili, anche se suscitano riserve e dubbi.
Luigi Barbara 158 1985 - John Fitzgerald Kennedy