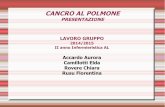Il Polmone Sclerodermico
-
Upload
paoly-palma -
Category
Documents
-
view
75 -
download
0
description
Transcript of Il Polmone Sclerodermico
-
Rassegna di Patologia dellApparato Respiratorio 2013; 28: 20-26
Gianluigi Bajocchi (foto)Cristiano Carbonelli*Luigi Zucchi*Carlo Salvarani
Unit Operativa diReumatologia Dipartimento di Medicina Interna e Specialit Mediche, * Unit Opera-tiva diPneumologia Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e di Area Critica, Azienda Ospedaliera Arci-spedale Santa Maria Nuova, IRCCS, Reggio Emilia
Parole chiaveNSIP UIP Sclerosi sistemi-ca Malattia infiltrativa polmo-nare diffusa
Key wordsNSIP UIP Sistemic sclero-sis Interstitial lung disease
Ricevuto il 17-7-2012.
Accettato il 31-8-2012.
*Gianluigi BajocchiUnit Operativa diReumatologia Dipartimento di Medicina Interna e Specialit Mediche, Azienda Ospe-daliera Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS viale Risorgimento, 8042123 Reggio [email protected]
Serie - La Medicina Interna vista dallo Pneumologo a cura di Gianluca Casoni
Il polmone sclerodermico nella forma diffusa e nella forma limitata (C.R.E.S.T.) Systemic sclerosis lung disease in limited (C.R.E.S.T.) and diffuse subset
20
Caso clinicoNel gennaio del 2002, un uomo di 61
anni non fumatore, richiedeva una visita pneumologica per tosse secca presente da qualche anno, soprattutto al mattino, al risveglio ma che da 3-4 mesi mostrava inusuale persistenza.
Lanamnesi patologica rilevava la pre-senza di un fenomeno di Raynaud presen-te da almeno 5 anni e che negli ultimi due inverni era divenuto pi severo per numero di attacchi ed estensione a pi dita delle mani. Nel gentilizio emerge una diagnosi di artrite reumatoide nella madre.
Di particolare nota, lesposizione a pol-vere di marmo a causa della sua attivit la-vorativa. Il paziente non assumeva farmaci.
Alla visita, il paziente ammette con do-mande mirate una moderata dispnea per sforzi intensi ma nega patologie cardiache o atopie. Lascoltazione polmonare, la sa-
turazione percentuale dellO2 e la pressione arteriosa sistemica sono nella norma, non sono presenti edemi declivi.
La radiografia del torace portata a visi-ta mostra un quadro reticolare e modesta prevalenza ventricolare sinistra. Lemocro-mo mostra una lieve anemia normocitica mentre lelettroforesi delle proteine rileva un aumento policlonale delle gamma-globuli-ne del 29,6%. Il dosaggio delle IgE e pre-cipitine risultato nei limiti. Nellipotesi che la tosse possa essere la manifestazione di una diatesi allergica da polveri richiesta una spirometria ed un test di broncopro-vocazione aspecifica alla metacolina che evidenziano un pattern restrittivo di grado moderato, riduzione medio-severa (33% dei valori teorici) della diffusione alveolo-capillare (DLCO) in assenza di iperreattivit bronchiale.
Nel contesto di una positivit del fattore reumatoide a basso titolo 54 UI/ml (vn < 20
RiassuntoLalveolite fibrosante e lipertensione arteriosa polmonare sono le principali complicazioni cardiopolmonari della sclerosi sistemica. Uninterstiziopatia polmonare clinicamente significativa presente nel 50% dei casi mentre una pressione arteriosa polmonare aumentata rilevata nel 20%. Lesordio dellinterstiziopatia polmonare caratterizzata da uninfiltrazione cellulare (alveolite) e da una micro-vasculopatia. La polmonite interstiziale non specifica laspetto pi comune di questo processo patologico. La quantificazione dellinteressamento polmonare ottenuta mediante TAC ad alta risoluzione e la riduzione della capacit vitale forzata con leventuale presenza di una sproporzionata riduzione della capacit di diffusione alveolo-capillare, sono predittivi dellevoluzione fibrotica o di ipertensione arteriosa polmonare. Pre-sentiamo un caso di sclerodermia limitata che ha condotto a unipertensione polmonare pre-capillare fatale.
Summary Fibrosing alveolitis and arterial pulmonary hypertension are the main cardiopulmonary findings in patients with systemic sclerosis. Clinically significant interstitial lung disease occurs in about 50% of the cases while 20% of the cases has pulmonary arterial hypertension. The onset of interstitial lung disease is characterized by cellular infiltration (alveolitis) and microvascular injury. Nonspecific interstitial pneumonia is the most common outcome of this pathological process. The extent of damage by means of high resolution CT and of disease severity by measuring the reduction of forced vital capacity with co-existing or isolated reduction of diffusing capacity, at the onset of the disease, are predictive of pulmonary fibrosis or pulmonary arterial hypertension. A case report with a limited cutaneous scleroderma leading to a fatal pre-capillary pulmonary arterial hypertension is presented.
-
Il polmone sclerodermico nella forma diffusa e nella forma limitata (C.R.E.S.T.)
21Rassegna di Patologia dellApparato RespiratorioV. 28 n. 01 Febbraio 2013
UI/ml) rilevata in esami precedenti nonch della familia-rit per artrite reumatoide e del fenomeno di Raynaud, il paziente inviato per consulenza reumatologica ed richiesta una TAC torace ad alta risoluzione (HRCT).
LHRCT documenta addensamenti polmonari a densit a vetro smerigliato prevalente alle regioni man-tellari periferiche. A livello interstiziale sono presenti ispessimenti lineari associati ad aree di enfisema di aspetto soprattutto centrolobulare. Nel mediastino si nota la distensione dellesofago e presenza di multi-ple linfoadenopatie in regione paratracheale ed inter-tracheo-bronchiale. Alla visita reumatologica vengono rilevate rare teleangectasie al volto e al palmo delle mani, con modesta sclerodattilia. In base a tali elemen-ti viene posto il sospetto di una connettivite sottostante alla interstiziopatia polmonare. Gli anticorpi antinucleari (ANA) risultano positivi a titolo elevato > 1:2560 con pattern anticentromero, la ricerca di antigeni nucleari estraibili (ENA) negativa.
La capillaroscopia periungueale mostra alterata ri-duzione della densit capillare, rallentamento del flusso microcircolatorio, numerose microemorragie e qualche isolato megacapillare. Alla radiografia dellesofago a doppio contrasto la canalizzazione appare conservata ma evidente un rallentamento dellonda peristaltica con ipotonia.
Discussione preliminare dei dati clinici, laboratoristici e di imaging
Analizzando i dati in nostro possesso lelemento pi solido per una patologia polmonare basato sul-la TAC ad alta risoluzione che mostra un quadro tipo NSIP (nonspecific interstitial pneumonia) e che pu ben spiegare il sintomo tosse e il successivo rilievo di una dispnea per sforzi intensi. Levidenza di una NSIP sostenuta dalla presenza di aree di attenuazione a vetro smerigliato (espressione radiologica dellispes-simento dellinterstizio interalveolare per edema, infil-trato infiammatorio, iniziale fibrosi), che si distribuisce soprattutto nelle regioni mantellari e senza un ovvio gradiente dai lobi inferiori a quelli pi apicali (caratte-ristica invece dellusual interstizial pneumonia - UIP). Oltre a ci evidente lassenza di aree honeycombing con bronchiectasie da trazione anchesse pi frequenti nelle UIP.
Peculiare la sproporzionata cadu-ta della DLCO che gi allesordio ha indotto al sospetto dipertensione pol-monare.
Pi comune nelle connettiviti oltrech il polmone NSIP la presenza di un pattern disventilatorio re-strittivo come documentato nel nostro paziente. Pe-culiare in questo senso la sproporzionata caduta della DLCO che gi allesordio ha indotto al sospetto dipertensione polmonare. Questo il motivo per cui si di seguito proceduto allo screening per liperten-sione arteriosa polmonare con ecocardiogramma. Gli
elementi pi importanti contributivi alla diagnosi di sclerodermia e quindi per attribuire ad essa la fibrosi polmonare, sono 1) la presenza di anticorpi antinucleo con pattern dimmunofluorescenza anti-centromero 2) la capillaroscopia in cui erano gi presenti elemen-ti specifici per un Raynaud secondario (associato a sclerodermia) e non primitivo, ossia i megacapillari. 3) il riscontro collaterale allesame della TAC polmonare di unipotonia dellesofago, 4) le teleangectasie. Vale la pena a questo proposito ricordare come la preferita ed attuale dizione di forma limitata di sclerodermia sia stata definita in passato con lacronimo di C.R.E.S.T. ossia: Calcinosi, Raynaud, Esofagopatia, Sclerodatti-lia, Teleangectasie.
Ulteriori accertamenti
Collegialmente si concorda di eseguire un lavaggio bronco-alveolare (BAL) che dimostra unalveolite mista linfocitaria prevalente CD8, neutrofila ed eosinofila (lin-fociti 17%, CD8 51%, neutrofili 6%, eosinofili 7%) ma non elementi suggestivi per una pneumoconiosi come incremento di macrofagi alveolari con accumuli lisoso-miali e/o materiale amorfo eventualmente birifrangente allo studio con luce polarizzata.
Allecocardiogramma era presente lieve rigurgito mitralico (1-2+), lieve rigurgito tricuspidale (2+) con PAP sistolica derivata di 30 mmHg.
Iter terapeutico
noto che la fibrosi polmonare la prima causa di morte nei pazienti sclerodermici. La presenza di fibrosi polmonare secondaria a sclerodermia in un paziente gi sintomatico con iniziale insufficienza respiratoria quindi unindicazione alluso di immunosoppressivi.
La fibrosi polmonare la prima causa di morte nei pazienti sclerodermici.
In particolare due studi prospettici randomizzati e placebo-controllati hanno dimostrato un effetto favore-vole della ciclofosfamide per lFVC, lo score HRCT e la dispnea a 12 mesi 12. Leffetto antiinfiammatorio della terapia per ha un indice terapeutico modesto (mas-sima dose non-tossica/minima dose efficace) e tende ad esaurirsi dopo circa 24 mesi dalla sospensione del-la terapia richiedendo successive somministrazioni se la dose cumulativa lo permette o in caso contrario un cambiamento della terapia. Nondimeno la forte eviden-za di una riduzione dellalveolite neutrofila indotta dal regime di ciclofosfamide nei pazienti sclerodermici la in-dica come prima scelta dalle linee guida internazionali3.
Nellaprile del 2003 si concorda di iniziare boli di ciclofosfamide da 1 grammo ogni 4 settimane per 6 mesi. Nel giugno 2003 una seconda TAC spirale (Fi-gura 2A) ad alta risoluzione mostra stazionariet del-le lesioni a vetro smerigliato pi evidenti ai segmenti medi e inferiori con un quadro di enfisema bolloso sub-pleurico a livello dorsale prevalente ai campi polmonari
-
G. Bajocchi et al.
Rassegna di Patologia dellApparato Respiratorio V. 28 n. 01 Febbraio 201322
superiori. Compaiono limitate lesioni honey-comb pre-senti ai segmenti dorsali inferiori con ispessimento dei setti interlobulari e intralobulari. Allecocardiogramma lieve rigurgito mitralico (1+), lieve rigurgito tricuspida-le (2+) peggioramento della PAP sistolica derivata di 45mmHg (v.n. < 25 mmHg a riposo) (Figura 1). Nel gennaio 2004 il paziente infonde 2 ciclo di ciclofosfa-mide (mensile per 6 mesi).
Nel dicembre del 2006 aggravamento della dispnea da sforzo che viene inquadrata come una dispnea di classe III-IV secondo NYHA e viene prescritto O2 do-miciliare con lindicazione allutilizzo per la rapida com-parsa di desaturazione sotto sforzo ed il trattamento dellipertensione polmonare (emogas: pH 7,44; pO2 55 mmHg; pCO2 31,1 mmHg; SO2 87,4%). Inizia Bo-sentan alla dose di 125 mg/die, dicumarolici, digitale, diuretici, non utilizzabili i calcio antagonisti per la scarsa tolleranza. Nel maggio del 2007 una nuova HRTC risul-ta sostanzialmente invariata rispetto a quella del 2003. Per lincremento grave dei valori di PAPs (Figura1) ag-giunge sildenafil 80 mg/die in associazione al bosentan 125 mg/die.
Un ultimo controllo HRCT del torace del gennaio 2008 (Figura 2B) con mdc mostra marcata congestio-ne del piccolo circolo, invariate entrambe le compo-nenti di interstiziopatia polmonare e di enfisema.
Il paziente decede per morte improvvisa nel 2008 senza che sia stato possibile effettuare un esame au-toptico.
Discussione Il quadro clinico emblematico di una scleroder-
mia con anticorpi anticentromero ed ipertensione arteriosa polmonare correlata. Landamento della spirometria e le immagini HRCT successive, sono concordi nel documentare uninterstiziopatia polmo-nare nel complesso moderata ma comunque non in progressione fino ad un grado di severit tale da giustificare la comparsa dellipertensione polmonare. Il calo progressivo della DLCO non correlato ad un parallelo peggioramento della sindrome restrittiva infatti segno comune della ipertensione arteriosa pol-monare isolata piuttosto che di quella secondaria alla fibrosi polmonare.
Il calo progressivo della DLCO non correlato ad un parallelo peggioramen-to della sindrome restrittiva segno comune della ipertensione arteriosa polmonare isolata.
La diagnosi di sclerodermia poggia sulla presenza dellanticorpo anticentromero, del fenomeno di Ray-naud caratteristicamente comparso in et avanzata (5 anni prima della diagnosi) ed infine sul pattern capillaro-scopico e le teleangectasie. La scarsa fibrosi cutanea circoscritta alle mani e dita (sclerodattilia) tipica della
Figura 1. Andamento dei valori spirometrici e della diffusione (% del predetto) e della PAPs (mmHg).
-
Il polmone sclerodermico nella forma diffusa e nella forma limitata (C.R.E.S.T.)
23Rassegna di Patologia dellApparato RespiratorioV. 28 n. 01 Febbraio 2013
forma limitata di sclerodermia (ex Calcinosi, Raynaud, Esofagopatia, Teleangectasie). Cos come tipica della sclerodermia la ipotonia esofagea dimostrata occasio-nalmente anche alla TAC del torace.
Liniziale terapia antifibrotica (ciclofosfamide) e quel-la successiva pi correttamente mirata allipertensione polmonare (bosentan e sildenafil) sono probabilmente iniziate a danno dorgano stabilito con drammatica e frustrante inefficacia sulla progressione della malattia (Figura1).
Diversit clinica dei pazienti sclerodermici
I pazienti sclerodermici hanno unampia variabilit fenotipica che complica ogni aspetto della valutazione del danno dorgano presente sul singolo paziente4.
Questa inomogeneit dei pazienti infatti determina incertezza nello stabilire una prognosi allesordio, i cri-teri di evolutivit durante la malattia e la decisione sul tempo e appropriatezza della terapia, considerando che questa gravata da rischi jatrogeni.
Linteressamento polmonare nella sclerodermia parte di tutte queste difficolt.
I criteri classificativi dellAmerican College of Rheu-matology (ACR) 5 riconoscono due gruppi di pazienti sclerodermici secondo lestensione della sclerosi cu-tanea: pazienti con forma diffusa e quelli con forma limitata in cui la cute risparmiata prossimalmente a braccia e cosce (questo gruppo corrisponde allab-bandonata definizione di sindrome C.R.E.S.T.).
Nel tempo, questa prima sottoclassificazione si dimostrata fondamentalmente corretta in quanto pur con ampia variabilit, ai due aspetti clinici di malattia corrispondono le due principali forme fisiopatologiche dinteressamento polmonare essendo la fibrosi polmo-
nare se non esclusiva pi spesso severa nella forma diffusa e lipertensione polmonare isolata pre-capillare, prevalente nella forma limitata.
Ma non tutto. La separazione dei due gruppi clinici ha trovato ulteriore giustificazione anche dal riscontro di due maggiori specificit auto-anticorpali che singo-larmente o in associazione con differenti anticorpi, ca-ratterizzano immunologicamente i due subset clinici6.
Gli studi epidemiologici multicentrici hanno potuto collegare i due pattern clinici di malattia alla presenza di autoanticorpi sierici anti-centromero nell89% circa delle forme limitate, in cui lipertensione polmonare prevalente e alla presenza di autoanticorpi sierici anti scl-70 nel 36% dei casi di forme diffuse in cui prevale la probabilit di una severa fibrosi polmonare.
Va per rilevato come anticipato che tale associa-zione clinico-autoanticorpale, soprattutto tra i pazienti della forma diffusa, risulti parziale per la presenza di autoanticorpi di solo recente identificazione che meglio identificano ulteriori subset della sclerodermia7.
Infatti queste nuove specificit autoanticorpali oltre quella anticentromero e anti scl-70 ben si adattano alle successive osservazioni di quadri non completamen-te assimilabili alla dicotomica classificazione in forma limitata anticentromero correlata e forma diffusa anti scl-70 positiva.
Al momento i ricercatori hanno identificato circa una decina di autoanticorpi sierici alcuni dei quali di rilevante significato clinico e molti dei quali non disponi-bili in forma kit di laboratorio standardizzati8. Il loro va-lore prognostico e clinico necessita ancora una volta di conferme con studi prospettici su numerose casistiche ma gi ora in parte spiega lampia variabilit clinica dei pazienti sclerodermici di cui abbiamo detto allinizio.
Figura 2. A. TAC TORACE HR (19.06.2003). Quadro sovrapponibile a quello del 2002 per stazionariet delle lesioni a vetro smerigliato pi evidenti ai segmenti medi e inferiori con un quadro di enfisema bolloso sub-pleurico a livello dorsale pre-valente ai campi polmonari superiori. Ispessimento dei setti interlobulari e intralobulari. B. TAC TORACE HR CON MdC (17.01.2008). Esame confrontato con il precedente analogo del 22.05.2007. Al controllo odierno si conferma il quadro ra-diologico gi descritto di esteso enfisema centrolobulare con presenza di numerose bolle subpleuriche pi evidenti alle basi. Si apprezza inoltre marcata congestione vascolare del piccolo circolo senza evidenza di aree addensative polmonari in atto. Si osservano linfoadenomegalie in sede ilo-mediastinica la maggiore delle quali in sede precarenale di 12 mmm.
A B
-
G. Bajocchi et al.
Rassegna di Patologia dellApparato Respiratorio V. 28 n. 01 Febbraio 201324
Patogenesi della fibrosi polmonare sclerodermica
A differenza di quanto sostenuto anni fa, la fibrosi polmonare caratteristica di entrambi i subset sclero-dermici, anche se le forme pi rapidamente progres-sive e pi estese rimangono appannaggio della forma diffusa con anticorpo anti scl-70 e che probabilmente il vero fattore di rischio per detta severit9.
Lalveolite fibrosante la lesione elementare alla base della fibrosi interstiziale.
Il suo esordio difficile da collocare nella storia na-turale della sclerodermia in quanto tale alterazione per lungo tempo asintomatica e potenzialmente al di sotto delle possibilit di risoluzione della TAC e ancora di pi dei test spirometrici e della diffusione del CO.
Teoricamente un incremento di neutrofili e/o eosi-nofili nel BAL come in effetti in alcune casistitche di-mostrato10, potrebbe essere la prima evidenza dellal-veolite la cui evoluzione fibrosante non comunque scontata nella totalit dei pazienti. Per tale motivo an-che lidea di un alveolite precoce diagnosticata secon-do criteri citologici rimane di significato patogenetico incerto non essendo direttamente predittiva di fibrosi polmonare.
Indipendentemente da quando inizi precisamente lalveolite fibrosante sappiamo da studi istologici per la gran parte post-mortem che la sequenza degli eventi potrebbe essere come di seguito descritto11.
In una prima fase si nota un ispessimento dello spazio interstiziale alveolare dovuto allinfiltrazione di fibroblasti ma soprattutto di miofibroblasti (cellule con caratteristiche di contrattilit per la presenza di mio-filamenti anti-alfa-actina positivi e quindi per questo simili alle cellule muscolari lisce). In parallelo si rileva un aumento dei capillari spesso di aspetto irregolare ed ectasico, nello spazio interstiziale e nei setti inte-ralveolari. Le cellule endoteliali dei capillari sono infatti riconoscibili per la positivit ad anticorpi anti fattore von Willebrand e anti-PECAM-1/CD31.
In una fase successiva procedendo la neovascola-rizzazione e laccumulo di miofibroblasti un terzo even-to compare. Dalla colorazione tricromica si rileva un aumento di matrice extracellulare (collageno tipo I e III, fibronectina e tenascina per gran parte sintetizzata dai miofibroblasti) che accumulandosi, porta alla progres-siva distorsione della struttura alveolare e perdita dello strato epiteliale alveolare.
Infine nella fase avanzata, con il progredire dellac-cumulo di matrice extracellulare e quindi della fibrosi, sul fronte vascolare comincia un processo opposto a quello iniziale con una regressione del microcircolo e le cellule endoteliali perdono i markers caratteristici, interpretabile come una de-differenziazione. La mor-fologia alveolare in questa fase gravemente com-promessa.
Nella fase finale la fibrosi interstiziale ha completa-mente rimpiazzato la quota cellulare di miofibroblasti e da ultimo anche di fibroblasti. annullata la vascola-rizzazione, il polmone ha perso completamente la sua architettura alveolare e vascolare.
Epidemiologia
Linteressamento polmonare la prima causa di morte nella sclerodermia sostituendo al vertice la crisi renale sclerodermica ora in parte trattabile con luso di ace-inibitori.
Il dato pi solido in questo senso viene da uno stu-dio retrospettivo che utilizzando la casistica di Pittsbur-gh ha rilevato che del totale dei decessi correlabili alla presenza della malattia sclerodermica il 30% era dovu-to alla fibrosi polmonare12.
Lesatta incidenza dellinterstiziopatia polmonare risente della sensibilit della metodica con cui viene rilevata e se osservata in pazienti sintomatici o meno.
Per cui se segni di interstiziopatia sono presenti nel-la quasi totalit dellistologia autoptica13, che raccoglie evidentemente i casi pi severi di malattia, allopposto la radiologia standard in pazienti con recente sintoma-tologia respiratoria pi spesso negativa.
Unimmagine pi precisa proviene da uno studio collaborativo di vari centri europei da cui risulta che in 3656 pazienti sclerodermici, la interstiziopatia polmo-nare era presente nel 53% dei casi con forma diffusa e nel 35 % dei casi con forma limitata14.
I quadri NSIP e UIP e gli elementi prognostici di evolutivit
La HRCT rappresenta al momento il gold standard per la diagnosi data lelevata sensibilit dimostrando segni di fibrosi nel 55-65% dei pazienti sclerodermici e nel 96% dei pazienti con alterate PFR e quindi per la maggior parte sintomatici15.
La HRCT rappresenta al momento il gold standard per la diagnosi.
Il pattern HRCT a ground glass (attenuazione del segnale polmonare) rappresenta lalterazione pi precoce e frequente che cominciando anche iso-latamente pu nel tempo accrescersi dalle regioni mantellari sub-pleuriche verso le aree polmonari pi profonde. Pu concomitare unaccentuazione reti-colare che pi spesso il segno della progressione fibrotica.
Il pattern HRCT a ground glass rap-presenta lalterazione pi precoce e frequente.
In questa fase in cui la distorsione del disegno reticolare e le bronchiectasie da trazione sono an-cora assenti il quadro sovrapponibile a quello di una NSIP e i dati istologici confermano la diagnosi radiologica.
Circa 80% dei pazienti con sclerodermia ha que-sto tipo di pattern, mentre il 20% presenta un pattern tipo UIP1617. Questultimo pattern caratterizzato da chiara alterazione dellarchitettura parenchimale con
-
Il polmone sclerodermico nella forma diffusa e nella forma limitata (C.R.E.S.T.)
25Rassegna di Patologia dellApparato RespiratorioV. 28 n. 01 Febbraio 2013
diffuso honey-combing per formazioni di aree cistiche e comparsa di bronchiolo-bron-chiectasie da trazione. Pos-sono essere infine presenti anche in tale contesto aree di attenuazione ground glass e ispessimento reticolare. inoltre pi tipico di questa for-ma una progressiva riduzione del danno parenchimale dalla base agli apici.
dibattuto se la presenza del ground glass sia interpre-tabile come la fase di alveolite e quindi soggetta a regressio-ne o se sia gi evidenza di una lieve ma irreversibile fibrosi. (Figura 3).
Sembra pi probabile che la presenza del rinforzo inter-stiziale reticolare sia il punto di non ritorno in quanto defini-rebbe linizio della fibrosi pol-monare18.
Comunque, anche di fron-te allevidenza di una fibrosi lulteriore progressione e i tempi di evoluzione rimango-no incerti. Indicazioni su que-sto sono fornite dai risultati dei trials farmacologici per il trattamento dellinterstizio-patia polmonare e dagli stu-di prospettici che indicano in due elementi, i fattori progno-stici di progressione.
Al congresso mondiale della sclerodermia del 2012 sono stati presentati dati dalla casistica australiana che identificano nellestensione della fibrosi polmonare, ridu-zione di FVC e DLCO e nel sesso femminile con posi-tivit anti scl-70 i fattori predittivi di deterioramento fun-zionale e mortalit per fibrosi polmonare (Tabella I)1920.
In conclusione le connettiviti ed in particolare la scle-rodermia possono essere una causa di fibrosi polmonare che a differenza della forma idiopatica sensibile al trat-tamento a patto di un riconoscimento precoce. Daltra parte i segni e sintomi delle connettiviti sono proteiformi e comuni anche nella popolazione normale (la xerostomia-xeroftalmia nella s. di Sjgren, ragadi digitali nella s. An-tisintetasi, il fenomeno di Raynaud nella Sclerodermia, la fotosensibilit nel Lupus Eritematoso Sistemico) e vanno quindi interpretati ed approfonditi con esami utili al rilievo di una malattia autoimmunitaria sottostante.
Lo pneumologo che primo per competenza chia-mato alla valutazione di una fibrosi polmonare deve avere ben chiara la possibilit di questi comuni segnali clinici. Deve inoltre avere disponibilit a condividere con il reumatologo le responsabilit di trattamenti immuno-soppressori anche a fronte di diagnosi spesso dincom-
Figura 3. Significato clinico dei pattern della HRCT nella sclerodermia e possibili evo-lutivit.
Tabella I. Elementi predittivi di deterioramento della funzionalit polmonare e della mortalit nella ILD sclerodermica, calcolati secondo il modello di analisi della regressione.
Variable Adjusted HR (95% CI) P
Estensione danno polmonare (HRCT) 0,59 (0,13, 2,71) 0,49 FVC, Capacit vitale forzata (L) 0,08 (0,01, 0,43) 0,003 DLCO, (ml/min/mmHg) 0,74 (0,58, 0,96) 0,023 Sesso femminile 0,05 (0,01, 0,28) 0,001 Ac anti scl-70 0,22 (0,05, 1,06) 0,06
HR = Hazard Ratio
pleta dimostrazione ma di cui anche necessario rico-noscerne la potenziale letalit qualora non trattate.
Lo pneumologo deve condividere con il reumatologo le responsabilit di trattamenti immuno-soppressori anche a fronte di diagnosi.
Questa collaborazione il valore aggiunto necessa-rio ad affrontare i casi pi complessi.
Bibliografia1 Scleroderma Lung Study Research Group. Cyclophospha-
mide versus placebo in scleroderma lung disease. N Engl J Med2006;354:2655-66.
2 Hoyles RK, Ellis RW, Wellsbury J, et al. A multicenter, prospective, randomized, double-blind, placebo-con-trolled trial of corticosteroids and intravenous cyclophos-phamide followed by oral azathioprine for the treatment of pulmonary fibrosis in scleroderma. Arthritis Rheum 2006;54:3962-70.
3 EUSTAR Co-Authors. EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis: a report from the EULAR
-
G. Bajocchi et al.
Rassegna di Patologia dellApparato Respiratorio V. 28 n. 01 Febbraio 201326
Scleroderma Trials and Research group (EUSTAR). Ann Rheum Dis 2009;68:620-8.
4 Wigley FM. When is scleroderma really scleroderma? J Rheumatol 2001;28:1471-3.
5 Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Thera-peutic Criteria Committee. Arthritis Rheum 1980;23:581-90.
6 Masi AT. Classification of systemic sclerosis (scleroderma): relationship of cutaneous subgroups in early disease to out-come and serologic reactivity. J Rheumatol 1988;15:894-8.
7 Walker UA, Tyndall A, Czirjk L, et al. Clinical risk assessment of organ manifestations in systemic sclerosis: a report from the EULAR Scleroderma Trials And Research group data-base. Ann Rheum Dis 2007;66:754-63.
8 Ho KT, Reveille JD. The clinical relevance of autoantibodies in scleroderma. Arthritis Res Ther 2003;5:80-93.
9 Clements PJ, Roth MD, Elashoff R, et al. Scleroderma lung study (SLS): differences in the presentation and course of patients with limited versus diffuse systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2007;66:1641-7.
10 Kowal-Bielecka O, Kowal K, Highland KB, et al. Broncho-alveolar lavage fluid in scleroderma interstitial lung disease: technical aspects and clinical correlations: review of the lit-erature. Semin Arthritis Rheum 2010;40:73-88.
11 Beon M, Harley RA, Wessels A, et al. Myofibroblast induc-tion and microvascular alteration in scleroderma lung fibro-sis. Clin Exp Rheumatol 2004;22:733-42.
12 Steen VD, Medsger TA. Changes in causes of death
in systemic sclerosis, 1972-2002. Ann Rheum Dis 2007;66:940-4.
13 Ferri C, Valentini G, Cozzi F, et al. Systemic sclerosis: demo-graphic, clinical, and serologic features and survival in 1,012 Italian patients. Medicine (Baltimore) 2002;81:139-53.
14 Walker UA, Tyndall A, Czirjk L, et al. Geographical varia-tion of disease manifestations in systemic sclerosis: a report from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) group database. Ann Rheum Dis 2009;68:856-62.
15 Goldin JG, Lynch DA, Strollo DC, et al. Scleroderma Lung Study Research Group. High-resolution CT scan findings in patients with symptomatic scleroderma-related interstitial lung disease. Chest 2008;134:358-67.
16 Ouros D, Wells AU, Nicholson AG, et al. Histopathologic subsets of fibrosing alveolitis in patients with systemic scle-rosis and their relationship to outcome. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:1581-6.
17 Glaspole I, Goh NS. Differentiating between IPF and NSIP. Chron Respir Dis 2010;7:187-95.
18 Shah RM, Jimenez S, Wechsler R. Significance of ground-glass opacity on HRCT in long-term follow-up of patients with systemic sclerosis. J Thorac Imaging 2007;22:120-4.
19 Goh NS, Desai SR, Veeraraghavan S, et al. Interstitial lung disease in systemic sclerosis: a simple staging system. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:1248-54.
20 Moore O, Goh N, Corte T, et al. Identify and quantifying the prognostic factors in SSc-realted interstitial lung disease us-ing a time-varying covariate survival model. Rheumatology 2012;ii3:Abs S.2.1.
Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse con largomento trattato nellarticolo.
Nessuno ha il diritto di costringere gli altri ad agire in base alla sua propria visione della verit.
Mahatma Gandhi