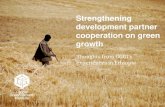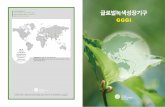II d QQuuuaaadddeeerrrnnniii ddiii SSa aan nnt ttaa GGGi ... · Gosanesh Cassol e Martino Frescura...
Transcript of II d QQuuuaaadddeeerrrnnniii ddiii SSa aan nnt ttaa GGGi ... · Gosanesh Cassol e Martino Frescura...
IIInnn cccooollllllaaabbbooorrraaazzziiiooonnneee cccooonnn iiilll
CCCooommmuuunnneee dddiii SSSaaannntttaaa GGGiiiuuussstttiiinnnaaa
III gggiiiooovvvaaannniii ppprrreeessseeennntttaaannnooo iiilll ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo
III QQQuuuaaadddeeerrrnnniii dddiii SSSaaannntttaaa GGGiiiuuussstttiiinnnaaa
NNNUUUMMMEEERRROOO SSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEE
555 IIILLL TTTEEEMMMPPPOOO DDDEEELLLLLLEEE SSSPPPAAADDDEEE
UUUnnn vvviiiaaaggggggiiiooo pppeeerrr iiimmmmmmaaagggiiinnniii nnneeellllll’’’aaarrrttteee dddiii PPPiiieeetttrrrooo dddaaa FFFooorrrmmmeeegggaaannn
CC COO O
LL LLL L
AA ANN N
AA A AA A
CC CUU U
RR RAA A
DD DEE E
LL LLL L
’’ ’ II ISS S
TT TII I TT T
UU UTT T
OO O CC C
OO OMM M
PP PRR R
EE ENN N
SS SII I VV V
OO O
"" "GG G
.. . RR R
OO ODD D
AA ARR R
II I ”” ”
3
I giovani presentano il territorio
I quaderni di Santa Giustina n. 5
IL TEMPO DELLE SPADE
Un viaggio per immagini nell’arte di Pietro da Formegan
Realizzato dalle alunne e dagli alunni delle classi 2B e 2D
Con la collaborazione degli ex alunni dell’I.C. Rodari: gli studenti Igor Peruzzo e Carina Riti per i testi, Gosanesh Cassol e Martino Frescura per i disegni
Scuola Secondaria di Primo Grado
Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Santa Giustina
a.s. 2015-2016 / 2016-2017
In collaborazione con il Comune di Santa Giustina
4
I testi di questo libro sono stati realizzati dagli alunni della classe 2B
e 2D dell’I.C. “G. Rodari” di Santa Giustina:
Bacchetti Nicola
Bonet Gianluca
Bortolas Giulia
Canal Valentina
Casagrande Sara
Chiesurin Paola
Cosau Sebastian
Dal Piva Kevin
Fregona Massimiliano
Meloni Syria
Pergentino Alessia
Perikliu Eneida
Pollet Gaia
Ren Daniele
Scot Ismael
Soares De Lima Arthur
Vigne Luca
Bolzan Edoardo
Bortoluzzi Alessio
Buoso Nicola
Cadorin Irene
Carrera Michele
D’Aprile Gabriele
Dal Borgo Manuel
De Min Erica
Duranti Manuel
Lucchetta Lucia
Markocevic Viktor
Pavei Filippo
Salton Irene
Sartor Alessandro
Triches Lorenzo
Zampieri Anna
Zannin Margherita
Con la collaborazione degli studenti Igor Peruzzo e Carina Riti per i testi, Gosanesh Cassol e Martino Frescura per i disegni
A cura dei professori Michele Vello e Matteo Masini
Hanno collaborato le professoresse Beatrice Comel e Simonetta Soppelsa e il tecnico del restauro Fabrizio Tonin
Quaderno autoprodotto. Tutti i diritti sono riservati. Santa Giustina 2016
5
Sommario
Prefazione .................................................................................................. 6
Premessa ................................................................................................... 7
Introduzione .............................................................................................. 8
Ringraziamenti ………………………………………………………………………………………. 9
Il tempo delle spade…………………………………………..………………………………….10
Pietro da Formicano ............................................................................... 11
La spada e le sue parti ............................................................................. 13
Le opere di Pietro da Formicano .............................................................. 16
L'arte della scherma…………………………………………………………………………….. 34
Il Fursìl, il "ferro dell'agnello" e Pietro ad Andraz………………………………… 35
Le fucine, le spadaie, una via, un altro grande maestro e
il nome di un paese diventato marchio di altissima qualità……..……… ….. 39
Pietro da Formicano in un romanzo!.........................................................41
Bibliografia ............................................................................................... 42
6
Prefazione
Questo quinto quaderno di Santa Giustina, dedicato ad un importante personaggio
che nel corso del XVI secolo dette lustro al nostro territorio, attraverso la sua arte di
spadaio, è un ulteriore prezioso lavoro realizzato dall’Istituto “G.Rodari”.
È prezioso non solo perché frutto di una ricerca che, sapientemente guidata da docenti
e appassionati di storia locale, ha coinvolto alunni ed ex alunni, dando loro
l’opportunità di accostarsi in maniera “personale” alla storia, ma perché gli
straordinari risultati stimolano ulteriori approfondimenti ai quali l’Amministrazione
Comunale continuerà a dare il proprio sostegno, nell’intento di valorizzare il
patrimonio storico, artistico e culturale di Santa Giustina.
La ricerca ha il merito di evidenziare l’importanza delle fucine di Formegan dalla
quale emerge in particolare la figura di Pietro da Formicano, cui sono attribuite vere e
proprie opere d’arte. Nel periodo tra ‘500 e ‘600 si stagliano altre figure di artigiani
che tramandarono l’arte del produrre spade, aprendo così l’orizzonte di un piccolo
centro bellunese a tutta Europa ed al mondo, dove oggi le spade prodotte nel nostro
territorio sono ospitate nei più importanti Musei. Questa prospettiva, considerato il
periodo, rende ancora più affascinante ripercorrere la storia di Pietro e rintracciare i
capolavori degli spadai bellunesi, ricercati e sfoggiati da sovrani e nobili dell’epoca.
Un sentito ringraziamento dunque a tutti coloro che, aprendo un fronte di ricerca
davvero ricco di scoperte, hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro, con
l’auspicio che il progetto continui e ci sveli ancora tante storie di un importante
passato del nostro Comune.
Il Sindaco L’Assessore all’Istruzione
Ennio Vigne Angela Bortolin
7
Premessa
È questo il quinto quaderno di una collana nata con lo scopo di coinvolgere i ragazzi
nella promozione del paese in cui vivono, al fine di rafforzare sempre di più il loro
legame con il territorio. Nei numeri precedenti sono state presentate alcune frazioni
del Comune di Santa Giustina. Questo invece è un numero speciale, dedicato a Pietro
da Formegan o da Formicano, uno dei più grandi artisti che la metallurgia abbia
avuto e i cui lavori sono conservati, non come testimonianza di un’epoca, ma come
straordinarie opere d’arte, nei più importanti musei del mondo. Non ci sono più sue
spade in provincia, ma le ragazze e i ragazzi delle classi 2B e 2D, hanno trovato il
modo per permettere a tutti di conoscerle e di ammirarle, anche nel luogo in cui sono
state create, preparando questo catalogo delle realizzazioni più affascinanti del
grande Pietro. Desideriamo sottolineare come il progetto sia stato possibile grazie
all’approvazione del Collegio Docenti e al contributo dell’Amministrazione Comunale.
Dal canto nostro, ringraziando gli ex studenti Gosanesh Cassol, Martino Frescura,
Igor Peruzzo, Carina Riti e il tecnico del restauro Fabrizio Tonin che hanno
collaborato con noi, esprimiamo la soddisfazione per il risultato ottenuto e
soprattutto per l’impegno che le ragazze e i ragazzi hanno mostrato nell’affrontare
un tema complesso, ma che, da subito, con grande naturalezza, hanno saputo leggere
sotto la lente dell’arte, che è quella più adatta quando si è di fronte all’opera di un
grande maestro spadaio. Siamo fiduciosi che la conoscenza del passato e la sua
valorizzazione li vedrà sempre più protagonisti. Ci auguriamo, per concludere, che
questo viaggio tra i capolavori di Pietro da Formegan possa essere per i lettori una
piacevole sorpresa.
Michele Vello Matteo Masini
8
Introduzione
Abbiamo voluto realizzare questo catalogo fotografico per far conoscere le opere di un
bravissimo spadaio, un vero artista nel suo campo: Pietro da Formegan o da Formicano,
come lui firmava le sue lame. Egli lavorò in una fucina, lungo una “Roia” - ovvero un piccolo
ruscello che alimentava il suo laboratorio - del Veses, il torrente che passa per S. Giustina, il
nostro paese. Pietro e i fratelli Andrea e Zandonà Ferrara, che lavorarono a Belluno, furono
spadai straordinari. Le loro opere furono collezionate da più famosi imperatori, re, principi
e duchi del Rinascimento. Il Bellunese, infatti, fu uno dei luoghi di produzione di armi
bianche più importanti in Europa tra Cinque e Seicento e i suoi grandi maestri
rivaleggiarono alla pari, per tecnica e bravura, con i più famosi maestri di Toledo e di
Solingen. Oggi le spade di Pietro si trovano nei più importanti musei del mondo; purtroppo
qui dove sono state create non ce ne sono più, né si possono riportare nei luoghi dove
vennero fabbricate, più di quattro secoli fa. Per questi motivi, abbiamo deciso di realizzare
un catalogo fotografico, in modo da permettere a tutti di ammirare le sue opere più belle, a
partire da chi abita oggi in quello che fu il suo paese. Sperando che questo nostro lavoro vi
possa interessare, vi auguriamo buona lettura!
We wanted to realize this photographic catalogue to make you know the works of a great
sword maker, a real artist in his sector: Pietro da Formegan or da Formicano, as he signed
his blades. He worked in a forge, along a “roia”- that is a small brook which supplied his
laboratory- of Veses, the stream that passes through Santa Giustina, our town. Pietro and
the brothers Andrea and Zandonà Ferrara, that worked in Belluno, were extraordinary
sword makers. Their works were collected by the most famous emperors, kings, princes and
dukes of the Renaissance. The zone of Belluno, in fact, was one of the most important place
of production of sidearms in Europe between the Sixteenth and Seventeenth centuries and
its great masters competed at the same level, in technique and skillness, with the most
famous masters of Toledo and Solingen. Today the swords of Pietro are in the most famous
museums of the world; unfortunately here, where they were made, there aren’t any more,
and you can’t either bring them to the places where they were created more than four
centuries ago. For these reasons, we decided to realize a photograph catalogue, to allow to
admire his most beautiful works, starting from who lives where he lived and worked.
Hoping that our work can be interesting for you, we wish you a good reading!
Wir wollten diesen fotografischen Katalog verfassen, um die Werke eines begabten
Schmiedes, eines wahren Künstlers auf seinem Gebiet, vorzustellen: Pietro von Formegan
9
oder Fomicano, wie er selbst seine Klingen zu unterzeichnen pflegte. Er arbeitete in einer
Schmiede, einer "Roja" entlang, einen kleinen Bach, den er seinem Labor zugeführt hat; der
Strom Namens Veses verläuft durch unser Dorf von Santa Giustina. Pietro und die Gebrüder
Andrea und Zandonà Ferrara, die in der Nähe von Belluno gearbeitet haben, waren
auβerordentliche Schwertmacher. Die bekanntesten Kaiser, Könige, Herrscher und Herzöge
in Europa der Renaissance haben ihre Werke gesammelt. Belluno war in der Tat einer der
wichtigsten Orte für die Herstellung von Klingenwaffen aus dem sechzehnten und
siebzehnten Jahrhundert. Die grossen Meister von Belluno massen sich mit den
berühmtesten Meistern von Toledo und Solingen. Heute findet man die Schwerter von
Pietro in den wichtigsten Museen der Welt. Leider gibt es genau hier in Santa Giustina und
Belluno, wo sie gemacht wurden, keine mehr. Auβerdem kann man sie nicht mehr an die
Orten zurück bringen, wo sie über vier Jahrhunderte lang hergestellt wurden. Aus diesen
Gründen haben wir uns entschlossen einen Fotokatalog zu schaffen, damit jedermann die
schönsten Werke von Pietro bewundern kann, von denen ausgehend, die eben an den
Orten wohnen, wo er lebte und arbeitete. In der Hoffnung, dass unsere Arbeit Sie
interessieren kann, wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Le Autrici e gli Autori
Ringraziamenti
Desideriamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, in vario modo, a realizzare questo
libro, in particolare: il nostro Dirigente Scolastico, l’Amministrazione Comunale, Fabrizio
Tonin, studioso delle spade rinascimentali, Igor Peruzzo, Gosanesh Cassol, Carina Riti e
Martino Frescura, il professor Dino Preloran dell’Istituto Minerario di Agordo, Gianluca
Zandanel della Biblioteca Comunale di Santa Giustina, Giulia Tasser, Lorenzo Troi, Moreno
Kerer dell’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” ed Eleonora Demattia del Castello di Andraz.
10
Il tempo delle spade
La fine del Medio Evo portò a una nuova epoca, in cui vi fu un recupero della cultura
antica. Il commerciò rifiorì, venne sempre più apprezzato il lavoro degli artisti (pittori,
scultori, architetti). Le classi alte della società, infatti, volevano vivere nel lusso. Nel
Quattrocento e nel Cinquecento, l’Italia, divisa in tanti piccoli stati, divenne il paese
europeo più importante per l’arte e la moda. Non fu un periodo pacifico, anzi! Si
fabbricarono molte armi, ma la loro produzione non fu legata solo alla guerra. Le spade, ad
esempio, vennero considerate accessori dell’abbigliamento maschile dei nobili, quasi dei
gioielli, da sfoggiare e, all’occorrenza, da usare con abilità. Le spade sono importanti
testimonianze della storia e della cultura di un popolo: arte, scienza, tecnologia ed
economia influenzano e sono influenzate da questi oggetti belli e terribili. Alcune località
italiane vantano tradizioni di abili armaioli, che alimentarono un'attività produttiva
considerata ancora oggi tra le più prestigiose del mondo. Questi grandi artisti del metallo -
perché tali possono essere considerati - realizzarono, spesso su commissione straniera,
pregevolissime opere. Formegan, Belluno, Feltre, Serravalle, Sacile: queste erano le
principali località di produzione di spade nel Veneto, tra il 1500 e il 1600, al tempo della
Serenissima Repubblica di Venezia. Le prime quattro formavano quello che oggi verrebbe
chiamato il “distretto industriale” della spada bellunese. Gli spadai più importanti, che qui
vissero e lavorarono, furono Pietro da Formegan, i fratelli Andrea e Zandonà Ferrara e
Daniele da Serravalle, anche se quest'ultimo operò soprattutto a Milano, dove portò la sua
arte. Le spade forgiate da questi abili maestri raggiunsero, in molti casi, livelli qualitativi
così alti da essere ricercate dai sovrani più importanti di quei tempi, che le vollero per le
loro raccolte personali. In quell’epoca, i maestri bellunesi, veri artisti del metallo,
rivaleggiarono alla pari con i più grandi spadai di Toledo, in Spagna, di Solingen, in
Germania, di Milano e di Brescia, i centri allora più famosi per la produzione delle spade. I
loro laboratori erano le fucine che venivano costruite non troppo lontano dalle miniere,
dove veniva estratto il minerale necessario per fabbricare le lame, nei pressi di un corso
d'acqua, come il Vesés, la cui forza veniva utilizzata per far girare le ruote che muovevano i
grossi e pesanti magli, e nelle vicinanze dei boschi, il cui legname serviva per alimentare il
fuoco, indispensabile per le operazioni di forgiatura. I segreti dei nostri spadai, che li fecero
tanto apprezzare in Europa, erano da un lato la loro straordinaria bravura e dall'altro il
ferro che utilizzavano per creare l'acciaio delle loro lame. Quello migliore proveniva dalle
miniere di siderite del Fursìl, nella parte alta della provincia di Belluno. Il minerale ferroso
che vi veniva estratto era infatti ricco di manganese, che rendeva le lame molto elastiche
ed allo stesso tempo resistentissime. Ed elasticità e resistenza sono le caratteristiche
fondamentali per una buona spada. Il ferro del Fursìl era noto sul mercato come “ferro
dell’agnello”. Questo marchio era garanzia di grande qualità, come il marchio della lupa
11
sulle lame delle spade, usato non solo a Passau o a Solingen, in Germania, ma anche dagli
spadai di Belluno.
Pietro da Formicano
Pietro nacque a Formegan, attorno alla metà del XVI secolo, da Lucia e dal maestro spadaio
Antonio, il quale era figlio di Giorgio, molto probabilmente spadaio pure lui. Pietro aveva
tre fratelli: Giovan Maria, uno spadaio molatore, che si occupava cioè di uniformare e
levigare le lame dopo la forgiatura, utilizzando la mola, e Giacomo e Giorgio, maestri
spadai. Aveva anche due sorelle: Ricca, che morì poco dopo il matrimonio con lo spadaio
acutore - cioè colui che affilava le lame - Girolamo Pilotto detto Bazzolle e Giovanna,
moglie di Antonio da Romagno, appartenente ad una famiglia nobile, ma ormai in
decadenza, cosa che lo spinse a diventare a sua volta spadaio. La casa e la fucina di Pietro e
dei fratelli si trovavano a Santa Margherita, in una località chiamata “al Brolo” o “alle
Molle”. Forse si tratta dell’elegante edificio che oggi è conosciuto come la “Casa dei Faori”.
Quando Antonio morì, nel 1585, la fabbricazione delle spade venne portata avanti da
Pietro con l’aiuto dei fratelli. Solo un grande maestro spadaio poteva firmare col proprio
nome le lame che forgiava. Su quelle di Pietro c’è la scritta “Pietro da Formicano”. L’intera
famiglia era impegnata nella produzione di armi, soprattutto lame da spade e spade
complete. Anche lo zio di Pietro, infatti, che si chiamava Lorenzo, era un maestro spadaio,
così come suo figlio Angelo. Si trattava di un’arte che veniva trasmessa di generazione in
generazione. A dire la verità, non sappiamo se Filippo, il figlio di Pietro, seguì le orme del
padre, ma il nipote Giuseppe, il figlio di Giacomo continuò a lavorare nella fucina. La
famiglia di Pietro sembra essere stata la più importante della zona nella produzione delle
spade, anche se ve ne furono altre. Le fucine si trovavano principalmente a Formegan, ma
una era anche a Volpere e un’altra si trovava a Ignan. La fabbricazione delle armi fu di
sicuro un’attività molto intensa nel territorio di Santa Giustina, tra Cinque e Seicento.
Questa produzione attirò in paese molti lavoratori del metallo, da zone vicine del feltrino e
del bellunese, i quali volevano imparare l’arte o aumentare le loro conoscenze alle
dipendenze di famosi maestri come Pietro. Spesso, dopo essere diventati bravi, trovavano
facilmente impiego in centri più grandi, soprattutto a Belluno. Anche Pietro, verso i primi
anni del Seicento, si trasferì a Belluno, nella fucina di Fisterre, dove avevano lavorato i
grandissimi maestri Andrea e Zandonà Ferrara. Lui ci andò, molto probabilmente, perché
aveva bisogno di una fucina più grande, perché a Belluno c’erano condizioni economiche
più favorevoli e forse anche perché c’era la possibilità di avere rifornimenti più abbondanti
del ferro migliore. Le spade a Formegan vennero prodotte anche dopo la sua partenza, ma
fu con lui che quell’attività visse il suo periodo d’oro. Pietro, assieme ai fratelli Ferrara, è
12
stato uno dei più grandi artisti europei della forgiatura. Le sue opere, realizzate per re e
imperatori, non hanno nulla da invidiare a quelle degli straordinari spadai di Toledo e di
Solingen. Purtroppo qui, a differenza di quel che è successo all’estero, questa storia
gloriosa non è stata molto considerata. Il ricordo di Pietro e il nome di Formegan vivono
oggi nelle sue realizzazioni che sono esposte nei più importanti musei del mondo, non
come reperti del passato, ma come opere d’arte di altissimo valore. Ora non vi resta che
girare queste pagine per scoprirne alcune!
I principali centri di produzione di spade in Europa tra 1500 e 1600. Disegno di Martino Frescura
13
La spada e le sue parti
Nel Medioevo la spada veniva usata principalmente per scopi militari. Con il passare del
tempo, però, le cose cambiarono, tanto che dalla prima metà del Cinquecento cominciò a
diffondersi anche per uso civile. Essa sottolineava, infatti, il prestigio del proprietario e, per
questo divenne più pratica, più maneggevole, di dimensioni più contenute. I nobili
sfoggiavano spade con lame formidabili e dalle guardie finemente decorate, spesso
arricchite con oro e argento o pietre preziose. Si diffuse la spada da lato, così detta perché
veniva portata lungo un fianco, quasi come un accessorio dell’abbigliamento. Questa
poteva essere diversa dalla spada di un semplice militare e non solo per la forma. La spada
di un comune soldato, infatti, non poteva competere, per molti aspetti, con quella di un
nobile di alto rango. Data la sempre più larga diffusione delle spade, nel Cinquecento
furono scritti molti trattati di scherma che insegnavano i passi e i movimenti da compiere
durante un duello. Nacquero così vere e proprie scuole di scherma, una disciplina che
aveva molti punti di contatto con la danza! Non dobbiamo inoltre dimenticare che in
questo secolo l'onore contava molto. Se una persona nobile veniva sfidata a duello non
poteva tirarsi indietro. Per questo, chi portava una spada era obbligato a conoscere le
tecniche di attacco e difesa. Portare una spada senza saperla usare poteva infatti rivelarsi
fatale. In una spada possiamo riconoscere quattro elementi sempre presenti: il pomo o
pomolo, l'impugnatura, la guardia e la lama. Ora li analizzeremo nel dettaglio, a partire dai
primi tre che costituiscono il fornimento.
Pomo o pomolo
Il pomolo, o pomo, è una parte fondamentale della spada, anche se spesso non lo si
immagina. Esso infatti ha l'importantissimo compito di bilanciarla.
Impugnatura
L'impugnatura serve a mantenere saldamente la presa sulla spada e può essere costituita
da diversi materiali, come per esempio legno rivestito di cuoio.
Guardia
La guardia (chiamata anche elsa o elso) è invece la parte che protegge la mano che regge la
spada dai colpi portati dall'avversario. Inizialmente era composta da due “braccia” di ferro
perpendicolari alla lama, ma poi, con il trascorrere del tempo, si fece sempre più elaborata,
arricchendosi di altri elementi.
14
Le parti del fornimento
Disegno di Martino Frescura
Lama
La lama è l'elemento più importate in una spada ed è formata da queste parti:
1. il codolo che passa all’interno dell’impugnatura della spada e al quale viene fissato il
pomolo. Si tratta di una parte non visibile quando il fornimento è montato.
2. Il forte (come è facilmente intuibile dal nome, questa è la parte più resistente). È il
primo terzo della lama, quello più vicino all’impugnatura.
3. Il medio, la parte centrale della lama.
15
4. Il debole, l’ultimo terzo della lama di cui fa parte anche la punta. L’avversario è
solitamente colpito dalla parte debole, quella che più facilmente si spezza se
sottoposta a sforzo eccessivo, specie quando la lama non è di ottima qualità.
Lo sguscio è una “scanalatura” della lama, che ha la funzione di alleggerire l’arma e
non ha scopi più cruenti, come molti invece credono.
Fornimento a Tre Vie, ideato dai maestri spadai bellunesi nella seconda metà del XVI secolo. Disegno di Gosanesh Cassol
16
Le opere di Pietro da Formicano
Spada di Pietro da Formicano, appartenuta all’imperatore Rodolfo II d’Asburgo e oggi conservata al
Kunsthistorische Museum di Vienna
17
Rodolfo d’Asburgo
Rodolfo II d’ Asburgo nacque a Vienna il 18 luglio 1552.
Nel 1556, quando Carlo V, il nonno di Rodolfo, rinunciò al
trono, il suo impero venne diviso in 2 parti: il figlio Filippo
II avrebbe regnato in Spagna e sui possedimenti dei Re
Cattolici, mentre il fratello Ferdinando, sulla parte
Orientale della Casa d’Austria. Alla guida dell’impero
successe suo figlio Massimiliano e a quest’ ultimo
succederà Rodolfo. Rodolfo, che visse la sua giovinezza a
Madrid, nel 1571 tornò alla corte di Vienna e lì venne
incoronato re e poi imperatore nel 1576. Nel 1582 lasciò
Vienna e si trasferì a Praga. Rodolfo II era interessato
all’alchimia, scienza suprema per comprendere i segreti
della natura e superarne le leggi che la regolano; il suo
obbiettivo era quello di trovare la pietra dei filosofi e l’elisir dell’immortalità.
Il Kunsthistorische Museum di Vienna
Il Kunsthistorisches Museum (in italiano Museo della Storia dell'Arte), è uno dei principali
musei di Vienna ed uno dei più antichi e ricchi al mondo. L'edificio principale, si trova in
Maria Theresien-Platz, lungo la Ringstraße che circonda il distretto di Innere Stadt. Il
Museo venne inaugurato ufficialmente il 17 ottobre 1891 alla presenza dell'imperatore
Francesco Giuseppe I d'Asburgo. L'edificio si affaccia sulla Maria-Theresien-Platz,
specularmente al Naturhistorisches Museum (Museo storico-naturalistico). I due musei
vennero commissionati dall'imperatore nel 1858 per contenere l'immensa collezione di
opere d'arte degli Asburgo e per rendere il loro patrimonio accessibile a tutti. Le facciate
richiamano lo stile rinascimentale italiano e gli interni sono decorati con marmo,
ornamenti di stucco e oro e pitture.
Daniel Sadeler
Daniel Sadeler, appartenente ad un’importante famiglia di artisti, fu uno degli orafi più
importanti dei primi del Seicento. Lavorò a Praga, per Rodolfo II e a Monaco di Baviera.
Sembra che sia opera sua il raffinato fornimento della spada di Pietro, appartenuta a
Rodolfo II. Molto probabilmente la lama per l’imperatore d’Austria fu uno degli ultimi,
importantissimi lavori che Pietro fece a Formegan, prima di trasferire la sua attività a
Belluno, nella fucina di Fisterre.
19
Purtroppo qui da noi, per molto tempo, le opere dei
nostri grandi spadai, non sono state molto
considerate e loro stessi non sono molto conosciuti.
Invece nel resto d’Europa non sono mai stati
dimenticati.
Fin dalla metà dell’Ottocento, infatti, le spade
realizzate da Pietro da Formicano, da Andrea e da
Zandonà Ferrara sono state riprodotte in
importanti giornali d’arte francesi ed inglesi,
accanto alle immagini di quadri e statue di artisti
famosissimi, come veri capolavori dell’arte della
lavorazione del metallo.
20
Ecco un’altra dimostrazione della grandissima fama raggiunta dalle opere di Pietro da Formicano.
La spada appartenuta a Rodolfo II (a destra), in un prestigioso catalogo di fine Ottocento
riguardante le collezioni imperiali asburgiche, fotografata assieme alla spada di
Don Giovanni d’Austria (a sinistra), trionfatore a Lepanto.
21
Don Giovanni d’Austria
Don Giovanni d’Austria (1547-1578) era il figlio illegittimo
dell’Imperatore Carlo V. Fu un condottiero e un
diplomatico molto celebre ai suoi tempi. Fu al comando
delle forze della Lega Santa a Lepanto con le quali
sconfisse quelle ottomane, comandate da Alì Pascià, che
morì in quella battaglia.
La battaglia di Lepanto
La battaglia di Lepanto, combattuta
nel 1571, fu la prima vittoria di una
flotta cristiana contro l’Impero
ottomano. Da un lato infatti c’erano
i Turchi e dall’altro le forze della
Lega Santa, composte dalla
Repubblica di Venezia, dall’Impero
spagnolo, dallo Stato Pontificio,
dalla Repubblica di Genova, dai
Cavalieri di Malta, dal Ducato di Savoia, dal Granducato di Toscana e da altri piccoli stati
italiani. La vittoria della Lega Santa in questa grande battaglia navale per un po’ frenò
l’espansione turca, ma essa riprese quasi subito e continuò per molto tempo ancora, tanto
che, più di un secolo dopo Lepanto, i turchi ottomani arrivarono ad assediare Vienna.
Molte delle armi bianche impugnate dalle truppe veneziane a Lepanto furono prodotte nel
Bellunese.
22
Straordinaria spada di Pietro da Formicano, a lama traforata, conservata al Museo delle Armi di Vienna e riprodotta in un giornale d’arte dell’Ottocento
23
La stessa spada in un altro giornale d’arte francese dell’Ottocento. Quest’opera, che non
sappiamo se sia ancora a Vienna, è un vero capolavoro. La lama di Pietro, che presenta una
traforatura che la rende simile a un gioiello, si accompagna a un fornimento finemente
cesellato da un abilissimo orafo. Nel fornimento sono rappresentati episodi e personaggi
biblici. A noi oggi può sembrare strano che si decorassero le armi con raffigurazioni di
carattere religioso, ma all’epoca era un’usanza molto diffusa.
24
Altro capolavoro di Pietro da Formicano. La spada del Granduca di Toscana conservata al
Metropolitan Museum of Art di New York. Anch’essa a lama traforata.
25
Ferdinando II Granduca di Toscana
Ferdinando II de’Medici, nacque a Firenze nel 1610 e fu
granduca di Toscana fino al 1670. Figlio di Cosimo II e di
Maria Maddalena d’Austria, successe al padre quando
aveva solo undici anni e governò sotto la reggenza della
nonna Maria Cristina e dalla madre. Fu al potere per
molti anni e si trovò coinvolto in diversi conflitti che
dissanguarono le risorse del paese, in particolare
durante il periodo della guerra dei Trent’anni, senza
che fosse possibile ottenere risultati importanti, tranne
l’acquisto della contea di Santa Fiora da un’altra
dinastia. Incoraggiò molto gli studi sperimentali e favorì
i traffici marittimi.
Metropolitan Museum of Art
Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The
Met", è uno dei più grandi ed importanti musei del mondo. La sua sede principale si
trova sul lato destro del Central Park a New York, lungo quello che viene chiamato il
Museum Mile (cioè il "Miglio dei musei"). Nel 1986 è stato inserito nella lista dei
National Historic Landmark. Il Met dispone anche di una sede secondaria, chiamata
The Cloisters, che contiene la sezione dedicata all'arte medievale.
26
Sempre da un antico catalogo d’asta, un’altra Pietro da Formicano, che sembra la stessa spada oggi conservata al Museo Marzoli di Brescia
27
Il Museo Marzoli
La collezione Marzoli di Brescia è tra le prime in Europa sia per la quantità che per la qualità delle armi esposte. Questa raccolta è il frutto di una generosa donazione, fatta il 26 gennaio 1965, dall'imprenditore Luigi Marzoli di Palazzolo sull'Oglio che, nel suo testamento, lasciò al comune di Brescia la propria collezione privata di armi antiche, raccolte in un cinquantennio di attente ricerche in Italia e nel mondo. Il museo venne inaugurato nel 1988 e unisce alla collezione donata dal cavalier Luigi Marzoli, un gruppo di armi già appartenenti al Museo dell'Età cristiana. La collezione ha sede nel mastio visconteo del castello ed espone armi bianche e armature dal XV al XVII secolo ed armi da fuoco fino al XVIII secolo, suddivise per epoche e tipologie diverse. Inoltre sono esposti anche quindici cannoni fabbricati nello stesso arco di tempo. In mostra si possono anche ammirare spade, spadoni, celate, pugnali e mazze.
Fornimento di schiavona, uno dei tipi di spada più prodotto nelle fucine del Bellunese. Disegno di Martino Frescura
29
La collezione Odescalchi
La collezione Odescalchi di Palazzo Venezia a Roma è una delle più conosciute e importanti raccolte di armi al mondo. Comprende esemplari che ricoprono un intervallo di tempo molto ampio che va dall'antichità, con una piccola ma importante sezione archeologica, agli esemplari dell'epoca medievale, rinascimentale e seicentesca. Nella collezione sono presenti molti tipi di armi: da quelle da guerra a quelle da cerimonia o parata, le armi bianche e le armi da fuoco, armi da caccia, armi da torneo.
Lo spadone a due mani
Lo spadone a due mani è un'arma molto lunga e pesante. L'impugnatura, spesso rivestita di cuoio, permette la presa con tutte e due le mani. Si usava soprattutto per dare fendenti in battaglia, ma gli spadoni potevano anche essere usati come armi da parata. Nel Cinquecento venne resa più sicura la presa attraverso cambiamenti all'impugnatura e alla base della lama, che fu allungata fino a far raggiungere l'altezza di un uomo. Lo spadone a due mani in battaglia veniva spesso usato per spezzare le picche nemiche, cioè delle lance molto lunghe che formavano vere e proprie "foreste" acuminate allo scopo di fermare i cavalieri avversari. Viste le dimensioni e il peso, lo spadone a due mani era usato soprattutto da soldati particolarmente forti e robusti.
Disegno di Gosanesh Cassol
30
Un’altra spada di Pietro da Formicano conservata nella Collezione Odescalchi. In questo caso , molti decenni dopo la sua realizzazione, sulla lama di Pietro fu montato un fornimento “alla spagnola”. I fornimenti infatti seguivano il gusto della moda. Quando erano considerati sorpassati, venivano sostituiti con altri ritenuti più moderni. Questo però succedeva solo per le spade dalle lame eccezionali. Come quelle di Pietro!
31
Altra Pietro da Formicano a lama traforata, come appare nel catalogo di un’antica asta svoltasi in Germania.
33
Cracovia
La città di Cracovia è stata la capitale della Polonia cattolica fino
alla fine del XVI secolo, quando il centro del potere politico
venne spostato a Varsavia. Nel 1978 il suo cuore medioevale è
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Cracovia
presenta molti luoghi antichi tra cui la Piazza Grande del
Mercato, sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale
Sukiennice e dalla Chiesa gotica di Santa Maria. A Cracovia,
inoltre, si trova il castello Wawel che fu sede del governo
nazionale per gran parte del Medioevo e del Rinascimento. Andando a visitare il
castello di Cracovia, se guarderete in basso alle mura, vicino al fiume Vistola, vedrete
un drago in metallo che sputa fuoco dalle fauci. Il suo nome è
Smok Wawelski. Si tratta di un drago che, secondo la
leggenda, ogni anno divorava 7 ragazzi e 7 ragazze della
collina di Wawel. Un calzolaio trovò il modo di ucciderlo
dandogli in pasto una pecora riempita di zolfo. Lui la divorò e
iniziò a bere acqua, ma, per quanta ne bevesse non riuscì a
placare la sua sete, tanto che morì.
La schiavona
La schiavona è una spada legata alla storia di Venezia. Si chiama così perché la usavano
gli “schiavoni”, cioè i soldati della Repubblica Veneta che arrivavano dai possedimenti
al di là del mare Adriatico, che speso venivano assoldati nella Guardia del corpo del
Doge. I primi esemplari compaiono poco dopo la metà del XVI secolo. Le schiavone
hanno il fornimento ingabbiato, l’impugnatura in legno rivestita in cuoio e pomo,
spesso in bronzo, dalla forma detta “a testa di gatto”. La lama è molto larga, a punta e
quasi sempre a doppio filo (taglia da entrambi i lati) con uno o più sgusci. Questa
spada subì vari cambiamenti nel tempo e fu in uso fino alla caduta di Venezia nel 1797.
Il Muzeum Narodowe
Il Museum Narodowe – cioè il Museo Nazionale - di Cracovia fu fondato nel 1896 ed
espone circa 700.000 opere. Il Museo è distribuito in più palazzi storici della città. Le
raccolte più importanti sono quelle del Museo Czartoryski. Tra le opere di maggior
rilievo, il Museo Czartoryski ospita il dipinto, attribuito a Leonardo, "La dama con
l’ermellino" e due tele di Rembrandt, "Paesaggio con il buon Samaritano" e "Paesaggio
prima della tempesta". Alcune sale del museo sono riservate all’esposizione di armi
prodotte in Europa comprese spade, armature e alabarde provenienti dall’Italia.
34
L’arte della Scherma
Nel Rinascimento la scherma fu considerata una vera e propria arte. Gli stessi trattati in
cui è descritta, pieni di incisioni di grande qualità e molto accurati dal punto di vista
linguistico, sono delle opere d’arte. I trattati del bolognese Achille Marozzo e di Antonio
Manciolino stabiliscono dei punti di partenza per i successivi maestri. Tra i più famosi,
ricordiamo Ridolfo Capoferro, Camillo Agrippa, che fu anche architetto e matematico,
Giacomo Di Grassi, Nicoletto Giganti solo per citarne alcuni. I maestri di scherma prestano
sempre più attenzione alle posizioni di guardia, alle parate, al passeggio, in cui molta
importanza è data agli spostamenti laterali, usati spesso nel duello, tanto che i movimenti
dei piedi si iscrivono in un immaginario cerchio sul terreno. Spesso alla spada si abbinano
altri due oggetti: una daga, una specie di pugnale da tenere nella mano sinistra, oppure
una cappa, un mantello da tenere al braccio sinistro.
Due maestri di scherma veneti: Salvatore Fabris e Vincenzo Saviolo
Salvatore Fabris nacque a Padova nel 1544. Della sua gioventù non si
conosce molto, forse frequentò l’Università di Padova. Fino al 1590 si
sa che viaggiò per molti corti europee; fu infatti in Francia, in
Germania e in Danimarca. Qui diventò istruttore di scherma del Re
Cristiano IV. Si racconta che nel 1599 fu invitato in Inghilterra da
William Shakespeare che gli chiese aiuto per la prima
rappresentazione di Amleto, nelle scene in cui venivano usate le
spade. Scrisse un’opera di scherma famosa, “La scienza e pratica
d’arme”, dedicata al Re Cristiano IV, che venne ristampata molte volte
e tradotta anche in tedesco. Morì a Padova nel 1618, a 74 anni, dopo 10 giorni di febbre
intensa, e la città gli rese grandi onori. Anche Vincenzo Saviolo nacque a Padova e fu un
soldato prima di diventare un maestro di scherma. Trasferitosi in Inghilterra, pubblicò un
trattato in inglese, intitolato “His Practice”, in due libri. Il primo tratta l'uso della striscia
(spada) e del pugnale, il secondo dell'onore e delle questioni d'onore. Egli dedicò il suo
libro al Conte di Essex, del quale era maestro, come si usava a quel
tempo. Saviolo istruì lui e altri nelle tecniche schermistiche che egli
stesso aveva contribuito a diffondere in Inghilterra. Qualcuno dice
che a scrivere il libro fu aiutato da John Florio, amico di William
Shakespeare, il quale forse trovò ispirazione negli insegnamenti di
Saviolo per alcune scene delle sue opere. Vincenzo Saviolo morì
attorno al 1599. Forse anche questi due celebri maestri di scherma
contribuirono a diffondere in Europa la fama delle spade bellunesi.
35
Il Fursìl, il “ferro dell’agnello” e Pietro ad Andraz
La siderite
La siderite è un carbonato di ferro (FeCO3) appartenente al gruppo minerario della calcite.
La siderite è composta per quasi il 50% di ferro, mentre la restante percentuale può
contenere altri elementi come alluminio, calcio, magnesio, zinco e manganese. Un tempo
era nota anche come “ferro spatico” o siderose. Il
colore è di gradazioni che variano dal giallo al
marrone scuro o nero nel caso della siderite
manganesifera. In Europa i giacimenti più fruttiferi si
trovano in alcune regioni tedesche, in Cornovaglia,
in Ucraina, in Austria, in Svizzera e nelle Prealpi
Lombarde (Val Seriana, Val di Scalve, Val Trompia,
Val Camonica). Altri giacimenti importanti si trovano in America. Nei secoli passati la
variante manganesifera del minerale si estraeva anche da noi nelle Miniere del Fursìl,
presso Colle Santa Lucia. Il minerale si formò, grazie a complicati processi, entro vene
idrotermali a profondità non molto elevate e lo ritroviamo oggi nelle rocce sedimentarie
della Formazione a Bellerophon che affiorano alle pendici del Monte Pore. La siderite
manganesifera era molto apprezzata perché, una volta lavorata, conferiva al ferro
caratteristiche simili a quelle dell’acciaio: grande resistenza, elasticità e contrasto alla
formazione di ruggine.
Le miniere del Fursìl
Colle Santa Lucia, uno dei comuni della Ladinia, era importante perché produceva un
ottimo tipo di ferro grazie alle Miniere del Fursìl. Questo tipo di ferro aveva la
proprietà di essere molto resistente, non faceva ruggine ed era elastico. Tra i suoi
numerosi impieghi, risultava ottimo per la fabbricazione delle spade. Per questo era
particolarmente ricercato dagli spadai di Belluno e di Formegan, in particolare dai
grandi maestri. Le miniere del Fursìl per secoli fecero arricchire i loro proprietari e,
trovandosi al confine tra i territori del Vescovo di Bressanone e quelli di Venezia,
furono spesso oggetto di contesa. Vengono nominate per la prima volta nel 1177, in un
documento dell’Imperatore Federico I “il Barbarossa”, che assegnò al Convento di
Novacella la loro proprietà. Poi furono del Principe Vescovo di Bressanone. Fino
all’inizio del XVIII secolo continuò l’estrazione dei minerali (in particolare la siderite
manganesifera) che venivano lavorati nei forni distribuiti nell’Agordino e presso il
36
Castello di Andraz. All’inizio del Settecento le miniere vennero chiuse perché
l’estrazione non era più redditizia. Molto tempo dopo, in piena epoca fascista, quando
l’Italia cercò di non dipendere più dall’estero per le materie prime, la ditta Breda fu
incaricata di riaprire le miniere, ma il tentativo non ebbe successo e nel 1945 le
miniere vennero definitivamente chiuse. Oggi è possibile percorrere la “Via della Vena”
e la “Via del Ferro” e osservare i siti minerar i. Rivolgendosi all’Istitut Ladin “Cesa de
Jan” di Colle Santa Lucia è possibile usufruire di interessantissime visite guidate alle
miniere.
Il castello di Andraz
Il Castello di Andraz sorge su di un grande masso roccioso trasportato a valle
dall’ultima glaciazione (15.000 anni fa circa) e si trova in posizione dominante sulla
vallata offrendo un totale controllo sull’area ed in particolare sulla “Strada della Vena”,
via di commercio e trasporto del ferro e dei metalli estratti nelle miniere del Fursìl. Il
castello, che si può raggiungere dalla strada che unisce il Passo Falzarego a Caprile, si
trova a circa 1800 m. d’altezza.
Probabilmente la fortezza esisteva già
intorno all’anno 1000. Il Principe Vescovo
di Bressanone se ne impossessò nel 1416
e ne mantenne il controllo fino ai
primissimi anni dell’Ottocento, quando fu
messo in vendita e acquistato da una
persona del luogo. Il maniero subì nei
secoli alcuni restauri e ristrutturazioni.
Durante il primo conflitto mondiale fu
addirittura bombardato dalle vicine
postazioni del Col di Lana. Oggi è sede di
esposizioni, meta di visitatori e di
rievocazioni storiche di grande fascino. La
struttura del Castello è caratterizzata da
piani sovrapposti che sfruttano
l’inclinazione e la forma del masso. Il
personaggio più illustre che vi soggiornò,
tra il 1457 e il 1460 fu Nicolò Cusano,
nominato qualche tempo prima, dal Papa,
Vescovo di Bressanone. Egli, per sfuggire
ai pericoli che avrebbe corso restando in città, si rifugiò ad Andraz dove portò avanti le
sue ricerche nel campo dell’astronomia e della filosofia. Il Castello oggi è circondato da
37
splendide foreste di conifere, attorniate da verdi pascoli e da cime rocciose. La
sacralità del luogo, la bellezza del paesaggio e il recente, straordinario intervento di
recupero del maniero, ne fanno uno dei simboli di maggior fascino delle Alpi Orientali
ed hanno contribuito al riconoscimento delle Dolomiti quale Patrimonio dell’Umanità
da parte dell’Unesco. La struttura del Castello è costruita su 5 piani. L’ingresso attuale
si trova sul lato nord e guarda vero il Passo Valparola. In passato l’entrata principale
era sul lato opposto e guardava verso valle. A sinistra dell’ingresso si trovano i resti
della piccola chiesetta annessa alla fortezza. L’altare in legno dorato è oggi visibile
presso la chiesa di Andraz. Opposta a questa si trovava la cantina che serviva a
custodire il vino, il formaggio e le provviste. Salendo la spettacolare scala metallica
esterna, si raggiungono le altre sale. Da notare la prigione degli uomini, separata da
quella delle donne, dove i prigionieri venivano gettati tramite una botola e dove
potevano anche essere incatenati. Salendo ulteriormente si trovano le cucine dove si
vedono ancora le canne fumarie. A fianco a queste troviamo le stanze della vita
quotidiana, i salotti, che potevano così sfruttare il calore generato nelle cucine ed
erano molto luminosi. A questo livello giungeva anche il grande argano che
permetteva di sollevare oggetti e materiali diversi dal piano del terreno. Salendo
ancora si raggiunge la stanza del capitano, dotata di servizi. Infine, nel sottotetto
trovavano alloggio i soldati e c’erano anche altri locali. Nei dintorni del Castello
sorgevano i forni fusori e il villaggio dove vivevano numerose persone. Sappiamo che
anche Pietro da Formicano fu ad Andraz in un giorno del 1600. Molto probabilmente
non fu l’unica volta che ci andò. Sembra che sia stato ad Andraz per controllare
direttamente il materiale estratto dalle miniere e scegliere il ferro migliore per
realizzare qualcuno dei suoi straordinari capolavori.
La leggenda della Delibana
Alle Miniere del Fursìl è legata anche la leggenda della Delibana. Si narra che tanto, tanto
tempo fa, una ragazza, per garantire che l’estrazione del minerale
fosse abbondante, venisse mandata a fare un giro del Monte
Pore, con una “bacchetta” dai poteri speciali, quasi per benedirlo.
Ma un giorno il castellano di Andraz vide una di queste ragazze
impegnata nel rito. Lei era bellissima e lui si innamorò tanto che
cominciò a trascurare la moglie, che ovviamente si infuriò. Pensa
che ti ripensa, per togliere di mezzo la rivale, decise di affidarsi
alla magia nera. Così si rivolse a un potente mago, il quale stabilì
che la Delibana doveva essere rinchiusa nella miniera, sorvegliata
dai nani che lì vivono, per sette anni, allo scadere dei quali
soltanto il padre o il fidanzato avrebbero potuto andare a liberarla. Passarono gli anni e le
38
Delibane si susseguirono una all’altra, finché si giunse
all’insediamento di una nuova Delibana che era orfana di
padre. Lei indossava lo splendido vestito magico tessuto
dalle madri dei minatori con i fiori che crescevano sul
Monte Pore ed era bellissima. Il figlio del castellano di
Andraz come la vide si innamorò e le promise che
sarebbe andato a riprenderla allo scadere dei sette anni.
Ma il giorno che sarebbe dovuto andare a prenderla, il
padre lo rinchiuse nella stanza più sicura del castello, in
modo che non potesse scappare con lei, visto che voleva
che il figlio sposasse una ragazza nobile. Questa ragazza, però, sapeva che il principe non
era innamorato di lei, tuttavia, non volendo rinunciare alle nozze, lo pose davanti a una
scelta: «Se sposi me farò in modo che non ci siano più Delibane, invece se andrai a liberare
la Delibana la tradizione continuerà e altre ragazze saranno rinchiuse». Il principe scelse di
sposarsi. Dall’unione nacque una bella bambina, ma la moglie morì di parto. Il principe allo
scadere dei successivi sette anni decise di liberare la Delibana, ma si presentò in ritardo,
dopo la mezzanotte, e i nani della miniera gli dissero che la Delibana non poteva essere
liberata perché era troppo tardi. Dopo qualche tempo i nani si presentarono al castello con
un baule contenente lo splendido vestito magico della Delibana, che, sentitasi
abbandonata, alla fine era morta. Il castellano, afflitto, nascose il baule con il vestito della
ragazza che aveva amato nel suo armadio e decise che non ci sarebbero più state altre
Delibane, ma così facendo ben presto la miniera
si esaurì. I nani pretesero quindi un’altra
Delibana. La figlia del castellano di Andraz
casualmente trovò il baule, lo aprì e indossò il
vestito. Così facendo, però, l’incantesimo
dell’abito la vinse, tanto che volle essere lei la
nuova Delibana. Il castellano, oppresso dalle
continue richieste dei nani e della figlia, alla fine
rinunciò ai suoi propositi e acconsentì che le cose
andassero così. Passarono però solo poche settimane da quando vide la figlia entrare nelle
miniere che il padre morì di crepacuore. Così, dato che la ragazza non aveva un fidanzato e
aveva perduto il padre, rimase rinchiusa nella miniera per più di cinquant’anni perché
nessuno andò mai a liberarla e alla fine morì con la veste, che un tempo era stata
splendida, divenuta ormai lacera. E da quel tempo le miniere si esaurirono.
39
Le fucine, le spadaie, una via, un altro grande maestro e il nome di un paese diventato marchio di altissima qualità
Le fucine
Le fucine erano il luogo di produzione delle spade ed erano solitamente costruite con
blocchi di pietra e coperte a coppi. Venivano infatti utilizzati certi materiali proprio per
prevenire i possibili incendi. Le fucine erano situate vicino ad un corso d’acqua, come il
Vesés, indispensabile per la produzione di lame. Esso infatti azionava una ruota a pale
collegata ad un meccanismo che faceva
ritmicamente alzare ed abbassare un tronco,
alla cui estremità era fissato un martello dal
peso di 25 o 30 kg. Questo meccanismo era
detto maglio, ed era utilizzato per
ammorbidire l’iniziale massa di acciaio. Nella
fucina poteva esserci anche più di un maglio;
questo naturalmente significava poter
forgiare una quantità superiore di spade.
Nella fucina lavoravano parecchie persone,
che avevano diverse specializzazioni. Attorno
alle fucine gravitavano anche altri artigiani,
come ad esempio i lavoratori del cuoio, sellai
e calzolai, che avevano le competenze
tecniche per creare i foderi in cui inserire le
spade. Ogni fucina era gestita da un maestro,
che a volte raggiungeva livelli di abilità
straordinari, come Pietro. Il maestro, in latino
detto “magister”, era colui che dirigeva il
lavoro nella fucina, e i più grandi nella loro
arte alla fine del procedimento di forgiatura
potevano firmare la lama. Le principali fucine
di Santa Giustina si trovavano nella zona di
Santa Margherita, a Formegan, ma ce n’era una anche a Volpere ed una a Ignan.
Quel che resta della roggia che alimentava i
magli delle fucine degli spadai di Formegan
40
Le spadaie
A Formegan è testimoniata la presenza di ben due spadaie! I
loro nomi si trovano in antichi documenti risalenti al
Cinquecento. Si tratta della madre di Pietro, Lucia, e della zia
del nostro grande spadaio, Domenica. Questo vuol dire che
anche le donne lavoravano nelle fucine? Probabilmente no.
Semplicemente venivano indicate come “spadaie” quelle
donne che avevano i rapporti di parentela più stretti con gli
spadai più famosi, come Pietro e suo padre Antonio.
Disegno di Gosanesh Cassol
La Via degli Spadai
Nel Rinascimento, in quasi tutte le grandi città, come Milano, Toledo e molte altre, c’era
una “via degli spadai”. La cosa straordinaria è che una Via degli Spadai esisteva anche a
Formegan, che non era certo una grande città, ma un piccolo paese di circa trecento
abitanti. Si trovava nella zona di Santa Margherita, dove c’erano le fucine di Pietro e dei
maestri più importanti. Formegan era davvero il paese degli spadai!
Un altro grande maestro di Formegan: Simeon Manani
Poco tempo fa, in un antico catalogo d’asta, è stata trovato il nome di un altro grande
maestro di Formegan: Simeon Manani. La spada apparteneva ad un collezionista francese
vissuto nell’Ottocento. Non si sa dove sia finita, ma sulla lama, oltre al nome del suo autore
e all’indicazione “da Formicano”, portava anche la scritta “JESUS MARIA. PENSA E PO FA”.
Un’invocazione e un invito a non usarla mai sconsideratamente! Ci sembra straordinario
che da un paesino come Formegan siano uscite spade firmate da ben due grandi maestri,
anche se abbiamo visto che questa non è la sua sola particolarità. E non è finita qui, ce n’è
un’altra!
Il marchio “Formicano”
Come pochi altri centri, però molto più grandi o famosi, ad esempio Toledo, Solingen,
Belluno e Caino, anche a Formegan vennero realizzate spade e altre armi, molto eleganti,
marcate solo con il nome del paese. È un’altra prova della grande fama che questa
frazione, piccola per numero di abitanti, ma importantissima per i suoi spadai, seppe
conquistarsi.
41
Pietro in un romanzo!
I più grandi maestri bellunesi hanno una particolarità
che li differenzia dagli altri spadai d’Europa: se qui,
dove sono vissuti e hanno lavorato, sono in pochi a
conoscerli, in molti paesi europei sono entrati nel
mito. Di loro si parla, infatti, in romanzi e racconti e i
loro capolavori (a volte loro stessi) sono stati
raffigurati da famosi pittori e incisori. Questo è
successo soprattutto ad Andrea Ferrara, ma anche a
Pietro da Formicano, il cui nome, ad esempio,
compare in un romanzo francese del 1902, “Monsieur
de Clerambon”, scritto da uno studioso di armi
antiche. La trama è complicata, ma l’episodio che ci
interessa riguarda una nobildonna che fa un prezioso
regalo al protagonista: una spada avvolta in velluto
verde. Nel consegnargliela gli dice che si tratta di “una
lama di Formicano, alla quale niente può resistere,
perché è in grado di trapassare la miglior corazza che esista”. E più mito di così non si può!
42
Bibliografia
AA.VV., Santa Giustina, Cornuda 1995
M. BALDIN (a cura di), Il castello di Andraz e le miniere del Fursìl. Un itinerario
storico culturale nelle Dolomiti, Venezia 1997
D. BARTOLINI, Ruote ad acqua lungo il Vesés. Storia e tecnologia, Rasai 2005
L. BOCCIA, E. T. COEHLO, Armi bianche italiane, Milano 1975
M. DAL MAS, Spade bellunesi. “…supra royam fluminis Ardi”, Belluno 1980
S. LONGHI, La spada da difesa e da duello, Firenze 2011
G. ROTASSO, Le armi nei secoli del Rinascimento, in Saggi di oplologia, Treviso
1997, pp. 5-26
G. ROTASSO, I Maestri Spadari bellunesi e feltrini, in Quaderni di oplologia, n.
3, Dicembre 1996, pp. 19-21
G. ROTASSO, Una spada schiavona per la Serenissima, in Da Cambrai a
Campoformio. Quaderni di oplologia, n. 5, Dicembre 1997, pp. 135-140
M. VELLO, Lo spadaio e il suo doppio: sul “mito” di Andrea Ferrara, in Dolomiti,
XXXVIII, n. 6, Dicembre 2015, pp. 18-31
M. VELLO, F. TONIN, Pietro, Simeon e gli altri. Appunti sugli spadai feltrini (I),
in Dolomiti, XXIX, n. 4, Agosto 2016, pp. 36-48
M. VELLO, F. TONIN, Pietro, Simeon e gli altri. Appunti sugli spadai feltrini (II),
in Dolomiti, XXIX, n. 5, Ottobre 2016, pp. 40-54
44
LE AUTRICI E GLI AUTORI
Bacchetti Nicola Bonet Gianluca Bortolas Giulia Canal Valentina Casagrande Sara Chiesurin Paola Cosau Sebastian Dal Piva Kevin Fregona Massimiliano Meloni Syria Pergentino Alessia
Perikliu Eneida Pollet Gaia Ren Daniele Scot Ismael Soares De Lima Arthur Vigne Luca Bolzan Edoardo Bortoluzzi Alessio
Buoso Nicola Cadorin Irene Carrera Michele
D’Aprile Gabriele Dal Borgo Manuel De Min Erica Duranti Manuel Lucchetta Lucia Markocevic Viktor Pavei Filippo Salton Irene Triches Lorenzo Zampieri Anna Zannin Margherita
con la collaborazione di
Igor Peruzzo e Carina Riti per i testi, Gosanesh Cassol e Martino Frescura per i disegni
Classi 2B e 2D
Scuola secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo “Gianni
Rodari” di Santa Giustina, a.s. 2015 - 2016 / 2016 - 2017
Della stessa collana:






















































![TTaa]]hhFFnnBB]]]]eemmFFggjjiimmmmbbZZee]] MMXXllnn … · ==^^nn]]llssiiooXXll]]qqlliihh``]]\\XXhh\\nnaa]]bbhhbbnnbbXXeeqqXXpp]]ii^^]]ggiinnbibihhaaXXmmjjXXmmmm]]\\±±ssiiooÄÄll]]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5e19bf042ff6ff7bf674dc89/ttaahhffnnbbeemmffggjjiimmmmbbzzee-mmxxllnn-nnllssiiooxxllqqlliihhxxhhnnaabbhhbbnnbbxxeeqqxxppiiggiinnbibihhaaxxmmjjxxmmmmssiiooll.jpg)