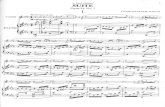GESTIONE ENERGIA 3 10 · 2018. 7. 18. · Dalle aziende: Nuovo standard BS ISO 50001 per le aziende...
Transcript of GESTIONE ENERGIA 3 10 · 2018. 7. 18. · Dalle aziende: Nuovo standard BS ISO 50001 per le aziende...

GRU
PPO
ITA
LIA E
NER
GIA
srl -
Via
Pia
ve 7
- 00
187
Rom
a (R
M) -
N. 1
/ 20
11 -
Ann
o XI
I - Tr
imes
trale
- In
cas
o di
man
cato
reca
pito
invia
re a
Mila
no R
oser
io p
er la
resti
tuzi
one
al m
itten
te p
revio
pag
amen
to re
siG
RUPP
O IT
ALIA
EN
ERG
IA sr
l - V
ia P
iave
7 -
0018
7 Ro
ma
(RM
) - N
. 3/
2011
- A
nno
XII -
Trim
estra
le -
In c
aso
di m
anca
to re
capi
to in
viare
a M
ilano
Ros
erio
per
la re
stitu
zion
e al
mitt
ente
pre
vio p
agam
ento
resi
® www.gruppoitaliaenergia.itè un prodottoeditoriale
gesti
one e
nergi
ap
eri
od
ico d
i in
form
azio
ne t
ecn
ica p
er
gli e
nerg
y m
an
ag
er
3/2011ISSN 1972-697XFEDERAZIONE ITALIANAPER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
FOCUSTelecontrollo e Automazione

gestione energiacov2

GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anninovanta all’interno dell’OPET (Organisations for the Promotion ofEnergy Technologies), rete delle organizzazioni interessate alla diffu-sione dell’efficienza energetica nei paesi della Comunità Europea al-largata, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsaquindi fin dall’inizio dei contributi ENEA, ISNOVA e FIRE e del sup-porto di Gruppo Italia Energia. Dal 2005 Gestione Energia diventaorgano ufficiale di comunicazione della FIRE. Indirizzata principal-mente alle figure professionali che operano nel campo della gestionedell’energia, quali i tecnici responsabili dell’uso razionale dell’energia,gli esperti in energy management, i professionisti e i tecnici di aziendedi servizi energetici, di energy utility, Gestione Energia si rivolge anchea produttori di tecnologie, università, organismi di ricerca e innova-zione, grandi consumatori industriali e civili. Persegue una duplice fi-nalità: da una parte intende essere uno strumento di informazionetecnica e tecnico-gestionale per le figure professionali suddette,dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tec-nica che interessano attualmente il settore energetico nel quadro piùcomplessivo delle politiche economiche e ambientali. I contenuti dellarivista sono ricercati e selezionati principalmente da FIRE, che necura direttamente la parte degli aggiornamenti informatico – istitu-zionali e assicura articoli sulle tematiche più rilevanti del momento,individuando in Gestione Energia uno dei canali privilegiati di comu-nicazione delle proprie posizioni e iniziative nel settore dell’uso razio-nale dell’energia, con la collaborazione di ENEA, ISNOVA e GRUPPOITALIA ENERGIA, nell’ambito dei campi di competenza di questi or-ganismi e dei relativi programmi di attività.
FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è nataper iniziativa ENEA nel 1988 ed è un’associazione tecnico-scientificasenza finalità di lucro per la promozione dell’uso razionale dell’energiae per la diffusione mirata dell’informazione di settore, in particolare asostegno degli utenti finali. La FIRE offre ai suoi associati una seriedi servizi di aggiornamento on-line e consulenza di prima guida persupportare le loro iniziative in campo energetico. Dal 1992 è incari-cata e opera in supporto al Ministero dello Sviluppo Economico perl’attuazione dell’art. 19 della legge 10 del 1991 concernente la figuradel Responsabile dell’uso dell’energia, Energy manager, raccoglien-done tra l’altro le nomine e gestendone la banca dati. Nel contestodel mercato liberalizzato, la FIRE rinnova il proprio impegno istituzio-nale e, grazie ai collegamenti con gli utenti può contribuire con effi-cacia anche alla messa a punto delle politiche di “demand sidemanagement”. L’attività di comunicazione della Federazione legataalla rivista Gestione Energia si avvale della stretta collaborazione conGRUPPO ITALIA ENERGIA.
GRUPPO ITALIA ENERGIA, collabora con FIRE, ISNOVA ed ENEAda circa un decennio. È una realtà che dal 1979 opera nel settoredell’informazione in campo energetico e, con le sue pubblicazioni,rappresenta il “polo editoriale dell’energia” in Italia. Nel contesto diun mercato liberalizzato, con la sua attività mira a rinnovare e con-solidare la funzione istituzionale di “Gestione Energia”, rafforzandoun prodotto realizzato per rispondere alle esigenze informative e for-mative degli energy manager riguardanti le opportunità d’impresa, gliincentivi, le normative, le tecnologie e le soluzioni finanziarie nei settoridella generazione e dell’uso razionale dell’energia. L’attività di unaredazione composta da autorevoli giornalisti ed esperti rende la rivistapunto di riferimento per gli operatori di un settore, quello energetico,che gioca un ruolo di primaria importanza nell’economia nazionale.
www.gruppoitaliaenergia.itwww.fire-italia.org
gestione energiaperiodico di informazione tecnica per gli energy manager
3/2011Direttore responsabile
Paolo De Pascali
Comitato scientificoUgo Bilardo, Cesare Boffa, Dario Chello, Sergio Garribba,
Ugo Farinelli, Sergio Ferrari, Giovanni Lelli
Comitato tecnicoWalter Cariani, Francesco Ciampa, Paolo De Pascali,
Mario de Renzio, Dario Di Santo, Wen Guo, Giuseppe Tomassetti
RedazioneMicaela Ancora, Antonella Ricci
Direzione FIREvia Flaminia, 441 – 00196 Roma
tel. 06 36002543 – fax 06 [email protected]
Redazione FIREvia Anguillarese, 301 – 00123 S. Maria di Galeria (RM)
tel. 06 30484059 - 30483626 - fax 06 [email protected]
Via Piave, 7 - 00187 Romawww.gruppoitaliaenergia.it
Direttore EditorialeEmanuele Martinelli
Pubblicità e ComunicazioneArmando Claudi
Tel. 335 [email protected]
Cettina SiracusaTel. 340 6743898
Responsabile ProduzioneAntonella Ricci
Tel. 348 [email protected]
Grafica e impaginazioneImage srl
Via di Valle Ioro 23 – 00060 Castelnuovo di Porto (RM)Tel. 335 8420851 - [email protected]
Rivista trimestraleAnno XII - N. 3/2011 - Settembre
Registrazione presso il Tribunale di Asti N° 1 del 20.01.2000Abbonamento annuale: Italia Euro 27,00 Estero Euro 54,00Costo copia: Euro 7,00 – Copie arretrate: Euro 14,00 cad.
StampaTEP Arti Grafiche srl
Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 Piacenza (PC)Tel. 0523 5049918 - Fax 0523 516045
Foto cover: fonte Schneider
®
®
GRUPPO ITALIA ENERGIA srlVia Piave, 7 – 00187 Roma – Tel. 06 45479150 – Fax 06 45479172 – [email protected] – www.gruppoitaliaenergia.it
Manoscritti, fotografie e disegni non richiesti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.Le opinioni e i giudizi pubblicati impegnano esclusivamente gli autori. Tutti i diritti sono riservati.È vietata ogni riproduzione senza permesso scritto dell’Editore.

FEDL’USO

GRU
PPO
ITAL
IA E
NER
GIA
srl -
Via
Pia
ve 7
- 00
187
Rom
a (R
M) -
N. 1
/ 20
11 -
Anno
XII
- Trim
estra
le -
In c
aso
di m
anca
to re
capi
to in
viare
a M
ilano
Ro
GRU
PPO
ITAL
IA E
NER
GIA
srl -
Via
Pia
ve 7
- 00
187
Rom
a (R
M) -
N. 3
/ 20
11 -
Anno
XII
- Trim
estra
le -
In c
aso
di m
anca
to re
capi
to in
viare
a M
ilano
Ro
®
www.gruppoitaliaenergia.it
è un prodotto
editoriale
gesti
one e
nergi
aperi
odic
o d
i in
form
azio
ne t
ecnic
a p
er
gli e
nerg
y m
anager
3/2011
ISSN 1972-697X
DERAZIONE ITALIANA
O RAZIONALE DELL’ENERGIA
FOCUS
Telecontrollo
e Automazione
Da una fauce all’altraPaolo De Pascali
PR
IM
AP
AG
IN
A
Piano efficienza energetica 2011: prospettive e novitàIntervista di Micaela Ancora a Nicola Masi, Dirigente Divisione VII Efficienza Energetica e Risparmio Energetico, Dipartimento per l'energia MSE
FOR
MA
ZIO
NE
& P
RO
FES
SIO
NE 8 Il sistema di gestione dell’energia lgs per la grande
distribuzione organizzataFlavio Rottenberg, Ph.D - Università “La Sapienza” di Roma
14 Illuminazione a LED per capannoni industriali: due casi di progetto e realizzazione Giancarlo Repossi, Amministratore Delegato Wissenlux
RU
BR
ICH
E
AppuntamentiNormativa. Delibere e comunicazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del Ministero dello Sviluppo Economico e di altre istituzioni
Le risposte ai Soci
NE
WS News: Realizzati un milione di interventi di efficienza energetica in edilizia • Primo Forum Nazionale sulla
Certificazione Energetica • Aeroporti di Milano leader europei per la neutralità nelle emissioni di CO2Dalle aziende: Nuovo standard BS ISO 50001 per le aziende meno costi e meno CO2 • Siemens mettein funzione i primi prototipi della nuova turbina eolica da 6 MW • REpower e juwi, accordo quadro per lafornitura di 240 turbine • La gamma EDI gode del premio del 10% su tariffa incentivante
22 Telecontrollo e automazione: le chiavi del futuroDario Di Santo - FIRE
24 Automazione degli edifici ed efficienza energetica: la Norma EN 15232Franco Bua, ECD - Engineering Consulting and Design; Angelo Baggini - Università degli Studi di Bergamo
30 Telecontrollo e automazione reti di pubblica utilità Antonio De Bellis, Presidente Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti AssoAutomazione - ANIE
32 La gestione intelligente e integrata degli edifici Gianluigi Gereschi, Area manager Nord Italia - UMPI Elettronica
36 La progettazione integrata come prerequisito per l’efficienza energetica degli edificiSaul Fava, Marketing & Development Manager, Efficienza Energetica - Schneider Electric 4
40 L’ICT per l’efficienza energetica: la prospettiva di Telecom ItaliaRoberta Cocchieri - Telecom Italia
TE
CN
OL
OG
IE&
IN
IZIA
TIV
E
Nuove prospettive per la trazione elettrica stradale Giovanni Pede - ENEA
PO
LIT
ICH
E,
PR
OG
RA
MM
I, N
OR
MAT
IVE Dai rifiuti un aiuto per combattere i cambiamenti climatici. Parte
il progetto di ricerca europeo Clim-WastenerLudovico Tosoratti, IBT EUROPE Business Development Manager; Lavinia Colonna Preti,IBT Group Marketing Manager
F O C U S
Focus Telecontrollo e Automazione22
18
8
6
5
ME
RC
AT
O
& F
INA
NZ
A
Massimizzare la redditività nella produzione dei moduli solariGeoffrey King, Market Manager, Energia Rinnovabile, Saint-Gobain Solar
42
44
48
54
56


3/2011 5
Paolo De PascaliDirettore Responsabile
Ed
itoria
le
nche quest’anno ho deciso di svolgere con piena con-vinzione il solito rituale dei compiti delle vacanze e hopreparato il dossier da portare sotto l’ombrellone.
Sarà perché le ferie diventano sempre più striminzite, o perchéi fascicoli si presentano sempre più gonfi, o più realisticamenteper la puntuale insorgenza a tradimento della pigrizia ago-stana, ma è un dato che negli ultimi tempi il rituale si è andatocomponendo di una seconda fase settembrina che con mestarassegnazione ha accompagnato il riposizionamento del dos-sier in ufficio sulla pila degli inevasi.Questa volta mi sento però abbastanza soddisfatto perché hosmaltito il fardello in misura superiore al recente passato; in ciò,ahimè, favorito dalla maggiore permanenza obbligata tra le muradomestiche, ma anche perché spinto dalla necessità di indiriz-zare l’attenzione lontano dal baratro della crisi che si andavaaprendo sotto i nostri piedi e nella nostra mente. La quale, tro-vandosi in quel frangente a mollo in semicupio marino come d’al-tronde i piedi a essa collegati, è risultata impreparata al crollo edesiderosa di appigli più o meno materiali per uscire dalla buca. Ho così avuto modo di dedicare un po’ di tempo alla piacevolelettura del PAEE 2011 (Piano d’Azione Italiano per l’EfficienzaEnergetica), curato dall’ENEA e pubblicato in bozza dal MSE,che era ai primi posti della mia lista. Per completare l’opera di promozione, e aspirare così ad uncaffè pagato al bar del suddetto Ministero, mi corre l’obbligodi invitare caldamente chi non l’avesse già fatto ad andarseloa leggere all’indirizzo:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/docu-menti/MASTER_PAEE_01_luglio_2011-ENEA.pdfHo detto piacevole lettura non perché il mio masochismo mentalesia arrivato fino al punto di farmi trovare divertente la mole di nu-meri, tabelle, grafici, riferimenti normativi, etc., che corredano levalutazioni già concettose del testo. State tranquilli, le mie prefe-renze vanno ancora ad un giallo di Simenon, specie d’estate. Il fatto è che risulta poco utile cercare di estraniarsi dalle faucidell’orco: non si scappa, continuano comunque a mordere, raf-forzate nella loro opera dall’amplificatore mediatico e dall’evi-dente annaspare delle istituzioni per contenerle. Quindiscaturisce in maniera naturale l’esigenza di applicarsi a ragio-nare in termini positivi e soprattutto propositivi.In questo senso il PAEE 2011 è un buon campo di esercizioprogettuale, non solo per le cose scritte ma anche per quellenon scritte che vengono in qualche modo suscitate dalle prime.Intendiamoci, non si tratta del piano di grande respiro, la sortadi New Deal italiano del risparmio energetico che tutti noi ciaspettiamo per lo meno dai tempi preistorici delle domenichea piedi e per il quale segretamente facciamo voti ogni seraprima di coricarci; piano per il quale, diciamocelo francamente,non abbiamo raccolto in passato serie intenzioni di messa incantiere. Per il futuro mi auguro vivamente che ci sia un decisocambiamento di rotta. Fatto sta che i processi di pianificazioneo programmazione a medio lungo periodo, o che comunquetentino di superare significativamente il “cogli l’attimo”, o se sivuole il “prendi i soldi e scappa”, sembrano non parteciparevalidamente alla conduzione del sistema socio economico no-strano. La classe dirigente italiota, non solo quella politica, diqualunque colore e connotazione, per ragioni per cui occorre-rebbe interpellare un antropologo molto esperto, appare per-vicacemente refrattaria ai programmi veri, quelli dettagliati,
stringenti e impegnativi per tutti. Quando costretti, si ottemperacon piani morbidi, composti da rimandi ad atti successivi, va-lorizzazione di quanto già fatto, frammentazioni della materia,scaricabarili di ruoli, dichiarazioni di intenti a futura memoria,facile cerchiobbottismo tra le parti antagoniste e così via.Ma non voglio indirizzarmi a criticare il PAEE, anche se qualchecritica da fare ce l’avrei. Peraltro alcune critiche importanti sonoriportate (nemmeno troppo velatamente) nel testo stesso (sottoforma quasi di excusatio non petita). Non intendo criticare per-ché credo che allo stato delle cose (vedi ad es. la mancanza diuna organica politica energetica nazionale) non si potesse faredi più. Aspettiamo le risposte della consultazione pubblica chespero siano numerose e pregnanti quanto a critiche, e chequindi rappresentino un segnale forte di interesse e partecipa-zione, per vedere se si rende possibile un ulteriore passo avanti. In questa sede mi interessa piuttosto evidenziare un elementonuovo e positivo inserito nel piano; che riguarda, credo per laprima volta in un documento programmatico istituzionale, il de-ciso intento di puntare alla promozione e valorizzazione di ca-pacità intellettuali.Questo il motivo principale di gradimento: aver trovato ricono-sciuto ciò che andiamo sostenendo con impegno da moltotempo, che cioè la transizione effettiva verso sistemi innovativied efficienti non può che basarsi sullo sviluppo delle cono-scenze e delle competenze, non sulla sola ferramenta. In par-ticolare, sulla promozione di nuove figure professionali nelsettore strategico dell’energy management, quali gli Esperti inGestione dell’Energia che nel Piano trovano ampio spazio ealla cui valorizzazione sono riservate significative iniziative ope-rative. Tra queste meritano sicuramente menzione la configu-razione per gli EGE del ruolo importante di certificatori deirisparmi energetici ottenuti dalle imprese per il raggiungimentodella quota nazionale e la funzione di soggetti attivi per l’otte-nimento dei certificati bianchi. Non ci vuole però molta immaginazione per prevedere chenell’ennesima opera in corso di raschiamento del barile le mi-sure considerate dal Piano corrono il rischio di venire meno,sia quelle preventivate ex novo che quelle già in essere; oquanto meno di essere sospese e dilazionate. Ma soprattuttoè molto probabile che venga meno quel poco di attenzioneconquistata dalle politiche di risparmio energetico: chi voleteche si preoccupi di risparmio energetico nella bufera? Ma forse non sarà così. Come spesso accade, da necessitàpuò nascere virtù e dalle ristrettezze forzate può sortire mag-giore spinta all’uso oculato delle risorse. La situazione puòforse servire a combattere l’avida lupa, per usare una figuradel Poeta, della dissoluzione, che imperversa da tempo nei no-stri paesi ricchi a favore di una maggiore sobrietà. Non lo so. Bisognerà starci dentro, e non solo con i piedi. Misembra molto difficile fare previsioni in questa estate bollentedi solleone e altro, in cui si preavverte l’abisso tra un caffè sha-kerato e una bruschetta all’ortolana, tra un’attesa bagagli e unapartita a racchettoni, nella normalità balneare del gossip e delcalciomercato, ma in cui cerchiamo in fondo di non voler capirecosa stia succedendo e soprattutto cosa potrà succedere, nonsolo per il risparmio energetico, nel freddo inverno che ciaspetta.In bocca al lupo a tutti. Che crepi insieme alla sua degnacompagna.
A
Da una fauce all’altra

P R I M A P A G I N A P R I M A P A G I N A P R I M A P A G I N A P R I M A
gestione energia6
Quali sono i punti più rilevanti del PAEE 2011?Quali le novità che potranno influire positivamentesul sistema Paese in termini energetici?Fra le novità rilevanti del 2° PAEE alcune riguardanoil processo, altre i contenuti. Fra i punti riguardanti ilprocesso ricordo la presenza, da rafforzare, delle Re-gioni e l’apertura di una fase di consultazione pub-blica. Fra i contenuti, la presa in considerazione, anchein linea con i suggerimenti della Commissione, dinuovi settori e di nuovi soggetti. In particolare settorinon rientranti negli usi finali, come la generazione ela trasmissione di energia. Inoltre, si sono prese in con-siderazione iniziative provenienti dalle Regioni o daiComuni (Patto dei Sindaci). Importante è stata anchel’introduzione, accanto all’orizzonte 2016, come dadirettiva 2006/32, dell’orizzonte 2020 del “Pacchettoclima-energia”, su cui è stato costruito il PAN rinno-vabili, effettuando un non semplicissimo esercizio diconvergenza fra PAEE e PAN e identificando in 12Mtep aggiuntivi di risparmi l’obiettivo 2020, misureaggiuntive da definire rispetto a quelle fin qui consi-derate. Obiettivo certamente sfidante, ma possibile
di Micaela Ancora
Si sono appena chiuse le consultazioni, ritiene dipoter già dare una valutazione sulle osservazioni in-viate dai vari attori interessati? Le consultazioni hanno generato un elevato numerodi risposte ricche di suggerimenti e di indicazioni con-divisibili e stimolanti. In estrema sintesi si possonoraggruppare le osservazioni in: a) segnalazioni di miglioramento editoriale-statistico
del testo b) richieste di ampliamento o approfondimento di
temi c) proposte di interventi puntuali, in qualche caso
quantificati d proposte in termini generali di interventi utili a mi-
gliorare le politiche di efficienza energetica.In generale, l’utilizzo immediato dei suggerimenti èstato influenzato dal ristrettissimo tempo per l’analisie il recepimento.Le osservazioni del primo gruppo sono state in gene-rale accolte, le seconde, pur di grande interesse, avreb-bero richiesto tempi più lunghi, o assai più lunghi diquelli disponibili e dunque costituiranno oggetto di
Piano efficienza energetica 2011: prospettive e novitàIntervista a Nicola Masi, Dirigente Divisione VII
Efficienza Energetica
e Risparmio Energetico,
Dipartimento
per l’energia MSE

P A G I N A P R I M A P A G I N
approfondimenti e interventi nella fase successiva.Quanto alle richieste di interventi specifici, adesempio incentivi quantificati, mentre rappresen-tano elementi da considerare nella predisposizionedi provvedimenti specifici, mal si adattavano allecaratteristiche del Piano di documento strategicofortemente caratterizzato sulle misure in vigore.Circa le proposte di carattere generale, sono stateinserite, sia pur brevemente, in varie parti del testo,come ad esempio il cap. V come indicazione di areed’interesse e possibili misure d’interventoOgni contributo esprimeva poi opinioni, sia criticheche di apprezzamento, sul documento. Tutte sonostate esaminate con grande attenzione e saranno digrande aiuto nelle fasi successive, sia di programma-zione, che di predisposizione di provvedimenti.
La FIRE, partecipando alle consultazioni attra-verso l’invio delle proprie Osservazioni al MSE,ha proposto l’introduzione di una componentetariffaria - analoga a quella che alimenta la ri-cerca di sistema - sia sull’elettricità, sia sul gas egli altri combustibili, mirata a finanziare misuredi accompagnamento, come indagini statistiche,studi e campagne di informazione e comunica-zione. Cosa ne pensa? Ritengo che dalla comunicazione dipenda in elevatapercentuale il successo delle politiche di efficienza(e non solo). Penso inoltre che la conduzione di ri-cerche di policy sia un importante strumento di mi-glioramento della qualità delle decisioni. Certo èimportante individuare le fonti di finanziamento (omagari inventariare e razionalizzare i finanziamentigià esistenti). Penso che sulla proposta FIRE si possaragionare, tenendo presente la delicatezza dell’argo-mento e considerando le varie possibili alternative.
Il PAEE giunge in un momento alquanto parti-colare, poiché la manovra fiscale prevede deitagli alle agevolazioni fiscali a partire dal 2013(tra cui le detrazioni 55% per gli interventi di ri-qualificazione energetica). Da una parte si pro-muove, dall’altra si frena. Non è un controsenso?La complessità della situazione finanziaria è sotto gliocchi di tutti. L’equilibrio dei conti pone sfide di di-mensioni generazionali, lasciando uno stretto sentierofra esigenze di sviluppo e condizioni dello sviluppo.L’efficienza energetica è fondamentale per assicurarela competitività del Paese, oltre che per stare nelle re-gole europee. Ma se si vuole un quadro di regole sta-bili occorre che l’impegno finanziario sia sostenibilee che le politiche di efficienza (e le altre) siano anchefinanziariamente efficienti. In questo quadro di ne-cessaria attenzione saranno da ricercare le più idoneemodalità per promuovere la valorizzazione del poten-ziale di efficienza energetica del Paese.
Le soluzioni che contano
gand
ini-r
endi
na.c
om
Ampia gamma di modelli per ogni esigenza
Disponibile versione senza manutenzione
Tutto anche in un unico strumento!
Analizzatori di combustione
fitreC
ÜTe97305NEINUinoizacif
VÜ
i dpii i tttuer tpel ro dloclaC
e CnoizaveliRmei ta drusiMoo a niggariTroa a ntuneTTe
e ghugfacerCuller ia picroTTo
l po isulcn, ielibitsubmoi ci dI 1Na Umroto a nnemidneel r
xO - Nri2O - C2O - Oe Cerffie dnoiessa e prrutaerpm
5480I 1Na Umro73119 e 121I 7Na Um
sae genoizanimu
telell p9 – 1 830I 1
elaizneer
tt
uller ia picroTTo
a Bie e vnumocto danemierfsarT
o attotuTTu
rofniiroiggamrePPe
enoizanimu
ADo PC e Pserh vtotouela Bi ptnapmate a shcni atto da
nmeurruttro sciicnn un ue ichno a
rehtosi:ottodorroplusinoizamr
Aa traer ci p
!otto
ti.liosi@cimr
gand
ini-r
endi
na.c
om .letesiniC
c
moc.liosi.ww.ww177.20662093+)ylatI(iM-.Bolle
inoizuloseL
onatnoceh

L’adozione di sistemi di gestione energia è, at-tualmente, un tema di prioritaria importanzaper le aziende che hanno la necessità di mi-
gliorare la propria efficienza energetica senza compro-mettere la propria competitività sul mercato, in terminidi beni e servizi offerti. L’approccio, ancora oggi do-minante, di legare l’efficienza energetica al migliora-mento prestazionale del parco tecnologico non risultasufficiente a garantire i cogenti obiettivi di conteni-mento dei consumi energetici richiesti a livello euro-peo. In tale contesto, la norma UNI CEI EN 16001 suiSistemi di gestione dell’energia definisce un approcciometodologico di sicuro interesse per questi scopi, of-frendo anche degli strumenti operativi. Al momentoun grande numero di aziende hanno implementato lanorma, ma ancora mancano settori industriali e pro-duttivi che ricoprono una rilevante importanza in ter-mini di consumi energetici. Tra questi, il settore della Grande Distribuzione è unodi quelli più promettenti in termini di risparmio ener-getico. Allo stesso tempo, è uno di quelli che presentale maggiori difficoltà nel coniugare le proprie esigenzeproduttive con la rigidità applicativa delle norme di ge-stione. L’articolo presenta il nuovo Sistema di gestionedenominato Energy Management System for LargeScale Retail (LGS), conforme alla EN 16001, ma conquegli elementi di flessibilità necessari per future im-plementazioni nel settore della grande distribuzioneorganizzata.
L’aziendaIl Gruppo su cui è stata condotta l’esperienza conta 115punti vendita e 6.000 dipendenti divisi tra 40 supermer-cati, 65 piccoli supermercati e 10 ipermercati. Il costoannuale per i consumi elettriciè pari a 12.337.315 euro, paria oltre il 96% del costo energe-tico totale. Confrontando que-st’ultimo dato con il margineoperativo lordo al 2009 delGruppo (9.696.000 euro) si hala misura di quanto i costi del-l’energia incidano copiosa-mente sui bilanci del gruppo.Dal punto di vista della riparti-zione dei consumi, l’illumina-zione, il frigo alimentare e ilcondizionamento coprono oltreil 90% dei consumi elettrici.
Da quanto detto emerge chiaramente che qualsiasi tipodi intervento di efficienza energetica, che determini anchepiccoli risparmi percentuali, può avere ripercussioni rile-vanti in termini di risparmio sulla bolletta energetica.
Il Sistema di gestione dell’energia (LGS)Il Sistema di gestione LGS nasce dall’esigenza di alli-neare la struttura, le procedure, i sistemi, le compe-tenze, l’organizzazione e la strategia della gestioneenergetica al settore della grande distribuzione. Tuttociò funziona solo se l’azienda, intesa come l’insieme dirisorse a tutti i livelli, opera seguendo le procedure svi-luppate con l’LGS.
Ripartizione consumi annui
Luci area vendita, riserve,servizi, luci esterne
carni
Luci qls ups 2
condizionamento
pasticceria
uffici
gastronomia
Luci qls ups 1
frigo alimentare
Luci si qg 1
gestione energia8
FO
RM
AZ
ION
E&
PR
OF
ES
SIO
NE
Il sistema di gestione dell’energia LGS per la grandedistribuzione organizzataFlavio Rottenberg • Ph.D - Università “La Sapienza” di Roma
Energy UniCoop
Strutture
Procedure
Sistemi
Compe-tenze
Strategia
LGS
Strutture
Procedure
Sistemi
Organiz-zazione
Strategia
? Organiz-zazione
Compe-tenze

9
FORMAZIONE & PROFESSIONE
Passi preliminari perl’implementazione del sistemaIl primo passo è stato quello diverificare le condizioni strutturalilegate della Direzione Energia. Il Gruppo, infatti, presentavasolo due risorse impegnate, unenergy manager e un collabo-ratore, a cui si aggiunge lastruttura amministrativa per ilcontrollo delle fatturazioni del-l’energia elettrica e del gas. Alcontrario, la struttura operativatecnica nel suo complessocontava 9 manutentori di iper-mercato, 16 tecnici, 8 addettiagli acquisti nel settore tecnico,per un totale di 33 unità. Taleassetto è tipico nel settore dellaGDO dove, a causa della bassaincidenza del costo dell’energia sul bilancio aziendale(0,5% fino al 2008 in crescita fino all’1,5% del 2010), si èsempre privilegiato prestare maggiore attenzione alla ma-nutenzione e alla conduzione degli impianti per evitareguasti o anomalie, piuttosto che alla gestione. Sulla basedell’analisi effettuata, si è ritenuto necessario rafforzare laStruttura Energia in maniera da costituire un presidio in-terno forte sulle tematiche energetiche, che fosse ingrado di coordinare e gestire il follow-up dei progetti ecoordinare l’attività delle strut-ture territoriali. Una volta creatala struttura, si è proceduto adassegnare dei compiti ben spe-cifici a ciascun componentedella Struttura Energia. Tra que-sti: il presidio sulle tecnologieenergetiche, il monitoraggio e ilreporting (andamenti temporaliconsumi, verifica dei piani di ri-sparmio, individuazione di best-practices), il presidio normativo,il supporto agli acquisti e allamanutenzione, la formazione,etc. Una volta individuate le at-tività preliminari, queste sonostate classificate in ordine aitempi di attuazione e quindi algrado di priorità. Come evidenziato in tabella 1,la formazione è la fase con lapriorità di intervento più alta e per questo è stata curatanei minimi dettagli. Nella prima fase in aula sono stati tra-sferiti i principi metodologici e le procedure del sistemadi gestione LGS oltre a lezioni tecniche per il rafforza-mento del know-how. Successivamente si è procedutoad affiancare la struttura nelle fasi di audit, diagnosi ener-getica e monitoraggio post-intervento, con lo scopo difar acquisire alla nuova struttura l’esperienza necessariaad individuare gli ambiti d’intervento più promettenti, uti-lizzare le metodologie più appropriate e, soprattutto, ve-rificare la corretta applicazione del sistema LGS.
In tal modo la struttura non si è limitata solo ad ottimiz-zare la gestione, è divenuta anche in grado di operarenel tempo e in maniera autonoma.
Audit energetici Per gli audit energetici è stato scelto un modello up-bot-tom che prevede un approccio di indagine sviluppatosecondo diversi gradi di analisi.L’approccio graduale permette di approfondire l’inda-
gine solo nel caso i risultati, in termini di energia rispar-miata, vengano confermati in tutte le fasi di analisi. Inquesto modo è possibile arrestare l’indagine in qualsiasimomento, evitando sprechi di tempo e risorse. Vice-versa, laddove il modello confermi lungo tutto il suo iterla validità delle ipotesi fatte, è possibile intervenire conun margine di errore molto limitato.Fondamentale è anche il rapporto finale di audit. Que-sto deve contenere, oltre a elementi descrittivi puntualidell’edificio e degli impianti, anche un documento inte-grativo, il cosiddetto “registro delle opportunità dei ri-
“walk-through” energy audits:una visita (letteralmente passeggiata) con occhio critico della realtà. “preliminary “energy audits: sulla base dei primi riscontri/ipotesi, si individuano e ci si ferma ad approfondire alcuni aspetti.
The
“scanning“ audit models (la “scansione” o “rassegna“
del modello energetico)
The “analytical” models
(i modelli analitici)
system-specific energy audits (audit relativi a sotto-sistemi specifici della realtà in esame);
comprehensive energy audits. (audit completi della realtà in esame).
selective energy audits: l auditor sceglie le aree di interesse. targeted energy audits, il
committente definisce le principali aree di interesse. Si dividono in: Pr
ofon
dità
di
an
alis
i
“
“
o “sca(la
auditscanning“
ci si ferma ad e dei primi preliminary“
critico della realtà. almente r(lette
walk-through“
“
“
assegnarnsione” “sca
delsmoaudit“scanning
The
ondire alcuni approfci si ferma ad riscontri/ipotesi, si individuano dei primi
sulla base : auditsenergy“minaryycritico della realtà.
) con occhio passeggiataalmente :una visita auditsenergy” walk-through
riscontri/ipotesi, si individuano sulla base
) con occhio :una visita
modello energetico) del
(i modelli aanalyticalThe “
aspetti. modello energetico)
litici) na(i modelli adelsmo”analytical
selective
indi in
sceglie le aree di interesse. targeted
nteromcoommi
aspetti. approf
system-specific
ddella realtà in esame); (audit relativi a sotto-sistemi specifici
energy audits
comprehensive energy audits.
selective energy audits: lsceglie le aree di interesse.
auditor
targeted
di interesse. Si dividono in: committente definisce le principali aree
energy audits, il
(audit relativi a sotto-sistemi specifici energy audits
energy audits.
committente definisce le principali aree
comprehensive(aududdit completi della realtà in esam
energy audits.
(audit completi della realtà in esame).
Tempi (mesi) Grado priorità
1 UrgenteIndividuazione di due risorse aggiuntive all’interno dellastruttura energia
2-6 Alta Formazione
1 Urgente Individuazione, tramite studio congiunto con la Direzione delPersonale, di persone che possano seguire l’attivitàperiferica part-time.
2 AltaConvention-meeting e lancio della raccolta di informazionilocali tramite check-list
2 Alta Elaborazione delle chek-list
1-6 Media Coinvolgimento risorse locali
2-4 Alta Predisposizione di procedure di audit
4-8 Media Effettuazione di audit
8-11 Media Analisi dei risultati e definizione interventi
12 Bassa Comunicazione
Tabella 1. Attività preliminari classificate secondo tempi e grado di priorità
Audit energetico (modello up-bottom)
3/2011

FORMAZIONE & PROFESSIONE
gestione energia10
sparmi energetici” che, compilato dai tecnici interni aseguito dell’audit, riporta alcuni interventi di facile e im-mediata attuazione.
Diagnosi energeticheDopo la consegna dei report finali di audit e delle schedeopportunità si è passati alla fase di diagnosi energetiche.Si è utilizzata una metodologia per passi, che consistenel ricostruire il percorso che i diversi vettori energeticicompiono all’interno della struttura oggetto di diagnosi,identificandone, ad ogni passaggio/variazione/utilizzo:1. origine (ad esempio linea f.e.m. n.3 derivante dal
quadro elettrico generale)2. natura del passaggio (ad esempio: boiler)3. valore reale (ad esempio KWh consumati, KW
impegnati)4. valore di targa (ad esempio: 1,5 KW)5. necessità (ad esempio acqua calda per la macelleria).
Dalla ricostruzione dei flussi di energia e dalla conse-guente raccolta di dati quantitativi si è iniziato a model-lizzare il sistema per trarne degli indici, o indicatorienergetici. Per questo tipo di ciclo produttivo è neces-sario sempre considerare, oltre agli indici dimensionali,gli indicatori riferiti ad un afflusso di pubblico (kWh/pp),oppure ad un orario di apertura (kWh/hanno).
Definizione del benchmark e calcolo del risparmio economicoUn passo fondamentale nella pianificazione di una stra-tegia di gestione energetica è la definizione del ben-chmark (o baseline) su cui si fonda il modello operativoe rispetto alla quale verrà misurato il risparmio. Il risparmio economico Ri, conseguito grazie all’inter-vento sull’utenza/componente i-esimo, è dato da:
Ri = CBenchmark,i – CMonitorato,iCBenchmark,i è il costo dovuto al consumo di energiadell’utenza/componente i-esimo prima dell’intervento.CMonitorato,i è il costo dovuto al consumo di energiadell’utenza/componente i-esimo dopo l’intervento e de-terminato nel periodo di monitoraggio.Ovviamente, affinché tali costi siano confrontabili,devono essere normalizzati rispetto a tutte le gran-dezze estensive da cui dipendono (durata temporale,volumi di produzione, dati climatici, modifiche im-piantistiche, etc.). I valori CBenchmark,i, CMonitorato,i sono espressi dalleseguenti formule
CBenchmark,i = EB,i x TEB,iCMonitorato = EM,i x TEM,i
EB,i EM,i - consumo di energia dell’utenza/componentei-esimo prima e dopo dell’inter-vento.TEB,i TEM,i - tariffa/costo del-l’energia consumata dall’utenza/componente i-esima prima edopo l’intervento.I valori EM,i, EB,i sono espressi davarie formule a seconda del tipo diutenza/componente consideratoe in dipendenza del tipo di para-metro, tra quelli da cui dipendonotali valori, che viene ottimizzato aseguito dell’intervento. In breve:Interventi “h-P”: interventi sugliimpianti che ottimizzano le ore dilavoro annue e/o riducono le po-tenze delle macchine (temporiz-zatori dei tempi di accensione espegnimento degli impianti, sen-sori di presenza, sostituzioneapparecchi illuminanti, inverter,motori ad alta efficienza, sistemidi accumulo, etc.).Interventi “η”: interventi sugli im-pianti che migliorano i rendimentidelle macchine (verifica manu-tenzioni, coibentazioni, regola-zioni, etc.).
Interventi “S”: miglioramenti nelle strutture, nelle geo-metrie e nelle destinazioni d’uso degli edifici. Interventi “C”: miglioramenti nei costi di gestione e ma-nutenzione degli impianti. (formazione, audit, l’ottimiz-zazione dei sistemi di telegestione, etc.).Gli studi di fattibilità con il calcolo dei benefici economicivengono poi sottoposti all’attenzione della struttura de-cisionale per lo studio economico-finanziario di dettagliodell’eventuale investimento.
Esempi di alcuni interventi Una volta concluse le fasi di implementazione, si è pas-sati alla fase applicativa del sistema LGS, che ha avutocome risultato concreto la progettazione di alcuni inter-venti di efficienza energetica e la loro attuazione pressoalcuni punti vendita. Nella pratica, le risorse interne
Ricostruzione del sistema


FORMAZIONE & PROFESSIONE
gestione energia12
hanno ripercorso l’intera filiera del sistema LGS fino allaprogettazione di soluzioni tecniche migliorative. Unavolta costruito il sistema di rendicontazione dei risparmie ottenuta l’approvazione del management aziendale,è stato possibile attuare gli interventi.
FreddoCome visto in precedenza, l’energia elettrica assorbitaper il freddo alimentare risulta pari a circa il 27% degliassorbimenti elettrici totali. Si è deciso, quindi, di inda-gare attraverso le procedure dell’LGS questo settore.Dopo l’audit e la diagnosi si è effettuata un’analisi deicicli frigoriferi. Sono stati utilizzati modelli software spe-cifici per acquisire informazioni riguardo l’efficienza glo-bale d’impianto. In via prioritaria ci si è orientati sugliinterventi a costo zero, tra i quali uno dei più promettentie di facile applicazione è l’ottimizzazione dei parametridi regolazione con particolare riferimento alla tempera-tura di condensazione. Le temperature di condensa-zione rilevate presso le centrali frigorifere, in situazionepre-intervento, risultavano mediamente superiori di 4÷5°C rispetto ai valori attesi. Il forte stress richiesto al parcocompressori per raggiungere le elevate temperature ri-levate, oltre ad una sostanziale riduzione del rendi-
mento, comportano un maggior logorio e l’aumento deicosti di manutenzione, che non possono essere com-pensati dal beneficio ottenibile con la produzione di ACStramite desurriscaldamento del fluido refrigerante. La di-minuzione delle temperature di condensazione di circa4÷5 °C ha comportato risparmi annuali variabili tra i7.000 e i 10.000 euro in ciascuno degli ipermercati con-siderati, con un risparmio complessivo superiore a600.000kWh e con risparmi annuali quantificabili in circa90.000 €. Il sistema LGS, quindi, non solo ha permessodi individuare e quantificare i benefici dell’intervento, masoprattutto ha consentito di attivare quel ciclo virtuoso
alla base del sistema di gestione tale da innescare uncontrollo continuo dei parametri di funzionamento.
CaldoUn secondo intervento ha interessato il consumo di gasnecessario per i fabbisogni di riscaldamento invernale eproduzione di ACS degli ipermercati che corrisponde acirca 587.045 m3 l’anno, per una spesa complessiva di481.208€. In questo caso, a seguito delle indagini ef-fettuate con il sistema LGS, si è riscontrata l’esigenzadi inserire una figura professionale tecnica addetta allagestione e al controllo del sistema di telegestione chenella struttura interna era assente. Tale mancanza avevacreato nel tempo disallineamenti tra i valori dei set-pointambiente rilevati e quelli impostati con ingenti perditeeconomiche ed energetiche. La semplice presenza diun tecnico addetto al controllo del sistema di telege-stione, istruito sulle procedure interne, ha fatto in mododi abbattere le perdite e, soprattutto, che tali perdite nonsi propagassero nel tempo. I risultati hanno mostratoche, a parità di ore di funzionamento e con temperatureesterne e afflusso comparabili rispetto all’anno prece-dente, si può arrivare a risultati quantificabili in un rispar-mio del 10% nel consumo di gas naturale.
Illuminazione Il peso dell’illuminazione sulla spesa energetica è il piùconsistente, con una percentuale che arriva al 29% deltotale (30 GWh) nel caso degli ipermercati. In fase diaudit si sono rilevati livelli di illuminamento eccessivi indiverse aree delle strutture del gruppo, anche laddovetali livelli non sono giustificabili con particolari esigenzedi marketing. In questi casi si può intervenire sia conla parzializzazione nell’accensione dei corpi illuminantidi alcune sezioni, sia con un più oculato sfruttamentodella luce naturale. L’intervento, che può essere con-siderato semplice dal punto di vista attuativo, hacreato molte difficoltà in rapporto sia alle diverse esi-genze a cui il sistema di illuminazione deve asservire(abbigliamento, profumeria, carni, verdure, etc.), siaper la numerosità delle tipologie e quindi delle tecno-logie utilizzate. L’applicazione puntuale del sistemaLGS che, come più volte detto, ha come caratteristicaessenziale l’interazione continua tra le varie aree fun-zionali. ha permesso l’applicazione di un interventoche, viceversa, avrebbe potuto creare inefficienze e di-sfunzioni. In questo caso i risparmi stimati sono nel-l’ordine di 100.000€ l’anno.
ConclusioniL’implementazione del sistema di gestione energeticaLGS sviluppato secondo le specifiche caratteristicheenergetiche della Grande Distribuzione Organizzata haportato a risultati decisamente interessanti, sia dal puntodi vista qualitativo, in termini di miglioramento dei pro-cessi, sia dal punto di vista quantitativo, in termini di ri-duzione sostanziale dei consumi. Il sistema LGSsviluppato nell’arco di due anni rappresenta una delleprime applicazioni della norma UNI 16001 ad un settoreche avrà necessità di adeguarsi a standard di efficienzasempre più stringenti, ma dove i potenziali di risparmiorisultano molto elevati e facilmente raggiungibili.
Mantenimento risultati raggiunti
Valutazione esiti
Intervento
Definizione progetto per arrivare alla soluzione
Valutazione dati e ricerca soluzione
Individuazione del perimetro esatto e rilevazione dati
Miglioramento Continuo

UNA GAMMA COMPLETA CGT è in grado di soddisfare tutte le esigenze di richiesta energetica in modo affidabile e sicuro.
GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITÀGruppi elettrogeni Diesel Prime e Stand-byLa più ampia gamma di potenze, con l‘esperienza del più grande costruttore al mondo.
GRUPPI CATERPILLAR: DA 10 A 2400 KW
Sistemi UPSDalla tecnologia Caterpillar, energia elettrica di qualità per le telecomunicazioni, gli ospedali e l’industria di precisione.
SISTEMI UPS CATERPILLAR: MODULI COMPONIBILI DA 120 A 2000 KW
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILEOlio Vegetale e Animale*Una vasta gamma di prodotti alimentati da una fonte rinnovabile incentivata dalle normative vigenti.* valido solo per motori a giri lenti.
GRUPPI ELETTROGENI CATERPILLARLENTI/VELOCI: DA 400 A 14400 KW
BiogasUna gamma che risponde alle esigenze di affidabilità richieste dall’utilizzo del Biogas, combustibile alternativo e rinnovabile che soddisfa i parametri CE per il 2020.
GRUPPI ELETTROGENI CATERPILLAR:DA 1000 A 2000 KW A 1500 RPM
IMPIANTI DI COGENERAZIONEGas MetanoProduzione combinata di energia elettrica e calore, riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, una miglior efficienza energetica con conseguente riduzione dei costi in bolletta.
GRUPPI ELETTROGENI CATERPILLAR:DA 370 A 2000 KW A 1500 RPM
FINO A 6500 KW A 750 RPM
ENERGIAEFFICIENTECGT Energia fornisce la migliore tecnologia al mondo, supportata dal miglior servizio oggi disponibile. I nostri uomini vi assistono dalla progettazione fino all’installazione e nella manutenzione degli impianti, garantendo la massima efficienza energetica ed economica.
LA SOLIDITÀ DI UN GRANDE GRUPPOCGT Energia è una divisione di CGT,dal 1934 dealer italiano di Caterpillar.
PRESENZA CAPILLARE IN TUTTA ITALIACGT è presente sull’intero territorio nazionale con una rete di 40 filiali.
ESPERIENZA SU FORNITUREDI OGNI DIMENSIONEDai grandi impianti ai piccoli gruppi, soluzioni su misura per ogni esigenza.
UNA GRANDE SQUADRA DI PROGETTAZIONEOltre 50 ingegneri che affiancano il Cliente dalla progettazione fino alla manutenzione.
LA CONVENIENZA DEI GRANDI NUMERIIl rapporto privilegiato con Caterpillar consente di proporre soluzioni ad alto contenuto innovativo e motori a costi competitivi.
www.cgt.it

gestione energia14
FO
RM
AZ
ION
E&
PR
OF
ES
SIO
NE
Iconsumi energetici legati all’illuminazione possonoarrivare al 20% del fabbisogno energetico totale inun’azienda produttiva e fino al 70% nel caso di at-
tività di assemblaggio e logistica: l’illuminazione, quindi,ha impatti significativi sui costi gestionali e richiedeun’attenzione particolare.L’illuminazione, inoltre, ha anche un’importante influenzasulla qualità di vita di chi lavora all’interno dell’azienda esulle prestazioni lavorative. Oggi, con adeguate tecno-logie, si può consentire un utilizzo più razionale dei con-sumi energetici.La corretta valutazione di un sistema di illuminazionedeve quindi includere aspetti relativi a:• costo di gestione, composto da consumi
energetici e interventi di manutenzione• performance dell’impianto in relazione ai requisiti
di illuminamento richiesti • condizioni per avere un ambiente di lavoro sicuro e
confortevole.Il tutto rispettando la normativa vigente che, per i luoghidi lavoro interni, fa riferimento alla norma UNI EN12464-1, che ha rivalutato l’aspetto qualitativo dell’illu-minazione contro la visione puramente quantitativa cheveniva fatta in passato.
Caso 1Il primo caso riguarda 2 installazioni e uno studio preli-minare effettuate presso Elica, gruppo attivo nel mer-cato delle cappe da cucina ad uso domestico.
È stato portata a termine un’operazione di re-lamping didue capannoni, all’interno dei siti produttivi di Cerreto eSerra San Quirico, con presenza di fari a ioduri da 400W.Un obiettivo primario dell’operazione è stato quello di con-servare la quantità di luce presente all’interno dello stabi-limento, valutando una sostituzione 1:1, senza aggiuntadi ulteriori apparecchi e garantendo nel contempo un si-gnificativo risparmio energetico. Ulteriori obiettivi sono statil’incremento della qualità della luce e il miglioramentodell’uniformità, oltre ad individuare una soluzione che po-tesse apportare una significativa innovazione: il passaggioad una nuova tecnologia che permetta di contenere i con-sumi garantendo i parametri quantitativi e qualitativi richie-sti è importante per un’azienda che voglia sottolineare lasua attenzione verso i temi energetici e ambientali.Il progetto illuminotecnico ha quindi tenuto conto dei se-guenti fattori: • mantenimento dello stesso livello di illuminazione• uniformità migliore rispetto all’esistente• risparmio energetico superiore al 60%• tempistiche di rientro comparabili ai macchinari
presenti nel capannone.È stato individuato il prodotto compatibile con le richiestedi cui sopra che potesse sostituire i fari esistenti: è un faroWissenlux, formato da 104 LED, per 11000 lumen diflusso illuminante, che soddisfa le caratteristiche richiestedal progetto, consumando meno di un terzo del prodottoa ioduri (127W alla spina contro 400W+10-20% consi-derando le perdite del trasformatore).
Illuminazione a LED per capannoni industriali: duecasi di progetto e realizzazioneGiancarlo Repossi • Amministratore Delegato Wissenlux

3/2011 15
FORMAZIONE & PROFESSIONE
Conclusa la fase progettuale e confrontato il progettocon il committente, si è proceduto ad una prova all’in-terno dell’attrezzeria con i prodotti a led proposti per lasostituzione.Al fine di una decisione finale in merito all’investimento,il processo decisionale aziendale ha seguito sia un per-corso top-down, con analisi della soluzione proposta,sia bottom-up, con compilazione da parte degli operaidi una scheda di valutazione basata su:• comfort visivo
• illuminazione ambiente• visibilità dettaglio.I risultati medi ottenuti (uguali o maggioria 4 su un punteggio massimo di 5, perun valore finale di 12,4 su 15), insiemealla valutazione dei parametri econo-mici, hanno convinto a dare l’assensoper investire nel nuovo impianto a led. In totale sono stati installati 91 fari neidue capannoni, per un risparmio com-plessivo in termini di consumi energeticifinalizzati all’illuminazione di circa il 70%.Il payback è stato calcolato in 3.4 anni,inclusa l’installazione.Una volta completata la posa in operadei nuovi apparecchi è stata effettuatauna verifica ex-post per confrontare i datia progetto con le misurazioni sul campo.In tabella 1 sono indicati gli aspettiquantitativi dell’impianto di Cerreto.
ProgettoIl committente, a fronte dei risultati otte-nuti, ha richiesto un ulteriore progettopiù complesso e sfidante per lo stabili-
mento di Mergo, in cui sono stati richiesti:• incrementi dei livelli di illuminamento sul tavolo di
assemblaggio, dai 610 lux medi esistenti• incrementi di uniformità e di illuminamento in tutto
il reparto• sostituzione 1:1.In questo caso l’impianto esistente comprende sia iclassici fari a ioduri da 400W, sia plafoniere a fluore-scenza 2x58W, per un totale di circa 320 punti luce.Il progetto illuminotecnico ha quindi tenuto in conto que-
Faro a 104 LED WL-TRO-104-5010 di Wissenlux
Tabella 1. Gli aspetti quantitativi dell’impianto di Cerreto
Anni di rientro calcolati: 3,4 Situazione preesistente Dopo intervento Wissenlux
Tipologia Faro loduri 400W Faro 104 LED 127W
Numero 50 50 1:1
Consumo W 22.000 6.350 -71%
Consumi totali W 22.000 6.350 -71%
Valutazione economica (base annua, 4500 ore di accensione)
Consumi kWh 99.000 28.575 -71%
Consumi EUR* 11.880 3.429 -71%
Manutenzione EUR 1.250 150 -81%
Totale/anno 13.130 3.579 -73%
Valutazione ambientale (base annua, 4500 ore di accensione)
Produzione CO2** 40 11 -71%
*EUR 0,12/kWh**Fonte IEA: o,4kg/kWh

FORMAZIONE & PROFESSIONE
gestione energia16
sti fattori e, senza un incremento dei punti luce, soddisfasulla carta le specifiche richieste. Per i fari da 400W èstata proposta la sostituzione con fari a 104 led da127W, mentre per le plafoniere 2x58 è stata propostauna plafoniera IP65 a 36 led da 48W di consumo, en-trambi Wissenlux. I consumi risultano così inferiori del70% rispetto alla situazione esistente, con 430 lux mediper l’intero reparto e 680 lux sui tavoli di assemblaggio,il tutto per una uniformità superiore a 0.7.Oltre al payback - calcolato in 3.5 anni compresa l’in-stallazione - un ulteriore fattore chiave per l’approva-zione del progetto è rappresentato dalla possibilità difinanziamento, che apporta notevoli benefici in terminidi impatto sul bilancio:• non va a gravare come bene patrimoniale a bilanci• il canone di noleggio è completamente spesabile a
conto economico con conseguente beneficio fiscale• si ha un significativo beneficio in termini di liquidità.All’interno della valutazione economica del progetto èstata quindi proposta la soluzione di noleggio. Nelcaso dello stabilimento di Mergo, il risparmio annualecalcolato è superiore alla rata annuale del noleggio(calcolato su 48 mesi), senza aggravi quindi sui flussidi cassa.
Caso 2Il secondo caso riguarda il gruppo parmense Laterlite,operante con il marchio Leca nel settore della produ-zione di materiali per l’edilizia. L’intervento in questo caso è stato richiesto in quantol’intero impianto dello stabilimento produttivo di Rub-biano di Fornovo doveva essere messo a norma e si vo-
levano valutare altre opzioni oltre alla classica soluzionefluorescente, in un’ottica di risparmio energetico, ma-nutentivo e di riduzione dell’impatto ambientale.La situazione esistente al momento del sopralluogo hamesso in evidenza come all’interno dell’impianto illumi-notecnico - piuttosto datato - ci fossero diverse “strati-ficazioni” in seguito a modifiche susseguitesi negli anni,in risposta a bisogni contingenti più che ad un progettorazionale e uniforme.La fase iniziale ha riguardato l’analisi e il rilievo degli ap-parecchi installati per andare a proporre il più possibileuna sostituzione 1:1 in un’ottica di ottimizzazione dei costi.Durante la fase progettuale si è quindi cercato di riutilizzareal massimo i posizionamenti esistenti, pur dovendo rive-dere tutto l’impianto per adeguarlo alle normative vigenti.Il progetto illuminotecnico è stato effettuato tenendoconto:• dei punti luce esistenti• della normativa vigente e degli adeguamenti
necessari• del contenimento dei costi sia di acquisto che di
manutenzione• del contenimento dei consumi energetici: anche in
questo caso l’azienda è particolarmente sensibile aldiscorso di minimizzazione dell’impronta ambientale.
È stato presentato un progetto reparto per reparto, tenendo conto dei vincoli e delle richieste del commit-tente: i diversi reparti hanno richiesto livelli di illumina-mento differenti e un mix di prodotti Wissenlux perraggiungere i risultati richiesti.È stato calcolato l’importo dell’investimento e i risparmiche si possono generare ed è stato stilato un piano di
Stabilimento ELICA Cerreto illuminato con fari a 104 LED WL-TRO-104-5010 di Wissenlux

FORMAZIONE & PROFESSIONE
3/2011 17
investimenti su tre anni, valutando la priorità dei lavorida eseguire per la messa a norma dell’impianto esi-stente.Considerando il costo di un impianto tradizionale, il pay-back del nuovo impianto a led è stato calcolato in pocopiù di un anno e mezzo: un arco di tempo estremamentebreve, che si raggiunge grazie ai risparmi generati suiconsumi di energia (-67%) a cui vanno ad aggiungersiquelli dati dalla manutenzione, che nell’impianto a led ri-sultano spalmati su un numero di ore di gran lunga su-periore alla tecnologia a fluorescenza. L’aspettomanutentivo ha infatti contato molto nella scelta aziendaledi passare al led, in quanto alcune lampade sono posi-zionate in luoghi difficilmente accessibili e che possonorichiedere una sospensione del processo produttivo.Non da ultimo l’azienda si è detta particolarmente sod-disfatta dalla riduzione di emissioni di CO2 nell’am-biente, nell’ordine di 86 tonn/anno.In tabella 2 gli aspetti quantitativi dei reparti.
ConclusioniPur essendo la tecnologia a led relativamente agli inizinell’ambito dell’illuminazione per interni, risulta esseregià matura per proporre sul mercato prodotti con carat-
teristiche prestazionali uguali se non superiori ai prodotticlassici. Sul piano economico, il divario del prezzo di ac-quisto iniziale viene riassorbito dai risparmi generati, contempi di payback tanto più bassi quanto più lungo è ilperiodo di accensione.Grazie alla continua evoluzione del led, l’incrementodell’efficienza, insieme alla diminuzione dei costi rendequesta tecnologia sempre più appetibile e sfruttabilee l’attenzione di questi ultimi tempi delle grosseaziende leader sul mercato testimonia la vitalità diquesto settore.La qualità sarà la discriminante per l’evoluzione futura.Una filosofia costruttiva basata sulla scelta accurata deiled migliori e sul loro sfruttamento razionale sia in terminienergetici (wattaggio di esercizio, che influisce sulla du-rata e sui consumi) che in termini illuminotecnici (qualitàe uniformità della luce, certificazioni), pagherà sulmedio-lungo periodo. I prodotti migliori si distingue-ranno da soluzioni improvvisate, più economiche all’ini-zio, ma con costi occulti di cui ci si renderà conto soload installazione avvenuta. Soprattutto in quei contesticome gli uffici o le aree industriali, meno soggetti allemode e ai dettami consumistici e più attenti alla so-stanza del prodotto e al suo uso intensivo.
Tabella 2. Aspetti quantitativi dei reparti
Anni di rientro calcolati: 1,6 Situazione preesistente Dopo intervento Wissenlux
Tipologia Faro Sodio 400W Faro 104 LED 127W
Numero 72 72 1:1
Consumo W 31.680 9.144 -71%
2x36W fluorescente Plafoniera 36 LED
64 64 1:1
5.888 2.816 -52%
2x58W fluorescente Plafoniera 45 LED
42 42 1:1
5.880 2.184 -63%
1x36W fluorescente Plafoniera 12 LED
12 12 1:1
588 192 -67%
Consumi totali W 44.036 14.336 -67%
Valutazione economica (base annua, 7200 ore di accensione)
Consumi kWh 317.059 103.219 -67%
Consumi EUR* 38.047 12.386 -67%
Manutenzione EUR 5.476 912 -83%
Totale/anno 43.523 13.298 -69%
Valutazione ambientale (base annua, 7200 ore di accensione)
Produzione CO2** 127 41 -67%*EUR 0,12/kWh**Fonte IEA: 0,4kg/kWh
LECA-Laterlite - Reparto insaccaggio (Rubbiano) e sala macchine (Lentella)

gestione energia18
Adistanza di oltre un secolo dall’introduzionedella trazione elettrica in campo ferrotranviario,la strada rimane invece il regno incontrastato
del motore a combustione interna. Solo recentemente le auto elettriche, volgarmente dette“a batteria”, hanno incominciato a essere considerateuna scelta concretamente possibile. Questo grazie aduna serie di miglioramenti tecnologici, soprattutto nelsettore dell’accumulo elettrico, che di seguito si prove-ranno ad illustrare.
I veicoli elettrici “puri” Perché i treni ad alta velocità sono a trazione elettrica ele automobili hanno motori endotermici? La risposta è semplice, i treni possono alimentarsi dauna linea esterna di trasmissione dell’energia, general-mente una catenaria o una terza rotaia, mentre un’autoha bisogno di trasportare a bordo tutta l’energia neces-saria al suo uso. Questo ha fortemente penalizzato le cosiddette “auto abatteria”, che, parliamo di quelle piombo-acido, di ener-gia ne accumulano pochina. Solo recentemente i dispositivi per l’accumulo a bordodell’energia elettrica hanno migliorato significativamentele due prestazioni indispensabili in un veicolo a trazioneelettrica autonoma, che sono:• la quantità di energia che può essere
immagazzinata in uno spazio limitato, equivalente aquello occupato dal serbatoio della benzina o delgasolio, e con un peso non eccessivo
• la velocità con cui questa energia può essereerogata al motore.
In termini tecnici, parliamo di energia e potenza specifi-che, per unità di volume e per unità di peso. L’energia specifica della benzina è di 12 kWh per chi-logrammo, quella delle batterie piombo-acido 30 Whper chilogrammo e quindi, mentre un litro di benzina,in un motore, sviluppa 8400 Wh termici, una batteriadi ugual peso, carica, eroga soltanto 24 Wh elettriciprima di scaricarsi completamente. In termini tecnici,parliamo di energia e potenza specifica, per unità dipeso e di volume. Anche mettendo in conto il miglior rendimento del motoreelettrico, circa quattro volte maggiore di quello del ter-mico nell’uso normale, alla fine il rapporto tra l’energia di-sponibile alle ruote per le due automobili, quellatradizionale e quella elettrica, a parità di peso dell’accu-mulo energetico, è all’incirca uguale a 100. A parità dipeso dedicato al serbatoio/accumulo si ha quindi unuguale rapporto tra le percorrenze delle due vetture: doveun’auto diesel, con un pieno, percorre 900 chilometri,un’auto elettrica, con 40-50 chilogrammi di batterie alpiombo, peso equivalente al serbatoio del gasolio, nepercorrerebbe solo una decina. E infatti le auto elettriche della passata generazione ave-vano bisogno di 3-400 chilogrammi di batterie al piombo-acido per consentire percorrenze dell’ordine di 70-80chilometri!Oggi, grazie agli sviluppi dell’elettrochimica (e delle tec-nologie di fabbricazione e, ancora, di quelle di gestionee controllo, termico ed elettrico, di pacchi batteria formatida centinaia di celle elementari) l’energia specifica di unabatteria per trazione di tecnologia Li-ione è 4-5 voltemaggiore rispetto al piombo (figura 1).
Nuove prospettive per la trazioneelettrica stradale Giovanni Pede • ENEA
TE
CN
OL
OG
IE&
IN
IZIA
TIV
E

19
TECNOLOGIE & INIZIATIVE
Conseguentemente, il rapporto tra le percorrenze possi-bili con le due motorizzazioni, elettrica e tradizionale,sempre a parità di peso del serbatoio/accumulo, è dimi-nuito dello stesso fattore, passando da 100 a 20. Con 50 kg di batterie Li-ione è quindi possibile percor-rere una quarantina di chilometri e, accettando un peso3-4 volte maggiore, sono possibili autonomie di 120-160 chilometri. Prestazioni così migliorate si accompagnano, però, acosti più alti, rispetto al piombo, dell’ordine degli 800-1000 euro/kWh per le batterie Li-Io, che in caso di pro-duzione di massa si ridurrebbero a 400 Euro/kWh. Unabatteria da 30 kWh, taglia adeguata ad una vettura diclasse C, costerà quindi circa 12.000 euro. È evidente che tale costo è difficilmente accettabile dal-l’utenza all’atto dell’acquisto del veicolo, mentre lo divienespalmandolo sull’intera vita della batteria, considerato ilminor costo d’esercizio del veicolo elettrico (2.5 euro/100km contro 7.1 euro/100 km per il termico, dato di fonteRenault per autovettura di classe B).Per questa ragione, insieme a considerazioni legate allamanutenzione di veicoli così innovativi rispetto a quelli tra-dizionali, la formula che sembra più indicata per l’avviodella commercializzazione di questi mezziè quella del leasing del pacco batterie,collegato magari alla modalità di riforni-mento della vettura mediante sostituzionedel pacco scarico con un pacco carico, oanche dell’intera vettura. Il costo del leasing viene quindi compen-sato dai minori consumi energetici e dalcarico fiscale (sul chilowattora) ridottodell’energia elettrica rispetto a quello deicarburanti. Ma peso e costo della batteria possonoanche diminuire considerevolmente e lestrade possibili (e percorribili in parallelo)sono due: ridurre i consumi energeticidell’autovettura e/o accettare un’auto-nomia ridotta tra due ricariche conse -cutive. I rifornimenti all’impianto fissodovranno allora essere molto più rapididell’usuale ricarica notturna, qualche mi-nuto rispetto a 6-8 ore.La ricarica rapida è particolarmente adatta
al caso del trasporto pubblico locale, che consente unaprogrammazione dei tempi di marcia e dei tempi di ricarica. Oltre all’impatto positivo sull’architettura del veicolo, la ri-carica rapida ha un impatto positivo anche sulla rete didistribuzione dell’energia elettrica. Infatti, per le potenzeelettriche impegnate dalle stazioni di servizio, occorre-rebbe provvederle di sistemi di accumulo elettrico stazio-nari. Queste batterie “a terra” svolgerebbero anche unafunzione di “carico caldo” per la riequilibratura della rete,di cui in alcune regioni italiane si sente già la necessità, acausa del recente tumultuoso sviluppo delle fonti rinno-vabili. In definitiva, ciò permetterebbe un’estensione delconcetto di “smart grid” dalla sola generazione distribuitaalla generazione-accumulo distribuito.Considerando quindi veicoli leggeri specializzati per l’usourbano, quello d’elezione della trazione elettrica, come city-car, micro vetture e veicoli leggeri a 2/3 ruote, i consumienergetici diminuiscono drasticamente, in proporzione allariduzione di peso del mezzo, e diminuisce proporzional-mente peso e costo della batteria. Nella Citroen C-Zero,ad esempio, la batteria Litio-Ione è da 16 kWh.Ma anche per un’autovettura media, se si accettano ri-duzioni consistenti dell’autonomia in solo elettrico, la bat-
Piombo-acido ad alta energia
Piombo-acido ad alta potenza
Ni-MeH ad alta potenza
Li-lo ad alta energia
Li-lo ad alta potenza Batterie Zebra
Wh/kg
Wh/L
W/kg
1000900800700600500400300200100
0
Figura 1: Le prestazioni in potenza ed energia delle moderne batterie per trazione
3/2011

gestione energia20
TECNOLOGIE & INIZIATIVE
teria può essere piccola. Una batteria da 10 kWh, delcosto quindi di 4000 euro, consente solo 50 km in elet-trico e questi diventano accettabili se il tempo di ricaricasi riduce a qualche minuto e ci siano infrastrutture di ri-fornimento di potenza adeguata1 e ben distribuite sul ter-ritorio, oppure se il veicolo è un ibrido, dove alla trazioneelettrica si associa una motorizzazione termica. In questocaso, la ricarica della batteria è comandata dall’energymanager di bordo, ogni volta che il suo stato di caricascenda sotto una soglia prestabilita.
I veicoli elettrici ibridi L’ibridazione è una tecnologia ormai applicata da tutte lecase automobilistiche, almeno nella sua declinazione mi-nima, che permette il solo “start-and-stop”. Questo è ilcosiddetto “micro-ibrido”, che diventa “minimo” se c’èanche la funzione di integrazione del motore termico inripresa, come ad esempio nell’Honda Insight, o nellaMercedes S400. Per entrambe le auto, la batteria ha unacapacità inferiore ad 1 chilowattora! In alcuni modelli, e parliamo allora di auto “full hybrid”, èpossibile usufruire dei due propulsori anche separata-mente e quindi usare il solo elettrico per distanze moltobrevi, come nella Toyota Prius, o maggiori, come nel pro-totipo Audi A3 e-tron, cui una batteria Li-ione da 12 kWh,ricaricabile dalla rete, assicura un’autonomia in solo elet-trico di 54 km, anche se a potenza ridotta (20 kW). La General Motors, infine, ha sviluppato le Chevrolet E-Volt e Opel Ampera, “E-Rev” (extended range electricvehicle), con una batteria da 16 kWh e autonomia in elet-trico di 60 km.
Queste auto possono essere considerate nell’uso “elet-triche” a tutti gli effetti, grazie alla potenza della motoriz-zazione elettrica adottata e ad una strategia di controlloche mantiene spento il termico fino all’esaurimento dellacarica delle batterie. La figura 2 illustra e sintetizza i concetti sopra esposti.
ConclusioniIn un articolo pubblicato dieci anni orsono su questastessa rivista “I veicoli ibridi: stato dell’arte e motivazioniambientali ed energetiche”, scrivevamo in conclusione:“Il potenziamento delle attività di ricerca in questo settoreè quindi certo e nel corso dei prossimi anni assisteremoad un rapidissimo sviluppo di questa tecnologia”, comepoi in effetti è avvenuto. Anche se costi e prestazioni delle auto “elettriche pure”non rispondono oggi a tutte le aspettative dell’utente, gliulteriori sviluppi nel campo delle batterie (per alcune cop-pie elettrochimiche si spera in un raddoppio delle energiespecifiche attuali) lasciano prevedere una diffusione sem-pre maggiore dell’auto elettrica, con alcuni milioni di vei-coli in Europa alla fine del decennio. La sua ampiezza dipenderà però anche da fattori esterni,come le preoccupazioni di carattere ambientale, l’au-mento del prezzo dei combustibili e la conseguente ne-cessità di diversificazione delle fonti di energia.
Figura 2: Funzioni dell’accumulo elettrico nelle diverse tipologie di veicoli ibridi
1. Ricaricare 10 kWh in 6’ richiede una colonnina di potenza pari a100 kW. N
OT
A
Micro ibridi Mild Hybrid E-Rev o Batt. Electric
Citroen C2
Honda Insight
Toyota Prius
Opel AmperaMarcia in
elettrico,
di norma
Motor assist Motor assist
Frenatura
a recupero
Frenatura
a recuperoStart & StopStart & Stop
Start & Stop
Start & Stop
Frenatura
a recupero
Frenatura
a recupero
Marcia in
elettrico
(ridotta)
Full performance

Disegniamo il futuro dell’Energia
www.ansaldoenergia.it
Towards a better world.

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia22
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
Dario Di Santo Telecontrollo
e automazione: le chiavi del futuro
Da sempre l'uomo ha cercato di inventare dispo-sitivi che gli consentissero di rendere automaticialcuni compiti frequenti, consentendogli di averepiù tempo libero, o di acquisire un vantaggiocompetitivo. Negli ultimi anni l'evoluzione tec-nologica ci ha messo a disposizione un insiemedi strumenti in grado di avere impatti conside-revoli sulla produzione industriali e sulla gestionedegli edifici, a costi sempre più bassi grazie allosviluppo dell'elettronica.Lo sviluppo di tecnologie senza fili, inoltre,consente di superare uno dei problemi princi-pali con cui si doveva confrontare un tempo chivolesse dotarsi di un sistema di telecontrollo,ossia la necessità di cablare le varie parti dellastruttura interessata dalle misure, con i conse-guenti costi. Ormai, oltre ai protocolli di trasfe-rimento a distanza come il GSM, è possibilecreare reti autoconfiguranti di sonde autoali-mentate e sistemi di lettura e controllo basatesu protocolli wireless. Questo estende l'utilizzodelle soluzioni di monitoraggio a situazioniprima impraticabili.Monitoraggio significa capacità di tenere sottocontrollo i consumi attraverso indicatori conve-nientemente definiti dall'utente, di gestire al me-glio gli impianti - non solo dal punto di vistaenergetico - ottimizzandone anche la manuten-zione, di aggiungere funzioni connesse alla sicu-rezza e all'anti intrusione. Inoltre il monitoraggioè una delle basi di un sistema di gestione del-l'energia, potente strumento che la norma inter-nazionale ISO 50001, subentrata alla precedente
versione europea EN 16001, mette a disposizionedelle aziende e degli enti interessati a coniugareimmagine con benefici energetici ed economici.In questo Focus i lettori troveranno una carrellatadi opportunità legate allo sviluppo delle soluzionie le novità legate allo sviluppo della normativatecnica a livello europeo. Visti i benefici offertidall'automazione - che si tratti di telecontrollo etelegestione, domotica, building automation, oautomazione industriale - e l'enorme possibilitàdi personalizzazione e la modularità che consentedi rispondere a esigenze diverse e a piani di svi-luppo in fasi successive, si suggerisce di valutarela convenienza di ricorrere a un sistema di questotipo nel prossimo futuro.
FIRE

3/2011 23
®
www.telecontrolloconvegno.it
PROMOSSO DA
ORGANIZZATO DA RIVISTA UFFICIALE MEDIA PARTNER
La 12a edizione del Forum Telecontrollo delle Reti Acqua, Gas ed Elettriche,
l’appuntamento biennale proposto da AssoAutomazione-ANIE, organizzato in
collaborazione con Gruppo Italia Energia, ha la finalità di mostrare come sia
possibile rendere più efficienti le infrastrutture attraverso l’utilizzo di
tecnologie e applicazioni dell’automazione e del telecontrollo.
L’edizione 2011 del Forum, programmata per novembre a Torino, propone un
ambito convegnistico di alta qualità scientifica strutturato in sessioni parallele
con approfondimenti tecnici, occasioni di dibattito e confronto e un’esposizione
permanente attraverso la quale toccare con mano le tecnologie, le esperienze
e le competenze degli operatori del mercato.
AUTOMAZIONE ED EFFICIENZADELLE INFRASTRUTTURE
PER UN PROGRESSO SOSTENIBILE
A SMARTER ITALY
SEGRETERIA SCIENTIFICA
[email protected] ORGANIZZATIVA

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia24
Quadro legislativo di riferimento: Direttiva EPBD1
La Direttiva sulla prestazione energeticadegli edifici (EPBD)2 è uno degli strumentimessi in campo dalla Commissione Euro-pea a supporto della politica energeticadell’UE e in particolare delle promozionedell’efficienza energetica.La Direttiva, muovendo dalla considera-zione che gli edifici sono responsabili del40% degli usi finali di energia, mira a mi-gliorarne la prestazione energetica incar-dinando la propria azione sostanzialmentesu quattro punti: l’utilizzo di uno schemadi calcolo generale della prestazione ener-getica degli edifici, l’imposizione di requi-siti minimi di prestazione energetica perdeterminate tipologie di edifici, la certifi-cazione energetica degli edifici e l’ispe-
zione periodica di alcuni impianti tecnicidegli edifici.La Commissione Europea ha dato mandatoal CEN per sviluppare un insieme organicodi Norme Tecniche a supporto della Diret-tiva che definissero una metodologia dicalcolo della prestazione energetica degliedifici, in conformità con le prescrizionifissate nella Direttiva EPBD.Questo insieme di norme, come tutte leNorme Tecniche che si basano sul con-senso e che definiscono una metrica diprestazione, dovrebbero garantire l’acces-sibilità, la trasparenza e l’oggettività deicalcoli di prestazione energetica degli edi-fici in tutti gli Stati membriLa legislazione in materia di edifici è unsettore nel quale gli Stati membri rivendi-cano il loro diritto a sviluppare una proprialegislazione nazionale, in base al principio
di sussidiarietà richiamato dalla DirettivaEPBD. D’altronde, le differenze regionali intermini di condizioni climatiche, tipologieedilizie, requisiti legislativi, livelli qualita-tivi e comportamento dell’utenza incidonoinfatti sui dati di ingresso, sulle proceduredi calcolo e, conseguentemente, sulla pre-stazione energetica.Il ruolo del pacchetto di norme CEN a sup-porto della EPBD sarebbe quello di fissareun concetto di prestazione energetica e unametodologia comuni per l’emissione dicertificati energetici e l’esecuzione di ispe-zioni sugli impianti.
Sintesi del pacchetto di Norme EN a supporto dellaEPBD: “Umbrella Document” (CEN/TR 15615)Il quadro della struttura e delle relazioni re-ciproche delle norme tecniche a supportodella Direttiva EPBD è fornita dal RapportoTecnico CEN 15615, documento che co-stituisce, di fatto, la linea guida d’applica-zione di queste norme.Questo Rapporto Tecnico CEN contieneanche una lista di più di 100 termini e de-finizioni e un elenco dei principali simbolie pedici che vogliono essere la base di unlinguaggio ingegneristico comune per lediverse aree di competenza coinvolte.Il pacchetto di norme CEN-EPBD può es-sere così suddiviso:• un primo gruppo di norme relative alla
fisica dell’edificio che descrivono tuttii fattori che concorrono al calcolo delfabbisogno di energia utile per riscal-damento e raffrescamento;
• un secondo gruppo di norme checlassificano e caratterizzano i sistemidi ventilazione e di condizionamentodell’aria;
• un terzo gruppo che descrive i sistemidi riscaldamento e produzione diacqua calda sanitaria con particolareriferimento:• al sottosistema di generazione• ai sottosistemi di distribuzione,
emissione e regolazione del ri-scaldamento
• ai sistemi di produzione dell’ac-qua calda sanitaria;
• ai sistemi a bassa temperatura in-tegrati nelle strutture edilizie.
• un quarto gruppo di norme che trattano:
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
Automazione degli edifici ed efficienza energetica: La Norma EN 15232
Angelo Baggini
Università degliStudi di Bergamo
Figura 1. Rappresentazione schematica delle relazioni fra le varie norme EN a supporto della Direttiva EPBD
Franco Bua
ECD, EngineeringConsulting and Design;

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 25
• dei sistemi di illuminazione degliedifici (compreso il contributodell’illuminazione naturale)
• dei sistemi di automazione degliimpianti tecnologici a serviziodell’edificio
• della classificazione delle condi-zioni ambientali interne
• della valutazione economica e fi-nanziaria delle applicazioni dienergia sostenibile.
• un insieme di norme sulle verificheperiodiche di:• caldaie e impianti di riscalda-
mento.• sistemi di raffrescamento e con-
dizionamento• sistemi di ventilazione.
In questo insieme di norme le due fonda-mentali riguardano le modalità di espres-sione della prestazione energetica, loschema del certificato energetico degli edi-fici, il calcolo del consumo complessivo divettori energetici, la conversione in energiaprimaria il calcolo delle emissioni di CO2,la valutazione del consumo energeticoreale e la definizione di indicatori di pre-stazione energetica.Come si vede, l’automazione entra a pienotitolo nella definizione della prestazioneenergetica degli edifici. È importante sot-tolineare che il termine prestazione ener-getica non va inteso in senso restrittivo,“confinandolo” al solo ambito delle certi-ficazione energetica, ma nella sua acce-zione più ampia.La Norma EN 15232:2007 costituisce, allostato attuale, la norma di riferimento chepermette di definire e specificare la presta-zione di funzioni di regolazione e controllostandard orientate all’ottimazione energetica.La Norma sintetizza infatti le procedure dicalcolo del fabbisogno energetico di unedificio per riscaldamento, raffrescamento,ventilazione, ACS e illuminazione e per-mette di quantificare i risparmi di energiaottenibili mediante l’applicazione delle di-verse funzioni di regolazione e controlloconsiderate.
Norme EN e Direttiva EPDB: è obbligatorio seguirle?La Commissione Europea ha finanziato losviluppo di norme EN per supportare l’im-plementazione della Direttiva EPBD confe-
rendo al CEN un mandato per produrre lenorme richieste.Tuttavia, a differenza di quanto succede inaltri casi come, ad esempio, per le normesviluppate ai fini dell’applicazione della Di-rettiva Materiali da Costruzione (CPD),l’adozione delle norme EN a supporto dellaDirettiva EPBD in ambito nazionale non èobbligatorio in virtù del fatto che gli StatiMembri fanno leva sul principio di sussi-diarietà con riferimento alla legislazione inmateria di edifici.In realtà in questo modo si è però creatauna contrapposizione (o quantomenoun’incoerenza) all’interno del corpo norma-tivo-tecnico da un lato con la pubblica-zione di norme tecniche nazionali inossequio al recepimento della Direttiva,dall’altro assolvendo all’obbligo di “ade-sione” all’Organismo di Normazione Euro-peo (CEN in questo caso).
La norma EN 15232:2007La Norma EN 15232, come evidenziato neiparagrafi precedenti, fa parte del pacchettodi norme a supporto della Direttiva EPBDe nasce con l’esplicita finalità di stabilireuna modalità di stima dell’impatto dell’Au-tomazione sulla prestazione energeticadegli edifici3.In particolare la Norma EN 15232:• propone una lista strutturata di fun-
zioni di regolazione controllo degliimpianti a servizio degli edifici e di al-cuni componenti dell’edificio stesso,che influenzano la prestazione ener-getica degli edifici;
• definisce 4 classi di “efficienza”4 per isistemi di automazione;
• propone 2 metodi5 di calcolo per va-lutare l’impatto di queste funzioni sullaprestazione energetica di un edificio.
Lista strutturata di funzioni di regolazione e controlloLa Norma EN 15232 propone una listastrutturata di 81 funzioni di regolazionecontrollo6.Le funzioni sono raggruppate secondo iltipo di impianto controllato 7 e secondo lavariabile di controllo o il componente con-trollato. La figura 2 mostra un esempiodella lista di funzioni definite dalla EN15232; in questo caso l’impianto control-lato è quello di illuminazione e le variabili
FO
CU
STe
leco
ntro
llo e
Aut
omaz
ione
di controllo considerate sono l’occupa-zione e il contributo di luce naturale.Un sistema di automazione può, in linea diprincipio, realizzare una o più funzioni di re-golazione e controllo. La Norma EN 15232definisce per i sistemi di automazione quat-tro classi di efficienza energetica sulla basedel numero e del tipo di funzioni di regola-zione e controllo che il sistema implementa.È bene ribadire che queste quattro classi,nonostante richiamino lo schema classicodell’etichettatura energetica, non esprimonouna prestazione, ma indicano esclusiva-mente la capacità del sistema a realizzareuna regolazione e un controllo efficace delsistema energetico dell’edificio e, quindi, lacapacità del sistema di automazione a rea-lizzare un risparmio energetico. Si tratta, insostanza, di una caratteristica potenziale enon effettiva.Sempre prendendo ad esempio la figura 2,le funzioni che caratterizzano e individuanoogni classe sono indicate da un rettangologrigio che definisce anche il livello minimodi automazione richiesto per quella dataclasse; un sistema di automazione diclasse B dovrà essere in grado di control-lare il livello di illuminamento in funzionedell’occupazione, parzializzando il contri-buto dell’illuminazione artificiale automa-ticamente e, manualmente, in funzione delcontributo di illuminazione naturale; un sistema di automazione di classe A dovràinvece regolare automaticamente il contri-buto dell’illuminazione artificiale sia in fun-zione dell’occupazione che del contributodi illuminazione naturale.La definizione della classe è diversa a se-conda che si tratti di edificio ad uso resi-denziale o non residenziale.Una classe “energeticamente più efficiente”richiede la realizzazione delle funzioni mi-nime della classe immediatamente prece-dente più alcune specifiche funzioniaggiuntive.È importante sottolineare, infine, che lalista di funzioni di regolazione e controllodella EN 15232:2007 non è esaustiva ditutte le funzioni di regolazione e controlloche si possono realizzare e che possonoavere un impatto sulla prestazione energe-tica di un edificio; tuttavia queste funzionidovrebbero essere considerate nella for-mulazione dei metodi di calcolo definitinelle rispettive norme tecniche8.

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia26
Metodo di calcoloUna delle finalità principali della Norma EN15232 è quella di definire una modalità distima dell’impatto dell’Automazione sullaprestazione energetica di un edificio.
La norma propone due approcci, uno ana-litico (il cosiddetto Metodo Dettagliato) euno sintetico (il cosiddetto Metodo dei Fat-tori BAC).Con il primo approccio (Metodo Detta-
gliato), l’impatto del sistema di automa-zione sulla prestazione energetica dell’edi-ficio viene calcolato partendo dallacostruzione del modello che descrive l’in-fluenza del sistema di controllo sul si-
Figura 3. Tabella 8 e 9 della Norma EN 15232:2007 - Fattori BAC per impianti di riscaldamento e raffrescamento
Non-residential building types
BAC efficiency factors fBAC, HC
D C (Reference) B A
Non energy efficient Standard Advanced High energy performance
Offices 1,51 1 0,80 0,70
Lecture hall 1,24 1 0,75 0,5a
Education buildings (schools) 1,20 1 0,88 0,80
Hospitals 1,31 1 0,91 0,86
Hotels 1,31 1 0,85 0,68
Restaurants 1,23 1 0,77 0,68
Wholesale and retail trade service buildings 1,56 1 0,73 0,6a
Other types:- sport facilities- storage- industrial buildings- etc.
1
a These values highly depend on heating/cooling demand for ventilation
Residential building types
BAC efficiency factors fBAC, HC
D C (Reference) B A
Non energy efficient Standard Advanced High energy performance
Single family housesApartment blockOther residential buildings or similarresidential buildings
1,10 1 0,88 0,81
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
Definition of classes
Residential Non residential
D C B A D C B A
LIGHTING CONTROL
Occupancy control
0 Manual on/off switch
1 Manual on/off switch + additional sweeping extinction signal
2 Automatic detection Auto On / Dimmed
3 Automatic detection Auto On / Auto Off
4 Automatic detection Manual On / Dimmed
5 Automatic detection Manual On / Auto Off
Daylight control
0 Manual
1 Automatic
Figura 2. Estratto della tabella 1 della Norma EN 15232:2007 che elenca le funzioni di regolazione e controllo considerate

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 27
Tele
cont
rollo
e A
utom
azio
neF
OC
US
Non-residential building types
BAC efficiency factors fBAC, el
D C (Reference) B A
Non energy efficient Standard Advanced High energy performance
Offices 1,10 1 0,93 0,87
Lecture hall 1,06 1 0,94 0,89
Education buildings (schools) 1,07 1 0,93 0,86
Hospitals 1,05 1 0,98 0,96
Hotels 1,07 1 0,95 0,90
Restaurants 1,04 1 0,96 0,92
Wholesale and retail trade service buildings 1,08 1 0,95 0,91
Other types:- sport facilities- storage- industrial buildings- etc.
1
Residential building types
BAC efficiency factors fBAC, e
D C (Reference) B A
Non energy efficient Standard Advanced High energy performance
Single family housesMulti family housesApartment blockOther residential buildings or similarresidential buildings
1,08 1 0,93 0,92
Figura 4. Tabella 10 e 11 della Norma EN 15232:2007 - Fattori BAC per impianti di ventilazione, illuminazione e ausiliari elettrici degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
Figura 5. Schema di calcolo dell’impatto di un sistema di automazione secondo il Metodo dei Fattori BAC della Norma EN 15232
Energy useEnergy need
1)System losses
2)Auxiliary energy
3)BAC factor Notes
e) Heating =QNH + QH loss ƒBAC, hc
+ Wh, aux ƒBAC, e
Cooling =QNC + QC loss ƒBAC, hc
+ Wc, aux ƒBAC, e
Ventilation = Wv, aux ƒBAC, e
Lighting = Wlight ƒBAC, e
The impact of lightingcontrol should beevaluated separatelywith EN 15193.
1) Energy need for heating and cooling should both be calculated with EN ISO 13790.2) System losses of a heating system should be estimated by using the EN 15316 series for different process areas where as losses
of a cooling system should be estimated by using EN 152553) The auxiliary energy required by the systems should be calculated by using EN 15316 series (heating systems), EN 15241
(ventilation systems) and EN 15193 (lighting systems) respectively.

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia28
stema controllato. In altri termini è neces-sario schematizzare i flussi energetici delsistema controllato e definire analitica-mente come il sistema di controllo influi-sce su di essi.A questo proposito la Norma EN 15232 in-dica esplicitamente quali funzioni di regola-zione e controllo devono essere consideratenel calcolo dell’energia fornita e in che modoi metodi di calcolo descritti in ciascunanorma devono essere adattati o modificatiper tenerne conto.Il secondo metodo (Metodo dei FattoriBAC) permette di valutare in modo decisa-mente più semplice l’impatto delle funzionidi regolazione e controllo sulla prestazioneenergetica di un edificio.In sintesi il metodo consiste nel calcolareil fabbisogno energetico di ogni sottosi-stema e applicare dei coefficienti correttiviin funzione della Classe di Efficienza delsistema di automazione che si vuole im-plementare o si è implementato. I fabbiso-gni considerati sono i seguenti:• energia in ingresso al sistema di ri-
scaldamento, calcolata secondo la EN15316 e la EN13790
• energia in ingresso al sistema di raf-frescamento, calcolata secondo la EN15255 e EN13790
• energia in ingresso al sistema di ven-tilazione, calcolata secondo la EN15241
• energia in ingresso al sistema di illu-minazione, calcolata secondo la EN15193.
La Norma EN 15232 definisce due set diFattori BAC, per applicazioni in ambito re-sidenziale e non-residenziale:• fBAC,HC: relativo all’energia termica
per il riscaldamento e il raffresca-mento
• fBAC,EL: relativo all’energia elettrica perla ventilazione, l’illuminazione e i di-spositivi ausiliari.
In sostanza per l’edificio o la porzione diedificio in questione il metodo prevede chesi determini il fabbisogno energetico (ter-mico) dell’impianto di riscaldamento e raf-frescamento e le relative perdite di sistema,il fabbisogno energetico (elettrico) perl’impianto di ventilazione, illuminazione edei sistemi ausiliari degli impianti di ri-scaldamento e raffrescamento; a ciascunfabbisogno si applica il relativo Fattore
BAC in funzione della classe di efficienzadel sistema di automazione. I Fattori BAC sono stati ricavati confron-tando il fabbisogno annuale di energia diun locale standard di riferimento conquello richiesto dallo stesso locale nellemedesime condizioni (tempi di occupa-zione, profilo d’impiego, variabili climati-che, esposizione, conduttanza termica,dimensioni, superfici, …) tenendo contodelle diverse funzioni di regolazione e con-trollo previste dalla diverse Classi di auto-mazione (A, B, C, D).Il Metodo di calcolo basato su FattoriBAC costituisce chiaramente una stimaapprossimata, del risparmio energeticoconseguibile attraverso l’adozione di si-stemi di automazione, tanto più signifi-cativa quanto più il caso reale coincidecon il modello di calcolo alla base delladeterminazione dei fattori. In ogni caso la semplicità di questo me-todo utilizzato lo rende particolarmenteinteressante in tutti quei casi sia neces-sario effettuare uno studio di fattibilitànelle fase preliminare di progetto del-l’edificio e del relativo sistema di con-trollo e gestione dell’energia.
Norma EN 15232 e Guida CEI 205-18La Norma EN 15232 definisce le funzionidi regolazione e controllo in modo sinte-tico; d’altro canto la sua finalità come ri-badito più volte è quella di fornire unmetodo stima del risparmio energeticoconseguibile attraverso l’uso dell’automa-zione degli impianti tecnologici a serviziodi un edificio.La Guida CEI 205-18 si propone comecomplemento della Norma EN 15232; essainfatti codifica le singole funzioni, illu-strandone la logica di funzionamento especificandone lo schema di principio e icomponenti.
Riferimenti1. http://www.iee-cense.eu/2. Norma EN 15232:2007 - Prestazione
energetica degli edifici. Incidenza del-l’automazione, della regolazione e dellagestione tecnica degli edifici
3. Norma CEI 205-18:2011 - Guida al-l’impiego dei sistemi di automazionedegli impianti tecnici negli edifici.
Identificazione degli schemi funzio-nali e stima del contributo alla ridu-zione del fabbisogno energetico di unedificio.
F O C U S
1. Dick van Dijk: Background, status andfuture of the CEN standards to supportthe Energy Performance of BuildingsDirective (EPBD) – CENSE_WP6.1_NO3. www.iee-cense.eu
2. La Direttiva 2002/91/EC "Energy Per-formance of Buildings Directive"(EPBD) è stata adottata il 16 Dicembre2002 ed è entrata in vigore il 4 Gen-naio 2003. Il 13 Novembre 2008 laCommissione Europea ha presentatouna proposta di revisione della Diret-tiva. La nuova Direttiva EPBD(2010/31/UE) è stata pubblicata il 18Giugno 2010.
3. Si veda EN 15232:2007, pag. 5, primocapoverso.
4. È importante sottolineare che questaclassificazione, pur richiamando loschema classico dell’etichettaturaenergetica (A, B, C, D, …), nonesprime una prestazione, ma esclusi-vamente la maggiore o minore com-plessità delle funzioni di regolazione econtrollo che il sistema di automazionerealizza e, quindi, la maggiore o mi-nore potenzialità del sistema di auto-mazione a realizzare un risparmioenergetico.
5. Per certi versi sarebbe più correttodire che la EN 15232 propone due di-versi metodologie (tipologie) di cal-colo piuttosto che metodi. La normadefinisce infatti due approcci: unoanalitico che presuppone la cono-scenza dettagliata (modellazione com-pleta) dell’influenza del sistema dicontrollo sul sistema controllato e unosintetico che fa uso di semplici coef-ficienti correttivi.
6. EN 15232:2007 - Tabella 1.
7. La norma EN 15232 considera i se-guenti tipi di impianto: riscaldamento,raffrescamento, ventilazione, illumina-zione e schermature solari.
8. Si veda EN 15232:2007, pag. 5, se-condo capoverso.
N O T E
Telecontrollo e Automazione

3/2011 29
VI DIAMO LE CHIAVIDEL MERCATO ELETTRICO
GUARDA IL VIDEO
Oggi la domanda espressa dalle grandi aziende industriali e l’offerta dei produttori termoelettrici e rinnovabili possono incontrarsi e generare valore. EGL, attraverso le attività di gestione del portafoglio energetico, del prezzo e dei rischi correlati, consente un accesso diretto al mercato energetico con la garanzia della competenza e dell’esperienza di un leader europeo.
www.egl.eu/italia

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia30
I n Italia opera da anni un Gruppo di La-voro denominato “Telecontrollo, Super-
visione e Automazione delle Reti”, il qualeè parte dell’Associazione Italiana Automa-zione e Misura - AssoAutomazione, a suavolta appartenente alla Federazione Nazio-nale delle Imprese Elettrotecniche ed Elet-troniche - ANIE. Il Gruppo raccoglieaziende leader del settore, rappresentandouno spaccato significativo della realtà deisistemi di telecontrollo e monitoraggio retie impianti per le filiere dell’acqua, del gas,dell’elettricità, ovvero per la gestione deisiti di produzione, nonché delle infrastrut-ture di trasmissione e distribuzione, finoalla consegna all’utenza finale. Con alternevicissitudini, le differenti filiere hanno datovita a realtà aziendali italiane che hannosviluppato una propria capacità di proget-tazione e realizzazione di sistemi e, in al-cuni casi, anche di progettazione e
produzione dei componenti basilari har-dware e software per tali sistemi.Negli ultimi anni il tessuto imprenditoriale diquesto comparto tecnologico ha risentitodelle evoluzioni del mercato, disegnandol’attuale panorama, che si continua a carat-terizzare e distinguere per la forte presenzadi un livello qualificato di professionalità ecapacità tecniche. A riprova di ciò il continuosuccesso del “Forum su Telecontrollo e Su-pervisione delle Reti di Pubblica Utilità” cheogni biennio il Gruppo organizza. La dodi-cesima edizione, è prevista il 3 e 4 novembre2011, a Torino, con il titolo “A Smarter Italy- Automazione ed efficienza delle infra-strutture per un progresso sostenibile”. Inquesta edizione vogliamo mettere in mostrale eccellenze del comparto che fanno del no-stro Paese, in particolare in ambito elettrico,un riferimento a livello mondiale. È usualeoggi discorrere sull’evoluzione delle reti elet-triche e delle città in una visione più “intelli-gente”, ovvero su una prospettiva attenta adun uso energetico più efficiente e rispettosodell’ambiente: stiamo parlando di smart gride di smart city.Per supportare questi concetti, le reti di pub-blica utilità stanno evolvendo nella direzionedi una maggiore diffusione e uso dell’auto-mazione e dell’ICT, nonché di una maggioreintegrazione e connessione tra di loro. Nonda ultimo è richiesta una maggiore flessibi-lità rispetto alla possibilità di integrare le“novità” che possono essere rappresentateda nuove tecnologie (ad esempio, nuovimezzi di comunicazione per il trasferimentodelle informazioni) e da nuovi dispositiviconnessi alla rete (a titolo d’esempio, l’inte-grazione di differenti impianti di generazioneelettrica ai differenti livelli di tensione delle
reti elettriche), il tutto da gestire assicurandocomunque l’erogazione del servizio di pub-blica utilità, in modo affidabile e sicuro. Di-venta pertanto importante per un’utilitydisporre di piattaforme per il monitoraggio ela supervisione, in grado di adattarsi a questicambiamenti in tempi rapidi e senza contrac-colpi nel servizio. Oggi le aziende del nostrosettore sono chiamate dai nostri clienti asoddisfare obiettivi di investimento che nonsi limitano esclusivamente alla sola fase difornitura e messa in esercizio di un sistemadi telecontrollo. Per rispondere ai requisiti diflessibilità è necessario garantire anchel’economicità nei costi di esercizio e manu-tenzione del sistema, per un periodo ditempo significativo di utilizzo dello stesso.Pertanto, fondamentale è anche la capacitàdi mantenere i sistemi di telecontrollo allostato dell’arte, con particolare attenzioneanche alla questione della sicurezza, inclusaquella informatica, oggi divenuta elementocritico con l’uso delle reti di telecomunica-zione e dei potenziali accessi indesiderati.Guardando al futuro, con le reti intelligentisi valutano i possibili contributi provenientida altre fonti di dati e informazioni, rispettoa quelle tradizionalmente usate per espletareuna qualche funzione. Rimanendo semprenel perimetro di un’utility, per esempio, è an-cora in fase di messa a punto l’utilizzo del-l’informazione proveniente dai contatoriintelligenti per dispacciare l’energia elettricanella rete di distribuzione, o l’uso di diffusisistemi di accumulo dell’energia a compen-sazione della fluttuazione dovuta agli im-pianti rinnovabili. Ma si sta andando ancheoltre, cercando di valutare e comprenderepertinenza e utilità di altre fonti dati. Adesempio, sfruttando le informazioni prove-nienti da centralini meteo domestici, per me-glio valutare l’apporto della produzione deipannelli solari, diffusi in un ambito cittadino,e l’impatto di ciò sul dispacciamento del-l’energia elettrica nella rete. La tendenza è diaprirsi, per integrare una qualsiasi fonte per-tinente e utile, andando anche a sperimentarenuovi algoritmi e nuove correlazioni tra le in-formazioni disponibili. Tutto ciò implica ri-mettersi in discussione su tutta la linea,poiché i sistemi attuali per l’acquisizione, iltrasferimento, l’archiviazione, l’elaborazionee la visualizzazione dati sono da ridimensio-nare. Sarà infatti necessario disporre di unanuova infrastruttura SCADA (Supervisory
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
Telecontrollo e automazionereti di pubblica utilità L’innovazione continua di un settore a supporto delle reti e delle città intelligenti
Antonio De Bellis
Presidente Gruppo Telecontrollo,
Supervisionee Automazione
delle Reti AssoAutomazione -
ANIE

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 31
Control and Data Acquisition) per integraree gestire la ”internet of things”; la nuova in-frastruttura SCADA sarà progettata per ela-borare ordini di grandezza superiori a quantofatto oggi, in termini di tipologia delle sor-genti e dei dati. I sintomi che vediamo oggirealizzando le smart grid e le smart city sonoquelli che annunciano l’arrivo di uno “tsu-nami” di dati. Per gestire il tutto sarà neces-sario attrezzarsi: fondamentale sarà disporredi adeguate infrastrutture, in primis quellaelettrica e di telecomunicazioni, in grado digarantire una “alimentazione” a tutti i dispo-sitivi connessi, in modo affidabile, sicuro edefficiente. Tutti i prodotti devono inglobare,o stanno per inglobare, le capacità e le con-nessioni richieste per essere parte di questonuovo mondo; ma la vera sfida è nella capa-cità di comprendere come beneficiare di tuttoquanto reso disponibile da “internet ofthings”, per eseguire i processi, erogare iservizi, produrre beni, contribuire a realizzareun modo di vivere più sostenibile.
Per tutte le reti, e in particolare per quelleelettriche di distribuzione, il ruolo dei sistemidi telecontrollo diviene cruciale per suppor-tare il cambiamento atteso nelle abitudini alconsumo. Un utente diviene un elemento at-tivo nella gestione di una rete, con la neces-sità di essere rappresentato e gestito a livellodi sistema di telecontrollo; ogni utente di-viene potenzialmente fonte di importanti in-formazioni per l’erogazione dei servizi, ingrado di mettere a disposizione generazioneo carichi al distributore elettrico, in forma ag-gregata con altri utenti. Si potranno cosìavere degli impianti virtuali connessi alla reteda usare per ottenere un dispacciamento ot-timo della potenza sulla rete, riducendo alminimo la necessità di una riserva da im-pianti tradizionali al fine di garantire il bilan-ciamento della rete. In quest’ottica unelemento nuovo è costituito dalla capacità diaccumulo, per esempio dai sistemi a batteriadei veicoli elettrici, dei data centers, degli im-pianti residenziali. Al momento la diffusione
FO
CU
STe
leco
ntro
llo e
Aut
omaz
ione
di questi elementi è estremamente limitatasulla rete, ma sono in corso sperimentazioniper valutarne la portata e i benefici, confidentianche di una drastica riduzione dei volumidi ingombro dei costi delle batterie.Per concludere, i sistemi di telecontrollo de-dicati alle reti di pubblica utilità sono in con-tinua innovazione per beneficiare dellenovità tecnologiche e supportare i cambia-menti normativi e sociali. A seguito degliobiettivi politici sul progresso sostenibile,in Europa sintetizzabili con l’obiettivo 20-20-20 (riduzione emissioni CO2, incre-mento efficienze, incremento produzione dafonti rinnovabili), siamo in una fase evolu-tiva epocale per quanto riguarda le reti e gliambiti urbani. Stiamo vedendo i primi timidieffetti, ma la portata è ben oltre. I sistemi ditelecontrollo e automazione delle reti dipubblica utilità e di conseguenza le aziendedi questo settore, per il loro scopo e la loronatura, sono in prima linea, cartina torna-sole del processo evolutivo in atto.
I sistemi di telegestione e telecontrollo in ambito ospedaliero hanno due funzioni principali: garantire il comfort del malato rego-lando il microclima degli ambienti e ottimizzare la gestione dell’energia. Una corretta gestione delle variabili microclimatiche deireparti ospedalieri, oltre ad assicurare un maggiore comfort alzando la qualità della vita ospedaliera, assicura adeguate condizioniper non favorire la diffusione di batteri, fattore di fondamentale importanza per una struttura sanitaria. Nel settore terziario, l’ospedalerappresenta la tipologia di edificio con una delle maggiori richieste di energia per unità di superficie e anche se il consumo ener-getico non fa parte del suo core business, rappresenta comunque una spesa rilevante. I vettori energetici presenti sono molti e nonsempre le modalità di funzionamento e consumo energetico delle macchine sono noti; nella maggior parte dei casi ci si limita apagare il conto senza sapere da dove proviene tale spesa. Il sistema di TG e TC, oltre a misurare consumi energetici, energia termicaed elettrica nelle varie parti di un edificio, permette di individuare malfunzionamenti, perdite e sprechi. Data l’elevata densità ener-getica, una corretta gestione corrisponde sempre anche ad una riduzione dei consumi.La FIRE, in collaborazione con l’azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma, sta svolgendo uno studio sull’impatto dei sistemi di TG eTC all’interno di tale struttura, cercando di ottimizzarne funzioni e applicazioni. Le figure che all’interno dell’ospedale hanno la pos-sibilità di accesso alla visualizzazione dei dati sono l’energy manager, la società di servizi energetici appaltante del contratto servizioenergia e i servizi tecnici di manutenzione. L’energy manager e la società fornitrice del servizio hanno maggiore attenzione al con-trollo dei consumi energetici, mentre i servizi tecnici curano gli aspetti legati alla manutenzione e garanzia di funzionamento dellemacchine. In questo modo il sistema è utile sia per questioni energetiche e di comfort, sia di sicurezza e affidabilità degli impianti.Nella prima fase di studio è stato preso come riferimento il reparto di Pronto Soccorso, cercando di sensibilizzare gli operatori sanitarie gli utenti ad una corretta gestione dell’energia. L’azione prevede la distribuzione del materiale informativo nel quale si informadella presenza del sistema di supervisione e si invitano gli utenti a segnalare azioni su cui intervenire con il sistema di controllo peruna corretta gestione dell’energia (ad esempio segnalare sale chiuse dove non serve climatizzazione, ambienti troppo freddi o caldi,etc.). Si procederà quindi a misurare gli effetti dell’azione e a quantificare i risparmi conseguiti. La FIRE ha inoltre distribuito agli energy manager del settore sanitario un questionario per valutare lo stato attuale di diffusione eil loro punto di vista riguardo all’utilità e i vantaggi forniti da tali sistemi. Quasi il totale degli intervistati (le risposte sono state 18)ritiene che il sistema sia utile e fondamentale ai fini dell’efficienza energetica, ma solo circa il 10% del totale ha la diretta gestione,questione altrimenti affidata ai servizi tecnici di manutenzione, o alle società di servizio energia. Gli impianti telegestiti e telecon-trollati sono generalmente quelli di climatizzazione (riscaldamento e ventilazione), mentre si hanno poche applicazioni sui sistemid’illuminazione interna (30%) ed esterna (20%). Sul lato delle tecnologie, la trasmissione dati avviene principalmente su sistemi ca-blati (ethernet, bus, etc.) e solo in un caso si ha l’applicazione di apparati wireless.Sicuramente un sistema di telegestione e telecontrollo che dia una visione completa di chi, cosa, dove, quando e perché si consumaenergia (regola delle cinque “W”) rappresenta in tutte le sue applicazioni un punto di partenza sia per l’ottimizzazione dei vettorienergetici, sia per la valutazione di nuovi interventi di efficienza energetica.
Studio FIRE: Telegestione e Telecontrollo nelle strutture ospedaliere
Marco Bramucci - FIRE

una piattaforma di gestione (il si-stema di Building Management Simple Life)in grado di far dialogare tra loro più sottosi-stemi, rendere l’edificio funzionale e in gradodi regolarsi autonomamente, predisponendoda remoto azioni di controllo, comando e re-golazione su apparecchiature presenti all’in-terno delle strutture, o ulteriori dispositivi diautomazione da integrare sul campo. La co-municazione powerline, ingrediente fonda-mentale alla base di questo nuovo modo disfruttare al massimo le reti elettriche degliedifici, fungono da vettore oltre che per il ri-sparmio energetico che ne deriva, anche pererogare servizi a valore aggiunto quali:• videosorveglianza• wifi• gestione cariche e allarmi• digital signage e Interattività • gestione integrata della sensoristica• controllo accessi• predisposizione intelligente delle reti
per impianti fotovoltaici.
Il sistema utilizza comemezzo trasmissivo le onde con-
vogliate che - integrate alle tecnologie bustradizionali - riescono a coprire lunghe di-stanze all’interno degli edifici evitando la ste-sura di linee e riducendo le opere murarie.Due esempi applicativi, tra le più impor-tanti realizzazioni che hanno scelto la ge-stione integrata del sistema, sono la sededel MIBAC Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali (figura 1) e la AUSL di Ferrara,che ha implementato su 11 edifici la piat-taforma di gestione. Presso la sedeMIBAC, sviluppata su un palazzo di piùpiani, sono stati installati dispositivi cheeffettuano il controllo e il monitoraggio deiconsumi elettrici degli uffici e dei corridoi,altri dispositivi che governano i consumiin base alla luminosità esterna e altri an-cora che ottimizzano i consumi in base allepresenze negli stessi. Nello specifico si èscelto di controllare il consumo dell’illu-minazione degli uffici, dei corridoi, delle
F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia32
L a necessità sempre maggiore di ri-durre i consumi energetici nel settore
edile è molto importante per il rispettodell’ambiente e delle politiche di efficien-tamento energetico. La Building Automa-tion diventa così una soluzione valida peril miglioramento dei servizi.Gli edifici di grandi dimensioni presentano,in genere, un insieme variegato di sottosi-stemi come l’impianto di riscaldamento econdizionamento, sistemi di gestione del-l’energia elettrica e illuminazione, sistemidi sicurezza degli impianti e videosorve-glianza etc.. Ogni comparto dell’architetturadi impianto è stato pensato e gestito sino aoggi come sistema a se stante. La BuildingAutomation ha permesso di cambiare laprospettiva progettuale di questi impiantiche - attraverso nuove tecnologie - pos-sono essere gestiti, monitorati e comandatida un’unica regia, che spesso non è pre-sente fisicamente all’interno dell’edificio. UMPI è intervenuto su diversi immobili con
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
GianluigiGereschi
Area manager Nord Italia -
UMPI Elettronica
La gestione intelligentee integrata degli edifici

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 33
prese PC, dei condizionatori e delle lineeFM. In questo modo la gestione delle retiè autoregolamentata dal Sistema SimpleLife, che governa gli impianti a seconda diquanto è necessario consumare (si evita difunzionare sempre al 100% in ogni mo-mento). Per realizzare questa automazionesono stati inseriti i reattori elettronici dim-merabili 1-10 V sulle plafoniere, con ge-stione su linea di comando da quadro dicontrollo (figura 4). La centrale di co-mando presente sul quadro è in grado dipilotare i comandi di accensione e di li-vello delle plafoniere secondo programma-zioni e configurazioni fissate dal software.In concomitanza, le sonde di luminositàpermettono di adattare il flusso luminosoalla luce ambiente. All’interno degli uffici,invece, sono state inserite sonde combi-nate di luminosità e presenza in modo daspegnere totalmente l’illuminazione in casodi assenza dell’utente all’interno del locale.Per quanto riguarda invece le sedi dellaAUSL di Ferrara, con tale piattaforma ladirezione tecnica ha uno strumento com-pleto in grado di elaborare i dati di con-sumo in forma grafica e statistica chepermette di comparare i vari consumi. Lapiattaforma software è in grado di inviaresegnalazioni di allarme in caso di supera-mento delle soglie prestabilite, evitandosprechi e costi inutili. Il software di super-visione (figura 3) permette inoltre di mo-nitorare costantemente le grandezze
elettriche e di impostare gli orari di accen-sione dell’illuminazione. La tecnologia adottata, in entrambi i casipuò integrare il comando e la programma-zione da remoto delle linee dei ventilcon-vettori e dei boiler presenti all’interno dellastruttura, di gestire eventuali allarmi pro-venienti dalle sale tecniche e dalle saleCED e di utilizzare ogni punto presa comenodo di comunicazione. Lo scopo diventa
FO
CU
STe
leco
ntro
llo e
Aut
omaz
ione
quindi quello di tenere sotto controllo si-stemi tecnicamente considerati diversicome l’impianto di illuminazione e quellodi riscaldamento/condizionamento mafunge anche da vettore, permettendo graziealla tecnologia ad onde convogliate ad altavelocità, di erogare servizi a larga banda(rete lan estesa su cavo elettrico).Tutta l’architettura di sistema è monitoratain tempo reale attraverso un server di con-
Figura 1. Il MIBAC (Ministero dei beni culturali) ha scelto una gestione domotica degli impiantiper alcune delle sue sedi
Figura 2. L’architettura di gestione relativamente all’impianto di illuminazione all’interno degli uffici del Ministero per la gestione domoticadell’impianto di illuminazione. Il dispositivo per il controllo ad onde convogliate Divo 1-10V governa la luminosità. Consente in abbinamento al grado di luminosità e alla presenza di modulare i consumi secondo necessità
ARMADIO DI PIANOPOSTAZIONE DI LAVORO
DORSALE DI EDIFICIO
CABLAGGIOORIZZONTALE
COMPUTERSERVER
CENTRALE TELEFONICA
VANO TECNICO
Divo 1-10V
1-10V
230V230V230V
1-10V1-10VRS 485
Divo 1-10V
MultisensorDimmer
MultisensorDimmer
MultisensorDimmer
Architettura tipo per comando linea luci su o.c.
Divo 1-10V
*
*
SimplexPL
Unità controllo quadro:Simplex + Simplex AL
ONDE CONVOGLIATE

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia34
trollo e gestione completo di software ap-plicativo per il telecontrollo delle unità diquadro e dei moduli di comando e di con-trollo. Il server è connesso ai moduli di co-mando presenti all’interno dei quadritramite un accesso sulla rete LAN; ogni mo-dulo concentratore è identificato da un pro-prio indirizzo IP fisso sulla rete Ethernet
della struttura. Il software di supervisionepermette di visualizzare - su un menù ad al-bero - le varie zone controllate, i quadri, lesegnalazioni e le misure raccolte dai dispo-sitivi presenti. Inoltre, specifiche schermatepermetteranno agli utenti la configurazionedei dispositivi e la programmazione deicicli di funzionamento.
Il Sistema Simple Life trova continuitàanche verso l’Outdoor ove la piattaformaMINOS può integrarsi come se fosse lastessa rete fisica; in realtà vengono gestitiin maniera logica e programmabile, glispazi e gli impianti di cui essi fanno partecon la possibilità di creare servizi a valoreaggiunto utilizzando la rete elettrica e i palidella luce (figura 4).Il punto luce, integrato con i dispositivi aonde convogliate ad alta velocità, diventail supporto abilitante a servizi come video-sorveglianza, connettività wifi e avvisi alcittadino o al pubblico.La direzione tecnica, nonché il gestore,possono così avere un’unica piattaforma,la quale permette una supervisione globaleche utilizza i dispositivi ad onde convo-gliate di ultima generazione.Oltre ai risparmi energetici stimabili media-mente intorno ad un -30%, le economie digestione possibili grazie all’adozione del si-stema di telecontrollo brevettato da UmpiElettronica si misurano in un’incidenza sullevoci di manutenzione intorno al -35%,senza contare la possibilità di implementarei servizi VAS concepiti normalmente se-condo metodi standard (scavi, opere, ri-strutturazioni, ecc.).
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
Figura 4. Il Building Automation (Sistema Simple Life di Umpi) si congiunge con le necessità del mondo Outdoor basandosi sulla stessa piattaforma integrata
Figura 3. Anche da postazione remota, un software dedicato (EasyCon) permette di monitorare le diverse funzioni del sistema e tutti i parametridell’impianto - Fonte: Umpi
ONDE CONVOGLIATE

3/2011 35
COGENERAZIONE,UNA SCELTA CONSAPEVOLE
VANTAGGI ENERGETICI, ECONOMICI E AMBIENTALI
Autonomia, sicurezza, affidabilità
ampa
dv.it
Gruppi Elettrogeni
Cogenerazione
Trigenerazione
una divisione di
Gr
Co
ru
og
Gruppi Elettrogeni
rigenerazioneT
Cogenerazione
Autonomia, affidabilità sicurezza,Autonomia,
www
affidabilità
.intergen.it [email protected] [email protected]
Gruppi Elettrogeni

peso progressivo degli impianti tecnologici.In questo contesto di mercato, il tema ener-getico sta assumendo una valenza vieppiùsignificativa, sia sul fronte della sensibilità,che sul fronte normativo.Bastano alcuni indicatorisugli andamenti di mer-cato per avere un’impres-sione, anche se indicativa,di quanto ci aspetta neidecenni a venire:• le nuove economie
crescono otto voltepiù veloci delle eco-nomie mature
• 60% della popola-zione mondiale vivrànelle città
• +2 miliardi di persone faranno partedel ceto medio.
Emerge il ruolo fondamentale della proget-tazione integrata, in grado cioè di cogliere
F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia36
Stato dell’arte e trend di mercatoSecondo il Cresme1 il valore della produ-zione del settore costruzioni nel 2001 èstato di 290.000 miliardi di lire, suddivisonei tre comparti di attività dell’edilizia re-sidenziale, edilizia non residenziale pub-blica e privata, genio civile. Una segmentazione fondamentale, ma chegià da alcuni anni il Cresme ha integratocon un ulteriore livello di segmentazione:la divisione tra attività di nuova costruzionee attività di manutenzione sia essa ordina-ria o straordinaria.Questa scomposizione trasversale rispettoalla segmentazione tradizionale del mer-cato consente di cogliere il primo grandefenomeno di trasformazione che caratte-rizza il settore delle costruzioni negli anni‘90: oltre il 60% del valore della produ-zione nelle costruzioni proveniente dall’at-tività manutentiva e di riqualificazione delpatrimonio esistente. E la rilevanza di que-sto dato emerge con particolare forza se siricorda come negli anni ’60 e ’70 la nuovaproduzione abitativa rappresentava il 70-80% dell’intero mercato, mentre oggi lasua quota si è ridotta a meno del 17%, parinel 2001, in vecchie lire a 48.000 miliardi. La sola manutenzione straordinaria nel 2009ha avuto un fatturato di oltre 65.000 miliardi. Questo spostamento di risorse dal nuovoal recupero e alla manutenzione ha riguar-dato anche i comparti del non residenzialee del genio civile.Sulla base dello scenario descritto è cambiataanche la percentuale di ripartizione dei costidelle componenti edilizie, con un maggior
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
La progettazione integratacome prerequisito per l’efficienza energetica degli edifici
Saul Fava
Marketing & Development Manager, Efficienza Energetica -
Schneider Electric
Variazione dei costi dei componenti edilizi
100%
50%
0200019801960
FINITURA
SISTEMI TECNOLOGICI
STRUTTURA E OPERE MURARIE
Il valore della produzione nelle costruzioni 2001 - miliardi di lire
VALORE DELLA PRODUZIONE
290.663
MANUTENZIONEORDINARIA
50.530
RECUPERO60,1
NUOVO39,9
NUOVO116.096
82,6
100,0
17,4
42,7
22,3
10,9
3,1
6,3
39,9
16,7
11,7
2,8
8,7
INVESTIMENTI240.133
RECUPERO124.037
Ediliziaresidenziale
64.953
Ed. non rea.privata31.785
Ed. non rea.pubblica8.969
OpereGenio Civile
18.300
Ediliziaresidenziale
48.604
Ed. non rea.privata33.928
Ed. non rea.pubblica8.266
OpereGenio Civile
25.298

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 37
tutte le sinergie tecnologiche possibili utiliall’efficientamento energetico. Sia che sitratti di nuove realizzazioni, sia di ristrut-turazioni delle costruzioni esistenti. In que-sta direzione sta evolvendo anche il quadronormativo di riferimento.
Automazione degli impianti per il miglioramento della loroEfficienza EnergeticaSia la nuova direttiva EPBD (Energy Perfor-mance Building Directive - 2010/31/CE),all’articolo 8.1 per quanto riguarda gli aspettigenerali, sia la norma UNI EN15232:2007
per quanto riguarda gli aspetti tecnici di det-taglio, pongono al centro della loro campodi intervento i requisiti di impianto, la cor-retta installazione e le dimensioni dei sistemidi regolazione e controllo degli impianti tec-nici per l’edilizia, sia per gli edifici nuovi chenella ristrutturazione di edifici esistenti. A prescindere dagli aspetti puramente tec-nici, il principio alla base di queste norma-tive è il fatto che il controllo manuale degliimpianti (siano essi di illuminazione, dischermatura solare, di raffrescamento o diriscaldamento) è intrinsecamente ineffi-ciente dal punto di vista energetico, sia
perché puramente sogget-tivo, sia perché può esseretrascurato per dimenticanza.L’introduzione di sistemi au-tomatici di regolazione econtrollo, per i quali la nor-mativa UNI EN15232:2007specifica funzioni e risparmiottenibili, è la strada maestra
FO
CU
STe
leco
ntro
llo e
Aut
omaz
ione
per introdurre una nuova categoria di im-pianti in grado di provvedere autonoma-mente (ovviamente senza penalizzare gliaspetti di comfort) alla propria regolazionein base a parametri preimpostati.
Sistemi di misura intelligenti per il controllo attivo e la contabilizzazione dei consumi energeticiLa direttiva EPBD, all’articolo 8.2, invita gliStati membri a promuovere l’introduzione diquesti sistemi. Si tratta di una novità asso-luta, che finalmente si pone l’obiettivo dicontabilizzare i consumi sui diversi vettorienergetici e di costituire un database di mi-sure che diventa strumento sia per l’analisidel comportamento energetico per indivi-duare le aree di miglioramento, sia per con-trollare i risultati di un intervento diefficientamento (confrontando il “prima” conil “dopo”). Si intravede quindi come, a fiancodei calcoli di progetto della prestazione ener-
Connections between EN 15232 standard and other Technical Committees
Energia termica in edifici non residenziali
Tipologia Edificio / Locale
Classi e Fattori di efficienza BAC Risparmio (rif. classe D) Risparmio (rif. C)
DSenza
Automazione
C (rif)Automazione
Standard
BAutomazione
Avanzata
AAlta
efficienzaC/D B/D A/D B/C A/C
Uffici 1,51 1,00 0,80 0,70 34% 47% 54% 20% 30%
Sale di lettura 1,24 1,00 0,75 0,50 19% 40% 60% 25% 50%
Scuole 1,20 1,00 0,88 0,80 17% 27% 33% 12% 20%
Ospedali 1,31 1,00 0,91 0,86 24% 35% 34% 9% 14%
Hotel 1,31 1’00 0,85 0,68 24% 35% 48% 15% 32%
Ristoranti 1,23 1,00 0,77 0,68 19% 37% 45% 23% 32%
Negozi / Grossisti 1,56 1,00 0,73 0,60 36% 53% 62% 27% 40%

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia38
getica e conseguente certificazione dell’edi-ficio, vedremo nascere nuovi strumenti percontrollare e analizzare i consumi reali.Il quadro normativo di riferimento, purnella sua complessità, oggi è sicuramentechiaro ed esaustivo, così come è evidentela necessità del progettista di saper gestiree integrare la tecnologia che, negli ultimianni e alla luce dell’evoluzione tecnologica,ha compiuto notevoli passi avanti sulfronte dell’efficienza energetica.I vantaggi di una progettazione integrata, eche quindi tenga conto dei contributi ap-portabili sia dall’utilizzo di apparecchiaturee tecnologie efficienti, sia dall’utilizzo di si-stemi di automazione che controllino inmodo intelligente le tecnologie efficienti,sono indicate in modo sintetico nelle ta-belle BACs factor proprio della normaEN15232 2, a cui si rimanda per gli ambitie le modalità di applicazione della stessa.Il dato evidente sottolineato dal normatore èil beneficio derivante da una progettazione in-tegrata che tenga conto già in fase di proget-tazione, non solo degli impianti e soluzionitecnologiche, ma anche di come gli stessiverranno gestiti e operati nel quotidiano.
Le tecnologie disponibili.Sistemi di BuildingAutomationI sistemi di Building Automation sono ingrado di fornire le funzioni necessarie aduna gestione degli impianti finalizzata a mi-gliorare l’Efficienza Energetica dell’edificio.In particolare, le aree di applicazione nel-l’automazione degli impianti sono tipica-mente le seguenti:• HVAC. Per alcuni aspetti si tratta di
applicazioni già note da tempo finaliz-zate ad un migliore utilizzo degli im-pianti di ventilazione, riscaldamento econdizionamento visti nel loro in-sieme e in termini di impatto energe-tico del loro funzionamento sull’interoedificio. Senza voler essere esaustivi,fanno parte di questa categoria le se-guenti applicazioni di automazione:• programmi di avviamento e arre-
sto ottimizzato • ventilazione notturna• free cooling con algoritmo di
controllo entalpico• banda a energia zero• reset dei carichi per zona
• gestione dei carichi (avvia-mento/arresto ottimizzato, arrestociclico).
Gli anni più recenti hanno visto ladiffusione di altre applicazioni di au-tomazione che guardano all’ottimiz-zazione dell’uso dell’energia da partedegli utilizzatori degli edifici e in par-ticolare al miglioramento dell’effi-cienza a livello di micro-ambiente (ilsingolo ufficio, camera di albergo,stanza di ospedale ecc.).Fanno parte di questo insieme di ap-plicazioni quelle legate alla rilevazionedella presenza delle persone (con sen-sori dedicati, con informazioni prove-nienti da altri sistemi di automazionequali il controllo degli accessi) al finedi modificare i set-point di temperatura(economy nel caso di ambiente nonabitato, comfort nel caso di ambienteabitato), oppure applicazioni che ren-dono disponibili interfacce uomo-macchina più intuitive e semplici dautilizzare (telefoni, telecomandi, PC,ecc.) per ovviare alla scomodità nel-l’utilizzo di interfacce tradizionali (ter-mostato a parete o similari) che a volterappresenta l’ostacolo ad un miglioreutilizzo personale degli impianti.
• Illuminazione. Anche per questa ti-pologia di impianti sono sempre piùdiffuse applicazioni che consentono diattivare o meno i singoli corpi illumi-nanti in funzione della presenza dellepersone, ovvero di regolare l’intensitàdel flusso luminoso in base all’ap-porto luminoso esterno, garantendocomunque i livelli minimi di illumina-mento previsti in fase di progetto. Perquest’ultima applicazione, la possibi-lità di personalizzazione del livello diilluminamento richiesto consente mi-gliorare ulteriormente il livello di effi-cienza fornendo, nel contempo, un piùalto comfort abitativo.
• Schermature solari. In ordine ditempo si tratta dell’applicazione di piùrecente introduzione, che prevede unadoppia finalità. Da un lato, l’apertura-
chiusura della scherma-ture in funzione dellapresenza per sfruttare l’ir-raggiamento solare in in-verno (contributo al
riscaldamento dell’edificio) e per evi-tarlo in estate (riduzione del fabbisognodi raffrescamento). Dall’altro lato, incaso di ambiente abitato, la regolazionedell’inclinazione delle lamelle per sfrut-tare l’illuminazione naturale indiretta.
Ovviamente il massimo di efficienza nel-l’uso di energia si ottiene quando tutte que-ste applicazioni operano in modo sinergico,grazie all’integrazione all’interno di ununico sistema di automazione di edificio.Tale integrazione oggi è resa più semplicee immediata grazie ad una sempre mag-giore diffusione dei protocolli standard dicomunicazione (BacNet, KNX, LonWorks)che garantiscono l’interoperabilità fra i di-spositivi (anche di produttori diversi).Anche le normative tecniche già citate inprecedenza promuovono l’integrazionecome elemento fondante dell’automazionedegli edifici.Un cenno merita la diffusione sempre mag-giore delle tecnologie wireless, anch’essesempre di più basate su standard di comu-nicazione (Bluetooth, ZigBee, WiFi), chepossono rappresentare la soluzione tecnicadi riferimento quando si ha necessità dioperare su edifici esistenti, all’interno deiquali la possibilità di intervenire sugli im-pianti è necessariamente limitata.
Le tecnologie disponibili.Costi e protezione degliinvestimentiSpesso, uno degli argomenti portati comegiustificazione di un mancato investimentoin automazione è quello legato all’inci-denza dei relativi investimenti. In realtàl’argomentazione è molto debole e sonosufficienti alcuni indicatori generali per farechiarezza sul tema.Considerando un ciclo di vita di un edificiodi 30 anni si può calcolare come i costi dicostruzione incidano sui costi complessiviper circa l’11% (fonte: Astrae American So-ciety for Heating,Refrigeration & Air Con-ditioning Engineers). All’interno dei costi dicostruzione, quelli legati alle componentiimpiantistiche sono mediamente del 27%e, di queste, la parte di automazione,quando applicata al massimo livello delletecnologie disponibili non riesce a superareil 15% del valore totale degli impianti.Stiamo quindi parlando di un impatto delsistema di automazione di edificio che può
F O C U S
Telecontrollo e Automazione

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 39
andare da un minimo dello 0% (nessunaautomazione) fino ad un massimo di menodi mezzo punto percentuale (tutte le mi-gliori tecnologie di automazione applicate),in rapporto al costo complessivo nel ciclodi vita dell’edificio.Come si può vedere, l’impatto in termini dicosti risulta trascurabile e comunque ampia-mente recuperabile nello stesso periodo, siain termini di valore dell’asset, sia per la ridu-zione dei costi legati ai consumi di energia. Per citare solo alcuni dati tratti da studi disettore sull’impatto dei sistemi di automa-zione possiamo indicare3:+ 7,5% in valore dell’edificio + 3% del canone di locazione+ 3,5% in occupazione+ 17% prezzo di vendita / m²- 9% costi operativi- 10% costi per l’energia.Anche il tema della rapida obsolescenzadei dispositivi di automazione non ha piùragione di essere posto. La diffusione deglistandard anche nel mondo dell’automa-zione di edifici offre un’importante prote-zione dell’investimento, consentendo difare riferimento a fornitori/produttori di-versi sia nella fase realizzativa, che inquella, successiva, di manutenzione e ade-guamento del sistema.Sono più complessi da quantificare, macomunque non da trascurare, gli aspetti le-gati al valore che l’edificio acquisisce intermini di rispetto delle normative vigenti
e a venire (da non sottovalutare l’im-patto che l’introduzione delle smart gridpotrà avere in termini di requisiti di au-tomazione degli edifici), oltre che di ri-spondenza alle esigenze dei decisionmaker di domani.
Progettazione integrata ed efficienza energeticaLo scenario di mercato descritto in pre-cedenza, la disponibilità di un’offertatecnologica abilitante e i positivi valorifinanziari in gioco dovrebbero aver pro-dotto un mercato fiorente e un parcoimmobiliare ad alta efficienza energe-tica, invece non è così.Quali sono le ragioni per l’arretratezza,da questo punto di vista, degli edificiesistenti e perché anche nella progetta-zione di nuovi edifici i criteri esaminatinon vengono applicati o vengono ap-plicati solo parzialmente e spesso in
modo non integrato?Ovviamente si tratta di una domanda allaquale le risposte possono essere molteplici,ma in questa sede vogliamo esaminare indettaglio quella connessa alla frammenta-zione del processo di progettazione. Si tratta di una frammentazione funzionaledovuta alla partecipazione al processo diprogettazione di figure professionali di-verse (architetti, progettisti strutturali,progettisti elettrici e meccanici) chehanno in carico aspetti diversi della pro-gettazione, della quale si occupano anchein momenti temporali diversi. Questo“metodo di lavoro” è spesso una dellecause delle scarsa organicità dal punto divista dell’efficienza energetica del pro-getto di un edificio, in particolare (ai finidi questo intervento) per quanto riguardala parte impiantistica.Un primo esempio può essere fatto perquanto riguarda la scelta del sistema di il-luminazione, fatta dall’architetto, che avolte significa la scelta di un sistema pro-prietario di governo degli scenari luminosie dell’intensità dei flussi luminosi. Unascelta di questo tipo impedisce poi, al pro-gettista elettrico, di utilizzare gli stessi sen-sori di presenza per l’automazione delsistema di climatizzazione o di sincroniz-zare il funzionamento delle luci con quellodelle schermature solari.Analogamente, la scelta di schermature so-
lari automatizzate, magari integrate nellafacciata continua e oggetto di una sceltaarchitettonica, impedisce all’opposto dipoter realizzare un’automazione integrata(dal punto di vista delle applicazioni conimpatto energetico) con i sistemi di clima-tizzazione e di illuminazione.Ancora i moderni sistemi di climatizza-zione localizzata dei micro-ambienti, checonsentono di migliore l’efficienza del si-stema, possono avere un impatto nellescelte architettoniche.Come diviene immediatamente evidente, laprogettazione di un edificio efficiente dalpunto di vista energetico porta, come im-mediata conseguenza, alla necessità di unteam di progettazione che sviluppi unaspecifica area di collaborazione interdisci-plinare su questo tema. Le scelte tecnolo-giche devono essere condivise e devonocontemperare gli aspetti estetici e funzio-nali per raggiungere l’obiettivo della mas-sima efficienza energetica dell’edificio.Questo nuovo “metodo di lavoro” dovrà di-ventare la prassi, perché la sua mancata ap-plicazione porterà rapidamente (perchérapidissima sarà nei prossimi anni l’evolu-zione di questo mercato) a escludere dalprocesso di progettazione quelle figure pro-fessionali che non sono in grado di operaresecondo questo schema interdisciplinare,unico in grado di garantire il risultato cheil cliente finale non solo si aspetterà, mapretenderà per i suoi edifici.
Lifecycle Cost Analysis di un edificio
1. Studio Cresme, “Le costruzioni al2010”.
2. Norma EN15232: «Prestazione ener-getica degli edifici - Incidenza dell’au-tomazione, della regolazione e dellagestione tecnica degli edifici».
3. Turner,C & Frankel,M. (2008). EnergyPerformance of LEED for new construc-tion buildings: Final report Kats,G.(2003) The costs and Financial benefitsof Green Building: A report to Califor-nia’s Sustainable Building Task ForceGSA Public Buildings Service (2008).Assessing green building performance:A post occupancy evaluation of 12 GSAbuildings RICSRESEARCH (2009). Ananalysis of the financial performance ofGreen Office Buildings in the USA Eu-rope Real Estate 2009 databook.
N O T E
Involucro(fondamenta, muri,solette, acciaio eLegno, ecc.)
Operativi50%
Costruzione11%
Finanziari14%
Ristrutturazione/Manutenzione
25%
Finiture(finestre e porte,pavimenti, piastrelle,verniciatura, ecc.)
Buildingtechnology
27
737
29
Altri
FO
CU
STe
leco
ntro
llo e
Aut
omaz
ione

F O C U S Telecontrollo e Automazionegestione energia40
• settore industriale 10.000 TEP • settore civile e trasporti 1.000 TEPIn questo contesto si inserisce l’offertacommerciale Nuvola It Energreen di Tele-com Italia, che porta sul mercato un arti-colato e sofisticato insieme di tecnologie,infrastrutture e conoscenze specifiche ma-turate internamente, al fine di contribuireal contenimento dei consumi di tutte quelleaziende la cui bolletta energetica rappre-
senta una voce rilevante nella propria strut-tura di costo. Fanno parte di questo gruppole aziende dotate di impianti produttivi neisettori della produzione industriale e dellatrasformazione (siderurgico, petrolchi-mico, costruzioni), le aziende con impor-tanti sedi direzionali caratterizzate datematiche di building management (grandiaziende, amministrazione pubblica), le im-prese dotate di reti commerciali di pro-prietà distribuite sul territorio caratterizzateda temi di facility management (grande di-stribuzione, reti di negozi, banche, logi-stica). Le principali esigenze di questestrutture sono di conoscere con precisionei profili di consumo per individuare trendanomali e consumi nascosti, e di gover-nare i processi per implementare politichedi efficienza e piani di intervento. Per rispondere a tutte queste esigenze, Nu-vola It Energreen offre una suite di servizi,le cui principali caratteristiche sono di se-guito sintetizzate:• Metering & Reporting:
infrastruttura di sensori dimisurazione per mappare lo stato
Il Gruppo Telecom Italia, operando in uncontesto, quello delle telecomunicazioni,caratterizzato da significativi consumi dienergia elettrica generati da una pluralitàdi siti operativi, ha da tempo affrontato iltema dell’efficienza energetica.L’obiettivo di contenimento dei consumienergetici ha portato Telecom Italia a spe-rimentare internamente l’utilizzo di reti wi-reless per il monitoraggio dei consumielettrici. Tale progetto si è evoluto in un si-stema completo di monitoraggio dei con-sumi nelle centrali telefoniche distribuitesul territorio nazionale. Dal progetto sperimentale, facendo leva sulknow-how acquisito e su una rete di partnercertificati, Telecom Italia ha anche sviluppatoun’offerta commerciale di servizi di EnergyManagement unica sul mercato, in grado disupportare le imprese di qualunque dimen-sione nel loro percorso verso un utilizzo piùconsapevole delle risorse energetiche.La volontà di intraprendere iniziative versouno sviluppo sostenibile si è oggi concre-tizzata in obblighi legali. Infatti, lo Stato ita-liano, anche al fine di ottemperare agliimpegni presi in sede internazionale, halegiferato introducendo norme e regola-menti per l’efficienza energetica negli usifinali. Ai sensi dell’articolo 19 dellalegge n. 10/91 tutti i soggetti consuma-tori di energia, pubblici o privati, per-sone fisiche o giuridiche, enti oassociazioni sono obbligati ogni annoa effettuare la nomina del tecnico re-sponsabile per la conservazione el’uso razionale dell’energia (energymanager), qualora i consumi ener-getici annui superino le seguentisoglie (espresse in TEP, Tonnel-late Equivalenti di Petrolio):
F O C U S
Telecontrollo e Automazione
RobertaCocchieri
Telecom Italia
La Nuvola Italiana. Il cloud computing di Telecom Italia.
NUVOLA IT ENERGREEN
L’ICT per l’efficienza energetica: la prospettiva di Telecom Italia

F O C U S Telecontrollo e Automazione 3/2011 41
dell’arte dell’efficienza energetica delcliente;
• Efficiency Strategy: servizi direportistica per permettere al cliente dicomprendere meglio i propri consumie valutare la portata dei risparmiraggiungibili;
• Audit Commerciale/EconomicsControl: consulenza commerciale percogliere le migliori offerte di mercato etenere sotto controllo la fatturazione;
• Audit Tecnico On-site: analisi on-site per determinare potenzialiinterventi di risparmio ed efficienzaenergetica;
• Special Projects: finalizzazionedell’audit on-site, prevede larealizzazione di interventi di efficienzaenergetica progettati ad hoc;
• Customer Social Responsability:servizi di consulenza sul tema dellasostenibilità ambientale.
Dal punto di vista tecnico la soluzione siarticola su tre livelli.
Il primo livello, dedicato al controllo e allagestione dell’infrastruttura fisica, è costi-tuito da un sistema di monitoraggio e aler-ting che, attraverso l’installazione di sensoriwireless di ultima generazione, garantiscela raccolta dei dati di ordine ambientale(temperatura, umidità e luminosità) e diconsumo energetico degli impianti, sullabase dei quali proporre politiche di rispar-mio energetico ad hoc. Il secondo livello è dedicato alla consulenzaremota, si realizza sulla base delle evidenzedai dati raccolti (siano essi di consumo che
di spesa connessa ai consumi) e consistein un servizio di Energy Management Re-moto per la gestione e l’analisi delle infor-mazioni, in modo da individuare aree diinefficienza, assicurando anche il controllodei costi associati alle forniture. Il terzo livello è costituito da un vero e pro-prio audit energetico con l’obiettivo di for-nire, attraverso analisi sul campo, unastrategia di intervento di medio-lungo pe-riodo, la definizione di una politica di effi-cienza energetica e la predisposizione diprogetti con tempi di pay-back (ROI) inlinea con gli obiettivi del cliente. L’impiego di sensori di nuova generazioneconsente di ridurre notevolmente i costi diinstallazione, rendendo la piattaforma fles-sibile e modulare. La soluzione Nuvola It Energreen, infatti,prevede l’impiego di sensori che, per laparte comunicazione, utilizzano il proto-collo radio ZigBee sulla banda non licen-ziata dei 2.4Ghz e trasmettono con unapotenza molto contenuta (10mW) pur co-
prendo aree che vanno dai 20/40 metri inambiente chiuso ai 100/200 metri in am-biente aperto.Dal punto di vista topologico le reti ZigBeeprevedono:• un concentratore che si occupa della
comunicazione bidirezionale tra ilcampo e la piattaforma di gestione;
• un insieme di ripetitori chegarantiscono la copertura dell’areaoggetto di monitoraggio;
• un insieme di nodi (sensori) cherilevano le misure.
FO
CU
STe
leco
ntro
llo e
Aut
omaz
ione
Le soluzioni basate su ZigBee presentanodelle interessanti caratteristiche. Unaspetto importante è che, essendo Zig-Bee una specifica aperta, i clienti pos-sono confidare in uno scenario futuro dimassima indipendenza. I protocolli Zig-Bee, inoltre, assicurano la possibilità dicreare reti mesh tra i ripetitori, contri-buendo alla costruzione di reti partico-larmente resilienti. Infine, i protocolliZigBee minimizzano il tempo di attivitàdel radiotrasmettitore: di conseguenzahanno un consumo energetico moltobasso e questo garantisce una lunga du-rata delle batterie (ove sono impiegate) ein generale è in linea con gli obiettivicomplessivi di efficienza energetica.I dati raccolti dai sensori vengono veico-lati con connettività fissa (xDSL), o mobile (GPRS), verso la piattaforma cen-tralizzata, installata presso i data centerTelecom Italia, che gestisce ed elabora idati attraverso strumenti evoluti di busi-ness intelligence e mette a disposizione
le informazioni ai clienti attraverso unportale web. Grazie alle sue caratteristiche Nuvola ItEnergreen è un’offerta unica sul mercato,capace di sposarsi sia alle esigenze deigrandi clienti, sia a quelle delle aziende didimensioni minori: le prime possono usu-fruire di un servizio distribuito sul territoriosenza le difficoltà e onerosità legate all’in-stallazione di un nuovo sistema, mentre leseconde hanno la possibilità di accederead un servizio Over-The-Top ad un costosostenibile.

gestione energia42
ME
RC
AT
O&
FIN
AN
ZA
La grid parity, vale a dire il punto in cui il costo diproduzione dell’energia solare è pari al costo diproduzione dell’energia generata da combustibili
fossili, rappresenta uno dei traguardi più critici per il set-tore del fotovoltaico e l’obiettivo verso il quale l’industriasolare continua a puntare sviluppando soluzioni innova-tive che rendano l’energia solare meno costosa. Oltre ai costi da sostenere per produrre energia fotovol-taica, la grid parity tiene conto anche di tutti gli investi-menti compiuti per generare una certa quantità dienergia. Tra i fattori da tenere in considerazione ci sonola produzione, la manodopera, il costo iniziale dei com-ponenti dell’impianto, l’installazione, la conduzione e lamanutenzione. Il progressivo avvicinamento alla grid parity si trova a do-vere affrontare alcune sfide, come la necessità di prolun-gare la vita utile e aumentare l’efficienza dei componentifotovoltaici, ad esempio celle, moduli e inverter, e di ri-durre il costo totale dell’impianto, in particolare i costi diproduzione, dei materiali e di manutenzione. In effetti, perriuscire a raggiungere una grid parity a livello mondialesenza contare su finanziamenti o incentivi statali, occorreridurre i costi complessivi degli impianti fotovoltaici. Grazie ai recenti sviluppi nel settore del fotovoltaico, laproduzione di pannelli solari è giunta ad una svolta nelrendere concreta la grid parity, un obiettivo verso il qualeattualmente tutti gli attori operanti nel settore della pro-duzione di energia solare si stanno piano piano dirigendo.Secondo le stime del National Renewable Energy Labo-ratory, considerato il ritmo sostenuto degli attuali sviluppinel settore del fotovoltaico, si dovrebbe raggiungere lagrid parity entro il 2017.
La domanda è: che cosa possiamo fare per tagliare icosti? La riduzione dei costi complessivi dell’impianto co-stituisce un passo avanti nel cammino che porta alla gridparity. Tenendo presente questo fattore, ho delineato treimportanti aree che i produttori dovrebbero prendere inconsiderazione per aumentare la redditività della produ-zione dei moduli solari.
I componenti dei moduliIl costo di un modulo rappresenta circa il 50-60%1 delcosto totale di installazione di un impianto solare, per-tanto il modulo solare e i relativi componenti costitui-scono elementi determinanti nel prezzo totaledell’installazione di un impianto solare. Il prezzo dell’ener-gia solare è in gran parte dettato dagli elevati costi deimateriali, che a prima vista sembrano ineliminabili. Esi-stono tuttavia dei modi per ridurre i costi complessivi eavvicinarsi sempre di più al raggiungimento della grid pa-rity. Sebbene i costi complessivi dei moduli comprendanonumerose e diverse variabili, anche elementi di pococonto come la scelta dei giunti angolari, possono influiresui costi complessivi di un modulo. Grazie ad un nuovo, fondamentale sviluppo oggi è pos-sibile sostituire materiali meno efficaci, impiegati in pas-sato, con materiali più performanti che permettono diottenere risultati in tempi più rapidi. Uno di questi mate-riali “intelligenti” è il nuovo sigillante schiumabile per cor-nici che richiede minori tempi di indurimento e riduce ilconsumo di materiale grazie a un minore spreco, con laconseguente riduzione dei costi e un maggiore rendi-mento rispetto ai sigillanti convenzionali. Per riuscire a tagliare i costi occorre operare un’attenta
Massimizzare la redditività nella produzione dei moduli solariGeoffrey King • Market Manager, Energia Rinnovabile - Saint-Gobain Solar

3/2011 43
MERCATO & FINANZA
selezione dei materiali e dei fornitori. Ad esempio, sce-gliere fornitori costantemente tesi ad individuare modi in-novativi per ridurre i costi, senza rinunciare a elevati livellidi prestazioni e durata nel tempo, è fondamentale per ot-tenere i risultati attesi. Anche riuscire a creare un modulo di alta qualità utiliz-zando un numero inferiore di componenti può rappre-sentare un ulteriore approccio per limitare i costi.Consideriamo l’esempio che segue nell’ottica di conte-nere il numero dei componenti: l’utilizzo di una lavora-zione che preveda una cornice monopezzo elimina inmodo efficace la necessità di tre dei quattro angolari dellacornice di un modulo. La cornice monopezzo viene av-volta attorno al modulo da robot, rendendo in questomodo superflui tutti gli angolari di fissaggio della cornice,tranne uno, e riducendo ulteriormente il costo dei mate-riali per ogni modulo.
Il processo di produzioneOltre ai componenti del modulo, anche il processo di pro-duzione rappresenta un fattore chiave da considerare perabbattere i costi. I costi della manodopera costituiscono una parte con-siderevole dei costi complessivi di un modulo e questoè uno dei motivi per cui l’attuale tendenza a ridurre icosti di manodopera ha promosso lo sviluppo dell’au-tomazione. L’automazione consente ai produttori di au-mentare l’efficienza della produzione riducendo i costicomplessivi. Per quanto un operaio possa essere ve-loce, l’automazione è in grado di superarlo sia perquanto riguarda la velocità di produzione, che la preci-sione. L’aumento della velocità è inevitabilmente colle-gato all’accrescimento della capacità produttiva.Nell’esempio dell’impianto con cornici monopezzo, siutilizzano i robot per eseguire l’applicazione delle corniciai moduli in tempi estremamente rapidi, dato che l’ope-razione richiede meno di 30 secondi per modulo. La maggiore efficienza produttiva fa aumentare la capa-cità produttiva, con un impatto sui costi complessivi. Ri-facendoci all’esempio del sigillante schiumabile per lecornici, la differenza tra materiali tradizionali e innovatividiviene evidente. I materiali adesivi tradizionali, come il si-licone, richiedono tempi di indurimento lunghi e bisognaattenderne l’assestamento. Per contro, i materiali intelli-genti ottengono gli stessi risultati in tempi ridotti. Anche allungando la vita utile dei materiali di consumosi influisce sui costi complessivi degli impianti a moduli.In questo caso, per ridurre i costi occorre ridurre al mi-nimo le soste della produzione e abbassare la fre-quenza di acquisto di nuovi materiali di consumo. Unesempio di come questo si possa attuare è rappresen-tato dalle membrane di silicone, che possono far ri-sparmiare i produttori nel processo di laminazione.Membrane più resistenti alla liberazione di gas dell’EVAdurante l’esposizione a calore intenso offrono ai pro-duttori possibilità di risparmio che si riflettono sui costicomplessivi. Dal momento che occorrono meno mem-brane nello stesso arco di tempo, cambia anche l’im-patto sulla logistica degli acquisti e sulle esigenze discorte. Inoltre le soste per la sostituzione delle mem-brane sono più intervallate. In genere occorrono da 4a 8 ore per sostituire una membrana, il che costituisce
un collo di bottiglia nel processo di laminazione; au-mentando il numero di cicli per membrana, i tempi diinattività del laminatoio si riducono in modo significa-tivo, così come i costi complessivi.
Installazione e manutenzioneNell’analisi dei costi degli impianti fotovoltaici non si de-vono sottovalutare i costi di installazione e manutenzione,in quanto possono incidere significativamente sul prezzocomplessivo degli impianti solari. Poiché la competenza e l’esperienza degli installatoripuò avere un effetto diretto sulla riduzione dei costi diinstallazione dei moduli, la manodopera incaricata del-l’installazione costituisce un elemento cruciale. È dun-que necessario che l’installazione degli impianti siaaffidata a operai qualificati, esperti e competenti, inmodo da ridurre i costi di manodopera e, allo stessotempo, contribuire a garantire la qualità e la sicurezzadegli impianti. Anche alcuni aspetti legati alla progettazione e alla pro-duzione dei prodotti possono aiutare a ridurre i costi diinstallazione dei moduli solari. Riducendo al minimo il nu-mero totale dei componenti nella configurazione di un impianto, ad esempio, se ne facilita il montaggio e l’ac-cessibilità, riducendo il tempo di installazione e le opera-zioni di manutenzione richieste. Il fattore manutenzione gioca anch’esso un ruolo signi-ficativo nel calcolo dei costi complessivi, in quanto lanecessità di un’unica ispezione di manutenzione al-l’anno può compensare il valore dell’energia prodottada piccoli impianti fotovoltaici su tetto. Questo aspettosottolinea la necessità di prodotti di alta qualità, datoche intrinsecamente una qualità più elevata richiedemeno riparazioni e minori investimenti di manutenzione.Un’altra soluzione possibile consiste nel migliorare leprestazioni globali dell’impianto massimizzando l’affida-bilità dei prodotti.
ConclusioniL’energia solare si è fatta strada come soluzione pratica-bile ai problemi posti dalla domanda di energia a livellomondiale, offrendo la possibilità di generare energia dauna fonte energetica immediatamente disponibile. Laprogettazione avanzata dei moduli fotovoltaici ha per-messo di raggiungere il traguardo fondamentale di ren-dere presto attuabile la grid parity. Negli ultimi cinque anni il costo dell’energia solare si è ri-dotto in modo significativo, ma sono necessari ulteriorimiglioramenti a livello di costi per raggiungere la grid pa-rity; in particolare, occorre attuare delle riduzioni dei costiper l’intero impianto fotovoltaico. In futuro verranno sviluppate ulteriori innovazioni nelcampo dei materiali e nuove soluzioni che consenti-ranno alle aziende di colmare la distanza che ancoraci separa dalla grid parity e infine portare l’energia so-lare allo stesso livello dell’energia prodotta da combu-stibili fossili.
1. Solarbuzz.com, novembre 2010.
NO
TA

gestione energia44
PO
LIT
ICH
E,
PR
OG
RA
MM
I, N
OR
MA
TIV
E
Parte il programma europeo LIFE plus per lo svi-luppo dell’innovativo progetto Clim-Wastener,volto a contrastare le cause dei cambiamenti cli-
matici legate all’inefficienza energetica nell’industriadello smaltimento dei rifiuti, grazie all’utilizzo del caloredi scarto per produrre elettricità “verde”.Il progetto Clim-Wastener è stato sviluppato grazie alcontributo di LIFE plus, programma di fondi dell’UnioneEuropea mirato alla formulazione e all’attuazione della po-litica e della legislazione comunitarie in materia ambien-tale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Dal 1992LIFE plus ha finanziato 3115 progetti, contribuendo a fi-nanziare 2 bilioni di Euro per la protezione del Pianeta.Il progetto da circa 2.5 milioni di Euro prevede la pro-gettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la divulgazionescientifica di un impianto integrato che consenta il re-cupero del calore di scarto proveniente da turbine ali-mentate a biogas e utilizzate per la produzione dienergia elettrica. Attualmente infatti la maggior parte delcalore prodotto da turbine o motori alimentati dal biogasottenuto dai rifiuti è disperso nell’ambiente o comunquepoco valorizzato, impedendo agli impianti di raggiun-gere valori di efficienza energetica superiori al 30%.Nello specifico, Clim-Wastener è volto a sviluppare un’ap-plicazione pilota basata su una macchina Organic Ran-kine Cycle (ORC) che operi congiuntamente all’interno diun impianto di cogenerazione situato presso una discaricanel sud della Francia. Questo intervento dovrebbe innal-zare la potenza prodotta dall’impianto di 125 kW da uti-
lizzare in loco, migliorandone l’efficienza elettrica fino oltreil 40%, il tutto con zero emissioni. L’impianto - già un mo-dello nel campo delle discariche in quanto realizzato con5 turbine a gas “oil free” per un 1MW di potenza che ga-rantiscono bassissime emissioni - grazie al nuovo sistemastabilirà un primato nell’efficienza del recupero energeticodai rifiuti e rappresenterà un esempio importantissimo diquanto può essere realizzato per ridurre l’impatto ambien-tale creato dagli scarti delle attività umane. La macchina a tecnologia ORC GE-Calnetix CleanCycle 125, grazie alla sua adattabilità funzionale anchea basse temperature, si è aggiudicata la gara pubblicaindetta con lo scopo di individuare il miglior prodotto adisposizione nel mercato per il tipo di sperimentazioneprevista nell’ambito di Clim-Wastener.Negli ultimi 5 anni è andato sempre più diffondendosil’acronimo “ORC” (Organic Rankine Cycle), riferito aspeciali turbine in grado di produrre energia elettrica uti-lizzando come energia primaria una qualsiasi fonte dicalore a “bassa” temperatura. La seconda parte delnome indica che si tratta di una tecnologia basata sul“Ciclo Rankine”: un particolare ciclo termodinamico,molto conosciuto, molto studiato e, soprattutto, moltodiffuso, dal momento che si realizza tipicamente nelleturbine a vapore che muovono i generatori delle centralitermoelettriche; tanto per dare un’idea, l’80% dell’ener-gia elettrica mondiale è prodotta da turbine a vapore.In queste applicazioni, un potente flusso di vapore adalta temperatura e pressione viene iniettato nella turbina,
Dai rifiuti un aiuto per combatterei cambiamenti climatici Parte il progetto di ricerca europeo Clim-WastenerLudovico Tosoratti • IBT EUROPE Business Development Manager; Lavinia Colonna Preti • IBT Group Marketing Manager

facendone muovere il rotore e ottenendo energia mec-canica. Ovviamente il vapore, per mantenere in rotazioneil rotore della turbina, perde energia, cioè si raffredda eperde pressione. Parliamo di “ciclo” termodinamico per-ché il vapore, una volta uscito dalla turbina, viene recu-perato, riscaldato, compresso, e, infine, nuovamenteiniettato nella turbina: secondo un ciclo, appunto.In questo processo c’è un importante passaggio inter-medio, che serve per aumentare il rendimento: ovverola condensazione del vapore all’uscita della turbina. In-fatti, poiché il lavoro di compressione fatto su un fluidoallo stato gassoso piuttosto che liquido è enorme, il va-pore che esce dalla turbina viene ulteriormente raffred-dato fino a trasformarlo in acqua liquida. Nella quasitotalità dei casi questo raffreddamento viene ottenutomediante torri evaporative. Con questo passaggio viene naturalmente persa un’im-portante quantità di energia, ma è ampiamente com-pensata dal risparmio di lavoro di pompaggio. L’acqua,quindi, viene compressa e successivamente riscaldatafino a trasformarla in vapore (per questo riscaldamentosi usano combustibili fossili o nucleari).Il “Ciclo Rankine Organico” è praticamente identico inprincipio a quello classico appena esposto, con la soladifferenza che il fluido di lavoro non è acqua, utilizzata neidue stati liquido e gassoso, ma è un fluido “basso bol-lente”, sempre utilizzato nei due stati liquido e gassoso.Tipicamente fluidi basso bollenti sono costituiti da com-posti molecolari organici (catene di Idrogeno e Carbo-nio), da cui il nome. Perché si è rivolta l’attenzione versoi fluidi organici? E perché solo recentemente, visto chei fluidi basso bollenti sono noti, prodotti e utilizzati dadecenni (per esempio nelle macchine frigorifere)?Per trovare la risposta dobbiamo considerare una fonda-mentale caratteristica del Ciclo Rankine: il suo rendimentoè tanto più elevato quanto più elevata è la temperaturamassima del fluido di lavoro; e viceversa, naturalmente.Per massimizzare il rendimento, quindi, scienziati e inge-
gneri hanno sviluppato sistemi in grado di funzionare atemperature sempre più alte: nel caso del Ciclo Rankinea vapore, prossime ai 600°C. Per contro, è stato trascu-rato lo sviluppo di sistemi a bassa temperatura e (quindi)poco efficienti: il risultato, ovvio, è che quantità immensedi energia termica a “bassa” temperatura (per intenderci:sotto i 300-400°C), prodotte da molti processi industriali,vengono semplicemente disperse nell’ambiante.Economicamente parlando, l’energia prodotta da un si-stema che sfrutta fonti di calore a bassa temperatura,non ripagava il costo dell’investimento. O meglio, nonfino a tempi molto recenti, in cui abbiamo assistito adun doppio scenario: da un lato il costo di energia elet-trica e di combustibili sempre più alto, dall’altro l’entratain vigore di direttive internazionali che impongono unariduzione della produzione di CO2 (o, il che è equiva-lente, il recupero quanto più completo possibile del-l’energia termica prodotta da qualsiasi processo).
POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE
3/2011 45

POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE
Oggi possiamo già trovare in commercio dei sistemi“ORC”, come quello Capstone, che utilizza come fluido dilavoro l’R245fa, che evapora a temperature molto basse,tanto che alla pressione di 15 bar e alla modesta tempe-ratura di 121°C lo possiamo trovare allo stato gassoso.Questa è la condizione a cui il fluido deve essere portatoprima di essere iniettato nel gruppo turbina-generatore.Il percorso seguito dal fluido di lavoro da questo mo-mento in poi è proprio il Ciclo Rankine: nel passaggioattraverso la turbina, l’R245fa si raffredda e perde pres-sione, uscendo alla temperatura di circa 63°C e allapressione di 1.8 bar. Queste condizioni garantiscono alfluido di essere ancora allo stato gassoso: se ci fosseroanche solo piccole gocce di liquido, infatti, queste dan-neggerebbero le palette della turbina.Come precedentemente spiegato, un passaggio obbli-gato per riportare il fluido di lavoro alla condizione dipressione e temperatura di immissione in turbina, èquello di condensarlo, e quindi comprimerlo mentre sitrova allo stato liquido. Per far sì che l’R245fa condensi,alla pressione di 1.8 bar, è sufficiente portarlo alla tem-peratura di 29°C, facilmente ottenibile mediante unapiccola torre evaporativa. Una volta allo stato liquido, losi può comprimere fino ai necessari 15 bar, con unasemplice pompa e una modesta spesa energetica.Raggiunta la pressione di 15 bar, quindi, “per chiudereil cerchio” basta solo riscaldare l’R245fa fino (almeno) a
121°C: per questo viene fatto passare prima attraversoil recuperatore (per “recuperare” quanto più calore pos-sibile dal fluido gassoso in uscita dalla turbina) e poi at-traverso l’evaporatore, il quale viene alimentato dallafonte di calore primaria.Come detto, la fonte di calore può essere di qualsiasitipo: gas (per esempio dallo scarico di motori endoter-mici, o da forni industriali), acqua calda (surriscaldata),vapore, etc.L’evaporatore, quindi, viene studiato e dimensionato adhoc in base alla fonte energetica disponibile.Del consorzio costituito per partecipare al progetto eu-ropeo fanno parte otto aziende pubbliche, private e nonprofit, tra cui: Verdesis S.A (Belgio) come capofila,EIFER (Germany), Environ Consultant Ltd (Gran Breta-gna), Verdesis Energie SAS (Francia), Getlini EKO LLC(Lettonia), Communauté d’Agglomération du Paysd’Aubagne et de l’Etoile (Francia), Pöyry Energie SAS(Francia) e la italiana IBT Group.Il progetto Clim-Wastener è iniziato nel gennaio 2010 esi concluderà nel dicembre 2012. Le varie fasi del pro-gramma comprendono lo sviluppo di un impianto pro-totipo, la sua messa in funzione per la fine del 2011 e lasuccessiva divulgazione scientifica dei risultati ottenutidalla sperimentazione nel corso dell’anno successivo,culminante con un evento mediatico che si terrà a metàdel 2012.
Massima potenza installata> EnviTec Biogas è la prima azienda del settore ad avere oltrepassato il traguardo dei 200 MW.
Gli impianti realizzati da EnviTec producono complessivamente, ogni anno, circa 1,75 miliardi di chilowattora di energia elettrica, corrispondente al consumo annuale di una grande città come Torino o Napoli
> E’ il leader tecnologico nel settore e uno dei principali fornitori di impianti a biogas del mondo
> Ha costruito a Penkun (Germania) uno dei più grandi parchi a biogas che produce 20 MWel per ora
> Ha costruito a Güstrow (Germania) l’impianto più grande del mondo per la produzione di biometano con una capacità termica allacciata di 55 MW
> Gestisce anche impianti a biogas di proprietà cooperando con partner dell’agricoltura e dell’industria
> E’ l’azienda con la crescita più veloce del settore di biogas in Italia
EnviTec Biogas Italia S.r.l.Via Bussolengo, 8c37066 Sommacampagna (VR)Tel: [email protected] www.envitec-biogas.it
Proget tazione, Realizzazione, Messa in esercizio, Gest ione, Assistenza
L‘impianto a Güstrow (Germania) che produce biogas in qualità di metano

EcoStruxureTM
l’architettura per la gestione attiva dell’energia
Nel momento in cui la comunità mon-diale si sta adoperando per rimediarenei prossimi 10 anni agli errori com-messi in ambito di CO2 negli ultimi 50,Schneider Electric ha una visionechiara della sfida energetica: c’è biso-gno di nuove soluzioni, nuove idee enuove imprese che aiutino ad otteneremigliori risultati riducendo al minimo iconsumi energetici.La risposta di Schneider Electric allesfide energetiche odierne è EcoStru-xure: un’architettura di gestione attivadell’energia in un’unica piattaforma.EcoStruxure che non è un prodotto,ma un approccio in grado di creare si-stemi intelligenti di gestione dell’ener-gia, permette la convergenza di cinquearee applicative: gestione dell’Energia,Processi e Macchine Industriali, Data-center, Edifici e Sicurezza.
Molte aziende con edifici caratterizzatida sistemi suddivisi sono obbligate asubire gli svantaggi derivanti dalla ge-stione di vari fornitori, la comunicazionesu reti diverse, l’attesa per processi dirisoluzione dei problemi complessi checomportano alti costi operativi e le dif-ficoltà nel raggiungimento dell’efficienzaenergetica: con EcoStruxure questonon accadrà più in quanto funzionacome una soluzione indipendente ingrado di fornire una compatibilità ga-rantita in differenti aree chiave di appli-cazione e sfruttare standard aperti siacon prodotti Schneider Electric che conprodotti di terze parti. EcoStruxureraccoglie vari sistemi autonomi e licombina in una soluzione integrata, ri-ducendo la ridondanza in dispositivi,software e personale. Unico approcciocompleto e integrato progettato per la
realtà dell’economia digitale, è scalabilee può essere applicato sia a ristruttu-razioni che a nuove costruzioni, rag-giungendo risparmi fino al 30% sucapitale e spese operative in tuttal’azienda, a partire da subito. Questosingolo sistema integra HVAC, alimen-tazione, illuminazione, distribuzioneelettrica, sicurezza, IT e telecomunica-zioni risultando più semplice da gestiree offrendo risparmi significativi non solodurante l’installazione ma anche lungotutto il ciclo di vita della struttura.Un’altra caratteristica dell’architetturaEcoStruxure è quella di offrire la pos-sibilità di controllare l’energia delle areedi applicazione chiave da una sola po-stazione. EcoStruxure supera i confinitradizionali dei software per la gestionedell’energia, rendendo possibile l’inte-grazione delle strategie aziendali.

gestione energia48
N E W S
Realizzati un milione di interventi di efficienza energetica in ediliziaI risultati di 4 anni di vita dello sgravio fiscale del 55% presentati dall’Enea
“In Italia il 35,2% dei consumi di ener-gia totale dipendono dal settore resi-denziale e, di questi, almeno il 70%sono relativi al riscaldamento. Oggi leabitazioni italiane consumano 120-150 kWh/m2 all’anno, un livello an-cora troppo alto, che tuttavia con leattuali tecnologie e con le dovute ac-cortezze costruttive, senza extra costi,potrebbe essere ridotto addirittura del50%” sostiene Giampaolo Valentini,U.T. Efficienza Energetica dell’Enea. Valentini, che lamenta le scarse risorsefinanziarie a disposizione dell’Enea pergestire al meglio le domande di interventidi efficienza energetica, ha comunquemesso in evidenza l’importanza dell’in-centivo in quattro anni di operatività:oltre 1 milione di interventi realizzati, conun picco nel 2010 (405 mila interventi);il 71% del totale quelli realizzati tra il 2009e il 2010.
Il decreto legislativo n.28/2011 pre-vede nuovi incentivi dal 2012 per l’ef-ficienza energetica e le rinnovabili, cheverranno determinati in base al valoreeconomico dell’energia prodotta o ri-sparmiata in edilizia e andranno conmolta probabilità a sostituire lo sgraviofiscale, che terminerà a fine 2011. Il fu-turo incentivo sarà tanto più elevatoquanto maggiore sarà efficiente l’inter-vento realizzato.Tra gli interventi più importanti in terminiquantitativi quelli relativi all’involucro(coibentazione) e per la sostituzionedegli infissi, mentre in termini di rispar-mio di energia la parte del leone l’annofatta gli interventi di sostituzione degliimpianti termici. Nel complesso, inLombardia, Veneto, Piemonte ed Emi-lia Romagna si è realizzato il 60% degliinterventi totali.L’Enea stima che il costo degli investi-
menti complessivi finora realizzati, datotuttavia ancora parziale, si aggirerebbeintorno agli 11,1 miliardi di euro, per unimporto relativo alla detrazione (cioèalle mancate entrate per le casse era-riali nei prossimi anni) pari a circa 6,1miliardi di euro. “Ma cosa possiamomettere come contropartita a questecifre?” si chiede Valentini. L’elenco è in-teressante: tra risparmi sulla bollettaenergetica nazionale, entrate per ilfisco per i prodotti e servizi realizzati,incremento del valore degli immobilipost interventi, i benefici economici siaggirano intorno ai 10 miliardi di euro,cioè ben 4 miliardi in più dei ‘costi’ perle detrazioni. A questi benefici nevanno aggiunti altri di più difficile quan-tificazione, come i minori costi collettiviper la CO2 risparmiata, lo sviluppo deltessuto produttivo e dell’occupazione,l’innovazione tecnologica, ecc.
Primo Forum Nazionale sulla Certificazione Energetica
Il CTI - Comitato Termotecnico Italianoe MCE - Mostra Convegno Expocom-fort hanno promosso nel giugnoscorso il Primo Forum Nazionale sullaCertificazione Energetica, svoltosi conil patrocinio del Ministero dello Svi-luppo Economico e del Coordina-mento Energia della Conferenza delleRegioni.Durante la manifestazione è stato pre-sentato il Primo rapporto nazionalesulla certificazione energetica in Italia,un dossier completo e dettagliato cheillustra come ogni Regione ha legife-rato sulla politica edilizia di risparmioenergetico. Il rapporto disegna una si-tuazione variegata, con aree dove ilpercorso legislativo è estremamenteavanzato e altre dove si è più indietro.Rimangono ancora irrisolti molti pro-blemi: dalla questione dei controlli al-l’accreditamento dei certificatori, finoai criteri stessi di certificazione.“L’obiettivo di questa manifestazione -ha spiegato Giovanni Riva, dell'Univer-sità Politecnica delle Marche e diret-
tore generale CTI - è quello di creareun punto di aggregazione comune frale Regioni in modo da favorire lo svi-luppo di una legislazione più coerente.Durante la due giorni si darà vita a unmomento di confronto tecnico sullosviluppo normativo e sullo stato del-l’arte della certificazione energeticadegli edifici in Italia”.Per Massimiliano Pierini, exhibition di-rector di MCE, “per la prima volta legi-slatori, tecnici e professionisti di tuttaItalia si confronteranno su uno dei set-tori cruciali per la politica economicaitaliana. L’edilizia, infatti, è responsa-bile, da sola, di oltre un terzo della bol-letta energetica italiana, dove un ruoloimportante per le prestazioni energeti-che è affidato al riscaldamento, al raf-freddamento e alle energie rinnovabilii comparti industriali al centro della no-stra manifestazione fieristica”.Il Forum ha affrontato sia argomenti diordine generale, che problematichespecifiche legate a settori particolari. Nelcorso della prima giornata è stato trat-
tato il tema della certificazione energe-tica in Italia e in Europa, con le proble-matiche da affrontare e le prospettive disviluppo. Nella seconda giornata sisono svolti quattro workshop di appro-fondimento che hanno toccato temispecifici come lo sviluppo della legisla-zione e della normativa tecnica a livellonazionale e regionale sulla base dellanuova direttiva europea EPBD2; gliaspetti legati alla formazione, all’accre-ditamento e ai controlli; la formazionetecnica delle diverse categorie profes-sionali coinvolte e infine quelli legati alletransazioni immobiliari e alle locazioni.L’evento ha visto convergere tutte leprincipali organizzazioni che si occu-pano di certificazione energetica, tra cuiMinistero dello Sviluppo Economico,Coordinamento delle Regioni, ComitatoTermotecnico Italiano, Comunità Euro-pea, Accredia; AICARR; Assotermica,Confedilizia; Enea; Federconsumatori,MCE; Politecnico di Torino; ProvinciaAutonoma di Bolzano; Renael; RSE;Università Politecnica delle Marche.

Aeroporti di Milano leadereuropei per la neutralità nelle emissioni di CO2Cresce la sensibilità ambientale. Il caso SEA dimo-stra come protezione dell’ambiente e competitivitàpossano davvero andare a braccetto. Il programmaper raggiungere l’efficienza nella riduzione delle emis-sioni di CO2, oltre a produrre un grande beneficioambientale, è risultato efficace anche sotto il profilodel risparmio dei costi energetici, con significativi ri-flessi sul conto economico. In particolare si è provveduto alla sostituzione di lam-pade interne e proiettori di 48 torri faro a Malpensa,all’introduzione di migliorie gestionali dell’illuminazioniattraverso un attento uso delle luci in relazione alledifferenti zone. Inoltre è stato presentato ad ENACun progetto, approvato, di spegnimento notturno diuna delle due piste. A livello della climatizzazione si è introdotta un’otti-mizzazione nella gestione degli im-pianti e, nell’otticadell’innovazione, è stata attivata un’attenta azione diaudit energetico complessivo per individuare contestie modalità di ulteriore miglioramento.L’attenzione verso una sostanziale riduzione delleemissioni coinvolgerà anche la progettazione dinuove infrastrutture. Un impegno a 360 gradi, in ot-tica LEED, Leadership in Energy and EnvironmentalDesign, che va dalla concezione progettuale, all’ado-zione di capitolati tecnici di costruzione che privile-gino materiali coerenti con l’azione strategicaambientale di SEA fino all’acquisto di beni e serviziattraverso gare e affidamenti che considerino pre-miante l’evoluzione sui temi ambientali del fornitoree l’aspetto emissivo tra quelli valutati nella scelta dibeni e servizi che debbono rispondere al requisito dibasso impatto CO2.Per quanto riguarda la mobilità e l’accessibilità del si-stema aeroportuale l’obiettivo è quello di incremen-tare la multi modalità con interventi di facilitazionedell’uso dei mezzi pubblici ai dipendenti, iniziative dicar sharing elettrico e di car pooling, miglioramentodei collegamenti ferroviari e della metropolitana non-ché interventi sulle attuali flotte bus navetta (pubblicie privati).Grazie a questi interventi, gli scali aeroportuali di Li-nate e Malpensa gestiti da SEA sono tra i primi in Eu-ropa nei quali è stato raggiunto il massimo livello diefficienza nella riduzione delle emissioni di CO2 inbase al programma Airport Carbon Accreditation,lanciato nel 2009 da ACI Europe (Associazione Inter-nazionale degli Aeroporti Europei).Linate e Malpensa hanno ottenuto nel 2010 la certi-ficazione al livello 3+ (neutralità), attraverso una co-stante e significativa riduzione delle emissioni dianidride carbonica e a una compensazione effettuatatramite l’acquisto di carbon credits, cioè certificati re-lativi a tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.

gestione energia50
N E W SD A L L E A Z I E N D E
Nuovo standard BS ISO 50001 per le aziende meno costi e meno CO2Il British Standard Institution (BSI) halanciato nel giugno scorso il primostandard riconosciuto a livello interna-zionale sul sistema di gestione del-l’energia, nato per aiutare le aziende amigliorare l’efficienza energetica e au-mentare la loro redditività grazie alla ri-duzione di CO2, favorire e creare lecondizioni più adeguate al cambia-mento climatico in continua evoluzione.Lo standard BS ISO 50001 aiuterà leaziende di qualsiasi dimensione ad im-plementare tutti i processi necessari acapire l’utilizzo dell’energia fino adoggi utilizzata, a mettere in atto pianidi azione, individuare gli indicatori dellaperformance energetica, indicare lepriorità e le opportunità per migliorarele prestazioni energetiche.La minaccia globale di carenza dienergia, le difficoltà di approvvigiona-mento energetico, l’aumento dei costie il proliferare di leggi per la riduzionedei gas serra, hanno portato alla crea-zione di questo standard. Con l’attua-zione della norma le aziende avrannola possibilità di ridurre fortemente i
costi e accrescere la loro reputazionee visibilità dimostrando il loro impegnoper il miglioramento della sostenibilità.La ISO 50001 è stata redatta sullabase della BS EN 16001, pertantoanche al ritiro di quest’ultima, previstoentro la metà del 2012, le aziende chehanno già implementato un sistema digestione per l’energia, non avrannonessuna difficoltà ad allinearsi ai requi-siti della nuova norma. A questo proposito, un caso eloquentearriva proprio dal nostro Paese, dove laCimberio spa, azienda storica produt-trice di valvole, è stata una delle primeal mondo ad ottenere la certificazioneBS ISO 50001. Roberto Cimberio, a.d.dell’azienda dichiara: “Tutti noi in Cim-berio siamo orgogliosi di quanto stasuccedendo: ricevere questa certifica-zione è un traguardo importante chepremia il nostro modo di fare e di essereazienda. Stiamo scoprendo e apprez-zando la ISO50001 come una certifica-zione concreta e funzionale, che trovaimmediato riscontro all'interno del-l'azienda: non solo un pezzo di carta,
non solo un traguardo raggiunto, ma unmodo diverso di lavorare”.Il Director of Standards di BSI, MikeLow, afferma: “ BS ISO 50001 è unostandard innovativo che comporterà unaumento di competitività e un forte in-cremento del business per tutte quelleaziende a livello mondiale che devonoaffrontare crescenti costi energetici euna legislazione in materia di cambia-menti climatici in continua evoluzione.La norma stabilisce in modo chiaro iprocessi e le azioni che posso permet-tere a qualsiasi azienda di cominciare aridurre i costi immediatamente, graziead un pacchetto completo offerto daBSI comprensivo di pubblicazioni, corsidi formazione, certificazione, softwaree la certificazione Kitemark per la veri-fica della riduzione del consumo ener-getico, per aiutare i nostri clienti adottenere in tempi rapidi tutti questi im-portanti benefici.BS ISO 50001 è applicabile a tutti i tipidi organizzazione, indipendentementedalle condizioni geografiche, culturalio sociali.
Siemens mette in funzione i primi prototipi della nuova turbina eolica da 6 MWIl Settore Energy di Siemens ha iniziato la fase di test del suoprototipo di turbina eolica offshore di ultima generazione SWT-6.0-120 a Høvsøre, in Danimarca. La nuova turbina ha una capacità di 6 MW e un diametro del rotore di 120 metri.
La nuova SWT-6.0-120 è la terza tur-bina senza moltiplicatore di giri pro-dotta da Siemens. Attualmente in fasedi collaudo e verifica delle perfor-mance, verrà immessa sul mercato nelprossimo futuro. “A differenza dellealtre turbine di grandi dimensioni, ingenere più pesanti, la SWT-6.0-120 haun peso per megawatt assai ridotto,simile a quello della maggior partedegli aerogeneratori da 2 e 3 MW” hadichiarato Henrik Stiesdal, chief te-
chnology officer della Divisione WindPower Business di Siemens. Il peso ridotto della nuova SWT-6.0-120 non solo renderà possibile una di-minuzione significativa dei costidell’energia prodotta dagli impianti off-shore, ma avrà un impatto positivoanche sui costi della turbina stessa,della torre e delle strutture di supporto.“Abbiamo sviluppato la SWT-6.0-120specificamente per i progetti offshoredel futuro. Grazie alla tecnologia Direct


gestione energia52
N E W SD A L L E A Z I E N D E
Drive di Siemens la turbina ha un de-sign semplice e intelligente che ci hapermesso di ridurre il numero di partimobili. Prevediamo che la SWT-6.0-120 sarà in grado di definire nuovistandard in termini di performance, ro-bustezza e ottimizzazione della manu-tenzione, aspetti cruciali soprattutto seconsiderate le condizioni estremedell’offshore” ha aggiunto Stiesdal. La nuova SWT-6.0-120 fa uso di nu-merose tecnologie chiave già ampia-mente testate sulla turbina offshore diSiemens da 3,6 MW. Un esempio è lapala B58, che verrà utilizzata nellaprima serie della nuova turbina da 6MW. Un’altra delle tecnologie utilizzateè il processo brevettato IntegralBlade,che ha il vantaggio di non richiederel’utilizzo di alcun tipo di colla nellegiunzioni tra le varie parti. La nuova turbina Siemens, progettataper agevolare i lavori di service e ma-nutenzione, dispone di una piatta-
forma d’atterraggio per elicotteri sulretro della navicella che consente unaccesso facile e sicuro ai tecnici di ser-vice. Inoltre si caratterizza per i suoi si-stemi di diagnostica d’avanguardiache, oltre a ridurre i rischi per il cliente,garantiscono livelli massimi di affidabi-lità e disponibilità. Il primo prototipo da 6 MW dovrà orasottoporsi a un periodo intensivo diprova e di messa in servizio prima diessere rilasciata in forma definitiva sulmercato. Siemens installerà nel corsodel 2011 altri prototipi di SWT-6.0-120per ulteriori test e verifiche e tra il 2012e il 2013 le turbine di pre-serie per lasuccessiva fase di collaudo e ottimiz-zazione delle performance. La produ-zione seriale è prevista per il 2014. Negli ultimi 20 anni, l’azienda ha instal-lato con successo più di 600 turbineeoliche offshore, con una capacitàcomplessiva di oltre 1.800 MW neimari europei. Con ordini assicurati di
nuovi progetti offshore, per un totale dicirca 3.600 MW, Siemens consolideràulteriormente la sua posizione di lea-der di mercato in questo settore.L’energia elettrica prodotta dagli im-pianti eolici offshore contribuirà a ren-dere il mix energetico sempre piùpulito e sostenibile.L’energia eolica è parte integrante delportfolio ambientale di Siemens.Nell’anno fiscale 2010 il fatturato de-rivante da tale portfolio ha registratoun totale di circa 28 miliardi di euro,attestando Siemens quale primo for-nitore al mondo nell’offerta di tecno-logie ecofriendly. Considerando lostesso periodo, i prodotti e le solu-zioni Siemens hanno permesso aiclienti di ridurre le proprie emissioni diCO2 di 270 milioni di tonnellate, unacifra che corrisponde alla sommadelle emissioni annuali di Hong Kong,Londra, New York, Tokyo, Delhi e Sin-gapore.
REpower e juwi, accordo quadro per la fornitura di 240 turbine
REpower Systems AG - aziende leadernell’ambito della produzione di turbineeoliche onshore e offshore - e juwiGroup hanno siglato un accordo qua-dro per la consegna, l’installazione e lamanutenzione di 240 turbine eoliche.La fornitura riguarderà per la maggiorparte le macchine da 3 MW, per una
potenza complessiva di 720 MW. L’accordo rappresenta ad oggi la mag-giore commessa europea onshore perREpower. Il piano di juwi, azienda eu-ropea leader nella produzione di ener-gia rinnovabile, prevede l’istallazione di180 turbine in Germania e 60 in altrenazioni europee. La fornitura da parte
di Repower interesserà prevalente-mente i modelli 3.4M104 e 3.2M114(con altezze mozzo comprese tra 123e 143 metri), ma anche turbine dellaserie MM da 2 MW. Le macchine saranno fornite a partiredalla seconda metà del 2011 fino allafine del 2014.
La gamma EDI gode del premio del 10% su tariffa incentivanteLa famiglia di inverter progettata da Reverberi Enetec consente l’accesso alle tariffe più remunerative previste dal nuovo Conto Energia
Dal 1 giugno 2011 la gamma degli in-verter EDI di Reverberi Enetec è pre-sente nel ”elenco dei dispositivicollegabili alla rete BT” di Enel e quindiEDI può essere a tutti gli effetti utilizzatoper gli impianti fotovoltaici in rete e ac-cedere agli incentivi del Conto Energia.In particolare la famiglia EDI, essendoprogettata e realizzata interamente inItalia, consente di contribuire all’ac-cesso a tariffe più remunerative previ-ste dal nuovo Conto Energia (il IV)
attivo attraverso il DM del 5 maggio2011. Il IV Conto Energia ha infatti in-trodotto la novità di un incrementodella tariffa “del 10% per gli impianti ilcui costo di investimento […] perquanto riguarda i componenti diversidal lavoro, sia per non meno del 60%riconducibile ad una produzione realiz-zata all'interno della Unione Europea”.Questo significa che scegliendo lagamma EDI sarà possibile risparmiareenergia e godere di un premio aggiun-
tivo grazie ai meccanismi di incentiva-zione per il fotovoltaico promossi dal IVConto Energia. Dall’esperienza della Di-visione Fotovoltaica di Reverberi Enetece dall’attenzione alle esigenze di instal-latori e utilizzatori è nata dunque una fa-miglia di inverter per la produzione dienergia da fonte fotovoltaica che unisceil massimo risparmio all’efficienza, inte-grabilità e praticità di una gamma diprodotti con peso e dimensioni ridotti eun design innovativo e accattivante.


gestione energia54
Autorità per l’energia elettrica e il gasDelibera ARG/gas 116/11http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/116-11arg.htmProcedure a evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza per ilperiodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 e modifica dell’Allegato A alla deliberazione28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata.
Delibera ARG/gas 114/11 http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/114-11arg.htmApprovazione delle opzioni tariffarie, per il servizio di distribuzione e misura di gas di-versi dal gas naturale, a mezzo di reti canalizzate, per gli anni 2010 e 2011, per leimprese elencate nelle tabelle 6a e 6b della deliberazione dell’Autorità per l’energiaelettrica e il gas 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10.
Delibera ARG/elt 111/11 http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/111-11arg.htmDeterminazione dei crediti spettanti, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’ar-ticolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti diimpianto riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, letteram), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che non hanno ricevuto quote diemissione di CO2 a titolo gratuito.
Chiarimenti applicativi della scheda 25ahttp://www.autorita.energia.it/it/comunicati/11/scheda25a.htmLe condizioni di applicabilità della scheda tecnica n. 25a inerenti la percentuale disconto o il prezzo minimo da applicare alla vendita dei dispositivi possono ritenersisoddisfatte anche laddove questa avvenga con modalità diverse dal pagamento diun esplicito corrispettivo in denaro, purché tali modalità alternative possano garantirecon altrettanta certezza che il cliente partecipante sia consapevole dell'esatto valoreeconomico dell'oggetto.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70www.gazzettaufficiale.itTesto del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale- n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011,n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia.». (11A09517) (GU n. 160 del 12-7-2011.
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93 www.gazzettaufficiale.itAttuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme co-muni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura co-munitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energiaelettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136).
06 nov 2011key EnergyRiminiInfo: www.keyenergy.it
10-12 nov 2011Clima ExpoRomaInfo: [email protected]
10-12 nov 2011Termo Roma Roma, RomaInfo: www.termo-roma.it
16-19 nov 2011Greenenergy 2011 MilanoInfo: www.greenenergyexpo.eu
16-19 novembreEcolife Biella BiellaInfo: www.ecolife-expo.com/biella/
16-19 novembreRottamazione degli impianti elettrici Milano Info: http://www.rottamazioneimpiantielettrici.it/
17-19 nov 2011Windtech - Offshore Conference & Wind EnergyTrade Fair Istanbul - TurchiaInfo: www.windtech-istanbul.com
27 30 mar 2012MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORTMilanoInfo: www.mcexpocomfort.it
Seminario FIRE “La presentazione di progetti perl'ottenimento dei certificati bianchi”Roma, 1-2 dicembre Info su: www.fire-italia.org
Corsi per Energy Manager FIRE-ENEA(durata 5 giorni) MULTISETTORIALE (Civile-Pubblica Amministrazione-Professionisti)Lamezia Terme, 14-18 novembrePer informazioni: Maurizio Musiani - ENEA Via Martiri di Monte Sole 4 40129 BolognaTel: 051.6098479 - Fax: 051.6098702 E-mail: [email protected]
Corso e Quem blended in Energy ManagementRoma, 21-25 novembre Info su: www.e-quem.enea.it
ENERMANAGEMENT 2011: Workshop Bologna, 22 novembre www.enermanagement.com
Al via Energy Efficiency Award 2011Parte la quarta edizione di Energy Efficiency Award, il riconoscimentoche ABB Italia dedica alle aziende che hanno scelto di investire consuccesso in efficienza energetica conseguendo risultati concreti intermini di risparmi e di riduzione delle emissioni di CO2. I parametriutilizzati nell’aggiudicazione del Premio, considerano sia i risparmieconomici che la riduzione delle emissioni di CO2. Ad aggiudicare ilPremio, sarà una Giuria composta da rappresentanti di ENEA, FIRE,WEC, Politecnico di Milano e RSE. L’adesione a Energy EfficiencyAward avviene attraverso la piattaforma online ABB. Compilazionedella scheda di adesione entro il 30 settembre 2011.
Campus per l’EnergiaSAVE THE DATE 6-7 Ottobre Campus per l’Energia 2011.“Efficienza energetica negli edifici - Impegno delle Amministrazioni Locali: strategie, obiettivi e strumenti (BER- BurdenSharing…)”. Con questa rinnovata iniziativa l’ENEA, insieme al MSE, offre alle P.A. Regionali e Locali, l’opportunità diun aggiornamento e confronto sugli aspetti tecnici, normativi ed economici mirati alla tempestiva attuazione deiprovvedimenti nazionali in tema di efficienza energetica. L’iscrizione gratuita è limitata ad un massimo di 80 adesioni.Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito http://www.enea.it/eventi2011/CampusEnergia o il numero 06 36.00.25.43
A P P U N T A M E N T I N O R M A T I V A

seguici su
carm
ieu
bert
is
usseguici
FIRENZEDIIACVINROP

Le risposte ai Soci
Cosa offriamo
Un sito web (www.fire-italia.it) dedicato ai diversi aspetti del set-tore dell’energia, che permette di averne una visione completa dalpunto di vista normativo e tecnico.
Per i soci è previsto un servizio di consulenza on-line e telefonicache permette di avere il parere dei nostri esperti.
La possibilità di richiedere consulenze, studi di fattibilità e monitoraggio normativo a richiesta.
L’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, di convegni e di incontri su temi diinteresse comune.
La rivista trimestrale “Gestione Energia” e le pubblicazioni FIRE.
gestione energia56
Nel nuovo regolamento del IV conto energia, alpunto 3.3, si parla di soggetti finanziabili per gli im-
pianti fotovoltaici ad alta concentrazione. Una personafisica titolare di azienda agricola e di partita IVA puòessere considerata soggetto finanziabile?
Il quarto conto energia prevede l’accesso alle ta-riffe relative agli impianti a concentrazione solo alle
persone giuridiche e ai soggetti pubblici.Le aziende agricole che non hanno personalità giuri-dica, ossia le partite IVA, non sono ammesse all’incen-tivo per gli impianti a concentrazione; la ragione diquesta esclusione potrebbe essere legata all’innovati-vità di questi dispositivi (si tutela in tal modo il largopubblico da possibili problemi legati a tecnologie nonancora consolidate).Una possibilità potrebbe essere quella di creare unasocietà di scopo (lo svantaggio sarebbe la perdita deivantaggi sul reddito agrario) o, in alternativa, an-drebbe valutata la possibilità di passare dalla partitaIVA a una forma societaria, ma va valutato se esistonovincoli al riguardo.
È possibile presentare progetti per l’ottenimento deiTitoli di Efficienza Energetica relativi ad interventi ese-
guiti nei semestri precedenti a quello di riferimento?
All’interno di ciascuna metodologia di valutazionepuò conteggiare anche i risparmi derivanti dagli inter-
venti degli anni precedenti, purché non abbia raggiuntola dimensione minima prima del semestre di riferimentoper la presentazione del progetto. Qualora avesse rag-giunto la soglia nei semestri precedenti, dovrebbe ri-nunciare agli interventi più vecchi, in modo che quellirealizzati prima del semestre sopracitato rimanganosotto le soglie minime previste dalle linee guida.
Sono un certificatore energetico, un cliente mi hachiesto di ricoprire l’incarico di energy manager per la
sua azienda. Come posso inoltrare la richiesta di inseri-mento nell’elenco?La formazione come si svolge ?
La nomina dell’energy manager deve essere effet-tuata entro il 30 aprile di ogni anno utilizzando il mo-
dulo disponibile sul sito FIRE (non serve la cartaintestata dell’azienda nominante). La FIRE, su incaricodel Ministero dell’Industria, ora MSE, una volta archiviatetutte le nomine provvede alla pubblicazione di un elencodei soggetti che hanno effettuato la comunicazione del-l’energy manager (circolare esplicativa MICA n.226 del1993 paragrafo 19). Nella sezione "legislazione" del sitoweb della Federazione trova tutta legislazione di riferi-mento: http://em.fire-italia.org/legislazione.htmlRelativamente alla formazione, l’ENEA, in collabora-zione con la FIRE, organizza dei corsi per energy ma-nager della durata di cinque giorni. Trova tutte leinformazioni al seguente link: http://timesheet.bolo-gna.enea.it/corsi_energia
D
D
R
R
D
R


L’unico watt sostenibile è il negawatt
A causa delle inevitabili dispersioni lungo la linea, 33 unità di energia al punto di consumo richiedono 100 unità di energia primaria
©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Efficient Enterprise, and EcoStruxure: Active Energy Management Architecture from Power Plant to Plug are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 35 rue Joseph Monier, CS 30323, 95506 Rueil Malmaison Cedex (Francia) 998-3259_IT*Fonte: World Energy Outlook 2009, IEA/OECD
Cos’è il negawatt? Semplice, è il watt che non avete utilizzato.
Visitate il sito Web all’indirizzo www.SEreply.com Codice chiave 93055t oppure chiamate il N. Verde 800 563 266
Scoprite di più sulla gestione efficiente dell’energia Scaricate il White Paper GRATUITO "Growing a Green Corporation"
Risparmio energetico, sinomino di risparmio economicoL'avvento della "rete elettrica intelligente" (smart grid) è ormai alle porte: stiamo lavorando attivamente all'integrazione di intelligenza e innovazione nelle nostre soluzioni in modo che la "rete intelligente" possa presto diventare realtà. E pensando alle reti intelligenti del futuro, dobbiamo fin d'ora disporre di una soluzione che ci consenta di risparmiare energia e di utilizzarla in modo efficiente. EcoStruxure: l’Architettura per la gestione attiva dell’energia, dalla centrale alla presa elettrica™EcoStruxure di Schneider Electric™ è in grado di ridurre l'utilizzo di energia fino al 30%, realizzando al tempo stesso risparmi su investimenti e costi operativi. L'efficienza nell’utilizzo finale dell'energia è l'obiettivo che intendiamo conseguire! La percentuale di fatturato che le aziende spendono per l'acquisto di energia elettrica potrebbe raggiungere il 30% entro il 2020. Esiste inoltre la necessità impellente di ridurre le emissioni di CO2, in conseguenza dell'aumento della domanda di energia. La gestione energetica è la chiave di volta del problema: rappresenta la soluzione più rapida ed efficace in grado di limitare le emissioni di gas a effetto serra, migliorando al tempo stesso le prestazioni aziendali. Infatti, entro il 2030, l'efficienza energetica e il cambiamento di approccio all'utilizzo dell'energia costituiranno due elementi in grado di ridurre maggiormente le emissioni di CO2 rispetto all'energia eolica e solare e a tutti i metodi di generazione di energia alternativa combinati insieme.*
Le soluzioni EcoStruxure consentono da subito una riduzione dei costi Poiché il prezzo dell'energia è in continuo aumento, è più che mai comprensibile il valore di ogni singola unità di energia risparmiata. A ogni unità risparmiata al punto di consumo, infatti, corrispondono tre unità di energia primaria. Oggi l'architettura EcoStruxure Active Energy Management è in grado di offrire un risparmio energetico fino al 30% in edifici, impianti industriali e data center. La vostra azienda merita una soluzione Efficient Enterprise™!
30% 30%30%
Estrazione Generazione Trasmissione Punto di consumo
100 unità di energia 35 unità di energia 33 unità di energia