Fotocerchi2002-2008
-
Upload
alberto-missana -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Fotocerchi2002-2008
2
FOTOCERCHI 2002 – 2008 INDICE PREMESSA 2
CAP 1 I FOTOCERCHI
1.1 COSA SONO I FOTOCERCHI 4
1.2 PERCHE’ SONO NATI I FOTOCERCHI 4
1.3 IL CERCHIO NON ESISTE, GUARDA IL CERCHIO 8
1.4 LA DIAGONALE NON ESISTE, GUARDA LA DIAGONALE 10
1.5 IL CERCHIO NELLA CULTURA OIRENTALE 12
1.6 IL CERCHIO NEL MONDO OCCIDENTALE 14
1.7 GEOMETRIA DELLA STRUTTURA 16
1.8 L’EFFETTO PROIETTILE 18
CAP 2 FOTOCERCHI 2002 - 2007
2.1 “LA” FOTOGRAFIA 20
2.2 IL CONTRAPPASSO DANTESCO 20
2.3 STUPORE 28
2.4 ISTANTANEE 34
CAP 3 FOTOCERCHI 2008
3.1 LE MULTIFOTO 40
3.2 IL CRITERIO UTILIZZATO PER DEFINIRE LA NUMEROSITA' DELLE MULTIFOTO 40
BIBLIOGRAFIA 48
3
PREMESSA Queste pagine nascono dalla volontà di condividere il percorso creativo che mi ha portato a scattare la serie di fotografie chiamata Fotocerchi, in modo da permettere alle persone interessate alle “Fotografie con Cerchio e Diagonale” di conoscere in maniera approfondita e completa le regole e le caratteristiche che hanno reso possibile la realizzazione delle immagini presentate.
5
I FOTOCERCHI
1.1 COSA SONO I FOTOCERCHI I Fotocerchi sono un insieme di fotografie con una caratteristica che le accomuna: tutte le immagini insistono sul medesimo layout grafico composto da un cerchio presente nel quadrante in alto a destra e da un altro elemento grafico che suggerisce in maniera più o meno definita la diagonale che taglia l'immagine dall'angolo in basso a sinistra verso quello in alto a destra.
1.2 PERCHE' SONO NATI I FOTOCERCHI
“Modelliamo la creta in un vaso, ma è il vuoto all’interno che contiene tutto ciò che vogliamo”
Lao Tzu Il progetto Fotocerchi parla del Vuoto inteso come essenza delle cose e non come assenza di sostanza. Per chiarire il concetto prenderò in prestito le parole dello storico della fotografia Diego Mormorio dal suo libro “Meditazione e Fotografia”: “La vita è un continuo manifestarsi della forma e del tempo. Ad ogni istante le cose maturano un nuovo aspetto e danno al tempo la forma di una catena infinita.
Nessuna cosa vive per essere sempre uguale a se stessa: tutto cambia continuamente, senza inabissarsi nel nulla, ma solo mutando. Per evidenziare questa continua mutazione delle cose, il maestro zen Thich Nhat Hanh ha fatto un bellissimo esempio. Ha detto:
Se chiedi ad una nuvola “Che età hai? Puoi dirmi quando sei nata?”, con l'ascolto profondo forse sentirai la sua risposta. Puoi immaginare la nascita della nuvola: prima di nascere era l'acqua dell'oceano, oppure era fiume, poi è diventata vapore. Era anche il sole, perché è il sole a produrre vapore. Poi c'era anche il vento che ha aiutato l'acqua a diventare nuvola. La nuvola non viene fuori dal nulla. Si è verificato un cambio di forma, ecco tutto. Non è nata dal nulla. Prima o poi la nuvola si trasforma in pioggia o in neve o in ghiaccio. Se osservi a fondo la pioggia puoi vedervi la nuvola. La nuvola non è andata persa: si è trasformata in pioggia e la pioggia si è trasformata in erba e l'erba in mucche e poi nel gelato che stai mangiando. Se oggi mangerai un gelato, datti il tempo di guardarlo e di dirgli: 'Ciao, nuvola, ti riconosco'. In questo modo raggiungerai la comprensione profonda della vera natura del gelato e della nuvola. Nel gelato puoi vedere anche il mare, il calore, il sole, l'erba e la mucca.
La nuvola non è andata persa, dunque. Si è trasformata. A questa consapevolezza, cui la sapienza orientale è pervenuta da molto tempo, è giunta anche la scienza occidenale,
7
nella cosidetta “legge di conservazione della materia”, formulata dal grande chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier, nel suo Trattato di Chimica Elementare (pubblicato nel 1789), normalmente così riassunta: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Comprendendo questo, si può comprendere anche l'affermazione di Dogen-Zenji: “Anche se è mezzanotte, l'alba è qui; anche se viene l'alba, è notte”. Questa continua trasformazione delle cose viene in sanscrito detta Sunyata e tradotta col termine vacuità – dal latino vacuus, vuoto. Tutte le cose sono nella loro intima essenza vacue, vuote: non nel senso che sono mere apparenze, ma per il fatto che esistono, e possono esistere, solo in relazione ad altre cose.” E ancora dallo stesso libro: “La forma è vacuità, la vacuità è forma. E in quanto arte dell'attimo per eccellenza, la fotografia può essere chiamata arte dell'evidenziazione della forma e della ricerca della vacuità. Unendo la meditazione alla fotografia, noi possiamo oltrepassare la natura “materiale” di quest'ultima e trasformarla in un occhio “spirituale”. L'apparecchio fotografico può infatti, forse meglio di ogni altro strumento, aiutarci a percepire la vera natura della realtà. Il vuoto. Bisogna tenerlo costantemente presente: il vuoto non è il nulla, ma l'interdipendenza dei fenomeni.
Ho voluto usare le parole di Diego Mormorio perchè ha saputo rendere in poche righe un concetto che riflette in toto il percorso creativo che si vuole sviluppare con il progetto fotografico Fotocerchi. Il punto di partenza e di arrivo è il Vuoto, si parte dalla volontà di rendere esplicito il processo stesso di fotografare il Vuoto per arrivare a creare una serie di immagini che ci lasciano ammirare le mille sostanze del Vuoto e infine il Vuoto stesso.
9
IL CERCHIO NON ESISTE, GUARDA IL CERCHIO Veniamo ora a definire quali siano gli strumenti utilizzati per la “Fotografia del Vuoto”. Cerchio e linea (diagonale) sono due concetti che appartengono alla geometria euclidea, citiamo le definizioni: Cerchio: luogo geometrico i cui punti hanno una distanza da un punto detto centro, minore o uguale ad un segmento detto raggio. Linea: la linea è definita da Euclide nei suoi Elementi come concetto primitivo, si rinuncia ad una sua definizione in quanto è pressochè impossibile darne una definizione senza usare sinonimi della linea stessa. Ma già nell'antica Grecia Platone descrive la diferenza tra il concetto astratto espresso nella definizione e ciò che riscontriamo nella realtà tangibile: "Platone porta l'esempio delle figure geometriche, dei solidi platonici da lui stesso scoperti e dei triangoli e cerchi. In natura non esiste un cerchio o un quadrato perfetto, che pur ogni individuo conosce, calcolandone area e perimetro. Questa capacità è dovuta al fatto che l'intelletto vede al di là del sensibile un'idea di cerchio e quadrato
che non è nella realtà fuori di noi." (2) Questi elementi sono parte intrinseca del mondo ma non sono sperimentabili o misurabili, in quanto il cerchio perfetto o la retta ideale non è misurabile; eppure l'intelletto umano li identifica e li riconosce negli oggetti intorno a sè. Se applichiamo ora queste affermazioni al concetto di Vuoto esse restano valide: l'Illuminato lo vede negli oggetti quotidiani come intrinseco agli oggetti stessi ma non può misurarlo e, come le linea, non può nemmeno definirlo. Se la linea si avvicina al Vuoto nella sua indefinibilità, il cerchio assume simbolicamente la rappresentazione del concetto di Vuoto. Mentre il Cerchio rappresenta nella cultura orientale il Vuoto come lo abbiamo descritto sino ad ora, nella cultura occidentale un concetto ad esso assimilabile non è contemplato, ma comunque il cerchio identifica il concetto occidentale di vuoto. Rimane quindi un simbolo per avvicinarsi al concetto.
11
LA DIAGONALE NON ESISTE, GUARDA LA DIAGONALE Anche se la linea non viene esplicitamente definita da Euclide, per identificarla univocamente bisogna dichiarare una direzione, che è comune a tutte le rette tra loro parallele, e fissare un punto attraverso cui la retta deve passare. La diagonale, come viene intesa in questo contesto è una direzione, un angolo di 37° che attraversa l'immagine; si introduce l'idea di “diagonalità”, rispettando questo angolo con un elemento che può appartenere allo sfondo o diventare parte integrante della composizione inserendolo dall'angolo in basso a sinistra verso l'angolo in alto a destra. La diagonale è solitamente ben riconoscibile, ma l'angolo può essere suggerito in molti modi: talvolta è definito dalla forza di gravità terrestre come nelle foto in cui i palazzi sono inclinati, in altri casi sono tutte le linee dello sfondo oppure, se le linee convergono al cerchio, una passa per l'angolo in basso a sinistra. Dopo aver guardato alcuni Fotocerchi è facile riconoscere il cerchio, mentre la diagonale rimane meno evidente, è un particolare da ricercare con più
attenzione; ma talvolta la diagonale sembra essere assente. Gli occhi scorrono l'immagine ma, ad esempio, l'unico soggetto è il cerchio su fondo nero. In un istante lo sguardo dello spettatore si muove dal cerchio verso angolo in basso a sinistra, la diagonale non è raffigurata ma l'atto stesso di cercarla implica che essa esiste negli occhi dello spettatore. Per confermare quest'ultima affermazione si segua l'esempio nella pagina a lato. Nella prima fotografia il cerchio e la diagonale sono espliciti, nella seconda è meno evidente, nella terza è scomparsa, ma la foto è ancora coerente con le precedenti; la quarta è sbagliata, la linea ha una diversa inclinazione ed in questo caso la diagonale non c'è perchè lo sguardo che la cerca viene deviato e distratto da altre linee che non gli permettono di compiere il tragitto della diagonale.
12
1.5
Corona e Sugheri 2004 - Ciclo Contrappasso Dantesco
Federico in controluce 2005 - Ciclo Stupore
Amen 2005 - Ciclo Istantanee
Senza titolo 2004 – non Fotocerchio
13
IL CERCHIO NELLA CULTURA ORIENTALE: IL GIAPPONE Nel buddismo Zen il concetto di vuoto è reso graficamente attraverso il cerchio, senza inizio e senza fine. È l’immagine dell’eterno divenire del ciclo della vita e della morte, delle stagioni, dell’universo intero che ruota nell’avvicendarsi di luce e ombra e delle tante sfumature che da millenni accompagnano il cerchio e le sue interpretazioni nelle varie filosofie orientali. I concetti dello Zen sono stati applicati in Giappone anche per definire le direttive principali per organizzare lo spazio all’interno dei giardini, piccoli o grandi che siano. Nel caso dei Tsuboniwa (3), i piccoli giardini sul retro delle case, la posizione della pietra principale era indicata dall’intersezione di due delle quattro linee che dividono il rettangolo in 9 rettangoli, posizionata nel quadrante in alto a destra. Se si fosse desiderato inserire un’altra pietra, comunque minore, all’interno del giardino si doveva utilizzare l’incrocio posto sulla diagonale del rettangolo per creare una composizione equilibrata e asimmetrica.
L’asimmetria permette di creare squilibri e di vedere lo spazio vuoto che si è creato, il vuoto valorizza il pieno, da rilevanza alla pietra principale. Quindi cerchio e diagonale.
14
1.6
Esempio di Enso, cerchio tracciato con un solo colpo di pennello da un Maestro Zen.
Planimetria di giardino prima della progettazione del giardino, si nota l’ingresso e alla base del disegno la veranda della casa.
Primi passi della progettazione del giardino giapponese, segnata la posizione delle due pietre principali, tratteggiata la zona a muschio e puntinata la parte a sabbia bianca pettinata.
15
IL CERCHIO NEL MONDO OCCIDENTALE La storia affascinante della cifra “zero” corrisponde all’evoluzione del concetto stesso di assenza. Nell’antichità non esisteva un termine o simbolo per indicare ciò che non c’era; la difficoltà che generava il non poter esprimere questo concetto portava ad usare come zero delle quantità molto piccole ma definibili, che venivano usate come “quasi zero”. Se si prova ad astrarre il concetto che sta alla base dello zero ci troviamo ad affrontare un problema che ha coinvolto pensatori per secoli: trovare un simbolo che indichi ciò che non c’è, non un oggetto mancante in particolare ma l’assenza stessa. Zero implica che non c’è niente da definire e il “niente” stesso quindi è presente. Non volendo in questa sede procedere ad analizzare un concetto così profondo, proseguiamo il percorso dell’analisi del simbolo grafico, cioè del cerchio adottato a simbolo della mancanza di sostanza. Il magnifico libro “Zero, storia di una cifra” (4), illustra, in diversi passaggi, come il graficismo, sia ad oriente che ad occidente, abbia coinciso nella scelta della circonferenza. Riportiamo un brano in particolare che dipinge lo scenario dell’Antica Grecia, in cui i primi grandi matematici Pitagorici muovevano i loro primi passi nella
definizione di insiemi numerici coerenti e strutturati su cui in seguito si sono basate le fondamenta della nostra moderna matematica: “Sappiamo da Platone che, almeno in certi casi, i geometri-filosofi tracciavano le loro figure sulla sabbia. Se è capitato che costruissero anche i numeri con ciottoli posati sulla sabbia, i mercanti – e chiunque altro usava i ciottoli per contare – osservando gli schemi numerici avrebbero anche notato cosa restava portando via un contrassegno: una depressione circolare: O In seguito la cifra zero si è allungata perché la scrittura con pennino e calamaio non permetteva agevolmente l’esecuzione del cerchio, molto più pratico era indicare lo zero con due tratti a forma di parentesi uniti alle estremità, da cui 0 e non O. Quindi anche ad Occidente il cerchio e il vuoto camminano sulla stessa strada e parlano la stessa lingua a chi li guarda. Dal Diagramma di Gutenberg (5) apprendiamo come la visione dell’uomo occidentale segua delle linee guida uguali per tutti: l’occhio parte ad esplorare un documento, testo o immagine che sia, dall’angolo in alto a sinistra per poi scorrere verso destra ad esplorare il foglio seguendo le linee principali e i punti salienti che colpiscono l’osservatore. Data questa dinamica, indipendente dalla propria volontà,
16
I numeri geometrici di Pitagora disegnati con ciottoli sulla sabbia e sotto i segni circolari rimasti una volta tolti i sassi.
Una linea che divide il piano provoca impressioni differenti a seconda della sua inclinazione.
17
è chiaro che una linea sarà percepita come in discesa se taglia l’immagine dall’alto a sinistra in basso a destra, sarà letta come statica se orizzontale e come in salita se unisce l’angolo in basso a sinistra con quello in alto a destra; la linea verticale interrompe il foglio, è percepita come separazione, rottura della linea visuale. L’idea che si è voluto trasmettere attraverso i Fotocerchi è dinamicità, quindi si è escluso l’orizzontale. La linea verticale non risponde a criteri di movimento ma piuttosto di ritmo e separazione. Quindi si è passati ad analizzare le diagonali: la “discesa” non risponde alla volontà espressiva dei Fotocerchi, che vogliono invece proiettare l’osservatore in un nuovo universo esplorando materiali, oggetti e concetti in modo nuovo ed entusiasta. Ecco nascere allora la diagonale “in salita”, proiettata verso il cerchio, vero soggetto delle fotografie.
1.7 GEOMETRIA DELLA STRUTTURA Alla luce dei concetti esposti sopra, ho analizzato la struttura compositiva per avere una solida base e affrontare le difficoltà che già ai primi scatti avevo incontrato. Dalla dimensione del cerchio deriva la porzione di spazio che viene inclusa all'interno dell'immagine, quindi decidere la proporzione tra circonferenza e rettangolo determina se alcuni particolari saranno visibili o meno nell'immagine finale. Diviene quindi fondamentale decidere a priori le proporzioni fra cerchio e diagonale all’interno della cornice. La base delle proporzioni è il cerchio, raddoppiando il suo diametro si ricava il lato corto della cornice, che a sua volta rappresenta i ¾ di quello lungo.
18
1.8
L’ immagine prima di essere tagliata come Fotocerchio.
Alcuni esempi di struttura compositiva.
Le varie strutture applicate all’immagine, si noti come cambia la porzione di spazio inclusa nella cornice in base alle dimensioni del cerchio.
La struttura compositiva scelta per i Fotocerchi.
19
L'EFFETTO PROIETTILE Per uno strano paradosso dei processi creativi, più è stretto il vincolo, maggiore sarà lo sforzo richiesto e migliore il risultato; se ad esempio qualcuno vi consegnasse un foglio bianco ed una matita e vi chiedesse “disegna qualcosa, quello che vuoi tu…” chiunque di noi sarebbe in imbarazzo davanti al foglio bianco. Anche un disegnatore esperto non farebbe altro che ricreare ad un soggetto già ben noto, con una creatività prossima allo zero. Ma se vi fornissero un foglio strappato a spirale e vi dicessero “disegna la carovana dei 40 ladroni al ritorno dal saccheggio”, probabilmente le vostre energie canalizzate in modo così ferreo sarebbero molto più prolifiche. A prescindere dal valore artistico del risultato finale, il metodo utilizzato porterebbe chiunque di noi a disegnare una minuziosa serie di particolari che diversamente avremmo stentato a concepire. Un paragone con le armi da fuoco dimostrerà come la costrizione funga da guida: se esplodiamo un proiettile da un fucile e da una pistola, otterremo un gittata molto più lunga nel primo caso perché la canna del fucile costringe il corpo espulso per molto più tempo. Sulla base di questo esempio definiamo questa metodologia di lavoro “l'effetto proiettile”. Tale metodo è stato applicato in ogni fase della scelta
compositiva, infatti i vincoli sono stati definiti di volta in volta aumentando nel corso degli anni.
21
FOTOCERCHI 2002 - 2007
2.1 “LA” FOTOGRAFIA In questo periodo di tempo ho interpretato ogni soggetto come rappresentante dell'insieme di tutti gli oggetti a lui assimilabili, come una sorta di “uno per tutti, tutti per uno”, ho convogliato il messaggio dell'esistenza di una classe di oggetti circolari in un unico fotogramma. Per chiarire il concetto è più comodo riferirsi ad un esempio: poniamo di voler fotografare il quadrante di un orologio come cerchio, esistono infiniti orologi e possono essere raggruppati per caratteristica, come ad esempio orologi da polso, da taschino, orologio in stazione ferroviaria, a pendolo, antico, di lusso, Swatch e così via, ma dovendo eseguire “LA” fotografia ad un orologio si sono sacrificate tutte le altre per fare un’unica foto che veicolasse l’idea del “quadrante di orologio”.
2.2 IL CONTRAPPASSO DANTESCO È un ciclo in cui la ricerca dei soggetti e la composizione della fotografia è molto simile ad una “pittura con gli oggetti”; la ricerca dei soggetti avviene a livello speculativo, è solo mentale, poi gli oggetti sono disposti secondo le esigenze per gli scatti fotografici. Concettualmente è stato collegato il soggetto principale, il cerchio, con lo sfondo attraverso una relazione ispirata al contrappasso dantesco, in quanto la scelta dei vari oggetti potrà essere fatta per analogia o per contrasto. Applicando quindi questi principi si indicherà che nel contrappasso per analogia lo sfondo richiamerà il soggetto amplificandone la sostanza e rendendo quindi comprensibile la materia di cui è formato. Ad esempio il cerchio ottenuto dal tonno è accompagnato da pesciolini e utensili per la pesca; nel contrappasso per contrasto lo sfondo si pone in antitesi con il soggetto essendo un sostituto dello stesso: gli elastici con il nastro adesivo, il tappo a corona con i sugheri e così via.
29
STUPORE La "decontestualizzazione" toglie allo spettatore i riferimenti spaziali per poter capire subito cosa sia l'oggetto fotografato. Questa tecnica è funzionale a destare la curiosità e a valorizzare soggetti comuni che, decontestualizzati, possono essere guardati con occhi nuovi e senza pregiudizi e apparire in tutta la loro bellezza. È come "aprire gli occhi" sulla quotidianità per scoprirne aspetti più interessanti e che spesso passano inosservati. Lo "Stupore" è guardare il mondo con occhi nuovi.
35
ISTANTANEE Le istantanee sono la conferma che la Struttura Cerchio e Diagonale non esiste solo nello studio fotografico, ma è presente nella vita di tutti i giorni. È una differenza sostanziale perché negli altri cicli esiste un’idea che viene realizzata e registrata sul sensore sotto forma di immagine mentre le Istantanee danno il via ad un atteggiamento di ricerca continua per cogliere l’immagine che è molto più vicina al concetto della fotografia intesa come “ferma l’attimo”. Le Istantanee rappresentano un “aprire gli occhi al mondo”.
41
FOTOCERCHI 2008
2.5 LE MULTIFOTO 1, 10, 100, 1000, 10000… i Fotocerchi sono delle entità che si rafforzano a vicenda. La visione di una singola immagine non veicola l’informazione cardine, cioè la fissità del layout grafico, e quindi è necessario abbinarne molte per mostrare la struttura e il concetto che ha generato le foto stesse. E allora quali foto sono da associare tra loro, quante e per quale motivo? Per poter trasmettere il messaggio della molteplicità emerge la necessità di creare degli insiemi omogenei con una caratteristica comune, nasce il ciclo Multifoto. Fino al 2007 le singole foto nascono come parte di un ciclo, ad esempio “Stupore” o “Contrappasso”, e questo genera degli insiemi molto ampi che devono poi essere suddivisi in sottoinsiemi per poter permettere una loro fruizione da parte dello spettatore in quanto, come accennato sopra, le stampe delle foto devono essere raggruppate per poter fornire l’idea della molteplicità. In questo periodo è stata adottata una concezione della singola foto che ha comportato una scelta tra soggetti equivalenti ma fisicamente diversi. Di conseguenza si sono perse molte immagini e spesso si trattava di immagini della stessa qualità della
fotografia scattata ma escluse per non duplicare il soggetto. Nel capitolo precedente ho fatto l'esempio della fotografia del quadrante dell'orologio: ci sono sicuramente diverse immagini molto interessanti che riguardano gli orologi, ma volendo dare vita a tutte le idee e le declinazioni di un soggetto, a che punto si può considerare l’insieme “orologio” concluso? Nasce quindi la necessità di dare una regola che permetta di costruire gli insiemi in modo definito e chiaro.
2.6 IL CRITERIO UTILIZZATO PER DEFINIRE LA NUMEROSITA' DELLE MULTIFOTO La notazione posizionale di origine araba di scrittura dei numeri, usata correntemente in occidente, utilizza la “scala gerarchica dei numeri” e come base le potenze di 10, infatti le cifre di un numero indicano quante volte considerare la potenza di dieci individuata da quella cifra (vedi pagina a lato). I numeri su cui si basa la moderna scrittura matematica sono le potenze positive e negative della base numerica utilizzata, quindi sono i “pilastri” su cui si regge la matematica e di conseguenza su cui si è fondata la civiltà così come noi la conosciamo, dal sistema metrico decimale ai conti
43
bancari, dalla vita quotidiana ai satelliti geostazionari. Per questo motivo si sono prese le potenze della base come riferimento per la numerosità degli insiemi. Si è scelto di utilizzare una base coerente con la struttura cerchio e diagonale capace di rispondere alla domanda: se i Fotocerchi potessero contare, come conterebbero? L’uomo conta in base dieci perché ha dieci dita, i Fotocerchi hanno solo due elementi, il cerchio e la diagonale, quindi contano in base due. Se analizziamo a quanto corrispondono i numeri 1, 10,100, etc in base due (vedi pagina precedente) gli insiemi appaiono definiti in modo chiaro con una numerosità pari alle potenze di 2 e tramite una caratteristica comune che varierà di volta in volta. Dove prima c'era una foto ora ci sono insiemi di foto, le Multifoto, che possono considerarsi dei sottoinsiemi dei cicli generali.
44
Fiammifero 2008 - Multifoto
Fiammifero in accensione 2008 - Multifoto
Fiammifero combusto 2008 - Multifoto
Fiammifero acceso 2008 - Multifoto
45
OCCHI
Il mio Albero Genealogico 2008 - Multifoto
Gabriella e Duino 2008 - Multifoto
Adriano e Lucia 2008 - Multifoto
Susy e Alberto 2008 - Multifoto
Martina ed Eva 2008 - Multifoto
47
Lampadina 2008 - Multifoto
Lampadina – Base a vite 2008 - Multifoto
Lampadina – Supporto della Lampada 2008 - Multifoto
Lampadina – Supporto del Filamento in Tungsteno
2008 - Multifoto
Lampadina – Bulbo in Vetro 2008 - Multifoto
49
BIBLIOGRAFIA
(1) Titolo: Meditazione e fotografia Autore: Diego Mormorio Ed. Diaframma – 2008
(2) http://it.wikipedia.org/wiki/
Platone (3) Titolo: A japanese touch to your
home Autori: Seike, Kudo, Engel Ed: Kodansha Int.
(4) Titolo: Zero. Storia di una cifra. Autore: Robert Kaplan Ed: Rizzoli
(5) Titolo: Principi Universali del Design Autori: Lidwell, Golden, Butler Ed: Logos




















































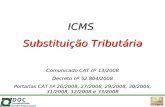

















![Diseny 2008 Calendar [MMS911© 2008] · Title: Diseny 2008 Calendar [MMS911© 2008] Author: MMS911© 2008 Subject: 2008 Calendar Keywords: Disney; Calendar Created Date: 1/13/2008](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/6059ae5486c210065a54d497/diseny-2008-calendar-mms911-2008-title-diseny-2008-calendar-mms911-2008.jpg)