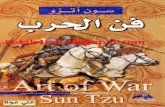filosofia_dispense_cl3.pdf
-
Upload
giaymila-saracino -
Category
Documents
-
view
6 -
download
2
Transcript of filosofia_dispense_cl3.pdf
-
1
I.I.S.. P. P. PASOLINI Milano
_____________________________________________
FILOSOFIA CLASSI TERZE - INDIRIZZO LINGUISTICO
La filosofia antica introduzione, fi losofia presocratica, sofisti
Socrate, Aristotele cenni sul pensiero ellenistico
questionari di r ipasso appendice sullApologia di Socrate
(prof. Fabio Maria Pace)
anno scolastico 2013-2014
-
2
PREMESSA La nascita della fi losofia e lo thuma Nel primo libro della Metafisica Aristotele presenta un quadro storico della filosofia, fornendo importanti notizie sui filosofi pi antichi. Ma non fa solo questo: spiega anche come e perch (cio da che cosa) la filosofia sia nata (e precisa altres quale sia la finalit, lo scopo della filosofia). Scrive dunque Aristotele: Infatti gl i uomini hanno cominciato a fi losofare, ora come in origine, a causa della meraviglia (thuma): Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed per questo che anche colui che ama il mito , in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicch, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilit pratica (Aristotele, Metafisica, I, 2, 982b, trad. Giovanni Reale). Aristotele, quindi, afferma che: a) alla base della filosofia c la meraviglia (thuma); b) gli uomini hanno iniziato a filosofare al solo scopo di sapere, senza aspirare al conseguimento di nessuna utilit pratica ( questo il carattere teoretico della filosofia, che infatti un sapere fine a se stesso1). Aggiunge pi avanti che che la meraviglia non solo ci da cui la filosofia nasce, ma anche ci da cui essa, nascendo, si l ibera: sempre nel libro primo della Metafisica, Aristotele precisa infatti che il possesso della filosofia permette alluomo di raggiungere uno stato contrario a quello in cui egli era allinizio della ricerca (cio allo stato della meraviglia, da cui la filosofia nasce). Quindi, riassumendo: la filosofia ha origine dal thauma, ma con il suo nascere e svilupparsi permette alluomo di liberarsi dal thauma e di raggiungere la condizione opposta al thauma. Per comprendere adeguatamente quello che Aristotele vuole dire, tuttavia essenziale fare una precisazione lessicale: tradurre con meraviglia il termine greco thauma improprio, perch rende solo uno dei possibili significati di questa parola, che invece molto pi complessa, come sottolinea Emanuele Severino: (E) improprio interpretare il thauma aristotelico come meraviglia. Si perde completamente di vista la tragica grandezza della nascita della filosofia. Thauma infatti, innanzitutto, l'angosciato stupore, lo stordimento e i l terrore dell' uomo dinanzi al divenire della vita, cio dinanzi al dolore e alla morte. Lo dice la stessa struttura etimologica di questa parola potente e terribile. Solo scorgendone il significato autentico ci si spiega perch Aristotele affermi che il
1 Per questo punto, vedi pi avanti la definizione di filosofia di G. Reale.
-
3
possesso della filosofia conduce nello stato contrario a quello costituito da thauma; ossia conduce alla felicit che sorge dal risolvimento dei problemi intorno al senso del mondo2. Sempre Severino, nella sua opera La filosofia dai Greci al nostro tempo spiega pi ampiamente il significato di thauma e quello che Aristotele dice sulla nascita della filosofia (Il termine thauma) - scrive Severino - indica lo stupore attonito di fronte a ci che strano, imprevedibile, orrendo, mostruoso. Se infatti non si conoscono le cause di ci che accade - se ci che accade non rientra nella spiegazione del mondo della quale l'uomo di volta in volta si trova in possesso -, allora l'accadimento delle cose diventa la fonte di ogni terrore e di ogni angoscia. E anche di ogni dolore, perch la sofferenza insopportabile quando non spiegabile e si avventa sull'uomo, imprevedibile e senza ragioni. Affermando che la filosofia nasce dalla meraviglia, Aristotele intende dire che la filosofia nasce dal terrore provocato dall'imprevedibilit del divenire della vita. Conoscendo le cause del divenire, la filosofia rende prevedibile l'imprevedibile, lo inserisce nella spiegazione stabile del senso del mondo, e quindi appronta il rimedio contro il terrore della vita. La filosofia greca () stata il primo formidabile strumento con il quale l'uomo dell'Occidente ha proceduto a soddisfare il proprio fondamentale interesse: la liberazione dal terrore della vita3. Proviamo schematicamente a spiegare:
- la realt caratterizzata dal fatto di essere molteplice e mutevole: molteplice perch costituita da una pluralit di oggetti e, di conseguenza, possiamo dire che manca di unit;
- mutevole - e questo ne laspetto qui pi sconcertante - perch tutto nasce, si sviluppa e muore e, di conseguenza, possiamo dire che la realt manca di permanenza, nel senso che tutto prima o poi scompare. Quindi, la realt, proprio per la sua mutevolezza, sembra essere costantemente aggredita dal nulla, anzi assorbita nel nulla: le cose non permangono, niente resta in eterno, niente sfugge alla corruzione: tutti gli esseri appaiono, vivono e scompaiono. Il nulla li risucchia inevitabilmente, li distrugge;
- da tutto questo deriva il thauma, lo sgomento delluomo di fronte al divenire delle cose, al loro continuo scomparire, scivolando ineluttabilmente nel nulla;
- luomo sente perci il bisogno, di fronte allangosciante molteplicit e mutevolezza della realt, di trovare una spiegazione, di trasformare questo caos in un ordine, cio di dare un senso al mondo, di conferirgli un valore;
2 E. Severino, Mito e meraviglia crearono la filosofia, in Corriere della sera, 14.12.2000 3 E. Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo, vol 3. La filosofia contemporanea, cap. 1, ed. BUR, Milano 2004
-
4
- questo ci che anche miti e religioni sempre hanno fatto: Aristotele stesso lo dice proprio nel brano che abbiamo letto: i miti danno una spiegazione della realt, le danno un significato e un valore, mostrandoci innanzitutto che essa frutto dellazione degli di, che impongono con le loro azioni un valore, un ordine e un significato alla realt4;
- tuttavia i miti (e le religioni) non sono verit assolute, almeno non nel senso che il concetto di verit ha per la filosofia: infatti essi vengono accettati e creduti da alcuni uomini, da altri no (infatti le mitologie e le religioni sono tante e differenti, cambiano da una civilt allaltra: popoli diversi hanno miti e religioni diversi). E vengono creduti per rispetto della tradizione o delle sacre scritture, sono accettati per fede, non sulla base di un ragionamento, di una dimostrazione. La filosofia, invece, aspira a raggiungere una conoscenza che sia assolutamente vera, indiscutibile, innegabile, che sia universale, valida per tutti: questa conoscenza non pu che derivare dalla ragione.5 E qui la novit straordinaria della filosofia: la sua volont di trovare con la ragione le risposte che permettono alluomo di liberarsi dal thauma, lo sgomento che lo assale di fronte al divenire della realt, alla sua apparente caoticit e mancanza di senso, al suo continuo scomparire nel nulla. In questo modo, pur nascendo da thauma, la filosofia col suo stesso nascere se ne libera e conduce alla condizione opposta a thauma. E questa condizione consiste nella felicit, come Aristotele spiega in unaltra sua celebre opera, lEtica Nicomachea: luomo che si dedica alla filosofia felice perch contemplare la verit, che quanto la filosofia consente di fare, porta gioia agli uomini: la filosofia, quindi, nasce dallo sgomento ma conduce alla felicit.
4 Aristotele - scrive sempre Severino - osserva che anche il philmythos (alla lettera: "colui che ama il mito", ossia che costruisce i miti e crede e vive in essi) in qualche modo filosofo, perch anche la costruzione dei miti scaturisce dalla "meraviglia", cio dal terrore che il divenire della vita produce nell'uomo. Anche il mito, infatti, raccoglie gli eventi del mondo all'interno di una spiegazione unitaria: predispone un'interpretazione stabile dell'universo e attende, preparato da essa, l'irrompere degli eventi, i quali dunque perdono la loro imprevedibilit terrorizzante e si adeguano all'ordine cosmico enunciato dal mito. Anche la conoscenza mitica delle cause e degli eventi un rimedio contro il terrore dellimprevedibile. 5 Infatti uno dei termini che il pensiero filosofico greco utilizza per definire questa conoscenza indubitabile epistme, solitamente tradotto come scienza: etimologicamente esso significa stare sopra, indicando perci un sapere che stando sopra la molteplicit delle opinioni (che sono tante e diverse), risulta fermo, certo, indiscutibile, si pone cio al di l e al di sopra di ogni possibile dubbio. Anche lo stesso termine filosofia interessante sul piano etimologico: esso significa letteralmente, come vedremo, amore del sapere (philo-sophia); tuttavia la parola sopha si collega molto probabilmente alla radice di phos, vocabolo che indica la luce: allora filosofia significa amare quel sapere che, proprio perch si trova nella luce, non pu essere in alcun modo negato, messo in dubbio. Del resto, la parola greca aletheia, che significa verit, letteralmente indica qualcosa che non nascosto: la sapienza della filosofia, certezza assoluta e chiara come la luce: propriamente un sapere non nascosto, un sapere che da nessuno e in nessun modo pu essere negato.
-
5
1 - NOTE INTRODUTTIVE Il vocabolo greco filosofia deriva dai termini greci philin, amare, e sopha, sapienza: significa dunque amore per la sapienza. La tradizione attribuisce la creazione del termine a Pitagora (VI sec. a. C.): si tratta di unattribuzione verosimile, perch il vocabolo di certo stato coniato da una personalit profondamente religiosa che presupponeva come possibile solo agli di una sophia come possesso certo e totale, mentre rilevava come alluomo sia possibile solo un tendere alla sophia, un continuo avvicinarsi, un amore mai del tutto appagato di essa, donde appunto il nome filo-sophia, amore di sapienza (G. Reale). Caratteristico quindi della filosofia il ricercare, giacch si cerca quel che si ama (e non si podssiede). Poich il filosofo ama il sapere, il suo compito ricercarlo (cosa che non fanno n gli di, che non ne hanno bisogno perch possiedono gi il pieno sapere, n gli animali, perch non ne sono in grado). Volendo dare una definizione generale della filosofia, che vada al di l della sola etimologia, possiamo riprendere quella formulata da Nicola Abbagnano: indagine critica e razionale intorno agli interrogativi di fondo che luomo si pone circa se stesso e le realt che lo circondano;
- il termine critico indica un sapere che nulla d per scontato, sottoponendo al giudizio della ragione (krnein = distinguere, giudicare) ogni affermazione e principio; va sottolineato che questo esame riguarda anche gli stessi poteri della ragione, della quale la filosofia vuole definire al contempo i limiti e e le condizioni di validit;
- di fondo sta ad indicare problemi e domande che riguardano tutti gli esseri umani, non quindi una particolare categoria di persone, ma luomo in quanto tale;
- razionale ovviamente significa che il solo strumento di cui la filosofia si avvale la ragione, rifiutando dogmi e imposizioni di qualsiasi genere (diversamente dalle religioni).
- Come abbiamo visto, sul piano delletimologia filosofare significa ricercare la sapienza; ma di quale sapienza si tratta, quali prerogative caratterizzano questo sapere rispetto agli altri? Possiamo schematicamente indicare tre caratteri distintivi della filosofia, precisati fin dal momento in cui nasce, cos come li illustra nella sua definizione di filosofia Giovanni Reale. Riguardano: a) il contenuto, b) il metodo, c) lo scopo della filosofia. a) Quanto al contenuto: la filosofia si propone di spiegare tutta la realt, senza escluderne nessuna parte o nessun momento, distinguendosi in tal modo dalle scienze particolari, che indagano specifici settori del reale, gruppi particolari di cose e di fenomeni. Gi il primo dei filosofi, Talete, si propone di ricercare il principio di tutte le cose. Si noti che la realt totale su cui indaga la filosofia non la somma delle singole realt, come se la filosofia non fosse altro che la somma di tutte le conoscenze sulla realt. La filosofia non la somma delle conoscenze acquisite dalle scienze particolari, come la fisica, la chimica, lastronomia: si risolverebbe cos in una sorta di mare magnum che si occupa di tutto e non approda mai a nulla. La realt di cui il filosofo si occupa la totalit delle cose come tale; la filosofia non tratta cio di
-
6
tutto, ma del tutto. Si tratta dunque non di una universalit di estensione, ma di una universalit di sguardo. b) Quanto al metodo: come abbiamo visto spiegando la definizione di Abbagnano, la filosofia vuol essere una spiegazione puramente razionale di quella totalit che costituisce il suo oggetto di indagine. In filosofia vale dunque soltanto largomento di ragione, la motivazione logica, il logos. Non le basta accertare dati di fatto, deve andare oltre il dato e lesperienza per ricercare ragioni, cause, principi. In questo uguale alle altre scienze, che - tutte - ricercano al di l del mero dato il piano dei significato e delle spiegazioni. Le differenzia per dalla filosofia - come detto - la settorialit del loro terreno di indagine: cercano s cause e significati, ma di realt particolari, mentre la filosofia indaga la globalit del reale. La filosofia dunque, come si legge nella definizione di Abbagnano riportata pi sopra, indagine critica e razionale, intendendo la criticit come rifiuto di qualsiasi pregiudizio o presupposto di qualsiasi tipo. Analisi critica significa analisi radicale che di tutto pu servirsi ma che tutto, senza timori reverenziali, sottopone allanalisi e al controllo della ragione, compresi i poteri della ragione. c) Quanto allo scopo: la filosofia ha carattere puramente contemplativo, teoretico6, cone sottolinea Aristotele, mira cio alla ricerca della verit per se stessa, prescindendo da tutte le utilizzazioni pratiche (tecniche ed economiche). La ricerca filosofica non tende a nessun vantaggio che sia ad essa estraneo: si risolve nella pura contemplazione della verit. Si spiega cos - ci pare - il nome stesso della filosofia, come amore duna sapienza ricercata in quanto tale, una sapienza del tutto fine a se stessa. Scrive Aristotele, che meglio di ogni altro ha definito questo carattere della filosofia: Se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dallignoranza, evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilit pratica () E evidente dunque che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, evidente che, come diciamo uomo libero colui che fine a se stesso e non asservito ad altri, cos questa sola, tra tutte le altre scienze, diciamo libera: essa sola, infatti, fine a se stessa7. Pu essere utile a questo punto confrontare la filosofia greca con le sapienze delle antiche civilt orientali: si spesso infatti sostenuto che i Greci non sarebbero stati i creatori della filosofia, ma che avrebbero invece recuperato e trasmesso allOccidente un sapere pi antico, originatosi nelle civilt pre-elleniche dellOriente. E indubbio che, prima del nascere della filosofia in Grecia (VI secolo a. C.) si siano sviluppate in Oriente - India, Cina, Persia - esperienze di straordinaria ricchezza culturale e spirituale, ma la tesi che fa derivare da queste (in particolare da quelle indiane) la filosofia non regge, per diversi motivi:
6 Il filosofare - scrive Di Napoli - nobile azione dello spirito umano, che vuol comunque penetrare se stesso nella realt, anche se non muove di un dito le cose della natura e non fornisce le comodit della vita Carattere essenziale del filosofare la teoreticit come puro e indipendente sguardo sulla realt. In tal senso la filosofia teoria (= concezione universale e critica) della realt nei suoi princpi supremi. 7 Metafisica, A2, 982b 11 ss.
-
7
a) il pensiero indiano appare concentrato soprattutto su problematiche di tipo esistenziale e religioso, mentre la filosofia greca, al suo primo apparire, ha come oggetto primario di ricerca la natura, il cosmo e i loro princpi.
b) La conoscenza orientale concepita non come sapere fine a se stesso (teoretico) ma in funzione della salvezza o della liberazione delluomo (per. es. dal ciclo delle rinascite); il filosofo orientale, se cos vogliamo chiamarlo, un illuminato, in santo che segue un itinerario di salvezza e non un disinteressato e scientifico ricercatore della realt.
c) La tesi della derivazione orientale della filosofia greca non affermata da nessun autore di et classica. Sono s menzionate le conoscenze matematiche o astronomiche di Egizi e Babilonesi, ma nessuno mai sostiene che quelle civilt abbiano influito in modo decisivo sulla nascita della filosofia greca.
d) E pressoch certo che i primi filosofi greci non abbiano avuto nessuna conoscenza delle dottrine orientali e nessun contatto con le civilt che le hanno sviluppate; solo con la spedizione di Alessandro Magno lOccidente si apre alle civilt della Persia e dellIndia. Prima di allora i greci hanno contatti soprattutto con le culture dellEgitto e della Mesopotamia, le quali avevano tuttavia una tradizione di sapienza mitico-religiosa lontana dal pensiero filosofico.
e) Infine, il sapere orientale pre-ellenico, di carattere, come detto, essenzialmente religioso, si esprime attraverso un linguaggio mitico, facendo ampio uso di elementi fantastici e simbolici. Fin dal suo esordio, invece, la filosofia si struttura come sapere razionale fondato unicamente sulla forza del pensiero, come indagine critica e argomentata, libera da ogni vincolo di tradizione o sacralit e utilizza un linguaggio di tipo scientifico, assai diverso da quello del mito e della poesia.
Va peraltro segnalato che temi di natura mitica relativi allorigine del mondo sono sicuramente transitati dal mondo vicino-orientale a quello greco: se ne trovano chiare tracce, per esempio, nella Teogonia di Esiodo e nei poemi omerici. Peraltro, anche ammettendo che dallOriente la Grecia abbia tratto qualche dottrina o qualche tema mitico, questo non significa evidentemente che la filosofia greca abbia origine orientale. Al contrario, proprio il confronto con la sapienza orientale evidenzia le caratteristiche peculiari della filosofia greca: le dottrine orientali sono infatti di tipo religioso e tradizionalistico, sono privilegio di caste sacerdotali, sono ritenute sacre e di conseguenza immutabili. La filosofia invece, in quanto ricerca razionale, nasce e si sviluppa proprio da un essenziale atto di libert di fronte alla tradizione e ad ogni credenza accettata come tale. Dunque la filosofia una creazione originale della cultura greca, una peculiarit di quella civilt e di quel popolo. Viene quindi spontaneo chiedersi quali condizioni storiche, politiche, culturali abbiano favorito il nascere della filosofia in Grecia. Va tuttavia premesso che non corretto
-
8
pensare che una serie di cause, per il fatto stesso di esistere, avrebbero necessariamente determinato la nascita della filosofia: si tratta piuttosto di condizioni, di elementi che hanno favorito e permesso (non determinato automaticamente) questo particolare evento. Possiamo schematicamente indicare due di queste condizioni: a) le civilt pre-greche e orientali sono nella quasi totalit monarchie stataliste e accentratrici, con un carattere decisamente statico: tendono a conservare la cultura in modo immutabile, presentando la tradizione come sacra e perci intoccabile. E chiaro che societ di questo tipo non presentano un quadro favorevole per la nascita di una indagine libera, critica e razionale come quella filosofica. Si tratta di regimi assoluti, dove il singolo tenuto alla cieca obbedienza al potere politico e religioso. In Grecia la situazione diversa: innanzitutto, manca uno stato accentratore: in sua vece si ha una molteplicit, estremamente diversificata, di citt-stato. Inoltre, gi in epoca omerica le monarchie antiche lasciano il posto a regimi aristocratici in uno sviluppo che prosegue (non uniformemente e senza travagli) verso forme di organizzazione democratica dello stato, che sono le pi antiche nella storia. Ebbene, democrazia significa scambio di idee ed opinioni, dibattito, confronto: questo sviluppa progressivamente una mentalit libera, non disposta ad accettare passivamente il dettato della tradizione, ma propensa a ricercare attivamente idee e modelli di comportamento convincenti sul piano intellettuale, imparando a distinguere ci che appare ragionevole da ci che non lo . In una situazione di questo tipo, dinamica, libera, aperta al futuro e capace di critica nei confronti del passato si verificano le condizioni pi favorevoli per la nascita del pensiero filosofico. b) In Grecia manca una casta sacerdotale depositaria dun sapere tradizionale dogmatico e immutabile. Il sacerdote considerato in Grecia un servitore del proprio dio, collegato strutturalmente al tempio in cui officia, senza mai conseguire prerogative di sacerdozio universale, senza cio acquisire una vera e propria condizione sacerdotale. Non gli viene nemmeno richiesta una formazione teologica o dottrinale specifica: essenzialmente un esecutore degli atti di culto, non il depositario duna dottrina codificata. Si tratta, se cos si pu dire, duna sorta di tecnico della religione, al quale tanto lo stato quanto le famiglie si rivolgono quando devono offrire sacrifici o celebrare riti. Nulla di paragonabile alle potenti caste sacerdotali di molte civilt pre-elleniche orientali e non. In Grecia mancano poi libri sacri: non c nessuna codificazione scritta (come non c orale) della religione, che definisca dogmi e credenze, che fissi una ortodossia assoluta e imprescindibile. Mancano cio le formulazioni di carattere dottrinale, morale e rituale che caratterizzano le religioni fondate (per esempio il cristianesimo) ed anche religioni etniche (come, per esempio, quella dellIndia antica)8. E ovvio che anche questo elemento configura condizioni favorevoli allo sviluppo della ricerca e alla libera espressione del pensiero.
8 La religione greca caratterizzabile come etnica e non fondata, perch non deriva la sua origine da un fondatore storico, come, invece, accade per il cristianesimo o lislamismo.
-
9
Appare opportuno a questo punto proporre qualche annotazione sulle forme religiose che caratterizzano la civilt greca antica, perch molti temi della filosofia sono caratteristici anche del pensiero religioso e perch alcune dottrine religiose hanno certamente influenzato la filosofia. Nella religione greca, considerata come complesso di credenze, istituti, mentalit, atteggiamenti religiosi, si riscontrano due tendenze fondamentali, storicamente non separate n separabili, anzi diversamente intrecciate, ma pur fornite ciascuna di un suo particolare timbro (Ugo Bianchi). Queste due tendenze possono essere definite rispettivamente olimpica e misterica (o mistica). Caratteristico della prima il netto distacco che separa - pur nella somiglianza evidente delle forme esteriori9 - il mondo degli di da quello degli uomini: gli di sono immortali, felici, dotati di vita e potenza al massimo grado; gli uomini, al contrario, sono per definizione i mortali soggetti alle pene della vita, estrema e pi caratteristica delle quali la morte, con il soggiorno tenebroso e vacuo nellAde (ivi). Tra i due ambiti, quello umano e quello divino, separati da tanto netta differenziazione, non v possibilit di contatto intimo e permanente, per quanto gli di intervengano nelle vicende umane: anzi, luomo che in un modo o nellaltro pretenda di ridurre la distanza che lo separa dagli di si macchia della colpa peggiore, resa dal termine greco, hybris, difficilmente traducibile (tracotanza, superbia). A questa religiosit si affianca, spesso nei medesimi ambiti, una serie di forme religiose strutturalmente differenti, definibili come mistiche o misteriche, il cui carattere essenziale proprio la possibilit per luomo di stabiire un contatto diretto con il divino. Per avere unidea generale del primo tipo di religiosit si pensi alla poesia di Omero ed Esiodo, dove costantemente viene ribadita la precariet della condizione umana e sottolineata la distanza che separa il mondo degli di da quello degli uomini. Laltra dimensione della religiosit greca, quella mistico-misterica, appare invece incentrata sullidea che luomo possa accedere al contatto diretto con il divino, concezione questa del tutto estranea al mondo omerico. Un esempio pu essere dato dai culti dionisiaci, nei quali veniva indotta dalla danza, dallebbrezza e dal delirio collettivo, una condizione di estasi, vale a dire un essere fuori di-s (ek-stasis), che significava proprio il superamento dei limiti normali della dimensione umana, in una comunione totale con il divino: luomo e il divino si congiungono. Tra le forme della religiosit mistica greca una riveste particolare rilievo in relazione alla storia della filosofia: lorfismo. Orfeo una figura molto nota del mito greco, che ne celebra la straordinaria capacit di ammaliare gli animali e perfino le pietre con la poesia e la musica: riesce ad ammansire le belve e perfino alberi e pietre si muovono per seguirlo, incantati dalla melodia. Si tratta dunque di un eroe assai diverso dagli altri, che sono quasi tutti guerrieri, protagonisti di
9 Come noto, infatti, gli di greci sono in tutto e per tutto simili agli uomini, sia nellaspetto fisico, sia nel carattere e nel comportamento.
-
10
straordinarie lotte e drammatici combattimenti: il valore di Orfeo diverso, risiede tutto nellinteriorit, nello spirito e trova espressione nellarte10. A questo eroe fa riferimento, come al proprio fondatore, la corrente religiosa detta appunto orfismo, nella quale, come vedremo, il ruolo dellinteriorit e della spiritualit decisivo. Il mito centrale dellorfismo non ha tuttavia Orfeo come protagonista, ma il dio Dioniso: un mito essenziale per gli orfici, perch definisce gli elementi di base della loro dottrina, fonda letica e le norme rituali che essi seguono. In questo mito, Dioniso , figlio illegittimo di Giove, talmente amato dal padre da suscitare lira della moglie Hera, che lo fa uccidere dai Titani. Essi ne fanno a pezzi il corpo e poi lo divorano. Segue la rinascita del dio, le cui membra sono ricomposte da Rea (o da Demetra) e resuscitate. Con le ceneri dei Titani Zeus crea il genere umano: negli uomini si associano quindi una componente dionisiaca, divina e immortale, e una titanica, malvagia e negativa. Su questo mito si fondano le verit essenziali della religione orfica, al centro della quale sta certamente la promessa dun destino beato dopo la morte, destino riservato per solo agli iniziati, ai membri della confraternita. Centrale nellorfismo quindi la sua antropologia dualistica11: luomo composto di due parti antitetich, opposte: lanima, di natura divina, e il corpo, fatto di materia e quindi malvagio. Pper via duna colpa primordiale lanima precipita nel corpo, dove giace imprigionata come in una tomba (sma, corpo, sma, tomba). Luomo deve quindi liberare la sua parte spirituale (il daimon, lo spirito) dal carcere del corpo. E questo il fondamentale concetto orfico della purificazione (ktharsis): lanima deve purificarsi, se vuole essere liberata. Se non lo fa, la attende la reincarnazione in corpi inferiori (il cosiddetto ciclo delle rinascite, che gira inesorabile come una ruota, simbolo orfico per eccellenza). Qual la strada che conduce invece alla salvezza, che opera la purificazione? La via da percorrere quella della cosiddetta vita orfica (orphik bis), caratterizzata dal rispetto di rigide norme di comportamento e divieti rituali. Lorfico non pu uccidere animali n cibarsi della loro carne, perch nel ciclo delle rinascite essi possono essere anime reincarnate. E altres proibito avere qualsiasi contatto con cadaveri e cimiteri e - pi in
10 l pi conosciuto mito di Orfeo senza dubbio quello del suo amore per Euridice. La vicenda notissima: nei pressi di Tempe, in Tracia, Euridice viene insidiata da Aristeo e, mentre fugge per evitarlo, inciampa ed morsa da un serpente. Il morso si rivela mortale e la giovane viene condotta agli inferi. Lamore spinge Orfeo a tentare la pi disperata delle imprese: strappare Euridice al suo destino di morte. E la sua arte a venirgli in soccorso: riesce infatti ad incantare il traghettatore Caronte, il cane Cerbero e i giudici dei morti; le torture dei dannati sono sospese e perfino il terribile Ade, signore delloltretomba, e la sua consorte Persefone sono mossi a commozione. Concedono cos ad Orfeo di riavere la moglie, a condizione, che - sulla via del ritorno - non si volti a guardarla finch non siano giunti alla luce del sole. Quando per i due sposi sono prossimi a raggiungere la superficie della terra, Orfeo non sa resistere alla tentazione e, spinto dallamore, si gira per accertarsi che Euridice lo segua. Questo gesto sciagurato produce subito il suo effetto ed Euridice di colpo piomba al suolo, ineluttabilmente prigioniera della morte. 11 Il termine antropologia significa concezione delluomo, indica cio il particolare modo che una dottrina, religiosa o filosofica, ha di concepire la realt umana; per dualismo si intende invece ogni concezione filosofica o religiosa che affermi lesistenza, nel cosmo o nelluomo, di due princpi opposti, uno benefico e laltro malvagio. Nel primo caso (cosmo) si parla di dualismo cosmologico, nel secondo (uomo) di dualismo antropologico. Nellorfismo troviamo un chiaro dualismo antropologico.
-
11
generale - con tutto ci che attiene al mondo dei morti: cos lorfico non pu mangiare legumi, che sono lofferta specifica che si fa ai morti, e deve mantenersi lontano da tombe e sepolcri. Non inoltre consentito indossare abiti di lana, perch essa stata il mantello di un animale ed prescritto di fuggire la generazione di mortali, cio il parto, ritenuto fonte di impurit. Nelle sepolture sono collocate vicino al morto piccole laminette doro che servono da amuleto e lasciapassare per il viaggio nellaldil. Liniziato che rispetta questo complesso insieme di norme, ottiene la completa purificazione (puro fra i puri lespressione caratteristica che si incontra sulle laminette) e vede dischiudersi un destino privilegiato dopo la morte. Fonti essenziali per la ricostruzione della dottrina orfica sono proprio le laminette doro ritrovate in varie zone di influenza greca: queste lamelle, lunghe pochi centimetri, contengono formule brevi che esprimono la fede e la speranza dimmortalit degli orfici in termini spesso oscuri e di difficile interpretazione. Schematizzando, le dottrine orfiche possono essere riassunte come segue: - nelluomo ci sono un principio divino, lo spirito, e uno malefico, il corpo; lo spirito, preesistente al corpo, viene in esso rinchiuso come in un carcere per espiare una colpa primordiale (dualismo antropologico); - il fedele deve purificarsi per potere liberare lo spirito dal carcere corporeo; la purificazione ottenuta attraverso il rispetto di rigide regole di vita e, verosimilmente, la partecipazione a riti e sacramenti; - se la purificazione realizzata, lorfico dopo la morte pu liberare la sua componente divina e vivere la vita perfetta e beata degli di; - se questa purificazione non viene ottenuta, lo spirito costretto a reincarnarsi, cio ad essere nuovamente incarcerato in un corpo. Con lorfismo viene capovolta la tradizionale concezione greca delluomo, per la quale il destino umano si gioca tutto nellaldiqua: nella religione omerica laldil infatti un regno desolato di tenebra, dove ai morti, ridotti a misere ombre, tocca un triste destino di sofferenza e privazioni (si legga, per esempio, il celebre canto XI dellOdissea). In una prospettiva di questo genere i valori primari non possono che essere quelli della vita presente: bellezza, valore, amore, piacere. Radicalmente diversa , come abbiamo visto, la concezione dellorfismo. 2 - LA FILOSOFIA JONICA Premessa: presocratici e presofisti - Si definiscono abitualmente presocratici i filosofi che - pur proponendo dottrine anche molto diverse tra loro - concordano nel soffermare lattenzione sul problema della natura e della realt fisica, diversamente da quanto far in seguito Socrate, che concentrer il suo pensiero sulluomo
-
12
e i suoi problemi12. A dire il vero, la pi recente storiografia, preferisce parlare di presofisti piuttosto che di presocratici, perch i primi pensatori che hanno spostato linteresse della filosofia dal cosmo alluomo sono stati appunto i Sofisti. Si dovrebbero quindi definire gli autori di cui di seguito ci occuperemo presofisti, ma la tradizionale dicitura presocratici talmente entrata nelluso che la si pi comunque mantenere. - I filosofi presocratici fioriscono dal sesto secolo avanti Cristo in avanti e non costituiscono un insieme compatto e omogeneo, ma si distinguono in numerose scuole e tendenze: a) la scuola jonica di Mileto, i cui principali esponenti sono Talte, Anassimndro e Anassmene; b) la scuola pitagorica (Pitagora e seguaci); c) la scuola eraclitea (Erclito e seguaci); d) la scuola eleatica, che ha come fondatore Parmnide e come esponenti pi significativi, oltre a lui, Senfane e Zenne; e) i fisici pluralisti: Empdocle, Anassgora, Demcrito. - Questi autori - va sottolineato - operano in una primo periodo nelle colonie greche dellAsia Minore (Jonia) e dellItalia meridionale (Magna Grecia); solo con Anassagora la filosofia arriva ad Atene. I fisici pluralisti vivono pi tardi, sono contemporanei dei Sofisti e di Socrate. La scuola di Mileto - Come detto, questa prima scuola filosofica si sviluppa nella zona costiera dellAsia Minore colonizzata dagli Joni, dove fiorisce una civilt ricca e raffinata, i cui centri principali sono Mileto, Efeso, Colofone, Clazomene, Samo e Chio. In queste citt domina una intraprendente classe di mercanti che, alla ricerca di sbocchi commerciali e di materie prime, crea potenti flotte mercantili, il cui raggio dazione si estende dal Mar Nero allEgitto, dalla Magna Grecia alla Spagna. - Siamo di fronte a una civilt molto dinamica, che offre condizioni estremamente favorevoli al nascere del pensiero filosofico, come sottolinea Nicola Abbagnano: Infatti, il rapido sviluppo di forme politiche democratiche, il rigoglio delle tecniche, i contatti con le civilt del Vicino Oriente, lallargarsi della mentalit media delle popolazione, abituata allestrema variet delle usanze e delle credenze, sono tutti fattori che, sommandosi fra di loro, contribuiscono allelaborazione di una nuova cultura, impegnata a liberarsi delle credenze magiche, mitiche e religiose, e tesa ad unosservazione pi attenta e razionale dei fenomeni naturali. Da ci lemergere, nella Jonia, di una figura di intellettuale che ha in s i tratti del filosofo, dello scienziato e del tecnico13.
12 Si parla a questo proposito di un passaggio dalla problematica cosmologica (cio relativa al cosmo) a quella antropologica (cio relativa alluomo). Va detto, comunque, che anche questi primi autori manifestano interesse per ll mondo delluomo, pur privilegiando il tema cosmologico. 13 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Filosofi e filosofie nella storia, 1, Torino 19922, 34.
-
13
- Questi autori, che la storia della filosofia tradizionalmente presenta come i primi filosofi, concentrano la loro attenzione sul problema della sostanza primordiale. Ai loro occhi il mondo in cui viviamo si presenta come una realt che: A) cambia in continuazione ( mutevole); B) si compone di uninfinit di cose diverse ( molteplice). Questi due caratteri, la mutevolezza e la molteplicit, richiedono per questi filosofi una spiegazione (si ricordi quanto scritto nella premessa sul nascere della filosofia da thauma): deve dunque esistere una realt che sia immutabile ed unica, di cui quanto vediamo nel mondo la manifestazione esteriore e provvisoria. In altre parole: il mondo in cui viviamo e che i nostri sensi ci fanno percepire mutevole e molteplice, quindi privo di stabilit e permanenza (cio di senso) ma alla sua base c una sostanza prima che - al contrario - immutabile e unica. Si tratta quindi di ricondurre ad un unico principio di spiegazione e dordine lapparente caoticit del mondo. - Questa sostanza unica e immutabile che sta alla base della realt chiamata dai filosofi jonici arch , che in greco significa principio. Secondo Abbagnano esso la materia da cui tutte le cose derivano e la forza o legge che spiega la loro nascita e morte14. Giovanni Reale ne propone la seguente definizione: (Il principio) una realt che permane identica nel trasmutarsi delle sue affezioni, cio una realt che continua ad esistere immutata, pur attraverso il processo generativo (cio il mutare) di tutte le cose. Quindi larch : a) fonte o scaturigine delle cose; b) foce o termine ultimo delle cose; c) permanente sostegno delle cose, ci che le alimenta e le fa vivere. In breve, ci da cui le cose vengono, ci per cui sono, ci in cui vanno a finire15. TALETE di Mileto il fondatore della scuola jonica; vive tra la fine del VII secolo a. C. e la met del VI; uomo politico, matematico, astronomo, fisico e viene solitamente considerato il primo filosofo della storia; di lui non ci restano scritti e la sua dottrina menzionata da Aristotele, che scrive: Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio lacqua (per questo afferma anche che la Terra galleggia sullacqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose umido, e che perfino il caldo si genera dallumido e vive nellumido. Ora, ci da cui tutte le cose si generano , appunto, il principio di tutto. Egli desunse dunque questa convinzione da questo fatto e dal fatto che i semi di tutte le cose hanno una natura umida e lacqua il principio della natura delle cose umide. Dunque Talete identifica larch, la sostanza primordiale, nellacqua, forse perch vede che soltanto dove c acqua c vita. Si tratta, occorre sottolinearlo, di unidea antichissima, che ricorre nei miti e nelle credenze di molti popoli. Anche i miti greci pi antichi pongono lacqua allorigine della realt: Teti e Oceano - due divinit acquatiche sono, per esempio, presentati da
14 Ivi. 15 Cfr. G. REALE, Storia della filosofia antica, 1, Milano 19762, 54-55.
-
14
Omero come i princpi della generazione16. Analoghe personificazioni acquatiche caratterizzano i miti delle origini di altri popoli dellantichit: dalla Mesopotamia allEgitto, dalle culture della costa siro-palestinese e quelle dellAsia Minore il tema delle acque primordiali costantemente attestato. Va rilevato, tuttavia, che Talete, pur proponendo un tema noto, abbandona il linguaggio simbolico del mito adottando termini e concetti razionali. ANASSIMANDRO concittadino e contemporaneo di Talete e come lui si dedica non solo alla filosofia, ma anche allastronomia e alla politica. E lui, stando alla tradizione, che adotta il termine arch per definire la sostanza primordiale. - Per Anassimandro larch non pu consistere in una sostanza definita, come lacqua, laria o il fuoco, perch, se cos fosse, non si spiegherebbe come da essa derivi linfinita complessit del reale. In altre parole, dato che larch il principio di tutte le (diversissime) cose che esistono, non pu essere qualcosa di specifico: come potrebbe, infatti, una realt umida derivare dal fuoco o una secca dallacqua? Per risolvere questa difficolt, Anassimandro afferma che il principio, larch, una sostanza indefinita, indeterminata: solo ci che indeterminato pu infatti acquisire tutte le determinazioni. Con termine greco, essa si chiama peiron: che letteralmente significa senza confine, cio indefinito. Da questo principio primo indeterminato traggono origine, secondo Anassimandro, tutte le cose; in esso tutte si dissolvono quando si conclude il tempo loro assegnato dalla legge suprema e immutabile che governa la realt del cosmo. - Anassimandro si anche posto il problema di come la realt derivi dallarch, cio di come vada concepito il processo di generazione di tutte le cose dal principio primo. E, secondo lui, un processo di separazione di contrari: dallunica sostanza originaria, lpeiron, si distaccano coppie di contrari (caldo e freddo, secco e umido, ecc.) dalle quali trae progressivamente origine tutta la realt. Si generano cos mondi infiniti che si succedono in un ciclo eterno. Ogni mondo nasce, dura un certo tempo e quindi muore: tutto definito da una legge cosmica immutabile. Anassimandro, in un suo celebre e misterioso frammento, parla di una colpa che tutti gli esseri devono espiare: Tutti gli esseri devono, secondo lordine del tempo, pagare gli uni agli altri il fio (che significa espiare la colpa) della loro ingiustizia. Di quale ingiustizia e di quale colpa parla qui Anassimandro? Qual lingiustizia che tutti gli esseri commettono e devono perci espiare? E probabile che essa si colleghi alla nascita stessa degli esseri, che, come abbiamo visto, avviene per separazione di contrari dalla sostanza primordiale: Evidentemente - scrive Abbagnano -
16 Omero chiama Oceano origine degli di (Iliade, 14, 201) (ovvero che di tutti i numi fu origine, ivi, 246). Oceano era concepito come un fiume, che, situato agli estremi confini della terra, rifluisce su se stesso, in un cerchio ininterrotto, alimentando tutti i fiumi e tutti i mari. Ad Oceano Omero affianca Teti, che chiama madre (ivi, 201): la sua compagna, madre dei suoi figli (i tremila fiumi e le tremila oceanine; cfr. ESIODO, Teogonia, 337; 367); cfr. K. KERENYI, Gli di e gli eroi dei Greci, 1, tr. it. Milano 1963; 19863, 21-2.
-
15
questa separazione la rottura dellunit, che propria dellinfinito; il subentrare della diversit, quindi del contrasto, l dove erano lomogenit e larmonia.17 - Anassimandro propone anche alcune dottrine sulla natura del cosmo curiose ma interessanti: innanzitutto afferma linfinit dei mondi, non solo nel tempo (infiniti mondi si susseguono in un ciclo eterno), ma anche nello spazio (essi sono infiniti anche contemporaneamente nello spazio); dice che la terra di forma cilindrica e sta sospesa nel mezzo delluniverso senza nessun sostegno che la regga; pensa infine che gli uomini non siano gli esseri originari della natura, perch - diversamente dagli animali - quando nascono non sono autosufficienti: traggono quindi origine da altri animali, in particolare dai pesci (una sorta di anticipazione della dottrina dellevoluzione delle specie ); si vedano a questo proposito i testi citati nellappendice. ANASSIMENE di Mileto, forse discepolo di Anassimandro, vive verso la met del VI secolo a. C. Secondo lui, come gi per Talete, larch una sostanza determinata e specifica: non si tratta per dellacqua, ma dellaria. Spiega Anassimene: Come la nostra anima, che aria, ci sostiene, cos il soffio e laria circondano il mondo intero. Come lpeiron di Anassimandro, laria di Anassimene infinita e in perenne movimento. Il mondo appare quindi come una sorta di grande essere vivente. Dallaria traggono origine tutte le cose che esistono e questo avviene attraverso un duplice processo di rarefazione e condensazione: la prima d luogo al fuoco, la seconda al vento, poi alle nuvole e quindi allacqua, alla terra, alle pietre. Come Anassimandro, anche Anassimene ritiene che il mondo segua un processo ciclico di nascita, morte e rinascita: periodicamente esso si discioglie nel principio originario - laria - da cui ha tratto origine, dal quale poi nasce un altro mondo e cos via in eterno. 3 LA SCUOLA PITAGORICA - E difficile, per non dire impossibile, distinguere Pitagora dai pitagorici, cio dalla sua scuola, innanzitutto perch egli non scrive nulla e di lui non sappiamo quasi niente di preciso; le notizie che abbiamo, infatti, sono in gran parte tarde e condizionate dal fatto che, dopo la sua morte (e forse gi negli anni conclusivi della sua vita), viene venerato dai suoi seguaci quasi come un dio e questo fa fiorire intorno alla sua figura leggende, per esempio quelle dei suoi viaggi in paesi lontani (soprattutto in Egitto) presso i saggi di vari popoli18. 17 Cit. 36. E bene sottolineare che qui il concetto di colpa non ha nulla a che fare con luomo, come noi siamo abituati a ritenere quando lo utilizziamo (per esempio nel racconto biblico del paradiso con il peccato, quindi la colpa, di Adamo ed Eva): si dovrebbe piuttosto intendere questa colpa nel senso di evento negativo, dato che lesistenza delle cose possibile sono se si frantuma loriginaria unit dellapeiron, che, come abbiamo detto, era concepita da Anassimandro (e dal pensiero greco antico in generale) come perfezione. In sostanza, il mondo esiste solo perch qualcosa di perfetto (il principio, lapeiron) che esisteva, unico e completo, allorigine venuto meno, si spezzato nelle coppie di contrari, che, al contrario, non possiedono la caratteristica dellunicit (e quindi della perfezione). 18 Scrive in proposito Diogene Laerzio: Essendo giovane ed amante dello studio, emigr dalla patria e fu iniziato in tutti i misteri greci e barbari. Fu in Egitto [...]. e poi presso i Caldei ed i Magi. Poi a Creta, con
-
16
Pitagora nasce a Samo verso il 570 a. C. e lapogeo della sua vita si ha verso il 530; emigra poi in Italia meridionale dove fonda (Crotone, Locri, Taranto, Metaponto) delle scuole che non hanno come scopo principale la ricerca filosofico-scientifica, ma linsegnamento di una dottrina di salvezza, rispetto alla quale scienza e filosofia sono non il fine ma il mezzo; la scuola pitagorica appare dunque come una vera e propria confraternita di tipo religioso, obbligata al rispetto di precise regole di convivenza e di comportamento, simile quindi alle associazioni degli orfici; le dottrine che vi vengono insegnate sono segrete, fatto questo che ne impedisce la divulgazione e la conoscenza (diversamente da quanto accade per le altre scuole filosofiche). - Il principio che i filosofi ionici avevano identificato nellacqua, nellaria o nellpeiron viene identificato dai pitagorici nel numero e negli elementi che lo costituiscono: Pensarono - scrive Aristotele - che gli elementi del numero fossero gli elementi di tutte le cose, e che tutto luniverso fosse armonia e numero; questa affermazione si collega al fatto che i Pitagorici sono stati i primi cultori della matematica (possiamo dire gli inventori della matematica come scienza): ecco perch sono stati anche i primi a notare che unamplissima serie di fenomeni e realt naturali sono riconducibili a rapporti numerici e perci esprimibili in linguaggio matematico. Notano in primo luogo come la musica sia traducibile in matematica (e la coltivano come strumento di purificazione) quindi evidenziano lincidenza del numero in molti fatti naturali: lanno, le stagioni, i giorni, i ritmi della natura, ecc. Ma ascoltiamo la testimonianza di Aristotele: Poich i numeri sono per natura primi nelle matematiche, e nei numeri essi credevano di trovare, pi che nel fuoco e nella terra e nellacqua, somiglianze con le cose che sono e che divengono, e poich inoltre vedevano espresse dai numeri le propriet e i rapporti degli accordi numerici, poich insomma ogni cosa nella natura appariva loro simile ai numeri, ed i numeri apparivano primi tra tutto ci che in natura, cos pensarono che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose che sono e che il mondo intero fosse armonia e numero19. Riassumendo, i pitagorici, cultori della matematica, poich avevano notato che molti aspetti della realt sono riconducibili al numero, ritengono che esso sia larch. - Va per precisato a questo punto, per comprendere appieno la dottrina pitagorica, che il numero veniva concepito diversamente da come lo concepiamo oggi: per noi esso infatti unastrazione mentale, frutto delle operazioni della nostra mente; per i pitagorici invece qualcosa di reale, di concreto e proprio per questo pu essere - come lacqua di Talete - il principio di tutte le cose; - Tuttavia, per i Pitagorici, il numero non il principio primo assoluto: deriva infatti da qualcosa di pi primario, da princpi pi elementari: gli elementi costitutivi del numero. Secondo la testimonianza del pitagorico Filolao (V secolo a. C.), i principi supremi del numero sono lillimitato (o indeterminato) e il limitante (o determinante); dato che, come detto, il numero ritenuto dai
Epimenide [...] e in Egitto conobbe glimpenetrabili (misteri) e fu istruito nei segreti circa gli Dei (Vite dei filosofi, VIII, I, 1-3). 19 Citato in M. DAL PRA, Sommario di storia della filosofia, 1, Firenze 197514, 9.
-
17
pitagorici il principio primo e della realt, questi elementi, che stanno allorigine del numero, sono i princpi supremi di tutte le cose. - Dunque il numero generato dal combinarsi di una componente indeterminata e da una determinante; si tratta cio, come dice Reale, di un imbrigliamento dellillimitato o indeterminato nei confini del limite e della determinazione; I due elementi sono presenti in ogni numero, ma nei numeri pari prevale lelemento illimitato, nei dispari il limitante; - Questa affermazione pu essere compresa se si pensa al modo in cui venivano rappresentati i numeri, cio come insieme di punti disposti in modo geometrico; se infatti rappresentiamo in questo modo un numero pari vediamo come il processo di divisione non incontra nessun limite: invece rappresentiamo i numeri dispari, la divisibilit incontra un punto di arresto. Si vedano in proposito i disegni riportati sul libro di testo a pag. 17. - Dunque illimitato e limitante sono i princpi primi della realt; da essi tra origine il numero che proprio una sintesi dei due elementi, sintesi che vede prevalere nel pari lelemento illimitato, nel dispari il limitante - La concezione pitagorica del numero come essenza delle cose conduce a concepire luniverso in un modo del tutto nuovo rispetto alla scuola di Mileto: si tratta infatti dun universo in cui gli elementi contrastanti si pacificano in una superiore armonia; infatti un universo costituito secondo armonie numeriche; in questo universo, interamente dominato dal numero, regna il pi perfetto ordine ( un vero e proprio cosmo, secondo il significato greco del termine kosmos, che significa, appunto, ordine); il mondo non dunque governato da forze oscure e misteriose, e nemmeno il campo dazione del cieco e indecifrabile destino: un ordine razionale, che la mente umana, razionale anchessa, pu serenamente indagare; lordine dice numero e numero dice razionalit, conoscibilit e permeabilit al pensiero (Reale); qui vediamo uno degli aspetti storicamente pi importanti del pitagorismo: molti secoli dopo, la scienza moderna riprender lidea che luniverso sia nella sua struttura pi profonda governato da leggi matematiche e che pertanto luomo possa, attraverso la matematica, comprenderlo. - Come si diceva, per i pitagorici, la scienza non concepita come fine per luomo, ma come mezzo in vista di ulteriori fini; occorre ora spiegare quali fini. E opportuno a questo proposito ricordare che Pitagora insegnava - come gli orfici (dai quali la riprende) - la dottrina della metempsicosi: lo spirito deve, come punizione di una colpa originaria, incarnarsi pi e pi volte in differenti corpi, non solo umani, ma anche animali; lo spirito dunque esiste prima del corpo e continua a vivere dopo la morte di questultimo ( cio immortale); la sua unione al corpo non per conforme alla sua natura, ma , al contrario, la punizione di una misteriosa colpa originaria. Bisogna perci vivere non in funzione del corpo (come pensavano tradizionalmente i Greci) ma dello spirito: questo significa che, nel corso della vita, bisogna impegnarsi per purificare lo spirito, cio per scioglierlo dal legame che lo incatena al corpo, in modo che, alla morte, esso possa liberarsi e vivere nella beatitudine senza pi reincarnarsi.
-
18
- Si tratta di dottrine che certamente il pitagorismo riprende dallorfismo; la differenza sta nel fatto che per gli orfici la via che conduce alla purificazione (e liberazione) dello spirito costituita da riti, pratiche religiose e norme rigorose di vita; i pitagorici invece, pur avendo anchessi regole rigorose di condotta (il vegetarianismo, per esempio) ritengono che lo strumento primario di purificazione-liberazione sia la conoscenza: sono dunque la scienza e la filosofia la via principale che permette alluomo di liberare il suo spirito, la strada primaria della purificazione; - Le pratiche pitagoriche di purificazione dello spirito pongono al primo gradino la musica, che (come detto) lespressione pi immediata dellarmonia numerica che costituisce il cuore stesso della realt; in sostanza, se la realt armonia di numeri, la musica il modo pi semplice, immediato ed efficace per percepire questa armonia, e quindi per avviarsi alla piena comprensione delle cose. Non un caso che i novizi, appena ammessi nella scuola pitagorica, debbano tacere ed ascoltare, considerate come le cose pi difficili da imparare; solo in un secondo tempo loro concesso fare domande sulla musica, poi sullaritmetica e la geometria, infine sul cosmo e le realt naturali; il maestro parla loro nascosto dietro una tenda, per separare il pi possibile il sapere, la verit, dalla persona che la comunica fisicamente; di qui la celebre formula auts fa (ipse dixit, lha detto lui): Pitagora lautorit assoluta, il depositario del sapere supremo. 4 - ERACLITO - Eraclito nasce ed Efeso, nella Jonia, intorno al 540 a. C., da una famiglia di nobili origini. Scrive unopera composta di aforismi di tono misterioso e oracolare, che difficile interpretare con certezza: di qui il soprannome loscuro che sin dallantichit associato aL suo nome20. Della sua vita si sa pochissimo: legato alle tradizioni aristocratiche della sua famiglia, entra in conflitto con la citt, che non riconosce pi il diritto dei re e dei nobili e sviluppa forme di organizzazione democratica. Contro i democratici e il popolo, Eraclito polemizza, con tono superbo e altezzoso: disprezza la gente comune, il dmos e lo fa oggetto di ironia e scherno spesso assai aspri21. - A suo avviso, gli uomini comuni non sanno elevarsi fino alla verit: vagano nellerrore e, anche quando la verit viene loro indicata, si comportano come se non la conoscessero. La massa, i pi, gli appare come composta di dormienti, cio di uomini incapaci di andare oltre le apparenze e di capire le leggi autentiche del mondo. Solo ai filosofi, agli svegli, concesso accedere al nucleo pi profondo delle cose, alla verit che sta al di l della apparenze. - Il vero fi losofo sa superare le idee comuni, le false certezze e, scandagliando in solitudine la propria anima, riesce a scoprirne linfinita complessit (Tu non troverai i confini dellanima - scrive Eraclito - per quanto vada innanzi, tanto profonda la sua ragione). E proprio linfinit dellanima 20 Secondo la tradizione, Eraclito deposit il suo libro nel tempio di Artemide, chiedendo che non fosse reso pubblico prima della sua morte. 21 Si narra che, ammalatosi gravemente, Eraclito rifiut le cure dei medici profani e, cosparsosi il corpo di sterco, si lasci sbranare dai cani sulla piazza centrale.
-
19
rende senza fine la ricerca del filosofo, che ricerca della verit. Il vero filosofo sa giungere ad una visione globale della realt, mentre i cultori delle discipline specialistiche e delle tecniche non sanno uscire da unottica settoriale e quindi parziale. Il vero filosofo sa definire e seguire un codice di comportamento e di vita indipendente, spesso divergente dai gusti e dalle inclinazioni della massa; disprezza per es., i piaceri del corpo, che giudica propri degli animali e non delluomo. - Nella storia della filosofia Eraclito celebre come il f i losofo del divenire: per lui la realt infatti caratterizzata dal perenne fluire, dal continuo, incessante cambiamento, proprio come un fiume, le cui acque sono sempre diverse (Non possibile discendere due volte nello stesso fiume, n toccare due volte una sostanza mortale nello stesso stato). Dunque tutto cambia, (pnta ri, tutto scorre, la celebre affermazione di Eraclito), tutto in perenne mutamento, perch tutto soggetto al tempo e al divenire; anche ci che appare statico, fermo, in realt dinamico perch immerso nello scorrere del tempo. - Immagine per eccellenza del divenire universale il fuoco, che di tutti gli elementi naturali lunico incessantemente in movimento. Ecco perch Eraclito afferma che proprio il fuoco il principio di tutte le cose: vuole indicare con ci che questo elemento, distruttore e trasformatore per eccellenza, rappresenta in modo esemplare la natura pi profonda della realt, caratterizzata prorio dal continuo mutamento, dalla perenne trasformazione. - Questo incessante cambiare delle cose, questo loro divenire, , secondo Eraclito, frutto della contrapposizione dei contrari: tutta la realt infatti caratterizzata dalla presenza di elementi opposti, in conflitto permanente tra di loro. Ecco cosa intende Eraclito quando afferma, in un altro celebre frammento, che plemos, la guerra, padre di tutte le cose: La contraddizione, il divenire, il mutamento universale - scrive F. Vegetti - vanno riconosciuti come caratteri essenziali e insopprimibili del mondo in cui viviamo. La realt in perpetuo fluire e trasformarsi, nel reciproco conflitto di tutte le cose; la Guerra, dice Eraclito, il padre del mondo. C conflitto tra gli uomini, e c conflitto nella natura, i cui elementi - acqua, aria, terra, fuoco - lottano per la supremazia, si trasformano luno nellaltro, si sottomettono a vicenda () In ogni cosa, in ogni fase ed aspetto della realt si cela la lotta implacabile degli opposti, che premono incessantemente verso la trasformazione degli equilibri raggiunti22. Tutto quindi cambia, tutto diviene e questo determinato dallopposizione dei contrari, che il cuore stesso della realt. - I contrari, per, che sono il motore del divenire universale, sono s opposti tra di loro, ma anche complementari, cio incapaci di esistere luno senza laltro: lottano quindi fra di loro, ma ognuno ha bisogno dellaltro, si completano e si integrano a vicenda. Emerge cos un quadro armonico della realt: essa pu apparire caotica e disordinata, dato che lotta di tutto contro tutto, ma, guardata in profondit, rivela un perfetto ordine interiore, in cui tutti gli elementi hanno la loro ragion dessere, in cui ogni cosa non pu esistere senza il suo contrario.
22 M. VEGETTI, Filosofia e sapere della citt antica, in AA.VV., Filosofie e societ, 1, Bologna 1975, 48.
-
20
- Eraclito afferma quindi che c nel mondo, al di l del suo perenne e conflittuale divenire, una profonda razionalit, che determina la superiore armonia del tutto. Il fatto che ovunque nella realt dominino lotta e scontro non significa perci che il caos sia signore del mondo, anzi, vero il contrario: in questa lotta ogni elemento indispensabile, tutto segue un ordine definito in una superiore, perfetta armonia23. - In uno dei suoi pi celebri (e discussi) frammenti Eraclito afferma: Il tempo della vita (= la realt) un fanciullo che gioca, gioca con le tessere (della scacchiera): il regno di un fanciullo. E possibile che il fiosofo voglia qui affermare che nella realt, come nel gioco di un bambino, non c un fine, non c uno uno scopo. Il gioco del bambino fine a se stesso e cos la realt delluniverso, casuale e priva di finalismo. Il che, ovviamente (come si spiegato sopra) non significa che la realt sia caos, ma soltanto che essa non attua alcun piano, alcun progetto. 5 - PARMENIDE - Con la scuola eleatica, che deve il suo nome alla colonia greca di Elea, in Campania (presso Paestum), la filosofia intraprende unindagine diversa da quella che caratterizza la scuola jonica di Mileto: gli Jonici, infatti, avevano ricercato la sostanza primordiale, il principio fisico (arch) capace di spiegare la complessit mutevole e molteplice della realt naturale; gli Eleati, invece, incentrano la loro riflessione sulla ricerca dellessere vero, della realt perfetta che sta dietro quella - ingannevole - che ci mostrano i sensi24. Infatti, i sensi non ci presentano la realt vera, ma unapparenza falsa e ingannevole; solo la ragione in grado di condurre alla verit. - Fondatore della scuola eleatica Parmenide di Elea, vissuto tra il 550 e il 450 a. C. Illustr la sua dottrina in unopera in versi intitolata Intorno alla natura, il cui proemio (ne restano 154 versi) certamente una delle pi famose e discusse pagine dellintera storia della filosofia. Esaminiamone brevemente I temi principali: - Parmenide immagina di trovarsi in compagnia di fanciulle divine, le figlie del sole, su un carro trainato da cavalle focose. Le ragazze indicano la via da seguire, una via che conduce alle case della notte e di qui verso la luce, fino a raggiungere una misteriosa porta, dalla quale si dipartono gli opposti sentieri della notte e del giorno. La porta, munita di architrave, ha una soglia di pietra ed chiusa da grandi battenti: le chiavi che li aprono sono nelle mani della dea Giustizia (Dike), che molto punisce. A lei le figlie del sole rivolgono parole soavi, convincendola ad aprire la porta. Il carro pu allora procedere e cos Parmenide giunge al cospetto duna
23 Eraclito esprime questo fondamentale concetto con unaltra celebre metafora: gli opposti che sono presenti nella realt sono s luno contro laltro, ma il loro contrapporsi genera una sostanziale armonia, proprio come accade nellarco e nella lira, strumenti in cui il contrasto degli elementi genera larmonico funzionamento del tutto. 24 La domanda di fondo della filosofia jonica : qual il principio che permette di spegare la realt naturale? La domanda dei filosofi di Elea invece: come si caratterizza lessere vero? Qual il vero essere: quello che ci mostrano i sensi o quello che ci presenta la ragione?
-
21
misteriosa Dea25, che gli rivolge queste parole: O giovane, tu che, insieme a immortali guidatrici, con le cavalle che ti portano, giungi alla nostra dimora, rallegrati, poich non uninfausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino infatti esso fuori dalla via battuta dagli uomini , ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda: sia il solido cuore della Verit ben rotonda sia le opinioni dei mortali, nelle quali non c vera certezza. - Il proemio parmenideo un testo molto complesso, ricco di simboli e allegorie che non facile decifrare. Schematicamente, si pu affermare quanto segue:
a) il viaggio che porta il filosofo al cospetto della Dea lavventura di un essere umano che oltrepassa i confini dellesperienza terrena abituale e che, proprio per questo, abbisogna dellaiuto divino; un viaggio verso la verit, il cammino di ricerca del sapiente, guidato dalla rivelazione della dea cos come gli antichi naviganti erano guidati dalla stella polare26. E il viaggio che porta al sapere, a quello che la dea chiama il solido cuore della Verit ben tonda, un viaggio che Parmenide ha compiuto e che invita il suo lettore ad intraprendere.
b) Le figure e gli oggetti che compaiono nel testo hanno sicuramente un valore simbolico, che gi gli antichi si sono sforzati di decifrare. Scrive in proposito Carlo Sini: Tutto questo esordio o proemio del poema stato interpretato sin dallantichit (per es. da Sesto Empirico) in modo allegorico. Le cavalle simboleggerebbero gli impulsi e i desideri irrazionali dellanima; la via delle Dee la via del pensiero e della saggezza (filosofia); le fanculle sono le sensazioni () La giustizia e le sue chiavi che aprono e chiudono stanno per la ragione che giudica del vero, dicendo s e no 27.
c) La dea che rivela a Parmenide la verit dellessere potrebbe essere la grande dea-madre caratteristica delle culture mediterranee e vicino-orientali; essa, diversamente dagli di olimpici, molteplici e diversi tra loro, unica, come unico lo vedremo lessere parmenideo.
- A Parmenide la Dea dice che ci sono due strade per luomo che ricerca: quella della verit, altheia, che si fonda sulla ragione e conduce alla conoscenza dellessere vero; quella dellopinione, doxa, che si fonda sui sensi e porta alla conoscenza dellessere apparente. Solo la prima strada veritiera; la seconda inevitabilmente fallace e ingannevole. In altre parole: luomo
25 Il tono misterioso e oracolare dei versi di Parmenide fa pensare che egli appartenesse a una cerchia aristocratica nella quale si credeva che il sapere fosse riservato a pochi eletti. Non un caso che, in questa celebre pagina, Parmenide presenti il suo messaggio filosofico come una rivelazione divina: Il sapere ha per Parmenide unorigine divina ed una sanzione celeste, proprio come voleva la tradizione religiosa e sacrale; ma il suo contenuto nuovo e razionale (DAL PRA, cit., 19). 26 E. FAGIUOLI, in AA. VV., Dal senso comune alla filosofia, 1, Milano 2001, 475. 27 C. SINI, I filosofi e le opere, 1, Milano 1986, 48.
-
22
deve decidere se affidarsi alla ragione o ai sensi: nel primo caso potr raggiungere la verit, nel secondo rimarr invece prigioniero delle opinioni ingannevoli e false. - Domandiamoci ora, finalmente, dove conduce la via della ragione, a quale verit assoluta porta chi la segue. Ascoltiamo ancora le parole del filosofo, leggendo due frammenti del suo proemio: Fr. 2: Orbene, io ti dir e tu ascolta e ricevi la mia parola - quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare: luna che e che non possibile che non sia ( il sentiero della Persuasione, perch tien dietro alla Verit) laltra che non e che necessario che non sia. E io ti dico che questo un sentiero su cui nulla si apprende. Infatti, non potresti conoscere ci che non , perch non cosa fattibile, n potresti esprimerlo; Fr. 6: necessario il dire e il pensare che lessere sia: infatti lessere , il nulla non : queste cose ti esorto a considerare. - Dunque la via della ragione mostra alluomo in tutta la sua evidenza la verit fondamentale: LESSERE E E NON PUO NON ESSERE, IL NON-ESSERE NON E E NON PUO IN ALCUN MODO ESSERE. Questo significa che soltanto lessere vero, reale, pensabile, esprimibile, mentre il non-essere falso, irreale, non-pensabile e non pu in nessun modo essere espresso. - Spiega Giovanni Reale: Lessere la sola cosa pensabile ed esprimibile; qualsiasi pensare, per essere tale, pensare lessere, al punto che si pu dire che pensare ed essere coincidono, nel senso che non c pensiero che non esprima lessere; viceversa, il non essere del tutto impensabile, inesprimibile, indicibile e quindi impossibile28. Scrive Giovanni Di Napoli: Parmenide dice che di tutto, nei nostri giudizi, si afferma che ; quindi in ogni giudizio c lessere; lessere in tutto, tutto, e tutto lessere. Chi pensa o parla, pensa e dice sempre lessere, mai il nulla; solo lessere quindi pensabile ed esprimibile; il nulla o non-essere impensabile e inesprimibile29 - Dunque la verit suprema che la Dea rivela a Parmenide e che egli pone al centro del suo pensiero che soltanto lessere esiste, pensabile, esprimibile, mentre il non-essere (cio il nulla) impensabile, inesprimibile e quindi inesistente. - Da questa affermazione fondamentale Parmenide trae con estremo rigore logico importanti conseguenze: deduce infatti una serie di attributi dellessere, di caratteri che lo qualificano e lo definiscono. In altri termini: partendo dalla certezza che solo lessere esiste ed pensabile, Parmenide deduce le caratteristiche o propriet dellessere. Queste caratteristiche devono escludere in modo categorico tutto quello che implica il non-essere30: a) lessere ingenerato: infatti, se fosse generato, dovrebbe derivare o dallessere, e in tal caso esisterebbe gi, o dal non-essere, il che impossibile (visto che, come si detto, il non essere non esiste);
28 Storia della filosofia antica, 1, cit., 122. 29 G. DI NAPOLI, Storia della filosofia, 1, Brescia 1967, 40. 30 In sostanza: dato che solo lessere pensabile e reale, tutto quello che, in un modo o nellaltro, implica, richiede, rende necessario il non-essere va scartato, va considerato inaccettabile.
-
23
b) lessere imperituro e incorruttibile: perch se si corrompesse e morisse dovrebbe diventare non-essere, il che , nuovamente, impossibile31; c) lessere immutabile, senza passato n futuro, fuori del tempo, eterno: infatti, se cos non fosse, se cio lessere fosse sottoposto al tempo e avesse un passato e un futuro, significherebbe che non pi quello che era nel passato, e non ancora quello che sar in futuro; ma entrambe queste affermazioni implicano il non-essere e quindi sono false; d) immobile, perch se si muovesse non sarebbe pi dovera prima; e) unico: se infatti ce ne fosse un altro luno non sarebbe laltro e di nuovo ci troveremmo di fronte ad unaffermazione che implica il non-essere; f) finito, perch secondo da mentalit greca, solo ci che finito perfetto: La finitudine sinonimo di compiutezza e perfezione e Parmenide per esemplificare tale compiutezza usa limmagine della sfera, intesa appunto come una sorta di pieno assoluto da cui risulta assente il non-essere32. - Da tutto quanto precede derivano conseguenze rilevantissime e decisive per la storia della filosofia: il mondo in cui viviamo, infatti, cos come ce lo mostrano i sensi, non corrisponde alle caratteristiche del vero essere definite dalla ragione (ed elencate da Parmenide). E infatti un mondo: a) in perenne cambiamento, b) nel quale si trova uninfinit quantit di cose diverse: in sostanza, mentre la ragione ci dice che lessere vero immutabile ed unico, i sensi ci testimoniano che la realt mutevole e molteplice. Si apre cos un dissidio tra sensi e ragione, dissidio che Parmenide affronta e risolve con logica ferrea: il mondo che ci mostrano i sensi, dice, non vero, ma solo unillusione, una ingannevole apparenza; solo il perfetto essere definito dalla ragione (immutabile e unico) esiste ed assolutamente vero33. La ragione, quindi, contraddice 31 Dice Parmenide: Lessere ingenerato e imperituro, infatti un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. N una volta era, n sar, perch ora insieme tutto quanto, uno, continuo n il nascere n il perire concesse a lui la Giustizia, sciogliendolo dalle catene, ma saldamente lo tiene. E pi oltre: E come lessere potrebbe esistere nel futuro? E come potrebbe essere nato? Infatti, se nacque, non ; e neppure esso , se mai dovr essere in futuro. 32 ABBAGNANO, FORNERO, cit., 51. Scrive Parmenide: E rimanendo identico e nellidentico, in s medesimo giace, e in questo modo rimane l saldo. Infatti, Necessit inflessibile lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tuttintorno, poich stabilito che lessere non sia senza compimento: infatti non manca di nulla; se, invece, lo fosse, mancherebbe di tutto () Inoltre, poich c un limite estremo, esso compiuto da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera, a partire dal centro uguale in ogni parte: infatti, n in qualche modo pi grande n in qualche modo pi piccolo necessario che sia, da una parte o da unaltra. 33 Parmenide dunque costretto dalla sua riflessione filosofica a negare sia la molteplicit sia il divenire, due caratteri della realt che invece i sensi ci testimoniano costantemente. Ricordo che: molteplicit significa che la realt del mondo composta da un gran numero di cose diverse tra loro, divenire che la realt del mondo in perenne mutamento. Il mondo che ci sta dinnanzi scrive Emanuele Severino nella sua infinita variet di aspetti (molteplice, ndr.) e nella sua incessante mutazione (mutevole, ndr.) non ha alcuna Verit (sunque non ): soltanto una gigantesca apparenza illusoria in cui I mortali ripongono ogni fiducia i mortali, che sono appunto coloro che non seguono il sentiero della Verit. Con Parmenide la filosofia si presenta come la sfida pi radicale rivolta al comune modo di pensare degli uomini (La filosofia dai Greci al nostro tempi, cit., p. 73).
-
24
quello che noi percepiamo tramite i sensi: la realt ci appare (come la mostrano I sensi) in un modo ma il vero essere in un altro modo (come ci attesta la ragione). Percezione sensibile e conoscenza razionale divergono: la cosiddetta aporia34 eleatica, che apre un vasto dibattito nella filosofia successiva e segna una linea di demarcazione fondamentale nella storia della filosofia antica (e di tutta la filosofia occidentale). - Completare lo studio di Parmenide leggendo il paragrafo La problematica identificazione dellessere parmenideo, a pag. 34 del libro di testo. Tra i seguaci di Parmenide spicca la figura di Zenone di Elea, suo successore alla guida della scuola, di circa 25 anni pi giovane del maestro e quindi nato probabilmente verso il 490 a. C. La tradizione ce lo descrive come uomo di grande coraggio: Poich volle abbattere il tiranno Nearco scrive Diogene Laerzio fu messo in prigione Allora, sottoposto ad interrogatorio circa i suoi complici e intorno alle armi che aveva portate a Lipari, denunzi tutti gli amici del tiranno, poich si era proposto di ridurlo allisolamento; poi gli disse che intorno a certe persone aveva da comunicargli alcuni particolari nellorecchio, glielo morsic e non lasci la presa finch non fu trafitto35 - La dottrina parmenidea, con le sue conclusioni drastiche, suscita subito grandi discussioni, sembrando a molti assurda e paradossale perch contrastante con i dati dellesperienza. Zenone si assume il compito di difendere linsegnamento del suo maestro da questi attacchi e lo fa usando un metodo originale: cerca di sostenere le tesi di Parmenide confutando quelle dei suoi critici. Nasce cos scrive Reale quel metodo di dimostrazione che, invece di provare direttamente una tesi, partendo da determinati princpi, cerca di provarla riducendo allassurdo la tesi contraddittoria36. In questa difesa Zenone abilissimo: i suoi ragionamenti stringenti, la sua logica ferrea, il rigore straordinario delle sue argomentazioni lo rendono celebre presso i contemporanei e pi tardi Platone stesso dir di lui che parlava con unarte da far sembrare agli uditori le medesime cose nello stesso tempo simili e dissimili, una e molte, immobili e mobili - Come si visto, la dottrina di Parmenide nega sia il movimento sia la molteplicit e proprio questa negazione al centro delle obiezioni dei suoi avversari. Zenone cerca di dimostrare che ammettere movimento e molteplicit comporta pi problemi e assurdit che non negarli; lo fa con i suoi celebri paradossi. I pi interessanti sono senza dubbio i quattro che riguardano il
34 Il vocabolo greco apora significa difficolt, incertezza, da poros, luogo impervio, luogo dal quale non c via duscita; nel suo significato filosofico il termine indica un problema per il quale difficile trovare una soluzione razionale, poich tutte le soluzioni appaiono possibili. E sinonimo di dubbio razionale e di coscienza problematica; cfr. F. P. FIRRAO, Dizionario dei termini e delle correnti filosofiche, Firenze 1995, 22. Le aporie sono i dubbi della ragione, scrive L. MAIORCA, Dizionario di filosofia, Napoli 1999, 20. 35 Citato in REALE, 1, cit., 132. 36 Ivi, 133.
-
25
movimento: con argomenti rigorosi, Zenone dimostra che il movimento assurdo (e che quindi bene ha fatto Parmenide a negarne lesistenza):
a) argomento dello stadio: Per percorrere uno stadio necessario percorrerne prima la met; ma prima occorre percorrerne la met della met, e cos di seguito fino allinfinito; e siccome linfinita divisibilit dello spazio non pu venir esaurita, il movimento sar impossibile37;
b) argomento dellAchille, cos illustrato da Aristotele: Esso dice che il pi lento non sar mai raggiunto nella corsa dal pi veloce. Infatti necessario che chi insegue giunga prima al punto da cui partito chi fugge, cosicch il pi lento si trover sempre necessariamente un po pi avanti del pi veloce38. Quindi Achille, il pi veloce degli uomini, non raggiunger mai una tartaruga che si muova un passo davanti a lui, perch ad ogni avanzamento di Achille ne corrisponde uno della tartaruga;
c) argomento della freccia: quando vediamo una freccia scoccata dallarco pensiamo che si stia muovendo, ma in realt in ogni singolo momento occupa un punto nello spazio e in ogni punto la sua valocit pari a zero39; ma la somma di stati di quiete non pu produrre movimento (0+0=0), quindi esso soltanto apparente;
d) argomento delle masse nello stadio: In uno stadio un punto mobile va ad una certa velocit, e simultaneamente al doppio di essa, a seconda che sia rapportato ad un punto immobile oppure ad un punto moventesi in senso contrario alla stessa velocit, generando in tal modo lassurdo logico che la met del tempo uguale al doppio40.
- Con questi argomenti, destinati a conoscere un successo straordinario nella storia del pensiero, Zenone vuole fornire un sostegno indiretto alle tesi del suo maestro: vuole cio dimostrare che Parmenide ha ragione nel negare la realt del movimento, perch chi la ammette cade in contraddizioni logiche insormontabili. Si noti bene: Zenone non vuole negare il fatto che il movimento si veda, che si colga coi sensi (sarebbe unassurdit): vuole invece dimostrare che esso razionalmente inspiegabile, con questo concermando le tesi di Parmenide. La tradizione indica come fondatore della scuola eleatica non Parmenide, ma Senofane, nato a Colofone nella Jonia verso il 570 a. C., ma presto trasferitosi nellItalia meridionale, dove, girando di citt in citt, vive molto a lungo, superando i centanni di et. Oggi questa teoria viene respinta sia perch il pensiero di Senofane affronta problematiche diverse da quelle degli Eleati sia perch non documentato nessun rapporto tra questo autore e la citt di Elea.
37 DI NAPOLI, cit., 41. 38 Citato in REALE, 1, cit., 135. 39 La freccia spiega Aristotele - non si muove dal momento che nulla si muove nellistante. 40 ABBAGNANO, FORNERO, 1, cit., 54.
-
26
- Senofane poeta, autore di elegie e satire, ma anche filosofo, forse autore dun trattato intitolato Della natura. Il tema di fondo che sviluppa nei suoi carmi la critica della concezione tradizionale degli di, codificata nei poemi di Omero ed Esiodo. A Senofane questa concezione appare inaccettabile per via del suo antropomorfismo, cio della convinzione che gli di abbiano aspetto, forma e sentimenti uguali a quelli degli uomini. Scrive:
- Omero ed Esiodo hanno attribuito agli di tutto quanto oggetto di onta e di biasimo: rubare, fare adulterio e ingannarsi reciprocamente
- Ma i mortali credono che gli di siano nati e che abbiano abito, linguaggio e aspetto come loro. Ma se i se i buoi, i cavalli e i leoni avessero mani e potessero con le loro mani disegnare e fare ci appunto che fanno gli uomini, i cavalli disegnerebbero figure di di simili ai cavalli e i buoi simili ai buoi, e farebbero corpi foggiati cos come ciascuno di loro foggiato
- Gli Etiopi dicono che I loro di sono neri e camusi, i Traci dicono invece che hanno occhi azzurri e capelli rossi.
- La critica di Senofane prende dunque di mira la tradizionale concezione greca del divino e i poeti che lhanno avallata e incoraggiata. Secondo lui, Dio non assomiglia in nulla agli uomini, n nellaspetto esteriore n nel pensiero; questo Dio si identifica alluniverso, un di Dio-tutto, eterno, immutabile, che non nasce e non muore41, sempre uguale a se stesso. Cos Senofane lo descrive: Uno, dio, tra gli di e tra gli uomini il pi grande, n per aspetto simile ai mortali, n per intelligenza. Tutto intiero vede, tutto intiero pensa, tutto intiero ode. Ma senza fatica con la forza del pensiero tutto scuote. Sempre nellidentico luogo permane senza muoversi per nulla, n gli si addice recarsi or qui or l42. - Alcuni hanno ritenuto di poter qualificare la dottrina di Senofane come monoteistica, ma, come ben sottolinea Reale, uninterpretazione antistorica: Infatti, in primo luogo, essa contraria allo spirito di tutta le grecit, al quale rimasto sempre del tutto estraneo il problema se Dio sia uno o sia molti, perch non ha affatto colto la contraddittoriet fra laffermazione che Dio uno e Dio molti, ma ha ritenuto del tutto naturale che il divino, per la sua stessa natura, avesse molteplici affermazioni o manifestazioni di varia specie () In secondo luogo, il verso di Senofane, nellistante stesso in cui parla di Dio al singolare, lo compara e lo pone al di sopra degli Di al plurale. Inoltre egli parla di Dio al singolare e di Di al plurale alternativamente senza discriminazione in tutti I frammenti () Dunque il Dio uno di cui parla Senofane il Dio-cosmo che non esclude ma ammette altri Di o enti divini (siano essi parti del cosmo o forze del cosmo o altre cose che dagli scarsi frammenti non si riesce a determinare43
41 Ricordo che gli di greci, compreso Zeus, sono immortali ma non eterni. 42 SINI, 1, cit. 47. 43 Cit., 113- 114.
-
27
6 PLURALISTI: Empdocle e Anassgora - I filosofi che vengono dopo lElatismo scrive Abbagnano - tornano ad interessarsi del problema della natura. Tuttavia, anche per essi, Parmenide non passato invano. Anzi, la loro filosofia rappresenta un primo tentativo di sintesi fra lEraclitismo e lEleatismo (come vedremo, il secondo tentativo sar fatto da Platone). Da Eraclito e dalla scuola ionica essi accettano lidea del divenire incessante delle cose. Da Parmenide accolgono invece il concetto delleternit ed immutabilit dellessere. Ma come conciliare le opposte affermazioni del divenire delle cose e delleternit e immutabilit del vero essere? Questi filosofi risolvono il problema distinguendo nella realt i composti (mutevoli) e gli elementi (immutabili). Essi ritengono, infatti, che le cose del mondo siano costituite di elementi eterni, ad esempio gli atomi (Democrito), che unendosi tra di loro danno origine a ci che noi chiamiamo nascita e disunendosi provocano ci che noi chiamiamo morte. In tal modo essi finiscono per giungere al principio secondo cui, in natura, nulla si crea e nulla si distrugge veramente, ma tutto si trasforma soltanto. Tali filosofi vengono anche detti Fisici pluralisti, in quanto ritengono che i princpi della natura siano molteplici44 - Dunque dopo Eraclito e Parmenide la filosofia torna ad occuparsi, come nella scuola jonica, del problema cosmologico, cio della realt fisica, ma deve comunque fare I conti con il pensiero dei due grandi filosofi. Deve cio cercare di conciliare la dottrina eraclitea del divenire con quella parmenidea dellessere: Parmenide dice che lessere immutabile ed eterno, Eraclito che la realt in perenne cambiamento. Come mettere daccordo queste due tesi opposte? E, daltro canto, come conciliare quello che ci dice la ragione (lessere e non pu non essere, come afferma Parmenide) con quello che attestano i sensi (la realt cambia di continuo, come dice Eraclito)? La soluzione adottata dai filosofi pluralisti semplice e geniale: la realt composta da elementi che sono, come lessere di Parmenide, eterni e immutabili; cambia invece il loro modo di combinarsi, che d origine a tutte le cose sensibili45. E un po quello che accade in un caleidoscopio: le perline che esso contiene non cambiano mai, a cambiare sono invece le loro combinazioni, che danno origine a figure sempre diverse. Alla base della realt, secondo i pluralisti, ci sono alcuni elementi (non uno solo come pensavano gli ionici) che non mutano mai; essi, combinandosi tra loro, originano tutte le cose. Queste combinazioni sono variabili, di qui la mutevolezza della realt. EMPEDOCLE: nasce verso il 492 ad Agrigento e vive circa sessantanni; oltre che filosofo medico, guaritore, scienziato, mago, mistico. Uomo dalla fortissima personalit, partecipa anche alla vita politica nel partito democratico. Sulla sua morte circolano molte leggende, la pi celebre delle quali afferma che sia caduto nel cratere dellEtna. Scrive due opere, Sulla natura e Carme lustrale, delle quali restano numerosi frammenti. 44 ABBAGNANO, FORNERO, 1, cit., 57. 45 Pluralismo2 la concezione per la quale il principio delle cose non unico, ma molteplice; diversamente da Talete, Anassimandro e Anassimene, che avevano identificato un solo arch, i pluralisti pensano infatti che i princpi siano molteplici (quattro per Empedocle, infiniti per Anassagora e Democrito).
-
28
- E scrive Reale il primo pensatore che cerca di risolvere laporia eleatica, tentando di salvare, da un lato, il principio che nulla nasce e nulla perisce e che lessere sempre permane e, dallaltro, i fenomeni che lesperienza ci attesta46. Empedocle ritiene, accogliendo la dottrina di Parmenide, che nascere e perire intesi come venire dal nulla o andare al nulla siano impossibili47: essi devono perci venire interpretati come un mescolarsi e un dissolversi di elementi eterni. Se una cosa nasce perch gli elementi che la compongono si associano, se muore perch si dissociano: Unaltra cosa dir scrive -: non v nascita dalcuna delle cose mortali, n termine di morte funesta; ma solo il mescersi e dissolversi di sostanze commiste v fra gli uomini e ha nome nascita48. Dunque il nascere e il morire delle cose sono in realt il mescolarsi e il disgiungersi degli elementi che le compongono. - Gli elementi che compongono la realt sono secondo Empedocle quattro: fuoco, aria, terra, acqua49. Tutte le cose esistenti, dunque, derivano dal mescolarsi e dal disgiungersi di questi quattro elementi che sono dunque le radici (rizmata) della realt; cambia il loro modo di combinarsi, e di conseguenza cambia la realt sensibile, ma essi sono eterni, indistruttibili e immutabili. - I quattro elementi si uniscono e si disgiungono continuamente, dando cos luogo a tutte le manifestazioni della vita, ma cosa li spinge a congiungersi e separarsi? Unione e divisione sono determinate, secondo Empedocle, da due forze cosmiche opposte, una che unisce e laltra che disgiunge: le chiama, antropomorficamente, Amore e Odio. Esse sono eterne, come gli elementi e prevalgono ora luna ora laltra secondo cicli costanti determinati dal Destino. - C una fase in cui prevale completamente Amore e gli elementi sono tutti congiunti e raccolti insieme in ununit indifferenziata, senza potersi distinguere luno dallaltro e quindi senza che possa esistere il mondo in cui viviamo. Empedocle chiama questa unit Sfero: ricorda molto la sfera di Parmenide. Quando prevale lOdio gli elementi invece si disgiungono, senza nessuna possibilit di incontrarsi: ovviamente anche in questo caso non esiste la realt del mondo. Perch essa possa costruirsi devesserci alternanza di Amore e Odio: il primo determina il nascere del cosmo, il secondo il suo distruggersi per dar vita a un altro cosmo. Ovviamente la perfezione data dallimmobile, originaria unit dello Sfero.
46 REALE, 1, cit., 151. 47 Fanciulli! Breve volo hanno i loro pensieri, essi credono che possa nascere ci che prima non era, o che alcuna cosa perisca e si distrugga del tutto. Poich non v mezzo che nulla sorga da ci che prima non era, e che ci che perisca vana cosa sarebbe senza termine alcuno; infatti (lessere) sempre sar l ovunque ci si debba sempre arrestare; ivi, 151-152. 48 Citato ivi, 152. 49 Perch Empedocle abbia creduto che gli elementi di base della realt siano proprio quattro non si sa con esattezza: Da un lato spiega Reale egli pot essere suggestionato dalla tetrade pitagorica, cio dalla convinzione della natura privilegiata del numero quattro: ma fu certamente determinante la costatazione dellesperienza, che sembra appunto attestare che tutto deriva da aria, acqua, terra e fuoco (cit., 153).
-
29
- Di grande interesse sono le riflessioni di Empedocle sul problema della conoscenza, uno dei pi importanti della filosofia50. Secondo lui, dalle cose che ci circondano si sprigionano effluvi che colpiscono i nostri organi di senso, i quali li riconoscono in base al principio per cui il simile conosce il simile. Infatti tutta la realt, come sappiamo, fatta di acqua aria terra e fuoco, e anche luomo si compone di questi elementi: orbene il fuoco che in noi conosce quello che viene (per effluvio) dalle realt esterne e lo stesso accade con gli altri tre elementi: onde con la terra scorgiamo la terra, con lacq