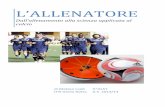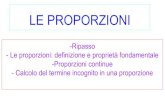Esame di stato Anno scolastico 2013/2014 - nattabg.gov.it · La tesina è stato elaborata in modo...
Transcript of Esame di stato Anno scolastico 2013/2014 - nattabg.gov.it · La tesina è stato elaborata in modo...
1
Esame di stato – Anno scolastico 2013/2014
“Un mondo che ruota intorno al denaro”
di
Marco Galbusera
I.S.I.S "GIULIO NATTA"
ISTITUTO TECNICO - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Europa 15 - 24125 Bergamo Tel. 035 319376 Fax. 035 316449
e-mail: [email protected]
2
Sommario
1) Introduzione
2) Note
3) Filosofia - Marx e le teorie del Capitale
4) Italiano - Denaro e letteratura
5) Storia – La crisi del’29 e il New Deal
6) Fisica - L’elettroscopio e le banconote false
7) Sitografia e bibliografia
3
Introduzione
La tesina è stato elaborata in modo completo ed in proporzione al tempo disponibile per
l’esposizione orale durante il colloquio di fine esame.
Ho scelto di portare l’argomento sopracitato (un mondo che ruota intorno al denaro), poiché lo
ritengo concreto e costante nel tempo.
Questo periodo di crisi inoltre mi ha fatto riflettere e rielaborare pensieri sul perché il denaro sia
cosi importante nella vita dell’essere umano.
Fin dagli inizi il denaro è stato l’elemento separatore fra le classi sociali, lo strumento di conquista
dei beni, l’elemento scatenante di guerre e successivamente fonte di riappacificazioni, il denaro ha
condizionato sempre la vita delle persone e anche di intere popolazioni.
Troppe volte i ricchi hanno aumentato il loro potere a discapito dei poveri, solo per il fatto che
possedevano ciò che fa ruotare il mondo: il ‘vile’ denaro.
Alcuni sostengono che con i soldi non si possa comprare tutto, io sono dell’idea che con i soldi si
può comprare molto, perché tutto ha un prezzo, (bisogna solo saper fare affari).
Viviamo in un mondo basato sulla circolazione di denaro e ritengo che partendo da una buona
situazione economica, i problemi della vita possono essere molto ridimensionati oserei dire quasi
dimezzati.
4
Note
Durante le ricerche via web e su supporti cartacei mi sono imbattuto in queste due citazioni del noto
John Maynard Keynes, economista inglese, personaggio fondamentale del ’900.
Le ritengo significative soprattutto riguardo al momento economico in cui ci troviamo e
strettamente collegate agli argomenti trattati in seguito.
“L'importanza dei soldi deriva essenzialmente dall'essere un legame fra il presente ed il futuro”
John Maynard Keynes
(Aforisma)
“Quando si risparmiano cinque scellini, si lascia senza lavoro un uomo per una giornata”
John Maynard Keynes
(da Esortazioni e profezie, il Saggiatore, Milano, 1968, p. 122)
5
[Filosofia]
Marx e le teorie del Capitale
Breve biografia
Karl Marx nacque a Treviri il 15 Maggio 1818. I genitori erano ebrei, tuttavia Marx non fu educato alla fede
ebraica. Dopo il liceo, si laureò in filosofia.
Dopo aver tentato la carriera accademica, si dedicò al giornalismo e divenne redattore della "Gazzetta
Renana". Il giornale fu però censurato e Marx si vide costretto a trasferirsi a Parigi. Qui conobbe Bakunin e
soprattutto Friedrich Engels (1820-1895), che gli sarà amico e collaboratore per tutta la vita. Nel 1844
pubblicò,” La questione ebraica e l’Introduzione alla Critica della filosofia hegeliana di diritto pubblico”.
Sempre nel ’44 scrisse i “Manoscritti economico-filosofici”.
Successivamente si trasferì a Bruxelles dove, insieme ad Engels, scrisse “La sacra famiglia (1845)”, che
segnò il distacco dalla Sinistra hegeliana; “L’ideologia tedesca” e le “11 Tesi su Feuerbach”.
Nel 1847 la Lega dei Comunisti chiese a Marx di scrivere un manifesto del loro movimento ed egli accettò
pubblicando nel 1848 il famoso “Manifesto del partito comunista”.
Nel 1864 fondò l’associazione internazionale dei lavoratori, conosciuta come la Prima Internazionale.
Nel 1867 pubblicò il primo libro de “Il Capitale”. Gli altri due appariranno postumi a cura di Engels.
Marx morì il 14 Marzo 1883 ed è sepolto nel cimitero di Highgate a Londra.
Il Capitale
Nella sua opera “ Il Capitale ”, Marx mostra e critica i meccanismi strutturali della società borghese; questo
libro è considerato il suo capolavoro.
Innanzitutto, a differenza dei grandi teorici dell’economia borghese, Marx ritiene che non esistano leggi
universali dell’economia e che ogni formazione sociale abbia caratteri e leggi storiche specifiche; è convinto
che la società borghese e il capitalismo portino contraddizioni strutturali.
6
Teorie del plusvalore
Secondo Marx il guadagno deriva dalla speculazione degli imprenditori sulla forza – lavoro spesa dagli
operai. Questo significa che un imprenditore al fine di arricchirsi deve sottopagare i propri operai oppure
farli lavorare più ore senza pagarli, in modo da vendere la merce sempre per quello che vale ma non pagando
adeguatamente il lavoro per la produzione del prodotto.
Gli operai d’altronde sono costretti a lavorare alle condizioni che detta l’imprenditore perché devono anche
loro procurarsi denaro per i beni primari.
Dunque il plusvalore che una merce acquista (ossia il profitto che l’imprenditore ricava da una merce
investendo parte del suo capitale sotto forma di salario per i dipendenti) dipende dal plus-lavoro (che è quel
lavoro in più non retribuito che un operaio compie per produrre una merce).
È possibile l’aumento del plusvalore attraverso 2 metodi fondamentali:
1 ) il prolungamento della giornata di lavoro (plusvalore assoluto);
2) la riduzione della giornata di lavoro necessario (plusvalore relativo).
Il plusvalore viene reinvestito dal capitalista per non soccombere alla concorrenza. In tal modo
l’accumulazione del capitale, se da una parte concentra la ricchezza nelle mani di un numero sempre minore
di capitalisti, dall’altra, attraverso l’eliminazione dell’operaio per mezzo di nuove macchine, genera sempre
disoccupazione e di conseguenza più miseria.
7
[Italiano]
Denaro e letteratura
Introduzione Il denaro è tema letterario di lunga durata, fin dall’antichità.
Che il denaro e le monete siano argomenti dell’ambito economico è ovvio e, proprio perché apparentemente
specialistico, tendiamo nell’insegnamento/apprendimento dell’italiano a non affrontare questo tema.
Ma riflettiamo! Il denaro, d’oro, d’argento, di carta che sia, è un denominatore comune a tutte le società di
tutti i tempi, che testimonia il passaggio dal baratto all’uso di quello che ancora oggi usiamo per gli scambi
economici: il denaro.
Solo con la novella e il teatro del Settecento le vicende economiche si fanno motore dell’azione (oggetto del
desiderio, motivo di conflitti e rivalità) : in un contesto mercantile che non riconosce altro valore né altra
autorità.
Che le ricchezze materiali siano il tema per eccellenza, in tutti gli episodi della ‘storia sociale’ ricostruiti dal
romanzo realista, non stupisce. Basti pensare ad esempio in Balzac, il vecchio Grandet guadagna con il
commercio una ricchezza enorme(Eugénie Grandet); l’onesto profumiere César Birotteau fa il passo più
lungo della gamba, lanciandosi in disastrose speculazioni, e finisce rovinato: (Histoire de la grandeur et de la
décadence de César Birotteau); per l’usuraio protagonista di Gobseck, oro e denaro sono strumenti di potere
e del desiderio esclusivi. Il denaro è la monomania di tutti i personaggi balzachiani. Perfino il patetico
protagonista del Père Goriot, non esita a dichiarare che «l’argent, c’est la vie»; e a ammettere che il soldo,
quasi personificato, «fa tutto» («monnaie fait tout»).
Perfino nella tradizione pullulano i patti con il diavolo, cui i protagonisti vendono l’anima, o l’ombra, o il
riflesso (insomma, l’identità), sempre in cambio di potere e denaro. Lo schema è ovunque lo stesso.
Il romanzo realista
Il romanzo realistico riflette la realtà della società ottocentesca attraverso l'analisi di individui che
rappresentano figure emblematiche della propria epoca e della propria classe sociale. Questo genere, che
rappresenta una sorta di specchio della società contemporanea, si diffonde in tutta Europa a partire dagli anni
trenta.
Gli elementi principali del romanzo sono considerati la trattazione seria dei fatti e l'inserimento di persone e
avvenimenti sempre della realtà quotidiana.
Tipico del romanzo realista è il mito del self-made man il quale allude a un’ascesa sociale a volte frutto di
sacrificio e lavoro mentre in altri casi attraverso il gioco e la speculazione in borsa, la caccia alla dote e
soprattutto all’eredità, la quale si trasforma in lotta senza esclusione di colpi, in squallida faida familiare.
I testi letterari dedicano un’attenzione marginale alle realtà produttive, moltiplicando invece le
rappresentazioni di pericolose alternative.
8
Verga e la roba
La produzione di Giovanni Verga (1840-1922) è, in gran parte, specchio della vita dell’autore, soprattutto
quando descrive il desiderio di successo e, nel contempo, il sacrificio delle radici, delle tradizioni e degli
affetti in nome della conquista dell’obiettivo.
Il successo economico lo baciò non tanto per la vasta produzione romanzesca, che ottenne un certo consenso
da parte della critica, anche se non di pubblico, ma in seguito alla sceneggiatura di una sua novella: la
Cavalleria rusticana.
Un personaggio su tutti è, però, la stigmatizzazione dell’idolo della roba e del possesso, quel Mazzarò che è
descritto nella novella “La roba”.
Cresciuto lontano dagli affetti familiari e dalle amicizie, dedito soltanto al lavoro, inizia ad acquistare terreni
con i soldi che riesce ad accantonare col sudore. Ben presto il suo diventa un patrimonio non monetario, ma
fondiario, tanto che i suoi possedimenti assorbiranno anche quelli del barone presso cui lavorava.
Non un piacere o un affetto amicale. «Non beveva vino, non fumava, non usava tabacco […]. Non aveva il
vizio del gioco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre».
Alla morte della madre, si dispiace solo del fatto che abbia dovuto impegnare «dodici tarì» per il suo
funerale. La gente lo invidiava, ma non sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna.
Il tempo passa inesorabile anche per Mazzarò, la vecchiaia incombe segnando sempre più la sua solitaria
lamentela: «Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando
arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla!». Quando Mazzarò si ammala e i medici gli
comunicano che ha poco tempo da vivere, furioso ammazza «le sue anitre e i suoi tacchini», gridando: «Roba
mia, vientene con me».
Come è noto il personaggio di Mazzarò sarà lo spunto per la genesi del romanzo Mastro Don Gesualdo.
L’omonimo protagonista rispecchia in parte il suo antenato per l’arricchimento e la scalata sociale, ma ha un
cuore che palpita e una consapevolezza che si risveglia in lui di fronte alla malattia e alla solitudine. Nel
corso degli anni il muratore si arricchisce e diventa imprenditore. Trova l’amore nella figura della serva
Diodata da cui ha anche dei figli. Preferisce, però, sposarsi con un’aristocratica spiantata, Bianca Trao, da cui
riceve il titolo nobiliare, ma non l’affetto. Anzi, l’accesso alla classe sociale aristocratica è mal visto dai
parenti di lei e dagli altri nobili e, nel contempo, accresce la distanza dai vecchi amici più poveri. Morta la
moglie e ammalatosi, Mastro Don Gesualdo trascorrerà le ultime settimane di vita lontano dalle sue terre, nel
palazzo della figlia Isabella nota come la duchessa di Leyra. Questa frutto, in realtà, della relazione che
Bianca Trao aveva avuto prima di sposarsi, non avrà mai rapporto con il padre.
Tristi sono le ultime pagine del romanzo in cui il protagonista in maniera cosciente percepisce di essere solo.
Lei, la figlia, è una Trao, un’aristocratica, lui, Gesualdo, sente di essere un Motta.
Il povero Gesualdo si congeda dalla vita, solo, senza il conforto di alcuno, anzi vilipeso dai servi, che non
tollerano che uno nato povero possa cambiare classe sociale.
9
[Storia]
La crisi del ’29 e il New Deal
Introduzione
Nel primo dopoguerra l'economia degli Stati Uniti ebbe un forte incremento, dovuto anche alla grande
richiesta d'investimento che veniva dall'Europa per la ripresa delle varie potenze che avevano partecipato al
primo conflitto mondiale. In America dal 1922 al 1929, infatti la produzione industriale aumentò del 64%, la
produttività del lavoro del 43%, i profitti del 76% e i salari del 30%.
Ma nel 1929 accadde quello che è storicamente conosciuto come la grande crisi del ’29, che diede vita alla
Grande Depressione. Fu un gravissimo tracollo economico che, partendo dagli USA, sconvolse
l’economia mondiale alla fine degli anni venti, con forti ripercussioni durante i primi anni del decennio
successivo.
Cause della crisi
La crisi iniziò ufficialmente con il crollo della Borsa di Wall Street che segnò la distruzione, di molti settori
industriali e imprenditoriali i quali avevano avuto una notevole crescita economica.
La crisi coinvolse profondamente gli Stati Uniti d’America, colpendone duramente i salari e i prezzi al
consumo e bloccandone gli scambi commerciali interni e internazionali, oltre ad aumentare il livello di
disoccupazione.
Le cause della depressione, quindi, furono sia interne all’economia statunitense, sia di carattere
internazionale.
Le cause interne furono una conseguenza del boom economico successivo alla Prima Guerra Mondiale.
Durante tale periodo, infatti, molti settori economici legati direttamente o indirettamente al mercato
dell’auto, al settore edilizio o più comunemente ai beni durevoli, ebbero uno sviluppo progressivo che
permise una crescita di produttività, di consumi e di salari, che assieme costituirono una formula di crescita
apparentemente inarrestabile. Praticamente, invece, tale sviluppo proseguì non senza alterazioni o non
senza ostacoli, nulla è infinito e la crescita non può essere infinita.
Ad un certo punto, infatti, il potere d’acquisto cominciò a diminuire non sostenendo più l’alta produttività
delle industrie. Inoltre il sistema borsistico americano era drogato da una bolla speculativa, soprattutto sui
titoli azionari di quelle società le quali erano state protagoniste del boom economico.
Le cause internazionali della crisi che si spostò dagli Stati Uniti d’America al resto dell’Europa furono
molteplici: i dazi doganali che impedivano al surplus produttivo di trovare degli sbocchi commerciali
adeguati, costrinsero le industrie e le imprese ad abbassare i prezzi rendendo tali beni non più convenienti e
quindi a fermarne la produzione.
Anche la Rivoluzione russa fu una causa poiché isolò molti stati dal resto del mondo dando vita ai piani
quinquennali di programmazione economica, i quali non prevedevano scambi e acquisti con le nazioni al di
10
fuori della sua area di influenza. Inoltre i principali paesi europei, durante il conflitto mondiale, si erano
indebitati pesantemente con Gli Stati Uniti e avevano caricato i loro debiti sulle riparazioni di guerra della
Germania, piegando pesantemente il sistema economico di quel paese.
Il New deal e le teorie di Keynes
Nel 1932, Franklin Delano Roosevelt (democratico e unico presidente con 3 mandati), dopo il governo di
Herbert C. Hoover il quale era repubblicano, venne eletto presidente e seppe imprimere un nuovo corso
all'economia americana e alla sua politica, introducendo una forte regolamentazione governativa ed un
pacchetto di progetti ambiziosi di lavori pubblici, al fine di aumentare la richiesta di manodopera e
migliorare le infrastrutture della federazione.
Il nome con cui è conosciuta questa svolta è “New Deal”.
Le politiche di tutti i governi precedenti si erano basate sul concetto liberista del laissez-faire, secondo il
quale lo Stato non deve intervenire negli affari dell'economia.
Roosevelt vide la situazione come una crisi di tipo strutturale a differenza di Hoover, il quale sosteneva che
la crisi sarebbe stata passeggera o più precisamente, in linguaggio tecnico economico, contingente.
La differenza principale stava nel fatto che in un’economia liberista lo stato non doveva intervenire al fine di
bilanciare la richiesta tra domanda e offerta, mentre nella nuova politica economica del New Deal lo stato si
faceva imprenditore.
Questo fu lo schema rotto da Roosevelt, che anzi aumentò come mai prima il controllo e l'intervento statale
sull’economia.
Le sue teorie economiche ricalcavano quelle dell'economista John Maynard Keynes, riconosciuto tra i più
grandi economisti del secolo e fautore della necessità dell'intervento statale nell'economia, sia con misure
fiscali che monetarie.
A livello prettamente tecnico, fu abbandonato il sistema di cambi fissi (in modo di favorire maggior libertà
nell'utilizzo della spesa pubblica, volta soprattutto, come si è visto, alle opere pubbliche); fu elaborato un
programma di sostegno ai prezzi agricoli ed un sistema di sussidi per chi avesse ridotto la produzione; si
monitorò il settore industriale, invitando le industrie a tenere alti sia i prezzi che i salari; si cercò,
complessivamente, di attuare un primo modello americano di Welfare State, attraverso sussidi per la
disoccupazione, salari minimi garantiti, servizi sociali gratuiti.
Quel che accadde, grazie a Roosevelt e al suo New Deal, fu che presto l'economia americana ricominciò a
crescere e la depressione a diventare un ricordo.
Per la diffusione di queste nuove teorie e per l'iniezione di nuovi dosi di ottimismo, Roosevelt scelse la radio,
infatti resteranno famosi i suoi interventi radiofonici in cui parla alla nazione, cercando di risvegliarne
l'orgoglio e lo spirito originario. Questi interventi passeranno alla storia come le conversazioni al caminetto.
11
[Fisica]
L’elettroscopio e le banconote false
Introduzione
L'elettroscopio è un semplice strumento con il quale è possibile rilevare la carica
elettrica di un corpo.
Esso è costituito da un pomello metallico collegato, tramite un'asta metallica, a due
sottili lamine metalliche chiamate "foglioline". Queste ultime sono racchiuse in un
recipiente di vetro per evitare il disturbo da parte di correnti d'aria esterne.
Avvicinando al pomello metallico (sfiorandolo), un corpo caricato
elettricamente, ad esempio una bacchetta di ebanite strofinata con un panno di lana,
si vedranno le due lamine divergere. La vicinanza del corpo elettricamente carico
produce un fenomeno fisico detto induzione elettrostatica . Le due lamine saranno
pertanto cariche dello stesso segno e si respingeranno. Allontanando il corpo carico,
detto anche corpo induttore, le due lamine tenderanno ad riavvicinarsi.
Nel caso in cui col corpo induttore si tocchi il terminale superiore, le due foglie rimarranno divise anche
dopo il suo allontanamento poiché in questo modo una parte della carica del corpo induttore si trasferisce
all'elettroscopio. Le foglioline si riavvicineranno e poi a poco a poco perderanno la carica.
Le banconote false
Le carta per le banconote degli Euro è tutta uguale: è carta cellulosa che si ottiene lavorando fibre di cotone.
Ovviamente questa tipologia di carta non la si trova in commercio. Inoltre gli scanner per il riconoscimento
delle banconote non riconoscono la tipologia di carta o il disegno, ma bensì utilizzano l’induzione
elettrostatica.
Come è possibile ciò?
Le banconote sono trattate con speciali vernici, le quali essendo magnetiche emettono un campo elettro-
magnetico. Lo scanner composto sia da un elettroscopio si da un elettrometro, in questo modo riesce a
riconoscere se il campo magnetico emanato dalla banconota ha la stessa intensità del campo magnetico di
serie (dettato dalla Zecca), nel caso non coincida la banconota non viene accettata.
12
I falsari difficilmente riescono a superare questo ostacolo, poiché vernici cosi specifiche sono difficili da
trovare in commercio.
Inoltre quando si ha una banconota molto usurata tra le mani e lo scanner non l’accetta, molto probabilmente
è dovuto al fatto che non essendoci più vernice la banconota emette un campo diverso da quello prestabilito.
13
[Sitografia e Bibliografia]
Italiano
http://www.minimaetmoralia.it/wp/denaro-e-letteratura/
http://www.leparoleelecose.it/?p=9556
Libro di testo - Panebianco Beatrice/ Gineprini Mario/ Seminara Simona, Letterautori - Percorsi ed
esperienze letterarie. Il secondo Ottocento e il Novecento-Contemporaneità e postmoderno. Vol. 3,
Zanichelli, 2011
Filosofia
http://www.antimperialista.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2228:la-crisi-
capitalistica-cause-e-soluzioni-keynes-e-marx-a-confronto&catid=170:crisi-sistemica&Itemid=27
Libro di testo - La Vergata Antonello/ Trabattoni Franco, Filosofia cultura cittadinanza - Da
Schopenhauer a Oggi, La Nuova Italia, 2011
Storia
http://www.sansepolcroliceo.it/olocausto/Elementi_Storici/Crisi_29.html
Libro di testo - Manzoni Marco/ Occhipinti Francesca/ Cereda Fabio, Leggere la storia. Vol. 3. Dai
nazionalismi alla II guerra mondiale. Dalla guerra fredda alla globalizzazione, Einaudi Scuola, 2007
Fisica
Libro di testo – Walker, Corso di fisica. Vol.3. Elettromagnetismo fisica atomica e subatomica,
Linx, 2010