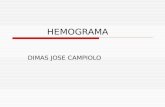ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA · La CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE è l’insieme...
-
Upload
nguyendang -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA · La CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE è l’insieme...
IPC MARCO POLO VENTIMIGLIA
ISISS FERMI POLO MONTALE Autore: prof. Giancarlo Memmo
ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA
PARTE SECONDA
1
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA
PARTE SECONDA
11. I DATI DELLA CONTABILITA’ NAZIONALE.
12. IL PRODOTTO NAZIONALE E INTERNO.
13. I VARI MODI DI CALCOLARE IL PRODOTTO NAZIONALE.
14.IL REDDITO NAZIONALE.
15. I DOCUMENTI DELLA CONTABILITA’ NAZIONALE.
16. GLI INDICATORI DELLO SVILUPPO.
17. GLI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA.
18. I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PUBBLICA.
19. RIASSUNTO CONCLUSIVO DEL MODULO.
2
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
I DATI DELLA CONTABILITA’ NAZIONALE
La CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE è l’insieme dei conti mediante i quali si descrivono quantitativamente la situazione del sistema economico in un determinato arco di tempo, solitamente un anno. La differenza tra flussi e stock: il caso del PIL (prodotto interno lordo): ANNO 2016 ANNO 2017= +18%
PIL Paese A= 2.200 MLD euro STOCK= consistenza patrimoniale finale FLUSSO= incrementi/decrementi economico finanziari Quindi ogni flusso è destinato a modificare gli stock
ISTAT
RILEVAZIONI CONTABILI
CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE
AGGREGAZIONE
DATI ECONOMICI
SERVIZI
INDUSTRIA
AGRICOLTURA
INDUSTRIA
AGRICOLTURA
SERVIZI
STOCK
FLUSSO=18%
3
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
PIL OCCUPATI ITALIA: PERCENTUALE OCCUPATI NEI SETTORI AIS
AGRICOLTURA
I N D U S T R I A
TERZIARIO (S)
PRIMARIO
(A)
SECONDARIO (I)
Considerazioni: 1) Un paese viene definito
industrializzato quando il numero degli occupati nell’industria supera di almeno il 10% il numero degli occupati in agricoltura;
2) La presenza di un terziario non sempre è un indice “positivo” soprattutto se il terziario è solo statale;
3) Il numero di addetti o occupati in rapporto ai settori e alla relativa percentuale rispetto all’intero PIL, ci può dare informazioni sul grado di efficienza economica del settore (per esempio pochi occupati che producono un buon valore aggiunto in agricoltura;
4) Primario perché fornisce input economici all’industria (secondario) e lo sviluppo dell’industria fornisce input economici ai “servizi” (terziario).
SERVIZI PAESE INDUSTRIALIZZATO
4
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
1970 ⇒ SEC (**) = modello europeo armonizzazione conti (SISTEMA EUROPEO DEI CONTI)
*revisionato ogni 10 anni
** basato sulla partita doppia (in uscita per l’operatore che la origina e in ingresso per l’operatore che la riceve
CONTABILITA’ NAZIONALE: IL CONCETTO DI RESIDENTE
≠
IL PROBLEMA DELLA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO Gli stock e i flussi nulla ci dicono su come il reddito è distribuito tra la popolazione, un primo indicatore grezzo è quello del Reddito pro-capite, cioè:
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑌𝑌𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌
= Ypc (reddito procapite) Y=Yeld=reddito
Tuttavia il dato è molto grezzo, perché è come se tutti prendessero la stessa percentuale di reddito prodotto, ma sappiamo che non è così, sappiamo che i poveri esistono ed esistono coloro che percepiscono meno del reddito procapite. Quindi nonostante la produzione sia “sociale”, la distribuzione del prodotto non è sociale ma avviene a seconda della forza dei gruppi di pressione, per cui in certe
MODELLO SEC 95 (*)
INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI
DEFINIRE I FLUSSI/RELAZIONI
IDENTIFICARE GLI AGGREGATI ECONOMICI
RESIDENTE=SOGGETTO CENTRO PROPRI ………INTERESSI ECONOMICI
INTERNO TERRITORIO ECONOMICO
NAZIONALE
RESIDENTI
INTERNO
NAZIONE
Giuridico Amministrativo
5
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
epoche alcuni gruppi riescono ad accaparrarsi quote crescenti di produzione e in altri periodi storici quote via decrescenti. LA FUNZIONE DI PRODUZIONE
La funzione mette in relazione il prodotto Q con i fattori della produzione K=capitale e L= lavoro, la funzione è costruita tenendo ferma la capacità tecnologica e produttiva (innovazioni e impianti) LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO SOCIALE (REDDITO) Popolazione 100%
75%
50%
25%
Ypc 75% Ynaz Y
Pop x Ypc = Ynazionale
Q q2 q1
K, L L1 L2
ZONA DEI RENDIMENTI DECRESCENTI
ZONA DEI RENDIMENTI CRESCENTI
RENDIMENTI COSTANTI
RENDIMENTI DECRESCENTI O ZONA DELLA DISOCCUPAZIONE NASCOSTA
4
3
2
1
2
3
4
Il 75% del Ynazionale è distribuito al 25% della popolazione e il 75% della popolazione ha il 10% del Ynazionale
6
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
UN METODO DI MISURA DELLA DISEGUAGLIANZA: LA CURVA DI LORENZ E L’INDICE DI GINI Uno dei metodi più interessanti per misurare il grado di diseguaglianza della distribuzione del reddito è costituito dalla cosiddetta curva di Lorenz, rappresentata nella figura 1.
Figura 1 • La retta a 45° indica una distribuzione perfettamente ugualitaria. Ogni punto della curva di Lorenz indica la percentuale di reddito percepita da una percentuale di famiglie. Lo scarto della curva di Lorenz dalla retta a 45°, indicato dall’area ombreggiata, costituisce una misura del grado di diseguaglianza nella distribuzione del reddito.
L’asse verticale indica le percentuali del reddito delle famiglie; l’asse orizzontale indica le percentuali di famiglie. Una distribuzione perfettamente uniforme del reddito si avrebbe qualora il 20% delle famiglie ottenesse il 20% del reddito totale (e anche all’interno di questa fascia la distribuzione risultasse uniforme), il 40% delle famiglie percepisse il 40% del reddito, e così via. La curva tratteggiata della figura rappresenta questo caso di distribuzione perfettamente eguale. La curva di Lorenz descrive, invece, la distribuzione effettiva del reddito: ogni punto della curva indica la percentuale di reddito ricevuto nella realtà da una percentuale di famiglie. Lo scarto della curva di Lorenz dalla curva della perfetta uguaglianza è indicato dall’area ombreggiata, che costituisce una misura del grado di disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Quanto più è ampia quest’area, tanto maggiore è la distanza della distribuzione effettiva dalla perfetta uniformità. Nel caso di completa disuguaglianza, l’area coinciderebbe con il triangolo 0AB.È possibile fornire un indice specifico della disuguaglianza, che è dato dal rapporto tra l’area compresa tra la curva di eguaglianza perfetta e la curva di Lorenz e l’area del triangolo 0AB. Tale indice, definito coefficiente di Gini, assume un valore compreso tra 0 (per l’uguaglianza perfetta) e 1 (per la massima disuguaglianza). (Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012)
Perc
entu
ale
redd
ito
uguaglianza
Curva
A
7
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
http://www.americaoggi.info/2011/10/10/27168-divario-sempre-crescente-buffett-la-lotta-di-classe-esiste-e-labbiamo-vinta-noi (la lotta di classe secondo uno degli uomini piu’ ricchi del mondo)
8
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
IL PRODOTTO NAZIONALE E INTERNO
Gli economisti della scuola neoclassica, non potevano concepire una crisi economica, tutti i mercati sono in equilibrio o vanno in equilibrio, quindi se c’è sottoccupazione i salari diminuiranno fino ad assorbire tutta la mano d’opera disponibile. Quindi il salario W di equilibrio è quello che permette la piena occupazione del lavoro L, l’aumento del reddito complessivo determinerà un aumento del risparmio e secondo Say tutto il risparmio è in equilibrio con l’investimento, cioè la produzione crea la sua domanda….ma la crisi del 1929 fece crollare questa visione economica.
Studiando quella crisi economica Keynes formulò la sua Teoria Generale, criticando la visione neoclassica, introducendo la possibilità per il sistema economico di stare in situazione di sottoccupazione.
Per Keynes l’espansione monetaria da sola non basta per far ripartire il sistema economico, perché la diminuzione del tasso di interesse oltre a creare delle aspettative per la preferenza per la liquidità sul futuro andamento, non va oltre un certo livello in quanto opera la trappola della liquidità: gli operatori si convincono che i tassi di interesse sono così bassi che non potranno che aumentare, quindi preferiscono fare incetta di scorte di liquidità, che potranno utilizzare quando si alzeranno i tassi di interesse valorizzando la loro liquidità (Valore liquidità= tasso di
AD
AS
P1
Q1
P1=indice dei prezzi
Q1= quantità prodotti
P1xQ1= PNL
AD>AS=P1↑↑ inflaz.
AD<AS=P1↓ deflaz.
VISCHIOSITA’ DEI PREZZI: l’aumento dei prezzi è più veloce della diminuzione (crescono velocemente, si abbassano lentamente).
E=EQUILIBRIO
9
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
interesse x quantita’ di moneta) o comprando titoli sfruttando i prezzi più bassi ( i Ptit…ma se mi tengo “liquido”, scommettendo che i tassi di interesse non potranno che aumentare, il Ptit e quindi comprerò..).
Quindi da sola l’espansione monetaria può non bastare a far ripartire il sistema e ha effetti inflazionistici gravi: gli operatori nella zona della trappola della liquidità rimangono “liquidi” e quindi non tutto il risparmio si trasforma in investimento, cade la legge di Say!
A questo punto interviene lo Stato, secondo Keynes solo lo Stato può con il deficit spending (disavanzo di bilancio) fare quelle opere e attività economiche che i privati non sono disposti a fare data la congiuntura negativa…però sono disponibili a prestare soldi allo Stato (debito pubblico).
Quindi nelle crisi è importantissima la leva fiscale (in termini di deficit spending non di nuove tasse perché queste non risolvono il problema e deprimono i consumi e la produzione).
Approfondimenti: 1) Teoria Generale di Keynes; 2) Poltica Monetaria; 3) Preferenza per la liquidità; 4) Trappola della liquidità; 5) Deficit Spending DEFINIZIONI:
Bisogna escludere i beni intermedi nel calcolo per evitare duplicazioni:
Il valore della Pizza venduta, incorpora già il valore della farina acquistata, dei pelati e degli altri ingredienti…
Pizza=100= 40 farina+30 ingredienti+10 altro+ 20 guadagno
Il valore aggiunto VA è dato dalla differenza tra il ricavo complessivo e il costo dei beni intermedi necessari per produrre il bene:
VA=RICAVO - COSTI BENI INTERMEDI
VA Pizza= 100-40-30-10 =20
Il PRODOTTO NAZIONALE LORDO è costituito dalla somma dei valori monetari di tutti i beni e servizi finali prodotti in un anno dagli operatori economici nazionali (imprese, Pubblica Amministrazione, famiglie) sia all’interno che all’estero.
PNL
SOMMA DEI VALORI MONETARI DI TUTTI I BENI E SERVIZI FINALI PRODOTTI
SOMMA DEI VALORI AGGIUNTI DELLE SINGOLE IMPRESE
10
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
In sintesi le differenze:
Il PIL è il valore dei beni e servizi prodotti esclusivamente sul solo territorio nazionale, da operatori economici nazionali o stranieri.
11
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
PILpc= 𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑛𝑛𝑛𝑛𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑟𝑟𝑌𝑌
prodotto pro capite
Il prodotto interno lordo pro capite è comunque una media che nulla ci dice su come è effettivamente distribuito il reddito.
I VARI MODI DI CALCOLARE IL PNL
Ynaz
Tempo
Il prodotto è sociale:
CONSUMO
K, L, T ⇒ MERCATO ⇐ Consumatori
PRODUZIONE
incremento
decremento I
ΔPIL/anno
12
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
1. IL PNL NOMINALE E REALE
ANNO PRODUZIONE PREZZO MONETARIO UNITARIO
PNL
NOMINALE
Δ PNL
1 5 MELE 100€ =500 € PNL1
2 ESEMPIO DI CRESCITA SOLO NOMINALE Pnl2-Pnl1=50
5 MELE 110€ =550 € PNL2
CRESCITA DEL 10% ??????
PRODOTTO NAZIONALE LORDO O NETTO A PREZZI DI MERCATO =
Comprende/non comprende, le imposte indirette
PRODOTTO NAZIONALE NOMINALE = i prezzi dei beni e servizi sono quelli attuali dell’anno considerato.
PRODOTTO NAZIONALE REALE = i prezzi dei beni e servizi sono quelli dell’anno base.
PRODOTTO NAZIONALE NETTO =
PNL - ammortamenti
13
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
2. IL PIL/PNL A PARITA’ DEI POTERI D’ACQUISTO (PPA)
PAESE A (EUROPA) PAESE B (U.S.A.)
Tasso di cambio=
1€=2$
PIL REALE PIL NOMINALE
PIL REALE PIL NOMINALE
5 mele P1=100€
5x100=500€
5 mele P1= 100 $
5x100=500$
PIL NOMINALE ESPRESSO IN $:
500€x2=1000€
PIL NOMINALE ESPRESSO IN €=
500/2= 250€
??????
PILreale A= PIL reale B
PIL€A=500x2=1.000€ ≠ PIL$B = 500 $
Quindi nominalmente il Paese A ha il PIL DOPPIO rispetto al Paese B, ma IL PIL REALE E’ IDENTICO!!!
Per evitare le ILLUSIONI MONETARIE dovute anche ai TASSI DI CAMBIO, dobbiamo chiederci:
quale è la massa monetaria necessaria per acquistare 5 mele?
500€A ⇔ 500$B
Occorre calcolare lo stesso PIL a parità di potere d’acquisto delle valute nazionali.
14
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
IL REDDITO NAZIONALE
PRODUZIONE = 100 AUTO
Prezzo unitario= 10.000 € RICAVO= 1.000.000 €
1.000.000 €
Costo del lavoro
(salari)
AMMORTAMENTO IMPIANTI +
REMUNERAZIONE CAPITALE
PROFITTO
(imprenditorialità)
COSTO OPPORTUNITA’
(Mec)
IL MIGLIOR IMPIEGO
ALTERNATIVO DEL CAPITALE
(monetario)
15
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
Si può pensare per completezza a remunerare anche il fattore produttivo Terra, nel senso che nella parabola neoclassica si può ulteriormente distinguere tra il proprietario degli impianti (il Capitalista, dove il capitale è inteso in senso fisico) e il proprietario della terra dove sorgono gli impianti (la Rendita intesa come remunerazione per il valore della terra occupata dagli impianti produttivi).
A patto che la produzione realizzata, venga tutta venduta, cioè non ci siano crisi di sovrapproduzione (!), possiamo dire che:
π = PROFITTO
Y(yeld)=REDDITO
W (wage)= SALARI
K= capitale fisico (impianti, capannoni, ecc.)
T= RENDITA TERRIERA (sempre in termini di “costo opportunità del miglior impiego alternativo di quella terra)
RICAVO=Y= π+w+T SCOMPOSIZIONE DEI REDDITI DISTRIBUITI DURANTE LA
PRODUZIONE
PRODUZIONE P=prezzo unitario
w=salario unitario
T=rendita terra (affitto terreno)
K=impianti,materie prime, ammortamento e remunerazione dell’investimento
π
bravura imprenditore
100 AUTO 10.000 1.000 100.000 200.000 ammortamenti e materie prime totali
Mec=30%
In dieci anni i 200.000 euro avrebbero reso circa il 30% cioè
50.000 euro
400 OPERAI 400.000
IMPIANTI 250.000
IMPRENDITORIALITA’ 150.000.000
PRODOTTO 1.000.000
N.B. E’ agevole dimostrare che spesso T+K+π, fanno capo ad un’unica persona che è il capitalista, cioè colui che detiene il capitale.
Quindi il PNL o Y o R, è controbilanciato dai redditi distribuiti nella produzione.
16
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
Il Consumo aumenta generalmente all’aumentare del reddito disponibile Yd (al netto delle tasse), ovviamente a un certo punto all’aumentare del reddito, il consumo si stabilizza: solitamente consumano in proporzione al reddito disponibile, molto di piu’ “i poveri” che “le classi abbienti”. In ogni caso un livello minimo di consumo anche in assenza di reddito disponibile deve esserci per la mera sopravvivenza (C0 da indebitamento).
Il Risparmio aumenta anche esso all’aumentare del reddito, tuttavia poiché comporta comunque un Yd per finanziare il Cm o “consumo di cittadinanza” a cui corrisponde un S=0 (le persone hanno qualcosa in più della mera sopravvivenza biologica..), infine -S0 serve per finanziare il C0 (ci si indebita per vivere).
Una ulteriore considerazione lega il Yd all’età degli individui, da cui discende il principio Keynesiano che la popolazione anziana statisticamente risparmia meno (in termini di flussi non di stock e comunque si pensi alla distanza sempre più ampia tra i redditi pensionistici che sono al 40-50% dell’ultimo Yd da lavoro) rispetto alla popolazione giovane.
Y= C+S (mercato)
Y= C+I (produzione)
Y=Y=C+S=C+I
0
Cm
-S0
C0
S, C
S=0 Yd=Ycit
C0
Yd
C
FUNZIONE DEL CONSUMO
C=f(Yd)
C0= consumo irriducibile
C=f (Yd)
S=SAVE =risparmio
Yd
C=f (Yd) FUNZIONE DEL RISPARMIO
S=f (Yd)
-S0 =indebitamento per vivere
EQUILIBRIO
C+S = C+I
S=I
17
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
Quindi il mercato macroeconomico è in equilibrio quando tutto il risparmio S, viene convertito in investimento I.
La natura circolare del Reddito Nazionale è data dal fatto che:
- Le famiglie alle imprese i fattori produttivi con i quali vengono prodotti i beni e servizi che le famiglie stesse acquistano (flusso reale) pagandoli con il denaro ricevuto dalle imprese sotto forma di redditi distribuiti durante la produzione (flusso monetario);
- La Pubblica Amministrazione (PP.AA.) acquista dalle imprese i beni e servizi e dalle famiglie i fattori produttivi necessari per la spesa pubblica (flusso reale) pagandoli con i tributi versati dalle famiglie e dalle imprese (flusso monetario);
18
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
- Gli operatori economici se acquistano beni dall’estero (importazioni), tendono a pagarli in equilibrio con i beni prodotti in loco ma venduti all’estero (esportazioni)
X= esportazioni M=importazioni BP=X-M=bilancia dei pagamenti Per calcolare il valore dei beni e servizi prodotti dalla PPAA, poiché spesso non hanno un prezzo di mercato, si adotta la finzione che il valore sia dato dai costi di personale ecc. necessari per produrli.
N.b.
Se la BP è in negativo, vuol dire che ci stiamo indebitando con operatori esteri per acquistare le importazioni, ciò determina una perdita sul Y nazionale.
EQUAZIONE DEL REDDITO NAZIONALE
Y= C+I+G+BP
19
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
I DOCUMENTI DELLA CONTABILITA’ NAZIONALE
Il BILANCIO ECONOMICO NAZIONALE (quello “pubblico” lo trovate qui: http://www.mef.gov.it/) mostra come vengono impiegate le risorse raccolte e disponibili.
ENTRATE=RISORSE DISPONIBILI USCITE= IMPIEGHI EFFETTUATI
PIL
+
IMPORTAZIONI
CONSUMI
+
INVESTIMENTI PRIVATI E PUBBLICI
+
ESPORTAZIONI
OFFERTA AGGREGATA DOMANDA AGGREGATA
IL CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI
1) https://www.forexguida.com/finanza/il-conto-economico-delle-risorse-e-degli-impieghi.html
2) http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/gascari/macro/Lezione%203.pdf
3) http://www.treccani.it/enciclopedia/contabilita-nazionale_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/
4) https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=6&id=704
20
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
GLI INDICATORI DELLO SVILUPPO
CRESCITA ECONOMICA ≠ SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PROFITTO ≠ UMANAMENTE ACCETTABILE
TUTTO CIO’ CHE E’
PROFITTEVOLE
NON E’
NECESSARIAMENTE
UMANAMENTE
AUSPICABILE
CRESCITA
ECONOMICA
ESTERNALITA’
POSITIVE
NEGATIVE
DISECONOMIE:
es. inquinamento
21
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
PNL=ASPETTI QUANTITATIVI= crescita economica SVILUPPO = ASPETTI QUALITATIVI Es. creo 1.000 posti di lavoro
precari
Dimezzando lo stipendio (job sharing)
Mansioni di basso profilo, ecc.
22
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
Vilfredo Pareto (ottimo paretiano)
Lo sviluppo è fortemente legato al benessere personale nazionale, prevedibilmente una migliore distribuzione del reddito, aumenterebbe il reddito personale disponibile e quindi migliorebbe la propria utilità o benessere.
Pareto per evitare visoni “egualitariste” della società capitalista, coniò la sua definizione e postulato di ottimo paretiano che sostanzialmente afferma che la distribuzione ottimale del reddito deve essere quella che può migliorare la posizione di alcuni ma SENZA PEGGIORARE LA POSIZIONE DI NESSUN ALTRO, in sostanza i margini di distribuzione del prodotto sociale sono affidati ai flussi e non agli stock.
Per approfondire:
1) https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=6&id=2286 2) http://www.treccani.it/enciclopedia/ottimo-di-pareto_%28Dizionario-di-
Economia-e-Finanza%29/ 3) http://www.okpedia.it/ottimo_paretiano
SVILUPPO BENESSERE PIGOU E LA FELICITA’ DELLA NAZIONE
DISTRIBUZIONE DEL REDDITO EGUALITARIA FA AUMENTARE IL BENESSERE NAZIONALE
23
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
GLI INDICATORI DELLA FINANZA PUBBLICA
1. L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA
2. LA SPESA PUBBLICA
3. LE ENTRATE PUBBLICHE
DERIVATI=deriva dalla ricchezza posseduta da
altri soggetti.
LA SPESA PUBBLICA è data dall’insieme dei mezzi finanziari che lo Stato e gli EE.PP. impiegano per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.
Le SPESE DI PRODUZIONE o spese per beni e servizi, sono somme pagate alla PP.AA. per Lavoro, Beni strumentali e Fattori produttivi che servono per produrre BENI E SERVIZI PUBBLICI da mettere a disposizione dei cittadini.
I TRASFERIMENTI sono somme pagate dalla PP.AA. a favore di determinate categorie di soggetti erogate a titolo gratuito.
ENTRATE PUBBLICHE
PREZZI
TRIBUTI
(derivati)
PRESTITI
(derivati)
24
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
Per ENTRATE PUBBLICHE si intende il complesso dei mezzi monetari che entrano nelle casse dello Stato e degli EE.PP. per perseguire le finalità che sono loro proprie.
I PREZZI sono il ricavato della vendita di beni e servizi prodotti da imprese o della vendita di beni facenti parte del patrimonio pubblico.
I TRIBUTI sono la principale fonte di entrate dello Stato, sono prelevamenti di denaro fatti ai cittadini avvalendosi del potere coercitivo dello Stato, che gli deriva dalla sua sovranità in questo settore.
IMPOSTE ⇒ finanziano i servizi indivisibili (difesa, ordine pubblico, sanità, tutela ambientale).
TASSE ⇒ finanziano i servizi divisibili ( istruzione, sanità, giustizia, raccolta di rifiuti-TARI).
4. LA PRESSIONE FISCALE
Pt = ∑𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑷𝑷𝑻𝑻𝑷𝑷
(pressione tributaria)
Pf = ∑𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕+𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑷𝑷𝑻𝑻𝑷𝑷
(pressione fiscale) 45%
Pfn = ∑𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕+𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕+𝒑𝒑𝒕𝒕𝒑𝒑𝒑𝒑𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝑷𝑷𝑻𝑻𝑷𝑷
(pressione finanziaria) 50%
25
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
5. LA CRESCITA DELLA SPESA PUBBLICA E IL DEBITO PUBBLICO
Nella misura in cui la Pf aumenta, potrebbe disincentivare la produzione, quindi diminuire il gettito fiscale e poiché certi servizi pubblici sono imprescindibili, si manifesta una vischiosità della spesa pubblica (che non scende) e quindi una maggiore richiesta di prestiti su titoli del debito pubblico o sovrano.
Pf ↑ ⇒ Debito PP ↑↑
LA CURVA DI LAFFER
N.B. Negli Stati Uniti, la teoria di Laffer venne applicata con la Regan economics, il risultato finale fu un gigantesco buco di bilancio che la FED dovette ripianare con nuova moneta.
CRISI DEL DEBITO SOVRANO
= default (insolvenza)
DEFICIT → E< U
DEBITO PUBBLICO = moneta dovuta dallo Stato ai suoi cittadini o ad altri Paesi o Istituzioni Internazionali.
INTERESSI SUL DEBITO
FIDUCIA
RATING
RICHIESTA TIT DEL DEB PUB
26
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
Δ s = SPREAD = i btp (ITA) – i bund (D)
Δ s ↑ ⇒ cade il Governo Berlusconi 2011
Δ s ↓ ⇒ gli investitori stranieri hanno fiducia ITA e comprano titoli deb pub
http://goofynomics.blogspot.it/2014/01/53-anni-di-spread.html
27
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
6. IL PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃
< 3% 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃
< 60% ⇐ early worning Patto di stabilità e crescita → Amsterdam 1997 Maastricht 1992 → convergenza delle economie europee
CRITICA
EUROPA DELLA TECNOCRAZIA, DELLE BANCHE E DELLE MULTINAZIONALI: hanno fatto la moneta (l’euro) SENZA L’UNIONE POLITICA !
I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BILANCIO
STATO FUNZIONI
DOC. CONTABILE
SPESE X I CITTADINI
ENTRATE DEL CITTADINO
ANNO Finanziario
1-12
DOC. POLITICO = POLITICA ECONOMICA
DOC. GIURIDICO
=
LEGGE
AUTORIZZA
SPESE/ENTRATE
PAESE DEMOCRATICO
Deve essere approvato dai cittadini
PARLAMENTO (*)
28
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
(*)
Parlamento inglese Assemblea rappresentativa del Regno d'Inghilterra, nata dall'evoluzione del Consiglio del re e delle corti feudali. Fu convocato per la prima volta nel 1264, dopo che la Magna charta (1215) aveva sancito che il re non aveva il diritto di riscuotere tasse senza il suo consenso.
http://www.treccani.it/enciclopedia/magna-charta_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
BILANCIO DI COMPETENZA E BILANCIO DI CASSA
ENTRATE USCITE/SPESE
ACCERTAMENTO IMPEGNO BILANCIO COMPETENZA
RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE
VERSAMENTO ORDINE
PAGAMENTO BILANCIO DI CASSA
BILANCIO PREVENTIVO
CONSUNTIVO CORTE DEI CONTI
PREVENTIVO
COSUNTIVO
C O N T R O L L O
29
ECON
OMIA
POL
ITIC
A E
INFO
RMAZ
ION
E EC
ONOM
ICA
| IS
ISS
FERM
I POL
O M
ONTA
LE
CONSEGNE/CONCLUSIONI
RIASSUMI INDIVIDUALMENTE CON L’AIUTO DEL MANUALE IL MODULO PRESENTATO.
Ventimiglia, gennaio 2018
Prof. Giancarlo Memmo
MANOVRA FINANZIARIA DELLO
STATO
DISEGNO DI LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
DISEGNO DI LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALEALE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZ. PUBBLICA
DECISIONI DI FINANZA PUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ ( ex Legge Finanziaria) + COLLEGATI