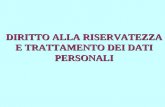Diritto dei Consumatori.docx
-
Upload
andrea-el-salvo -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
description
Transcript of Diritto dei Consumatori.docx

Capitolo Primo
Il diritto dei consumatori
Le fasi del processo di tutela
La cronistoria della tutela del consumatore si snoda secondo un processo economico, sociologico e giuridico che si può scandire in fasi.
Prima fase:
Si colloca in Italia tra l'inizio degli anni '70 e l'inizio degli anni '80; essa è connotata da una fondamentale esigenza: individuare la figura del consumatore come controparte, non solo economica, dell'impresa, e sviluppare il tentativo di identificarne i diritti, che assolvono anche alla funzione di limite alla libera attività imprenditoriale. Nella prima fase si è assistito quindi all'individuazione dei diritti in capo agli individui considerati come consumatori.
Seconda fase:
Collocata tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90: intervento legislativo e giurisprudenziale nei singoli settori in cui si può articolare il consumo (ad es. pubblicità, credito, risarcimento in caso di danni derivanti da vizi e difetti di prodotti e servizi).
Terza fase:
Si colloca nell'ultimo decennio, in cui si è accreditato lo status di consumatore e si sono introdotti primi provvedimenti di tutela. Si discute se sia opportuno o no elaborare un quadro normativo organico di protezione del consumatore, sia nella dimensione individuale che in quella collettiva, si discute sulle modalità di intervento se quest'ultimo si debba mantenere a livello statuale o anche regionale, se si debba lasciare spazio all'autonomia privata o debba essere frutto della mediazione dell'intervento pubblico.
In ambito comunitario si può dire che il settore della tutela dei diritti dei consumatori è uno dei settori in cui gli organi comunitari hanno ritenuto di non applicare in modo esteso il principio di sussidiarietà, cioè di non affidare interamente agli Stati membri il compito di tradurre in regole gli indirizzi di protezione del pubblico considerato nella dimensione del consumo, dell'utenza e del risparmio, ma piuttosto di mantenere costante e vivo l'impulso all'armonizzazione degli ordinamenti nazionali.
In ambito europeo si sono moltiplicate le occasioni d'incontro tra giuristi e operatori dei diversi paesi membri dell'unione e del consiglio d'Europa, questa tecnica di comunicazione e discussione viene avviata mediante convegni, cicli di conferenze e seminari ed ha la finalità di illustrare i modelli nazionali e agevolarne il trapianto e la circolazione.
Nel nostro paese si ricorda l'approvazione della recante la "disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" (L.281/98), tale legge da ingresso ad alcuni diritti che non avevano ancora ricevuto il riconoscimento generale. In più assicura una tutela collettiva dei consumatori attraverso il riconoscimento generale della legittimazione ad agire delle loro associazioni.
Dalla fine del 1998 alla primavera del 2002 il diritto dei consumatori a registrato novità in ambito comunitario e nell'esperienza il nostro paese da richiedere un vero e proprio ripensamento dell'intera materia.
In ambito comunitario l'apice della trasformazione è rappresentato dal "quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori 1999-2003", dal libro verde sulla "protezione dei consumatori nell'unione europea", da alcune direttive di portata generale quali: la direttiva n. 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Nel diritto interno, oltre all'attuazione delle direttive comunitarie, emerge l'esigenza di coordinare tutta la disciplina in un testo unico. Questo disegno che portava a compimento con il D.Lgs n. 206/2500 che ha introdotto il codice del consumo.
Altri grandi novità riguarda l'autentica rivoluzione che si attuata nel sistema delle fonti del diritto interno, in cui per effetto della L. Cost. 3/2001 si è riscritto l'art.117 Cost. e si sono modellati i poteri normativi dello Stato e delle regioni, a quest'ultima spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non strettamente riservata alla legislazione dello Stato. Tra le materie riservate allo Stato non compare una dizione concernente i consumatori, ma compaiono materie che investono il diritto di consumatori, come la moneta, la tutela del risparmio, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e penale, la visita amministrativa, la giurisdizione e le norme processuali; mentre la tutela della salute e l'alimentazione sono materie di legislazione concorrente.Costituito da fonti di diversa natura, il settore dei consumi da luogo ad un vero e proprio corpus normativo, aggregando istituti, singole discipline, problematiche che si possano tutte riferire ai consumatori, al rapporto di consumo e così via.
Le fonti del diritto dei consumatori
Il diritto comunitario
Il diritto comunitario è stato il vero motore per la realizzazione di un diritto dei consumatori negli ordinamenti nazionali. Per il nostro paese è stato determinante, anzi si può dire che solo l'adesione dell'Italia al Mercato comune ha consentito di decollare a questa branca del diritto; per contro il diritto comunitario si è esteso in modo straordinario, pervadendo ambiti un tempo considerati inattingibili perché riservati al legislatore statuale, comunque alle prerogative degli Stati membri. Superato il primo decennio, dagli anni 70 agli anni 80 del novecento, i due percorsi, comunitario e interno, si sono intrecciati.
Il diritto interno. La costituzione e il ruolo dello Stato e delle Regioni
Nel linguaggio dei costituenti le categorie economiche contemplate riflettevano una storia classica del mercato, senza particolare considerazione della libertà di concorrenza e delle dimensioni dei consumi. Il ruolo di consumatore si può pertanto costruire tenendo conto delle disposizioni che riguardano la persona, per godere dei consumatori, come tutela della persona (art.2 Cost.), diviene un limite interno all'iniziativa economica privata, che non deve offendere la dignità, la sicurezza e la salute della persona e della conformarsi alla utilità sociale (art.42, c.2, Cost.).
Nella distribuzione della potestà legislativa tra Stato e regioni, con la modificazione dell’art. 117 Cost. per effetto della L. Cost. 3/2001, lo Stato si è riservato alcune materie, altre le ha condivise con le regioni e per tutto resta affidata la legislazione alle regioni. Tra le materie riservate allo Stato non compare una legislazione sul consumo, ma compaiono materie che investono il diritto di consumatori, come la moneta, la tutela del risparmio, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e penale, la visita amministrativa, la giurisdizione e le norme processuali; mentre la tutela della salute e l'alimentazione sono materie di legislazione concorrente.
La legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati
Molte sono le disposizioni del codice civile che trattano materie che interessano i consumatori; da considerare con attenzione è il settore del credito, che non si può circoscrivere solo alla disciplina del credito al consumo, ma abbraccia tutti rapporti contrattuali tra le banche, gli intermediari finanziari, le società finanziarie e i consumatori.
Con ritardo rispetto alle iniziative legislative assunte in altri paesi europei, nel luglio 1998 è stata approvata la legge che riconosce diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti delle loro associazioni.
Anche gli statuti regionali talvolta tengono conto degli interessi dei consumatori, così pure gli statuti comunali, provinciali e delle città metropolitane.

Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) ha incorporato gran parte delle disposizioni contenute in leggi speciali e le disposizioni del codice civile in esso inserite in attuazione delle direttive comunitarie.
Le leggi regionali
Gran parte delle questioni giuridiche che investono i consumatori appartiene all’ordinamento civile, la cui disciplina è riservate allo Stato. In una sentenza della corte costituzionale si chiariva che le regioni possono avere competenza legislativa in quelle materie del diritto privato che non incidono sugli istituti
fondamentali, quali ad es. i modi di acquisto e di estinzione della proprietà, le obbligazioni, la famiglia, la responsabilità civile, i soggetti. Poiché anche le regioni possono attuare direttive comunitarie, sarà di volta in volta necessario capire a quale livello si debba attestare l'attuazione delle direttive e quali differenze tra provvedimenti possono essere consentite.
Comuni e province
Nei comuni e nelle province sono stati istituiti uffici per la tutela del consumatore, per l'informazione e l’educazione, oppure per i controlli della polizia annonaria; si può quindi individuare una sotto branca della materia raccolta di diritto amministrativo di consumi.
Provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti
L'antitrust, l'Isvap (Istituto sulla vigilanza delle assicurazioni private), la Consob (commissione di vigilanza sulle società e sulla borsa), il Garante dei dati personali, l'autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, hanno potere normativo sub-primario, e adottano provvedimenti che concernono la tutela degli interessi dei consumatori nei settori di loro competenza.
Autodisciplina e codici di condotta
La formazione negoziale del diritto come fattore unificante dei fenomeni in esame
Autonomia privata, codici deontologici, accesso alla giustizia sono fenomeni collegati tra loro che hanno come minimo comune denominatore: la formazione negoziale del diritto. La formazione negoziale del diritto è un connotato essenziale della stessa positività dell'ordinamento giuridico, in quanto è lo stesso ordinamento che consente la creazione di norme giuridiche al di fuori delle fonti istituzionali: si tratta della creazione di regole e della istituzione di diritti soggettivi che non proviene dall'altro, cioè dall'imposizione con legge o con provvedimento amministrativo avente natura di normazione sub-primaria, ma proviene dalle formule organizzatorie della società civile. La creazione negoziale non può farsi strumento di prevaricazione del più forte sul più debole, né strumento di contrasto con l'ordinamento, né strumento di elusione delle regole dell'ordinamento; così come l'autonomia privata non può sconfinare nell'arbitrio e nella sopraffazione, essa deve consistere in un agire positivo e non può sottrarsi al limite controlli.
Autonomia e controlli: due prospettive di analisi in conflitto e quattro modelli possibili di classificazione
Ogni settore dell'economia ha alimentato la polemica tra liberisti e interventisti, tra sostenitori del mercato libero da limitazioni, prescrizioni e controlli, e sostenitori del mercato libero nel rispetto delle regole di correttezza, buona fede, tutela degli interessi deboli e degli interessi socialmente rilevanti.
Le due posizioni appaiono antitetiche più per gli assunti ideologicamente opposti da cui muovono che non per gli effetti pratici che ne conseguono: anche il mercato più libero non sfugge a limitazioni e controlli; gli stessi controlli non possono essere fino al punto di inceppare l'esercizio dell'attività economica.

Individuata la scelta di campo da parte del legislatore e dell'interprete, si possono individuare diversi modelli di rapporto tra autonomie e controlli, cioè tra le creazioni di regole e il controllo sulla loro osservanza da parte dei loro destinatari possono ascriversi a 4 diversi modelli:
1. autonomia e autocontrollo;2. autonomia ed eterocontrollo; 3. eteronormazione e autocontrollo;4. eteronormazione ed etero controllo.
I soggetti e gli interessi investiti
Un'analisi rivela che la categoria degli status non è stata superata né soppressa dalla codificazione del 1942, dalla legislazione speciale e dagli orientamenti giurisprudenziali. Convivono status di privilegio e status di protezione: quando i primi basta menzionare le regole protettive che governano le professioni liberali, per i secondi le regole di protezione che per l'adesione dell'Italia al Trattato CE, il legislatore statuale è tenuto ad introdurre. Mentre nella nostra esperienza si distinguono i professionisti dagli imprenditori, non sono state ben definite quelle del consumatore, risparmiatore ed utente. Gli interessi sono: individuali, diffusi, collettivi; ma nei diversi settori indagati ha rilievo l'interesse pubblico, che non si può considerare soddisfatto dal reciproco o concorrente soddisfacimento degli interessi privati in gioco.
Coordinamento delle fonti normative
Il quadro normativo in esame presenta lacune e difetti di coordinamento; ciò dipende dalla diversa origine, il diverso grado e il diverso operare delle fonti normative. Quanto al diritto comunitario, è assente la distinzione tra professionisti liberali e imprenditori, tutti unificati con la terminologia di "professionisti". Quanto alla normativa costituzionale si pone al centro di questo diverso l’art. 41, da coordinare con gli artt. 2,3 Cost. Quanto alla legislazione speciale e ordinaria, si richiamano le osservazioni fatte sulle leggi istitutive degli ordini. Quanto agli atti normativi sub-primari si segnalano i regolamenti Consob sul comportamento delle SIM (società di intermediazione mobiliare), e la ricerca presso l'Autorità antitrust sulla legittimità degli Albi professionali. Quanto alla prassi legittimata sub specie di consuetudine dalla identificazione normativa delle fonti e legittimata dalla giurisprudenza, si pongono problemi analoghi a quelli inerenti all'autonomia negoziale. Quanto alle regole deontologiche, si pongono alcuni fondamentali problemi: la loro natura, la loro formulazione, il loro ambito, la loro finalità, il loro contenuto, il loro ruolo.
Elaborazione di clausole contrattuali e la tutela della concorrenza
Gli organismi che regolano il comportamento degli aderenti, mediante codici di condotta si propongono spesso anche di regolare i loro rapporti negoziali interni e quelli con i terzi.
Con la L. n. 580/1993 è stato affidato alle Camere di commercio, il compito di agevolare la redazione di moduli o formulari per la disciplina convenzionale dei rapporti tra imprese e dei rapporti tra imprese e consumatori.
Vi sono fenomeni assai diversi e complessi: Le associazioni di categoria, gli organismi di controllo della deontologia, spesso si propongono di uniformare e di sistemare le regole negoziali che i singoli aderenti istituiscono con i terzi; si pone un problema grave e delicato se queste regole possano ostacolare la libera concorrenza. I contratti standard, contengono "condizioni economiche" concernenti, prezzi, tariffe, corrispettivi e clausole che incidono sugli aspetti economici, quali quelle relative a limitazioni esclusioni della responsabilità, decadenze, recessi ecc.
La predisposizione di moduli uniformi alle imprese di un settore è spesso incoraggiato dalle associazioni di categoria, per il settore assicurativo l’ANIA, per il settore bancario l’ABI; il problema è stato sottoposto

alla Commissione per la tutela della concorrenza e del mercato (c.d. Autorità antitrust), la quale ha ritenuto che le direttive delle associazioni di categoria rivolte ad impegnare le imprese iscritte ad attenersi ai modelli o alle regole elaborate dalle medesime associazioni contrastino con l’art.2, c.2, della L. 287/1990, perché le direttive delle associazioni possono considerare o come cartelli veri è propri oppure come intese che falsano la concorrenza.
Per il settore assicurativo, l'Autorità ha irrogato sanzioni a carico di una ventina di società assicuratrici per aver posto in essere intese aventi ad oggetto la determinazione delle tariffe e degli scoperti delle polizze relative al ramo "rischi diversi" e per essersi scambiate informazioni finalizzate alla determinazione comune degli elementi contrattuali, per aver uniformato le franchigie delle polizze al ramo "infortuni" e al ramo "malattia" ed ad altri rami.
Per il settore bancario, la Banca d'Italia occupata di controllare se la redazione di clausole uniformi relative ai contratti bancari da parte dell’ABI (c.d. Norme bancarie uniformi, NBU) potesse esporre l’ABI e le imprese aderenti alla sanzione dell’Autorità antitrust, che con un provvedimento ha sottolineato che l’ABI è un'associazione senza scopo di lucro alla quale aderiscono la quasi totalità delle banche e degli istituti finanziari, avendo lo scopo di cooperare con le istituzioni, di informare gli aderenti (cioè le banche e gli istituti iscritti all'associazione) promuovere studi, ricerche e scambi di informazioni; le c.d. NBU in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese rientrano nelle fattispecie dell’art. 2, c.2, legge antitrust; poiché le intese riguardano la formulazione di norme bancarie uniformi che l’ABI invita o suggerisce di adottare. La Banca d'Italia recepito il parere dell'Autorità antitrust ha con proprio provvedimento, precisato che: 1. il carattere non strettamente miracolante delle intese non trae al vaglio della concorrenza;2. devono essere modificate le condizioni contrattuali che riservano alla banca la potestà di modificare unilateralmente il contratto, escludere gli interessi di diritto e così via.
In ottemperanza a questo provvedimento l'ABI ha modificato le NBU ed ha elaborato un codice di condotta concernente i rapporti con i clienti.
Il Codice del Consumo (Cc)
Il codice del consumo (D.lgs. 206/2005) entrato in vigore il 23 ottobre del 2005, si compone di 146 articoli (diventati 171 dopo le modifiche del 2007); tale codice si apre con una enunciazione di carattere generale che richiama la normativa dell'U.E. e definisce i propri scopi intesi nel senso di armonizzare e riordinare le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e degli utenti.
L'art. 3 include il testo della L. 281/1998, identificando i diritti dei consumatori e le necessarie definizioni relative al consumatore/utente e alle associazioni di consumatori e utenti.
L'elenco dei diritti dei consumatori corrisponde all'elenco di diritti previsti dalla risoluzione CEE del 1975, con qualche formulazione innovativa. Oltre alla salute e alla sicurezza, si considera la qualità dei prodotti e dei servizi; per quanto concerne il diritto all'informazione, quest'ultima deve essere adeguata non solo sufficiente a consentire al consumatore di effettuare le sue scelte, ma anche completa, comprensibile e non fuorviante, deve essere corretta.
Gli interessi economici devono confermarsi a <<correttezza>> (essa esprime un principio generale riguardante l'intera materia delle obbligazioni e la clausola generale di buona fede), <<trasparenza>> (si deve verificare se il contratto è chiaro,inintelligibile, e se il consumatore è stato adeguatamente informato prima della sua istallazione e durante l'esecuzione del rapporto) ed <<equità>> (è la più complessa e può implicare sia parità di trattamento, sia congruità del prezzo, sia considerazione della situazione concreta e specifica del consumatore).
Il diritto all'educazione intricata un impegno da parte delle istituzioni a informare il consumatore e a formare la sua capacità di scelta, di giudizio e di consapevolezza dei propri diritti.
Natura dei diritti elencati

Questi sono riconosciuti e garantiti dalla legge statuale e dalla stessa Costituzione, come il diritto alla salute (art.32), il diritto alla sicurezza (art.41, c.2), il diritto di azione (art.24), garantiti a ciascuno in quanto persona. La categoria giuridica dei consumatori non ha trovato esplicito riconoscimento nel testo originario della Costituzione; in ogni caso alcune situazioni si pongono come veri e propri diritti soggettivi che oggi potremmo qualificare come tradizionali.
La qualificazione di <<diritti fondamentali>> può essere intesa:
a) in senso proprio -come posizioni soggettivi inviolabili, insopprimibili, immodificabili come ribadito dall'art. 143 del Cc (codice del consumo);b) in senso traslato - cioè come posizioni soggettive che costituiscono lo status giuridico del consumatore e sono da considerarsi particolarmente rilevanti.
Questi diritti <<fondamentali>> dei diritti dei consumatori a cui potranno aggiungersi altri diritti; un elenco dunque non a numero chiuso ma tale da costituire i diritti basilari che non possono essere lesi nell'esercizio di attività economiche.
I diritti delle associazioni di consumatori e utenti
Artt. 136ss, riguardano i diritti delle associazioni dei consumatori, il cui scopo primario è quello di tutelare il consumatore tramite l'esercizio di attività giudiziale alla quale si l'attività di informazione, educazione, assistenza, di promozione dei loro interessi, di negoziazione con le imprese e di risoluzione dei conflitti.
Diritto di azione consiste:
1. nell'esercizio dell'azione inibitoria (di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti);2. nell'esercizio di azioni cautelari rivolte a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;3. Nell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in forma specifica, limitatamente alla richiesta di pubblicazione del procedimento ottenuto.
Si tratta di azioni proposte in via autonoma o nel procedimento promosso dal singolo consumatore o utente.
Alle medesime associazioni si riconosce il diritto di promuovere la procedura conciliativa, la quale può essere promossa anche dai singoli interessati, la procedura si può concludere con la conciliazione verbale dichiarato esecutivo dal pretore.
La rappresentatività si fonda su alcuni requisiti di base:
I. costituzione in forma scritta e un ordinamento a base democratica,II. uno scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti senza fini di lucro,III. un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale,IV. la presenza in almeno 5 regioni o province autonome,V. un bilancio conforme alle prescrizioni dettate per le associazioni non riconosciute,VI. svolgimento di attività continuativa,
VII. immunità da condanne dei rappresentanti.
Novità del codice del consumo
Si segnalano:
- disposizioni sull'educazione del consumatore (art.4) orientata a favorire la consapevolezza dei suoi diritti;
- gli artt. 33 e ss. incorporano le regole del codice civile sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori senza correzioni di sorta. Vi sono 2 disposizioni che collegano il Cc con il codice civile:
art.38 che qualificando indirettamente queste disposizioni come speciali, fa rinvio alle norme del codice civile per quanto non previsto dal Cc e l'art.142 che modifica il testo del codice civile da inserire nella Cc, ribadendo l'applicazione del codice civile laddove non siano applicabili le norme del Cc o altre norme più favorevoli al consumatore.

-art.39 chiarisce che le pratiche commerciali sono improntate ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori;- artt. 40-43 trattano il credito al consumo, fanno sostanzialmente rinvio al testo unico bancario, viene inserita una disposizione (art.42) sull'inadempimento del fornitore di beni e servizi secondo la quale "il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche il terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito".-disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (artt.47 ss.), dei contratti a distanza (artt. 50 ss.) e la disciplina del recesso che è comune (artt. 64 ss.);-il commercio elettronico è oggetto di una disposizione di rinvio (art.68),-regole sulla multiproprietà (artt.69 ss.)-regole sui viaggi (artt.82).-carte dei servizi, il Cc si occupa dei servizi pubblici (art.101);-disciplina della sicurezza dei prodotti (artt. 102 e ss.);-responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt.114 ss.);-nella vendita di beni di consumo (artt.128 ss.);-azioni inibitorie e accesso alla giustizia.
Con l’introduzione dell’art. 140-bis, il Codice si è arricchito dell’ “azione di classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto.
Modifiche al Codice del Consumo
Nel corso del 2007 il Codice del consumo è stato oggetto di alcuni rilevanti interventi normativi a
testimonianza del fatto che non fosse sufficientemente esaustivo ai fini della tutela a tutto tondo dei
consumatori. Nonostante le modifiche apportate e pur non mancando apprezzabili sforzi ricostruttivi, manca
ancora un coerente impianto sistematico. Ad esempio, la solenne enunciazione dei diritti fondamentali dei
consumatori di cui all’art. 2 comma 2 del Codice: il diritto alla tutela della salute, il diritto alla sicurezza ed alla
qualità dei prodotti, il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali ed ancora il
diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, si palesa come priva di un
reale contenuto precettivo, esaurendosi nella riaffermazione, peraltro con norma di rango inferiore, di diritti
già formulati nella Carta Costituzionale e già tutti indubbiamente spettanti ad ogni cittadino in quanto tale,
indipendentemente dalla posizione ricoperta nella circolazione di beni e servizi, cioè dalla sua qualifica di
imprenditore o consumatore.
Si è recepita la direttiva 2005/29/CE in materia di “Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”
(ad opera del d.lg. n. 146/2007), quindi, l’attuazione delle “Disposizioni correttive ed integrative a norma
dell’art. 7 della legge n. 229/2003” (ad opera del d.lg. n. 221/2007) per mezzo del quale si provvede anche a
far rifluire all’interno del Codice la disciplina riguardante la “Commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori” (dettata dal d.lg. n. 190/2005 in attuazione della Direttiva 2002/65/CE).
Con questi poderosi interventi, gli articoli del Codice passano dagli originari 146 agli attuali 171, rilevanti sia
per dimensioni che per contenuti. La regolamentazione in materia di pratiche commerciali, in particolare, è
destinata ad influenzare in modo complessivo il grado di tutela riconosciuto ai consumatori, trattandosi di un
intervento che, ponendosi l’ambizioso obiettivo di contrastare in modo trasversale le condotte scorrette
adottate dai soggetti professionali (nella pubblicità e nella promozione dei prodotti, al momento della vendita
come sul versante delle garanzie) impatta in modo consistente sull’impianto del Codice.
Le disposizioni correttive ed integrative (d.lg. n. 221/2007) rispondono, invece, all’esigenza di completare il
quadro dell’ordinamento di consumo. Di particolare rilievo, come detto, l’intervento in materia di pratiche
commerciali tra professionisti e consumatori che, dal punto di vista sistematico, ha il merito di mettere ordine
nella disciplina della pubblicità realizzando una chiara separazione tra le norme a tutela dei professionisti

concorrenti (oggi poste al di fuori del Codice di settore) e quelle a tutela dei consumatori che oggi si trovano
proprio nei nuovi artt. da 18 a 27-quater. Si osservi, infine che le norme sulle pratiche commerciali scorrette
operano anche altri interventi di coordinamento: il d.lg. n. 146/2007 riforma anche l’art. 57 del Codice
riguardante la “fornitura non richiesta” (art. 2) ed incide altresì (art. 5) sulla legge n. 173/2005, recante la
disciplina della vendita diretta a domicilio e delle vendite piramidali stabilendo l’abrogazione, nella parte in
cui riguardano forme di vendita tra consumatori e professionisti, dell’art. 5, 1° e 7° comma. Dopo tanto tempo
di legislazione speciale, sull’onda di una evidente esigenza di semplificazione della normativa, è tornato in
auge l’ operazione di codificazione per risistemare la materia oggetto del Codice, con uno sforzo che va
riconosciuto.
Inutile aggiungere il valore simbolico e politico di una siffatta operazione per i consociati che possono trovare
in un unico corpus tutta (o quasi) la disciplina che riguarda un certo ambito, contribuendo a quella
conoscibilità della legislazione, in grado, secondo i precetti costituzionali, di rimuovere gli ostacoli alla
uguaglianza sostanziale tra i consociati.

Capitolo terzo
La disciplina della concorrenza e laCorrettezza nell’attività commerciale
La Legge Antitrust
La L.287/1990 concerne la tutela della concorrenza e del mercato.
Terminologia: Ci si è soffermati sul significato di concorrenza e mercato, si tratta di due fenomeni differenti e contrapposti fra loro: mentre vi può essere mercato senza concorrenza (c.d. mercato monopolistico o oligopolistico), non vi può essere concorrenza senza mercato. Aggiungendo "e mercato" si è voluto avvertire che lo spettro degli interessi incisi è più ampio a quello a cui di solito ci si riferisce quando si parla di concorrenza (cioè agli interessi degli imprenditori concorrenti, nel c.d. libero mercato).La nozione giuridica di mercato: rimane vaga essendo il mercato una figura ideale dell’incontro di domanda e offerta, che varia a seconda dei beni e dei servizi, delle regioni, dei sistemi politici e quindi dei sistemi economici.
La nozione di concorrenza: varia con riguardo alla concorrenza sleale, ai consorzi, ai patti di non concorrenza, ecc.
Inoltre i riferimenti ai principi di diritto comunitario amplia l’aerea di intervento dell’interprete, inoltre nel testo della legge il termine “consumatore” ricorre a più riprese in particolare: in tema di abuso di posizione dominante, a danno dei consumatori; in materia di deroghe al divieto di intese restrittive della libertà della concorrenza, si ritengono lecite tali intese, autorizzate dall’agenzia amministrativa, diano luoghi a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiamo effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori.
Disciplina del mercato e tutela diretta dei consumatori
La disciplina della concorrenza e del mercato, investe in modo diretto gli interessi dei consumatori, ciò perché nel mercato operano anche questi, riguardo agli interessi dei consumatori la L.287 riserva un’attenzione modesta: dal testo si ricava che l’interesse dei consumatori è preso in considerazione solo come punto di riferimento, come metro di valutazione dell’anticoncorrenzialità di un atto o di una pratica, cioè come mezzo, piuttosto che come fine.
Tecniche di tutela del consumatore e disciplina della concorrenza
La strumentazione tecnica con cui provvedere alla tutela dei consumatori nell’ambito della disciplina del mercato e della concorrenza, propone iniziative molteplici, ma in particolare se ne segnalano 2:
1) La rappresentanza (c.d. diritto di essere ascoltati e il diritto di partecipare agli uffici o organi che amministrano gli interessi dei consumatori);
2) L’azionabilità degli interessi incisi.
Né l’una né l’altra tecnica sono contemplate nella disciplina antitrust statuale. La prima perché i consumatori non sono rappresentati nella individuazione dei componenti dell’Autorità di controllo. L’obiettivo del Legislatore in questo provvedimento, come negli altri che riguardano il mercato, non è quello di tutelare
i consumatori, ma gli interessi dei consumatori insieme con gli interessi degli imprenditori. Ma l’equilibro da questi tipi di interessi è apparante, in quanto gli interessi degli imprenditori sono solidi e sono presenti nella

disciplina legislativa, per contro, gli interessi dei consumatori non sono interessi di categoria, sono deboli, essendo affidati alle associazioni e sono da poco tempo presenti nei testi legislativi.
Neppure la seconda tecnica è contemplata nella disciplina antitrust perché le azioni a difesa degli interessi dei consumatori nella disciplina di tutela della concorrenza e del mercato sono considerate in modo marginale, alle associazioni si riserva solo la facoltà di informare l’Autorità, cioè di portare alla sua attenzione i fenomeni anticoncorrenziali che si devono reprimere. Quanto alla legittimazione ad agire in materia di risarcimento del danno, le associazioni sono ignorate,essendo tutta al più possibile un’azione individuale. La dottrina si è concentrata sulla natura e l’entità del danno; ma in materia di illecito aquiliano derivante da violazione della disciplina antitrust il problema più delicato è dato dal nesso causale.
Solo con l’ammissione della legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative, cioè con la class action , si sarebbe potuta assicurare una efficace tutela dei consumatori.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di competenza del giudice ordinario, provvedere al risarcimento del danno subìto dal consumatore, in caso di violazione della disciplina comunitaria da parte di imprenditori che avessero alterato la concorrenza. Il caso in esame riguarda le società di assicurazione che avevano concordato le tariffe per le RC Auto, che sono state condannate dall’Autorità antitrust con apposito provvedimento, confermato dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato.
La circolazione delle merci e dei servizi
Recente interpretazione attinente agli artt. 81,82, ex 85, 86 del Trattato di Roma in ordine alla circolazione delle merci, alle restrizioni introdotte dagli Stati membri e alla protezione degli interessi del consumatore.
Una ormai nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia documenta questo indirizzo innovativo. Essa non riguarda solo le restrizioni alla circolazione ma anche la denominazione e l’etichettaggio dei prodotti e così via.
Il caso più importante (Cassis de Dijon, del 1979) ha dato l’avvio ad una nuova prassi; si discuteva se fosse legittima la restrizione all’importazione in Germania di questo liquore, restrizione dettata dalla legislazione tedesca che vieta la commercializzazione di liquori di frutta a bassa gradazione alcolica, la Corte ha precisato che le disparità tra le singole legislazioni nazionali causano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ma questi ostacoli vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere a esigenze imperative attinenti in particolare all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. Essa ha accolto la richiesta dell’importatore francese, escludendo che la legge tedesca fosse rivolta a tutelare questo specifico interesse.
La Comunità ha approvato diversi provvedimenti concernenti i prezzi; tra gli altri la direttiva n.88/314/CEE, approvata su D.Lgs 78/1992 dispone che i prezzi dei prodotti non alimentari siano precisati in modo chiaro, anche su riferimento a peso, misura, quantità, per la migliore informazione del consumatore.
La correttezza commerciale e i nuovi progetti di intervento a favore dei consumatori
Nel Libro verde sulla tutela del consumatore, la Commissione europea, chiede se sia utile predisporre un testo unitario preceduto da alcune regole generali sulla correttezza nell’attività commerciale (fair trading).
Il problema volto a determinare le modalità di prevenzione dei comportamenti scorretti nei confronti dei consumatori, che ha portato la Comunità ad intervenire per tutelare i consumatori, avrebbe facile soluzione se ogni paese fosse dotato di regole di fair trading.

In ambito europeo ben 13 Stati prevedono nel loro ordinamento una clausola generale di correttezza, ciò avviene sulla base di diversi modelli quello delle pratiche commerciali corrette, all’illiceità o alla colpa; la terminologia è varia ma ogni formula appare legata ad una clausola generale.
Il contrasto più grande non sta nelle formule, ma nella contrapposizione tra ordinamenti dell’Europa continentale e ordinamenti dell’Europa insulare, cioè di common law.
Le regole generali sulle quali si fonda il mercato integrato comunitario devono coordinare cioè rendere compatibili 3 principi: la concorrenza, la correttezza nell’attività commerciale, la protezione del consumatore.
Prima dell’Atto unico solo la concorrenza insieme con le 4 libertà (di circolazione delle persone, dei capitali, dei beni e dei servizi), costituiva l’ossatura del diritto comunitario, gli interessi dei consumatori erano protetti solo in via mediata, dopo l’Atto unico e soprattutto dopo il Trattato di Amsterdam la protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori è divenuta una degli obiettivi primari dell’Unione.
In ogni ordinamento i 3 principi sono variamente combinati, nel nostro Paese sono tra loro separati ed hanno peso diverso, il più forte è quello che garantisce la libertà di concorrenza, la sua nuova veste giuridica consolidata con la legge antitrust del 1990, ha fatto sì che potesse essere considerato come inclusivo il principio di tutela del consumatore.
Questa linea evolutiva, che costituisce al tempo stesso una possibile soluzione alla frammentazione dell’ordinamento comunitario e al coordinamento dei 3 principi, vi sono diversi livelli di armonizzazione a seconda delle materie delle singole direttive, a seconda dell’epoca e della congiuntura in cui la direttiva è approvata, a seconda degli obiettivi che le direttive intendono raggiungere.
Le pratiche commerciali scorrette
Trattasi di una delle forme più aggressive di vendita, perché il contatto con il consumatore non è effettuato da un dipendente del distributore ma da un soggetto che agisce per conto del distributore e può presentarsi sotto le spoglie di un vicino, di un amico, di un conoscente; è difficile persino distinguere in questo caso tra proposta di vendita e semplice consiglio all’acquisto. Vi sono poi le ipotesi di pubblicità occulta, e altre informazioni che sono oggetto della disciplina di tutela dei dati personali (L. 675/1996 e successive modifiche).
Le vendite piramidali
L. 173/2005 ha colmato la prima lacuna, la legge prevede una definizione delle vendite dirette a domicilio, intese come le vendite al dettaglio effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova. L’attività è assoggetta alla disciplina della vendita al dettaglio, di cui alla riforma della disciplina del commercio prevista dal D.Lgs 114/1998, in particolare si prevede che chi svolge attività di promozione della vendita si identifichi, in modo da non sorprendere o ingannare il consumatore sulle sue effettive intenzioni commerciali; l’incaricato deve esibire il relativo tesserino. Il termine "piramidale" deriva dalla struttura formale in cui viene organizzata la vendita: la persona in cima alla piramide è la prima a vendere un bene o un servizio a un numero limitato di persone, le quali si incaricano di introdurre altre persone nella "piramide" a un livello successivo, con l'obiettivo di formare una nuova piramide sotto di sé e di ottenere i guadagni corrispondenti ai volumi di vendite prodotti dalla propria struttura.
La legge in esame disciplina anche il rapporto tra incaricato e imprenditore che esercita l’attività di vendita diretta, e fa divieto a quest’ultima di imporre all’incaricato l’obbligo dell’acquisto di minimi quantitativi di merci o servizi offerti. Si fa l’obbligo all’incaricato di applicare le disposizioni contrattuali stabilite dall’impresa, salva la sua responsabilità. Si prevede il suo compenso mediante provvigione.

La legge vieta la promozione e realizzazione di attività e strutture di vendita fondate sul reclutamento di altri rivenditori: il divieto non è generale, perché è subordinato al fatto che il reclutamento sia l’incentivo primario dei componenti della struttura di vendita; vieta altresì le c.d. catene di Sant’Antonio e i giochi ad esse collegati (che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinto previo il pagamento di un corrispettivo). Per accertare la sussistenza di un rapporto piramidale la legge prevede alcuni indici presuntivi inerenti il contenuto degli accordi tra impresa e incaricato della vendita.
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE)
Per pratiche commerciali sleali, si intendono le pratiche ingannevoli e aggressive, come ad esempio la vendita forzata. L'Unione europea (UE) garantisce lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell'UE. Essa protegge quindi anche i consumatori più vulnerabili, come i bambini, nei confronti della pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare.
Campo d'applicazione: La direttiva quadro si applica a tutte le transazioni delle imprese con il consumatore
nei casi in cui questo viene influenzato da una pratica commerciale sleale avente un'incidenza sulle sue
decisioni, come quella di acquistare o meno un prodotto, sulla libera scelta in caso di acquisto e sulle
decisioni riguardanti l'esercizio o meno di un diritto contrattuale. Essa non si applica alle transazioni fra
imprese. Essa non affronta neppure le questioni relative al buon gusto o all'educazione, alla salute e alla
sicurezza ovvero alla normativa che regola i contratti. La direttiva armonizza interamente la normativa
vigente in questo settore istituendo un divieto di ordine generale. Gli Stati membri non avranno la possibilità
di utilizzare le clausole minime previste da altre direttive per imporre prescrizioni supplementari nel settore
coordinato dalla presente direttiva.
Inoltre, questa direttiva completa le disposizioni relative alle transazioni fra impresa e consumatore di cui
alla direttiva sulla pubblicità ingannevole.
Il consumatore di riferimento è il consumatore medio, così come definito dalla Corte di giustizia. Questo
criterio è modulato allorquando una pratica commerciale riguarda in maniera specifica un gruppo particolare
(ad esempio, i bambini); in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di riferimento.
Essa modifica la direttiva 84/450/CEE riguardante la pubblicità ingannevole (abrogata dalla
direttiva 2006/114/CE), la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza, la direttiva 98/27/CE riguardante le azioni inibitorie e la direttiva 2002/65/CE riguardante la
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Criteri generali: La direttiva definisce i criteri generali per determinare se una pratica commerciale sia sleale
al fine di stabilire un ventaglio limitato di pratiche disoneste vietate in tutta l'UE. Tali criteri considerano se la
pratica sia contraria alle esigenze della diligenza professionale e se alteri o possa alterare sostanzialmente il
comportamento del consumatore medio. Inoltre, essa stabilisce la differenza fra le pratiche ingannevoli e le
pratiche aggressive precisando i criteri per individuarle.
Pratiche ingannevoli: Una pratica commerciale può ingannare sia tramite un'azione, sia tramite
un'omissione. Una pratica è ingannevole per omissione se non fornisce le informazioni minime o le
informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno prima di acquistare. La direttiva stabilisce quindi un
elenco di informazioni essenziali di cui il consumatore ha bisogno prima dell'acquisto; ad esempio, le
caratteristiche principali del prodotto, il prezzo (tasse comprese), le spese di consegna (ove necessario) e il
diritto di recesso. Una pratica commerciale è ingannevole per azione se contiene informazioni false ovvero
se induce o può indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono
oggettivamente corrette.

Pratiche aggressive: D'altra parte, la direttiva definisce i criteri per stabilire se una pratica commerciale sia
o meno aggressiva: se cioè questa utilizza molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.
«Lista nera» di pratiche vietate: Essa stabilisce, nell'allegato I, l'elenco completo dei comportamenti
commerciali sleali vietati in tutta l'UE in ogni circostanza; una specie di « lista nera » delle pratiche
commerciali sleali. Ad esempio, i sistemi piramidali di vendita, la fornitura non richiesta ovvero l'utilizzazione
della pubblicità-esca (quando il prodotto pubblicizzato ad un buon prezzo non è disponibile) ovvero
l'utilizzazione di finte interviste pubbliche. Questa lista può essere modificata solo tramite revisione della
direttiva.
Gruppi «sensibili» di consumatori :Gruppi di consumatori considerati « sensibili » sono protetti in maniera
particolare. Ad esempio, i bambini sono protetti contro la pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare.
Il criterio di consumatore medio è modulato quando una pratica commerciale riguarda in materia specifica un
gruppo particolare (ad esempio, i bambini), in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di
riferimento.
Contesto: La presente direttiva quadro fa seguito al libro verde del 2001 sulla protezione dei consumatori ed
al Libro verde (Libri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla
Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che
partecipano al processo di consultazione e di dibattito) pubblicato nel 2002. Oltre alle garanzie che essa
fornisce al consumatore, la direttiva permette uno sviluppo migliore del commercio transfrontaliero nel
mercato interno.

Capitolo sesto
I contratti di massa
Le condizioni generali del contratto
La negoziale delle condizioni generali di contratto, dell'uso di moduli o formulari, dell'impiego di modelli contrattuali uniformi o standard è tipica delle società a capitalismo maturo, ma non soltanto di esse.
I <<contratti di massa>> sono definiti così per sottolinearne l'ampia diffusione, il collegamento con la distribuzione di prodotti e servizi essenziali, le uguaglianza delle condizioni praticate agli utenti, ciascuno dei quali si confonde nella massa.
Il ricorso a questi strumenti negoziali è universale, la prassi negoziale attuata mediante condizioni generali consente di:
a) praticare a tutti consumatori uguali condizioni;
b) trasferire sui consumatori rischi e oneri non negoziabili;
c) accentrare i procedimenti giudiziali eventualmente sorti dalla acquisizione di beni e servizi in un unico foro, che coincide con quello dove ha sede l'impresa.
Ciò che preme sottolineare è il fatto che nella prospettiva che riguarda diritti dei consumatori si possono collocare solo le condizioni generali praticate dall'impresa nell'amministrazione dei suoi rapporti con i consumatori.
Il modello originario di controllo previsto dal codice civile
Il codice civile dedica alcune norme alle condizioni generali di contratto. Il modello normativo si articola in alcune disposizioni che riguardano l'efficacia delle clausole predisposte e gli oneri formali per il loro impiego (artt. 1341, 1342 cod. civ.). Si ricordano inoltre le clausole di esonero da responsabilità e delle prassi negoziale di impresa sono frequenti, che spesso la problematica delle clausole di esonero si confonde con quella delle condizioni generali (artt. 1228, 1229).
Art. 1341 cod. civ.:
a) comma 1, impone al consumatore un onere di conoscenza o conoscibilità delle condizioni generali di contratto che ne aggrava la posizione (come avverte Gorla, il cliente non ha tempo di leggere il lungo tratto della stampa anche da sola davanti ai suoi occhi, nello stesso tempo si favorisce chi può impedire le formulari clausole poco leggibili e di scarsa comprensione), in questo modo la sottoscrizione e le clausole vale a sancire il potere normativo dell'impresa di cui il consumatore deve subire, suo malgrado, gli effetti;
b)comma 2, esclude l'efficacia delle clausole vessatorie, qualora esse non siano partitamente sottoscritte; il fatto della semplice sottoscrizione, se vale a rendere avvertito il consumatore degli impegni che sta assumendo, nello stesso tempo garantisce all'impresa la possibilità di introdurre nel contratto clausole di ogni tipo, non negoziabili e non modificabili da parte dell'aderente.Il c.2 dell'art. 1341, legittima l'uso delle clausole vessatorie, in altri termini non ne circoscrive l'impiego, ne impedisce all'impresa di utilizzarle, indica solo in modo nel quale tale clausole si devono utilizzare: un modo che si esaurisce nell'adempimento di semplici oneri formali (la sottoscrizione).
Art. 1342: le clausole aggiunte, ancorché prevalenti su quelle a stampa non possono modificare toto il piano economico predisposto dall'impresa.
Art. 1370: con esso si fa riferimento alle clausole oscure e ne rende evanescente il ruolo di tutela dell'aderente.
Il sistema normativo del codici civile legittima l'impiego delle condizioni generali di contratto anche a danno del consumatore e quindi le disposizioni, devono leggersi come direttive a sostegno dell'impresa cui garantisce il più ampio campo d'azione e immunità da qualsiasi controllo esterno. Questa

valutazione viene rafforzata dall'esame della disciplina delle clausole di esonero da responsabilità, con la quale il codice civile predispone alcuni meccanismi di controllo delle pattuizioni che tendono a trasferire il rischio da una parte e l'altra (art.1229).
Direttiva sulle clausole abusive e la sua attuazione
Direttiva 93/13/CEE: vengono in evidenza:
a) principi generali;b) questioni aperte dalla esegesi del testo;c) le novità o le somiglianze rispetto agli ordinamenti stranieri;d) novità rispetto all’esperienza italiana.
Nel nostro Paese il recepimento non è avvenuto in modo lineare, in quanto nel redigere e approvare il testo il Parlamento, secondo la Commissione aveva violato la direttiva. Sicché con la L. 526/1999 si è provveduto a modificare il testo del codice civile:
1. soppresse le parole che specificavano il contenuto del contratto del consumatore all’art. 1469- bis, c.1;
2. si è aggiunto il c.3 all’art. 1469 quater, in modo da specificare che l’interpretazione più favorevole al consumatore non esclude il ricorso all’azione inibitoria;
3. art.1469-quinquies, con la specificazione che è inefficace ogni clausola contrattuale che abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurativa.
La Commissione ha convenuto l’Italia dinanzi la Corte di Giustizia, in quanto non si era provveduto ad apportare tutte le modifiche richieste, la quale ha ritenuto il nostro paese inadempiente agli obblighi comunitari e l’ha condannato ai sensi dell’art.69, n.3, della procedura regolante il contenzioso dinanzi alla Corte.
È stato attivato un osservatorio per accertare quali clausole siano dichiarate abusive negli ordinamenti dei Paesi membri.
Contratti dei consumatori
Per contratti dei consumatori, s’intendono quel tipo di contratti, nei quali, una delle parti è il consumatore, in modo specifico quelli posti in essere tra consumatore e professionista.
Quanto al tipo contrattuale si fa riferimento ad una categoria variegata di contratti, perché ricomprende i contratti di credito al consumo, i contratti di viaggio, i contratti di acquisto di beni e servizi, alcuni contratti bancari, ecc.
Il codice civile riportava nell’intitolazione del capo XIV- bis l’espressione “contratti del consumatore” ed aveva ad oggetto regole di portata generale.
La direttiva prevedeva che gli Stati dovessero uniformarsi entro il 31 dicembre del 1994, l’attuazione da parte dell’Italia è avvenuta solo nel 1996 a seguito di un lungo e travagliato iter e da molteplici interventi e emendamenti.
Le disposizioni già inserite nel codice civile sono state ora incluse nel codice del consumo (artt.33-38 Cc).
Aspetti generali
a) Ambito di applicazione
Per i contratti conclusi anteriormente all’approvazione della direttiva, poiché essa non è retroattiva si applica la disciplina prevista dagli artt. 1341,1342,1370.

Per i contratti conclusi successivamente al termine di scadenza della moratoria concessa agli Stati per il recepimento (31.12.1994) si discute se la direttiva sia immediatamente applicabile, in quanto sufficientemente dettagliata (si avrebbe applicabilità verticale).
Per il periodo successivo all’entrata in vigore, sono assoggettati alla nuova disciplina, sia i contratti conclusi dopo il 25 febbraio 1996 sia i contratti a tempo indeterminato, conclusi precedentemente a tale data e destinati ad esaurire i loro effetti ed i contratti rinnovati o prorogati sia anteriormente che posteriormente a tale data.
La disciplina di recepimento non si applica, in ogni caso, a:
1. Clausole che riproducano disposizioni di legge (art.1469 –ter, c.3 ora art.33 Cc);2. Clausole che riproducano disposizioni o siano attuative di principi contenuti in convenzioni
internazionali di cui siano parti contraenti gli Stati membri dell’U.E. o la stessa U.E.
La disciplina di recepimento si applica a:
1. Clausole previste da essa, sia testualmente sia in via interpretativa; sia a quelle non previste purché presentino i caratteri di vessatorietà previsti dall’art.33 Cc;
2. Clausole non predisposte direttamente dal professionista ma da terzi e da questo utilizzate; sia clausole di altro contratto, come le clausole di rinvio o per relationem richiamate o assoggettate a regolamenti predisposti dal professionista o dalla P.A.
3. Si applica ai contratti conclusi per atto pubblico, con l’assistenza di notaio.
b) Collocazione nel titolo II (<< dei contratti in generale>>)
La disciplina di recepimento aveva scelto di collocare la nuova disciplina nel codice civile; con la nuova collocazione nel Codice del consumo, le cose non sono cambiate, in caso di dubbio questa deve essere interpretata alla luce della direttiva comunitaria; dei principi del diritto comunitario e delle regole contenute nel codice civile grazie ai rinvii contenuti nell’art.38 e negli artt.142 ss. del Cc.
c) Coordinamento con altre disposizioni
Nel codice civile e nelle leggi speciali sono numerose le disposizioni che si occupano di contratti che abbiano come parte il consumatore. Il loro coordinamento in assenza di regola ad hoc introdotte dalla nuova disciplina deve essere effettuato sulla base di criteri ordinari di interpretazione della legge e nel rispetto del d.comunitario.
Con riguardo:- Alla disciplina delle condizioni generali di contratto (artt. 1341,1342,137 cod.civ.), si ritiene che la
nuova disciplina non sia sostitutiva ma integrativa. In altri termini gli articoli pocanzi citati si applicano comunque ai contratti tra imprese;
- All’art. 1229 cod.civ. (clausole di esonero o di limitazione della responsabilità); la sanzione di tale art. è più grave, in quanto consiste nella nullità, anziché nell’efficacia; essa prevale perché più protettiva per il consumatore;
- Alla disciplina prevista dalle regole di recepimento di altre direttive (es. multiproprietà, viaggi), si applicano solo le clausole di tenore generale, ma non quelle che concorrono singole clausole, perché tali discipline sono da considerarsi speciali, anche se anteriori al recepimento di tale direttiva.
d) Terminologia
Nel testo della nuova disciplina di usa a volte l’espressione clausole “abusive” a volte “vessatorie”, l’espressione “abusive” è data dall’inesatta versione del testo italiano della direttiva; esse devono intendersi omologhe.

Principi generali
1. Autonomia della volontà delle parti; il professionista è limitato nella sua libertà contrattuale perché se inserisce clausole vessatorie, queste (se ne viene accertata l’esistenza) non sono efficaci. Restano salve le clausole che si riferiscono all’oggetto del contratto o al corrispettivo di beni o servizi e le clausole o gli elementi di clausole che siano stati oggetto di trattativa. La forma dei contratti del consumatore è libera, salvo i casi di quei contratti per i quali in cui si prevedano forme vincolate;
2. Principio della chiarezza e comprensibilità delle clausole redatte per iscritto, nel dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Le clausole oscure o incomprensibili, non sono di per sé inefficaci, ma sono intese in modo favorevole alla parte più debole.
Ci si chiede se:
a) Il principio valga anche per i contratti conclusi verbalmente o per fatti concludenti;b) Il giudice possa tener conto delle circostanze del caso (es. il contratto è sottoscritto da un analfabeta , che sa fare solo la proprio firma);
in entrambi i casi soccorre il principio generale di buona fede oggettiva. Si discute se la buona fede sia requisito aggiuntivo al requisito dello squilibrio giuridico tra le prestazioni, siccome il significato di squilibrio è ipotesi contraria alla buona fede, non è necessario effettuare un doppio controllo, ad es. nell’accertamento di clausole vessatorie, essendo sufficiente l’accertamento del significato di squilibrio.
Altre regole
La nuova disciplina contiene regole di carattere generale che riguardano la valutazione di vessorietà, gli effetti della declaratoria, le tecniche di controllo e la legittimazione ad agire:
Disciplina sulla vessatorietà prevede 3 diversi livelli:
1. Clausole dichiarate inefficaci, si tratta di quelle clausole di esclusione o limitazione delle azioni del consumatore nei confronti del professionista, quelle che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o omissione del professionista; di inadempimento inesatto del professionista, ecc.
2. Clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria;3. Clausole non contenute nell’elenco (ved. Art. 33 Cc).
La vessatorietà deve essere valutata tenendo conto di 2 elementi:
I. Contrarietà contro la buona fede oggettiva;II. Squilibrio degli obblghi e diritti derivanti dal contratto.
Il primo è collegato al secondo, poiché in presenza di squilibrio, si può determinare la violazione della buona fede, inoltre questo consente l’inefficacia della clausola, cosa che la violazione oggettiva di per sé non ha.
Lo squilibrio presenta 2 caratteri:
1. Deve essere significativo e deve riguardare i diritti e gli obblighi delle parti, deve avere cioè natura giuridica e non economica; il giudice non può valutare la adeguatezza economica del corrispettivo, del prezzo, ecc solo se:
a) La singola clausola arrechi uno svantaggio al consumatore, ma non sia simmetrica ad altra clausola che arrechi svantaggio al professionista;

b) La singola clausola sia collocata in un contesto che non giustifichi lo svantaggio imposto al consumatore;c) La singola clausola arrechi uno svantaggio che appaia significativo, tale da squilibrare il rapporto tra la posizione del consumatore e quella del professionista.
Si tratta di 3 diverse operazioni interpretative che il giudice è chiamato a compiere tenendo conto della natura del bene o del servizio, delle circostanze e delle altre clausole (art.33 Cc). Nella prima il giudice deve ricavare dal testo la convinzione oggettiva che la clausola sia svantaggiosa per il consumatore; la seconda è più complessa perché questa deve essere considerata alla luce delle altre e coordinata con esse; la terza è estremamente difficile in quanto il giudice deve raffrontare il contratto in concreto esaminato con un modello di contratto “equilibrato”, in sostanza deve valutare l’equilibrio delle posizioni giuridiche previste dal contratto in modo complessivo.
Regole speciali
L’art.. 33 Cc elenca clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, si tratta di una rassegna di clausole utilizzate di frequente nei contratti predisposti dall’impresa, dirette a trasferire i rischi al consumatore, a limitare gli impegni assunti a chi produce o fornisce prodotti e servizi, a incidere sulla durata del rapporto a consentire all’impresa di recedere o di variare il contenuto del rapporto.
Là dove la nuova disciplina colpisca clausole che nel nostro ordinamento riproducono disposizioni di legge, questa rimangono efficaci, in quanto la direttiva e quindi la disciplina di recepimento fa salve le clausole riproduttive di norme.
Gran parte delle clausole contenute nell’elenco corrispondo a quelle che la giurisprudenza aveva già classificato come vessatorie, la cui efficacia è subordinata alla specifica sottoscrizione ex art. 1341, c.2; la clausola è efficace se sottoscritta; nell’art.34 Cc si presume vessatoria e quindi inefficace fino a prova contraria.
Tipi di controllo
La disciplina di recepimento affida al giudice ordinario la competenza in materia di azioni inibitorie e di azioni dirette a far dichiarare inefficaci le clausole vessatorie. Il controllo delle clausole vessatorie è di tipo giudiziale, nel senso che spetta al singolo consumatore contraente promuovere l’azione per la declaratoria e alle associazioni dei consumatori. La legge non prevede l’intervento delle associazioni o delle Camere di Commercio, nel procedimento intentato dal singolo consumatore, ma non è escluso che in via giudiziale tale intervento possa essere ammesso. La disciplina di recepimento deve essere osservata oltre che dallo Stato e quindi dalla P.A. anche dalle c.d. agenzie indipendenti (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, Autorità antitrust), quando queste dovessero emanare regolamenti afferenti clausole praticate nei confronti dei consumatori, esse non potranno ignorare la nuova disciplina, ma anzi uniformarsi ad essa e renderla applicabile.
La sanzione
La sanzione della clausola vessatoria riconosciuta come tale è l’INEFFICACIA, si tratta di una figura speciale di inefficacia, perché presenta caratteriste peculiari:
- è INEFFICACIA RELATIVA: in quanto opera solo a vantaggio del consumatore (art.36 Cc);
- è RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE;
- è PARZIALE: in quanto il contratto rimane efficace per il resto.
La sanzione riguarda solo il contratto preso in esame dal giudice: non riguarda tutti i contratti esistenti sul mercato contenenti identica clausola dichiarata inefficace. Di qui l’utilità di assicurare, oltre che una tutela individuale,anche una tutela collettiva, mediante la legittimazione ad agire per inibitoria concessa ad associazioni e alle Camera di Commercio.

Applicazione giurisprudenziale degli artt. 1469-BIS-SEXIES Cod.Civ. (ora artt. 33-38 Cc)
Numerose sono le pronunce che si sono raccolte negli ultimi decenni sugli artt. 1341,1342, 1370 del Cod.Civ. riguardanti le condizioni generali di contratto.
Nella grande varietà di modelli contrattuali utilizzati solo pochi sono i settori investiti dalla problematica, quali i contratti di assicurazione, i contratti bancari, i contratti di viaggio, di acquisto di autoveicoli, mentre sono rimasti indenni in contratti delle agenzie immobiliari per la compravendita di immobili, i contratti per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ecc.
Per quanto riguarda i procedimenti inibitori, si è delineato un contrasto tra le prime ordinanze, con cui si è ritenuto non sussistente il presupposto dell’urgenza e quelle successive, con cui altri tribunali hanno accolto azioni inibitorie. Il contrasto sembra ora quasi in fase di superamento con una interpretazione estensiva delle disposizioni di natura processuale.
I professionisti, le loro associazioni, le Camere di Commercio
Alcune associazioni di categoria (ABI, per i contratti bancari – ANIA per i contratti assicurativi) hanno segnalato solo alcune delle clausole che più vistosamente appaiono lesive degli interessi dei consumatori. Da questo punto di vista si ricorda il parere del Comitato economico e sociale della C.E. che ha segnalato per tutti i Paesi dell’Unione più di 40 clausole abusive inserite nei contratti di assicurazione e produttive di effetti lesivi degli interessi dei consumatori.
Le Autorità amministrative indipendenti e l’applicazione della direttiva
Nel nostro ordinamento le Autorità di vigilanza, come la Banca d’Italia per le imprese bancarie, la CONSOB per le imprese di investimento mobiliare, l’ISVAP per i contratti di assicurazione, l’Autorità sulle telecomunicazioni, l’Autorità di vigilanza sulla concorrenza e sull’integrità dei mercati hanno conservato poteri sui professionisti dei singoli settori in ordine alla redazione e conclusione di contratti conclusi con i consumatori.
L.580/1993 ha disposto il riordino delle Camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato, e sono state attribuite a queste nuove funzioni e competenze .
Le Camere di commercio possono:
1. promuovere la costituzione di commissioni arbitrali o conciliative per le controversie, sia fra imprese, sia fra imprese e consumatori e utenti;
2. predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
3. promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;4. costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio
e promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale.
Particolarmente significativa è la funzione generale di controllo. L’attuazione di tali competenze, compresa la facoltà di promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie, non solo tra imprese, ma soprattutto fra imprese e consumatore, consente alle Camere di promuovere la tutela del consumatore.

Capitolo nono
La sicurezza dei prodotti, i difettie la responsabilità del fabbricante
Nella società moderna è fenomeno consueto il propagarsi di danni connessi con il processo produttivo. In ogni ordinamento, prima che fossero introdotte leggi speciali o regole ad hoc, la circolazione di prodotti difettosi è stata assoggettata alla disciplina prevista in materia di vendita o di responsabilità civile dai codici e dalle regole consolidate dalla tradizione.
Oggi la garanzia è regolata dal D.lgs. 24/2002, ora artt. 128 ss. Cc.
Responsabilità extracontrattuale. Il principio della colpa
La circolazione di prodotti difettosi provoca danni che possono essere considerati presupposti di un atto illecito. Il danno risentito del consumatore è causato, nell'ipotesi più frequenti, dalla fabbricazione negligente, un prodotto alimentare sigillato contiene corpi estranei, un capo di vestiario che è facilmente infiammabile, una macchina tagliacarte che non ha schermi di protezione per gli operai, sono esempi di prodotti di negligente costruzione o progettazione. In tutte le ipotesi considerate e in molte altre, è possibile identificare dunque una colpa a carico del produttore.
Danno, nesso di causalità, colpa sono gli elementi fondamentali dell'atto illecito extracontrattuale. Le norme applicabili sono quindi quelle di responsabilità civile e in particolare la clausola generale dell'art. 2043 del cod. civ.
Il principio "nessuna responsabilità senza colpa", opera anche in materia di responsabilità del produttore; l'esperienza italiana sintomatica dell'arretratezza dei modelli codicistici e della giurisprudenza, ha sempre seguito il principio nessuna responsabilità senza colpa. In un primo tempo, in verità, si è tentato di escludere la responsabilità diretta del produttore, successivamente la colpa del produttore comporta responsabilità aquiliana a suo carico. Inoltre si risale alla responsabilità del fabbricante anche in un caso nel quale non vi erano prove evidenti della sua colpa: una bottiglietta di coca cola estratta da un refrigeratore esplode non appena posata sul banco di mescita, ferendo la venditrice; l'improvvisa e insolita esplosione viene considerata circostanza sufficiente a fondare una colpa dell'imbottigliatore per aver posto in circolazione un contenitore difettoso.
Particolare rilievo hanno della suprema corte in materia di danni da prodotti:
1. La prima ricorrere ancora al principio di responsabilità per colpa -in assenza di prove evidenti della negligenza del fabbricante-ritiene che la responsabilità che porta egualmente affermare quando, da un'attenta valutazione delle circostanze, la colpa può essere presunta.
2. La seconda ritiene che la responsabilità oggettiva del conducente dell'autoveicolo per danni dovuti a vizi di costruzione non esclude la responsabilità per colpa del costruttore.
Nozione di difetto = intesa non solo nell'accezione di meccanica assenza di parti o ingredienti necessari, o di presenza di corpi estranei del prodotto, o di ridotto uso del prodotto, ma anche nel senso di mancanza di adeguate informazioni nell'uso.
Confini della responsabilità = tutti i soggetti danneggiati dal prodotto devono essere risarciti, ma le loro richieste non possono rivolgersi agli intermediari o ai rivenditori, i quali di solito non hanno colpa nella produzione del danno. Quanto ai soggetti che sono legittimati passivi del risarcimento, la dottrina ritiene sia possibile affermare la responsabilità solidale del produttore di singole parti del prodotto e del produttore del prodotto finale.
Nell'ambito della prova, ci si chiede se occorre dare la prova della negligenza del fabbricante, il linea astratta, la risposta deve essere positiva; sì che nell'eventualità che il consumatore non riesca ad addurre prove convincenti, non sarà possibile affermare la responsabilità dell'impresa.

Importante è segnalare il fatto che il concorso di colpa del danneggiato non esclude, a priori, la responsabilità dell'impresa: la presenza di un difetto del prodotto è sempre un evento che incide sul processo causale del danno. In alcuni casi, tuttavia la giurisprudenza ha deciso in senso contrario, escludendo la responsabilità del produttore in presenza di atti negligenti del danneggiato.
Il rischio d'impresa
La tesi che fa riferimento all’art. 2043 cod. civ. al fine di fondare una responsabilità per colpa del fabbricante è certamente la più fedele al dato letterale del codice civile e ha incontrato non solo il favore della giurisprudenza ma anche quello di parte della dottrina.
Ad ogni costruzione dottrinale che elegga ha proprio fondamento il principio della responsabilità per colpa (anche presunta) nella individuazione delle direttive da applicarsi alle fattispecie di danni derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali si è infatti obiettato che:
a) ogni sistema fondato sulla colpa è viziato da veri e propri pregiudizi di natura storica e di natura ideologica;
b) il ricorso a tecniche di presunta colpa è frutto di un'anacronistica fictio iuris, e comporta un errore logico nella interpretazione delle norme giuridiche;
c) il sistema fondato sulla colpa esclude ogni tentativo di assicurare una razionale distribuzione del rischio;
d) il sistema fondato sulla colpa ha un costo sociale molto più alto del costo dei sistemi fondati su altri criteri di imputazione, in particolare dei sistemi informati al principio del rischio d'impresa (responsabilità oggettiva).
Il consolidarsi di regole di responsabilità svincolato dal presupposto soggettivo della colpa e l'imputazione al produttore di responsabilità (oggettiva) per rischio d'impresa si collocano nell'ambito della responsabilità civile.
È corrente opinione, che sui principi di responsabilità oggettiva si fondi l’art. 2049 cod. civ., in tema di responsabilità dei padroni e committenti per danni cagionati dai dipendenti e preposti; e che a criteri di natura oggettiva sia ispirata alla responsabilità dell'esercente di attività pericolose ( art. 2050), del custode di cose e di animali (artt. 2051, 2052), dei proprietario di edifici (art. 2053) e di autoveicoli (art. 2054).
In materia di circolazione di prodotti difettosi, alcuni autori ritengono che la responsabilità oggettiva debba colpire solo le imprese di grandi dimensioni, mentre per quelli di ridotte dimensioni, per le imprese artigianali e così via siano più adeguati i criteri fondati sulla colpa. Altri propongono di applicare il criterio del rischio d'impresa solo nell'ipotesi di danni derivati da difetti di produzione o per omessa informazione, ma non nei casi di difetti di progettazione, perché riscontrandosi questi tipi di difetti, non in un articolo isolato ma in tutti gli articoli della serie, l'onere accollato all'impresa risulterebbe troppo gravoso. Altri infine escludono l'operatività del criterio della colpa e propongono un'applicazione indifferenziata del criterio del rischio d'impresa, ricavandolo dall'art. 2049 che non disciplina solo le attività svolte dai dipendenti, ma può inteso in un senso più generale, come regola di responsabilità di tutte le attività svolte in forma imprenditoriale.
Nell'esperienza statunitense la definitiva affermazione della colpa del fabbricante è stata fermata nel caso Greenman, dove si afferma che il "produttore è oggettivamente responsabile, se diffondendo un prodotto sul mercato, con la consapevolezza che esso sarà usato senza alcun controllo preventivo, il prodotto risulta pericoloso per la salute umana.

In realtà, il ricorso alla disciplina contrattuale, la costruzione di garanzie implicite al contratto di vendita, l'affermazione della responsabilità oggettiva del venditore, sono tecniche impiegate dalle corti per pervenire a un risultato preciso: l'imputazione oggettiva del rischio d'impresa, a vantaggio del consumatore.
L'orientamento delle Corti americane viene registrato nella raccolta dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per atto illecito. Il secondo Restatement of Torts, dal 1965 reca un paragrafo aggiunto la sezione 402 A, nel quale trova ampio spazio la regola di responsabilità oggettiva dell'impresa per la fabbricazione dei prodotti difettosi:
1. Chi vende un prodotto in condizioni difettose e pericolose in modo irragionevole per l'utente o il consumatore, o per le cose che a loro appartengono, è responsabile del danno fisico in tal modo cagionato al consumatore o all'utente o alle loro cose, se:
a) il venditore svolge attività di vendita di quel prodotto,b) e ci si può aspettare che il loro prodotto pervenga all'utente o al consumatore nelle stesse
condizioni nelle quali è stato venduto.2. Le regole di cui al comma 1 si applica anche se:a) il venditore ha esercitato tutta la diligenza possibile nella fabbricazione e nella vendita del
prodotto,b) l'utente o il consumatore non hanno acquistato direttamente da o non hanno instaurato
rapporti contrattuali diretti con il venditore.
Questa linea di tendenza è stata accolta con favore dalla dottrina, anche se non mancate critiche ai risarcimenti eccessivamente generosi.
La direttiva sulla responsabilità del produttore e la sua attuazione
Direttiva n. 374/1985, si apre con il principi generale in virtù del quale "il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto".
Per prodotto si intende "ogni bene mobile", ivi compresa l'elettricità a esclusione dei prodotti agricoli naturali;
Per produttore si intende "il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante della materia componente " nonché "ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso ".
Quando si applica il principio generale della responsabilità del produttore?
La direttiva introduce una vera e propria responsabilità oggettiva, perché prescinde dall'accertamento della colpa; il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. L'attenzione si concentra quindi non sul criterio di imputazione della responsabilità, che anche se non menzionato può identificarsi nel rischio o se si preferisce nella emissione medesima del prodotto nel mercato, ma piuttosto sulla nozione di difetto del prodotto, che è difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (quelle relative la presentazione del prodotto, l'uso cui il prodotto è ragionevolmente destinato, il momento della messa in circolazione).
Regola generale di responsabilità oggettiva del produttore
Il provvedimento di attuazione della direttiva è stato incorporato nel codice del consumo agli artt. 114 ss.Si apre con un’enunciazione di carattere generale che recita: “ il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” .

La norma produce una vera e propria ipotesi tipica di responsabilità senza colpa, in quanto circoscrive nell'ambito della responsabilità in termini soggettivi alla figura del produttore, in termini oggettivi ai soli danni derivanti da difetti dei prodotti.
La norma è formulata con l'impiego di espressioni che seguono il tenore degli artt. 2048, 2049, 2052, 2053 cod. civ., a differenza di quanto previsto dall'art. 2048 non c'è una semplice presenza di colpa; a differenza di quanto previsto negli artt. 2052, 2053, non si fa riferimento al caso fortuito come causa di esclusione della responsabilità. La colpa del produttore non è mai menzionata, e le prove di aver diligentemente fabbrica del prodotto, o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non sono ammesse, ed è quindi chiaro che si è in presenza di una responsabilità oggettiva.
Rimane aperta la questione della sopravvivenza del fortuito: ma se il danno cagionato da difetti derivanti da causa ignota, il produttore non può in alcun modo esonerarsi da responsabilità. Se il danno invece è causato da un caso fortuito, tale circostanza deve considerarsi fattore esonerativo della responsabilità del produttore, sempre che si tratti di un evento che da dietro il rischio sotto dall'imprenditore.
A questa concezione sembra ora allinearsi la stessa suprema corte.
L'onere della prova
Art. 120 del codice del consumo dispone:
1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno;2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità, ai fini dell'esclusione della responsabilità è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione;3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Esclusione della responsabilità
Il testo italiano, all'art. 116 riprende quasi letteralmente il disposto della direttiva.Il c.1, lett. e, ove dopo la esclusione della responsabilità del produttore per il c.d. rischio dello sviluppo, precisava: "se il produttore, dopo la messa in circolo del prodotto, abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscere la sua pericolosità, è responsabile secondo le norme del codice civile e se omette di adottare le misure idonee a evitare il danno, quali informazioni del pubblico, l'offerta del richiamo per revisione o l'offerta del ritiro del prodotto". Si ignorano le ragioni della soppressione di questo comma del testo approvato.
La definizione di prodotto
L'art. 115 Cc definisce il prodotto:
1. Prodotto, è ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile;2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
Rispetto al testo della direttiva, si è aggiunta la definizione del prodotto, si è esclusa invece l'applicazione della direttiva ai prodotti agricoli del suolo e a quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia; occorre precisare che la direttiva lasciava liberi gli Stati membri di includere anche queste fattispecie.
La definizione di produttore
Art. 103 enuncia le definizioni di produttore:
1. Produttore è il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto, gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

2. È distributore qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
3. Art. 116 dispone che sia sottoposto alla stessa responsabilità del produttore, il fornitore che abbia distribuito il prodotto omettendo di comunicare al danneggiato l'identità del produttore.
La definizione di difetto
Art. 117 enuncia i criteri con i quali identificare il prodotto difettoso. Si considerano ipotesi più frequenti di responsabilità: l'errata progettazione, l'errata fabbricazione e l'errata confezione del prodotto; anche le omissioni o gli errori dell'informazione costituiscono fondamento di responsabilità oggettiva del fabbricante e, ove necessario, dell'importatore e degli altri soggetti considerati responsabili.
Intervento di un terzo e colpa del danneggiato
L'intervento del terzo non esclude la responsabilità del produttore (art. 8 c.1), la colpa concorrente danneggiato può comportare la riduzione o la soppressione della responsabilità del produttore (art.8 c.2).
Il testo italiano non riproduce il testo dell'art. 8, c.1, trattandosi di un principio ovvio è costantemente applicato in giurisprudenza, quest'ultima tende a equiparare l'intervento del terzo al caso fortuito, e quindi a esonerare il danneggiante. Tale principio potrà convincere il giudice della opportunità di affermare la responsabilità del produttore anche se vi sia intervento del terzo; si tratterà di accertare, secondo le circostanze, in che misura tale intervento abbia inciso sul processo causale del danno.
Prescrizione, decadenza, requisiti di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno
Le regole previste nel testo italiano non comporta particolari novità è stata quella della direttiva. Una sola annotazione vale la pena di fare: l'introduzione nel decreto italiano del requisito di proponibilità dell'azione per il danno a cose, e il fatto che non si è previsto un massimale per i danni da difetti di serie. La giurisprudenza esclude il risarcimento del danno morale, posto che la responsabilità prevista del d.p.r. 224/1988 ha natura sostanzialmente obiettiva, il produttore che sia ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere condannato al risarcimento del danno morale.
La giurisprudenza
A differenza di quanto accaduto in altri paesi dell'U.E., la giurisprudenza in materia di responsabilità del fabbricante nel primo decennio di applicazione del d.p.r. 224/1988 non è stata copiosa, anzi le pronunce si contano in un numero esiguo.
In ordine agli aspetti processuali, alla Corte di Cassazione ha precisato che la domanda diretta a far valere la responsabilità aquiliana del produttore per i danni conseguenti ai difetti di costruzione della cosa è fondata su presupposti diversi da quelli dell'azione di rivalsa rivolta al costruttore chiamato a rispondere dei vizi dell'opera eseguita con materiale difettoso contro il fornitore del materiale e pertanto non può essere proposta per la prima volta in appello.
L'onere della prova che grava sul produttore in ordine alla messa in commercio di un prodotto esente da difetti è assolto quando sia provata tale circostanza, sicché il produttore non risponde del danno risentito dalla vittima se questa non sia in grado di provare l'esistenza del difetto successivamente alla sua messa in commercio.
Sulla destinazione prevedibile del prodotto all'uso, una sentenza del Tribunale di Monza ha precisato che il fabbricante di una mountain-bike è responsabile del danno provocato all'utente dalla rottura della forcella e dal distacco di una ruota mentre l'utente percorreva un sentiero di campagna. Quando tuttavia l'uso non sia prevedibile da parte del fabbricante, questi è esente da responsabilità: la corte di cassazione ha così statuito a proposito di un'altalena collocata nei giardini comunali, sulla quale era salito minore, anziché prendere posto sul sedile il minore era salito sul bracciolo, perdendo l'equilibrio e amputandosi un pollice.

Il difetto può riguardare anche le modalità di fabbricazione del bene e che siano casualmente collegati con il danno derivante dal suo contenitore, sicché è stata affermata la responsabilità del produttore di una bottiglia
di succo il cui atto si era improvvisamente staccato colpendo il consumatore, per effetto della fermentazione del liquido non sufficientemente pastorizzato.
In un caso nel quale aveva trovato la morte per ustioni una neonata perché la coperta termica, non provvista di dispositivo termostatico, la cassazione penale ha sottolineato che proprio l'assenza di normativa ad hoc, dalla quale deriva l'obbligo del fabbricante di inserire tale dispositivo, implicava il dispiego di maggiori cautele e attenzione da parte del fabbricante.
Sulla responsabilità solidale del produttore di parti staccate e del venditore che le abbia assemblate si registra una pronuncia del tribunale di Milano, ciò perché il prodotto non presentava le necessarie condizioni di sicurezza e perché il montaggio avrebbe dovuto essere eseguito a regola d'arte. Qualche incertezza si riscontra sul coordinamento tra disciplina delle garanzie contrattuali e disciplina della responsabilità civile. In un caso in cui un trattore aveva causato danni al conducente, il tribunale di Pesaro ha escluso la responsabilità extracontrattuale del fabbricante, e ha ammesso la responsabilità contrattuale del venditore-concessionario, ma solo per i difetti del veicolo.
Il settore nel quale si registra il maggior numero di pronunce concerne l'esercizio di attività pericolose; si tratta ad es. dello scoppio di bombole a gas, fattispecie ben nota e frequente; a questo proposito la suprema corte ha precisato che nell'ipotesi in cui non sia fornita la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode, riferendosi a due omissioni differenti.
Problemi attuali
Uno dei problemi più spinosi riguarda il rischio dello sviluppo, cioè la produzione e la distribuzione di beni ormai obsoleti rispetto ai nuovi traguardi della scienza e della tecnica.
La Corte di giustizia ha precisato che per potersi liberare dalla responsabilità, il produttore di un prodotto difettoso deve dimostrare che lo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche al momento della messa in commercio del prodotto, non consentiva di scoprire i difetti di quest'ultimo.
La Suprema Corte ha precisato che è da ritenere esercente attività pericolosa, colui che produce una sostanza potenzialmente lesiva da utilizzare per comporre un farmaco destinato ad essere ineattato nell'organismo umano, pertanto ai sensi dell'articolo 2055 del cod. civ. egli è responsabile in solido con il produttore finale dei danni derivanti dall'uso del medicinale, salvo che e provi di aver impiegato ogni cura e misura secondo le conoscenze tecniche e scientifiche esistenti, atte a impedirlo.
Altro esempio emblematico è dato dalla responsabilità del fabbricante di prodotti da fumo, cui opera il principe di accettazione del rischio in base al quale il consumatore che non può ignorare il danno derivante fumo e tuttavia si accolla volontariamente il rischio, non può chiedere il risarcimento. Tuttavia sono in corso altri procedimenti che potrebbero avere esito diverso, ciò perché le case produttrici di prodotti da fumo non avrebbero informato i consumatori dei risultati di ricerche da esse commissionati concernenti sia l'assuefazioni al prodotto, sia la sua nocività effettiva.
Monitoraggio della Commissione europea e le modificazioni alla direttiva.
La direttiva n. 85/374/CEE aveva realizzato un'armonizzazione solo parziale, una prima relazione è stata presentata nel 1995, dove era stata posta in luce il necessario adeguamento progressivo degli ordinamenti alle nuove regole e la scarna giurisprudenza che nei primi anni di applicazione si era venuta formando in materia.
Il Parlamento europeo ha approvato la modificazione direttiva, a seguito dell'epidemia della mucca pazza, in base alla quale prodotti agricoli non trasformati e prodotti della caccia sono stati esclusi nell'area della responsabilità del produttore.

Nel luglio del 1999 la Commissione ha pubblicato un libro verde sulla responsabilità civile per danno da prodotti difettosi per accertare se si dovessero introdurre ulteriori modificazioni.
In attuazione della direttiva 99/34/CE, il d.lgs. 25/2001 ha modificato la disciplina del d.p.r. 224/1988 sopprimendo l'esenzione dei prodotti agricoli.
La corte di giustizia europea ha affrontato il problema dell'attuazione della direttiva 85/374/CEE con riguardo al rapporto tra le regole da essa recate e la disciplina preesistente negli ordinamenti nazionali, secondo la pronuncia, la disciplina prevista in sede comunitaria non può essere derogata per offrire al consumatore una tutela maggiore. La sentenza appare del tutto arbitraria, dal momento che le direttive offrono una tutela minimale, si attende pertanto di sapere se questa pronuncia sarà confermata da altre successive.
La sicurezza dei prodotti
La direttiva più recente 2001/95/CE, è stata attuata con d.lgs. 172/2004, ora incorporato nel Cc, agli artt. 102 ss.
Art. 103 Cc definisce prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, conclusa la durata e la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcune rischio oppure presenti rischi minimi considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione in particolare dei seguenti elementi: caratteristiche del prodotto, il suo effetto su altri prodotti, la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, la categoria di consumatori esposte ai rischi di utilizzazione, in particolare i minori e gli anziani. È prodotto pericoloso qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.
Art. 104 Cc il produttore deve informare il consumatore su tutti i dati utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla prevenzione dei rischi. Il distributore deve agire con diligenza per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri. L'uso dell'espressione implica che al distributore si possa solo imputare una colpa, ma non una responsabilità oggettiva, salvo il caso in cui non sia identificabile il produttore.
Art. 105 Cc c'è una presunzione di sicurezza derivante dalla conformità del prodotto alla normativa comunitaria e nazionale, tale presunzione non esime produttore, il fornitore o il distributore dalle loro rispettive responsabilità.
Artt.107 ss. prevedono misure di controllo dell'Amministrazione e degli organi comunitari per effettuare le verifiche, per acquisire le informazioni, per vietare la distribuzione di prodotti pericolosi, per prevederne il ritiro dalla circolazione.
Art. 108 Cc consente agli interessati di partecipare alla fase del procedimento amministrativo, agli accertamenti e di depositare memorie e documenti. Oltre agli elementi di responsabilità civile, derivanti dal diritto comune, il codice del consumo prevede sanzioni di natura penale per la violazione di queste disposizioni.
La responsabilità del prestatore di servizi
Il progetto di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizi potenzialmenti dannosi per la salute umana, segue il modello della direttiva sulla responsabilità del fabbricante per i prodotti difettosi. A differenza di questo, il progetto risulta più articolato nelle regole definitorie, oltre a offrire la nozione di servizio (corrispondente a cura di prodotto) e di prestatore (corrispondente a cura di produttore e importatore, si aggiunge nella disciplina attrattiva quella di fornitore), dà pure la nozione di consumatore.
Definizioni:
- Consumatore: persona fisica che è destinataria o fornitrice di un servizio scopo eminentemente privato (si sottolinea la destinazione delle direttiva alle persone fisiche proprio perché lo scopo di questa consiste nel

tutelare la persona fisica del consumatore pertanto deve trattarsi di consumo privato e non effettuato a scopo commerciale).
Il rapporto produttore-consumatore è costituito da un contatto sociale, in quanto non vi è una relazione contrattuale diretta tra i due soggetti: il consumatore intreccia i suoi rapporti direttamente con l'intermediario.Nel caso dei servizi, l'utente invece ha un rapporto contrattuale diretto con l'erogatore del servizio: si ricorre perciò a una finzione e si considera anche un questo rapporto extracontrattuale. La soluzione è di natura necessitata per il fatto che gli ordinamenti dei singoli stati membri prevedono, al di là della legislazione
speciale, figure assai diverse tra loro, quali gli obblighi di sicurezza integrativi del contratto, o il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
- Servizio: ricomprende ogni prestazione effettuata a titolo professionale o nell'ambito dell'utenza pubblica, a titolo oneroso o gratuito, che non abbia per oggetto diretto ed esclusivo la fabbricazione di beni mobili, il trasferimento o la cessione di diritti reali o intellettuali e sia realizzata a beneficio di un consumatore. I servizi possono essere anche materiali o immateriali. Non sono considerati servizi gli atti non idonei a provocare un danno fisico al consumatore o ai suoi beni, i trasporti internazionali e i servizi sanitari.Le esclusioni dell'area semantico-normativa di servizio sono dettate da ragioni diverse: per esempio per la fabbricazione di beni mobili esiste già una direttiva riguardo, per il trasferimento o la cessione di diritti reali e di diritti d'autore si tratta di settori che nei paesi comunitari hanno già una disciplina specifica; per i servizi sanitari perché implicano l'intervento su soggetti già affetti da malattie, anomalie o comunque già compromessi nella loro salute, mentre la direttiva progettata riguarda le lesioni che possono derivare da sinistri.
Sono invece ricompresi tutti servizi che si aggregano intorno all'appalto, al contratto d'opera, anche professionale, al trasporto non internazionale, al mandato, all'agenzia.
- Prestatore di servizio: è il fornitore che abbia sede all'interno della CEE, se esterno è considerato tale l'importatore del servizio. Ai soggetti che appartengono alla categoria di prestatore di servizi era dapprima imputata la responsabilità oggettiva per il difetti di sicurezza del servizio prestato. Tale responsabilità era fondata sul rischio creato e sul profitto che se ne trae. Si capovolgeva quindi il tradizionale criterio di impostazione della responsabilità fondata sulla colpa nell'esercizio di professioni liberali e dei destini di. La responsabilità oggettiva non era illimitata. Si trattava come nel caso della fabbricazione di prodotti, di una responsabilità oggettiva attenuata; infatti il prestatore rispondeva del difetto di sicurezza del servizio, intendendosi per tale la lesione della legittima aspettativa dell'utente in ordine alla salute, alla propria integrità fisica e alla integrità dei propri beni.
Per contro, il prestatore si poteva esonerare dimostrando l'intervento di cause non derivante dalla propria volontà (forza maggiore avente natura di causa imprevedibile, irreversibile ed estranea) oppure che il servizio era stato prestato nell'osservanza delle leggi comunitarie o statuale avente natura imperativa o di regole imperative emanate dall'Autorità amministrativa.
Quanto all'onere della prova il danneggiato doveva dimostrare l'esistenza del danno e il difetto di sicurezza del servizio, non era richiesta la prova del nesso di causalità, ma sono la dimostrazione dell'esistenza di elementi suscettibili di stabilire la verosimiglianza del nesso di causalità.
Il modello è stato successivamente modificato e si è attestato alla presunzione di colpa.
La responsabilità non può essere ridotta per l'intervento del terzo ma se vi è concorso di colpa della vittima. Non è consentito ricorrere a limitazioni o esclusioni convenzionali della responsabilità. Si tratta di norme che riprendono la disciplina comunitaria della responsabilità del fabbricante. La prescrizione dell'azione si compie in 18 mesi.
Qualche novità ulteriore si registra nella definizione del danno, perché oltre al danno fisico alla persona, si prevede il risarcimento del danno alle cose, senza le limitazioni ammesse dalla direttiva sulla responsabilità del fabbricante; in più si considera risarcibile il danno morale, ignorato da quella, e pure il c.d. danno finanziario e il lucro cessante collegati con il danno fisico o alle cose. Non è risarcibile invece il mero danno economico.
Ora diventa facile compiere il traslato dal servizio all'attività, quindi considerare assoggettabili alla disciplina solo le attività pericolose in sé e non a qualsiasi attività di prestazioni di servizi potenzialmente dannosa.

Una grave lacuna si registra ove non si precisa che la normativa prevista per la sicurezza deve essere imperativa. Il progetto non è stata mai approvato, ora alcune sue previsioni sono incluse nel progetto di direttiva sui servizi generali in corso di approvazione.