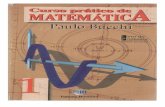Bucchi - Scientisti e Antiscientisti sintesi
-
Upload
myblackrainbows -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
description
Transcript of Bucchi - Scientisti e Antiscientisti sintesi

SCIENTISTI E ANTISCIENTISTIINTRODUZIONEScienza e società non soffrono di un deficit di comunicazione, ma di un eccesso di complicità dovuto a spinte complementari che fomentano la sovrapposizione di società e tecnoscienza. L’insieme di queste spinte è lo “scientismo”, che impedisce di cogliere la vera natura delle sfide che vedono protagonista la tecnoscienza nella società. SCIENTISMO: discorso sui rapporti tra scienza e società che alimenta l’illusoria distinzione tra scienza e società, tra scienza e anti-scienza.SCIENTISMI: La ricerca scientifica propone nuove proposte, che suscitano preoccupazioni dalla parte della società per le loro implicazioni. Da qui l’esigenza di un bilanciamento tra innovazione ed istanze non scientifiche (politiche, morali, etiche). Es. posizione di Einstein nel 1945 di fronte alla produzione di armi atomiche. Posizioni diverse: SCIENTISMO ATTIVO o tecnocrazia (Dawkins, Odifreddi): totale adesione della società alle ragioni della tecnoscienza. Primato degli specialisti nei processi decisionali. Movimenti colonizzatori di domini che prima erano loro preclusi: es. intrusione del settore delle neuroscienze in aspetti tradizionalmente competenti la filosofia. Guerra alla diffusione di idee religiose, intese esclusivamente come forze resistenti al dominio della scienza.SCIENTISMO PASSIVO o antiscientismo: invocazione di una maggiore attenzione politico-sociale nei processi decisionali che coinvolgono la diffusione/regolamentazione di prodotti tecno-scientifici. SCIENTISMO INCONSAPEVOLE: Scientismo attivo e passivo sono complementari, e la loro combinazione rappresenta il motivo per il quale non si esce dal frustrante scontro tra scienza e società. Hanno bisogno l’uno dell’altro (lo scientismo ha bisogno di un “selvaggio” da colonizzare con le manovre della public understanding of science, mentre l’antis. necessita dello straniero a cui resistere). Tale concezione considera scienza e società come entità disgiunte, in cui ogni intromissione è considerata invasione di campo. Ad ogni azione della tecnoscienza corrisponde reazione sociale (movimenti protesta ecc): retorica del bilanciamento e del compromesso. Lo scientismo attivo adotta armi “antiscientiste”: egemonia del mezzi di comunicazione non specialistici (prima mass media considerati responsabili della resistenza alla tecnoscienza).La scienza diviene sensibile alle logiche dei mass media: “Eventificazione” della scienza (es. 2008: avvio esperimento con nuovo acceleratore di particelle al Cern vissuto come evento sociale dal peso internazionale). Lo scientismo attivo adotta armi “antiscientiste”: ricorso ai linguaggi di protesta (es. contro le restrizioni verso le sperimentazioni sugli Ogm). “Isomorfismo istituzionale”: assimilazione di pratiche politiche-istituzionali degli antiscientisti. Lo scientismo fa pensare la scienza come blocco da accettare o respingere in toto: sempre più spesso, però, gli orientamenti sociali verso la tecnoscienza risultano diversificati ed analitici. Es: scissione del termine “biotecnologie” in biotecnologie “rosse” (es. clonazione a fini riproduttivi) e biotecnologie “verdi” (Ogm), con le prime a rischio di stigma generale.Questioni come il “buco dell’ozono” hanno trovato coesione presso il pubblico prima ancora che a livello specialistico: la “partecipazione dei cittadini” alla discussione di temi tecnici tramuta gli stessi cittadini in caricature di specialisti.Spettacolarizzazione della scienza: utilizzo della scienza di cadenze e stilemi propri del settore massmediale per invadere aree da colonizzare. Es. pubblicità con grafici, camici bianchi e tecnicismi. Invasione della scienza di aree a cui prima era estranea: es. “la scienza in cucina” (cucina molecolare ecc.). Questa “addomesticazione” della scienza è funzionale anche allo scientismo passivo, in quanto la scienza diviene elemento di legittimazione per altre pratiche e la stessa scienza viene segregata a questioni di secondo piano per tenerla distante da una discussione sul senso politico di specifici settori di innovazione. L’“addomesticazione scientifica” si incarna anche nell’uso sempre più diffuso da parte dei politici di dati scientifici di dubbia validità: la posizione ideologica sottesa è che solo la garanzia di scientificità determini azioni giuste, sagge, buone. L’appello alla scienza come marchio per mettere a tacere posizioni non scientifiche.

AMBIENTALISMO: Sc. Att.: colonizzazione di un’altra area prima preclusa. Sc. Pass: strumentalizzazione della scienza come arma retorica per legittimare strategie economiche (es. “environmental friendly”) e sociali (retorica dell’innovazione, quale fatto da promuovere tout court). L’ambientalismo è divenuto un tema discusso quanto il tema dell’AIDS tra gli anni ’80 e ’90, divenendo potente strumento di ridefinizione dell’ordine morale.ANTISCIENTISMO CONSAPEVOLE: es.1 una recente analisi storica ha dimostrato come, nella prima fase della vicenda Ogm, già diversi specialisti avessero intuito la propria futura perdita di credibilità presso l’opinione pubblica, rendendosi disponibili a sfruttare mediaticamente la corrente di scetticismo che stava montando.Es2. Studiosi hanno documentato come il dissenso di specialisti verso pratiche come la clonazione a scopo riproduttivo venga argomentato sulla base di parole che incorporano paura pregiudiziale e irrazionalità, generalmente riferite all’opinione pubblica.Lo sc. pass. usa la scienza come risorsa retorica (opportunismo) per avvalorare le proprie testi, lo sc. att. fa lo stesso con la società (opportunismo).
DAL MULTICULTURALISMO AL MULTITECNOLOGISMO?Lo scientismo è, come l’etnocentrismo, un universalismo, che presuppone l’universalità dei risultati della tecnoscienza.La varietà di regimi regolativi che sono applicati ai medesimi prodotti tecnoscientifici (Ogm, cellule staminali di embrioni, ecc) è vastissima. Questi prodotti sono regolamentati in modo diverso negli USA e in Europa (ed anche all’interno della stessa Europa). La spiegazione che di questa eterogeneità danno gli scientisti attivi è sostanzialmente di un “deficit” nei confronti della scienza di cui peccherebbero i Paesi con politiche più restrittive, mentre gli scientisti passivi imputano ad un disinteresse verso ragioni etico-sociali l’eccessivo liberismo dei Paesi meno restrittivi. Nessuna delle due fazioni mette in discussione, però, due schemi fallaci: il primo, che la scienza avanzi e la società insegua, il secondo, l’aspirazione ad una regolamentazione scientifica universale non più ottenibile, a causa della frammentarietà dei centri di ricerca, non più univocamente regolamentabili. Nel primo Novecento questa pretesa era ammissibile per l’esiguo numero dei maggiori centri di ricerca. Oggi, invece, si ha a che fare, oltre che con un numero molto maggiore di centri, con oggetti tecnoscientifici “mobili” (prodotti sofisticati sono divenuti economicamente accessibili anche al singolo consumatore, in grado di sfuggire al controllo di esperti: es. nel 2007 si seppe che il DCA (dicloroacetato) fosse efficace nella cura sperimentale di cancro, e diversi consumatori, in vie non ufficiali, erano riusciti a procurarlo) e “privati” (perché interrogano molto più frequentemente scelte di vita individuali: es. “situazioni di fine vita”) non regolamentabili universalmente. L’altro rischio di questa eccessiva frammentarietà gestionale è che ci si possa concentrare in maniera miope solo sulle conseguenze che i prodotti tecnoscientifici più in voga (es. nanotecnologie) hanno sulla salute, mentre si ignorino totalmente altri temi, come l’esposizione costante alle sollecitazioni prodotte dalle tecnologie dell’informazione.
Nel 2001 Bush decise di limitare i finanziamenti federali alla ricerca su linee di cellule staminali-embrionali prodotte prima del 2001. Venne allora proposta da Hurlbut una “soluzione non tecnologica ad una impasse morale”, che avrebbe previsto, attraverso l’inibizione di un gene fondamentale, un’entità che non si sarebbe mai sviluppata in un essere umano completo. La vicenda è interessante perché mette in luce il fatto che si possa giungere ad una forma di contrattazione condivisa in ambito tecno-scientifico, non dissimile da quella nei dibattiti sindacali. Si prospetterebbe, cioè, l’ipotesi di un multitecnologicismo, ossia la produzione di oggetti tecnoscientifici in base alle priorità etiche, morali o religiose della terra di produzione. Appare quindi in crisi l’idea di scelte generali univoche (anche in caso di “situazioni di fine vita”, tecniche di brain scanning direttamente esportabili nei tribunali consenzienti), a favore di una sempre maggiore frammentarietà. Dal “laboratorio degli stati” agli “stati-laboratorio” (Billings), fino al pensiero della scienza come individualmente plasmabile. Nel settore della tecnologia

dell’informazione, il multitecnologismo è da anni la norma, ma qualcosa di simile sta avvenendo finanche nel settore della produzione energetica (durante la presidenza di Bush 12 stati approvarono piani di riduzione delle emissioni contrastanti con i disegni federali).Il sociologo Merton nel 1968 individuò nella comunità scientifica l’”Effetto San Matteo”, ossia lo stanziamento di risorse e il guadagno di visibilità solo a coloro che già si trovavano in posizioni di prestigio e di visibilità. Questo effetto, secondo Merton, sarebbe disfunzionale alla carriera del singolo, ma funzionale per il sistema complessivo, in quanto consentirebbe di operare una selezione nell’enorme massa dei saggi pubblicati e inviati per le riviste. Questo effetto resta valido anche nell’epoca delle pubblicazioni e archivi digitali? Chris Anderson ha coniato il fortunato termine di “coda lunga” per i mercati digitali, con cui si intende l’enorme proliferazione di merce (a costo di “stoccaggio” zero, a differenza dei negozi fisici), che consentirebbe una vivificazione anche per i mercati più di nicchia. La scienza descritta da Merton, invece, aveva una coda corta. Questo vorrebbe dire che la coda della scienza contemporanea si è allungata, e anche i dati relativi al numero della pubblicazioni (più che raddoppiato rispetto all’inizio degli anni ’90) lo proverebbero. Il guadagno dell’attenzione di riviste prestigiose (quali “Science”) e dei media, è, però, ancora un fenomeno caratterizzato da altissima competizione e selettività. Quest’ultimo processo (in cui ancora persiste l’”Effetto San Matteo”) ne alimenta un altro, il cosiddetto star system, per il quale scienziati che hanno ottenuto grande visibilità diverrebbero brand spendibili sul mercato spettacolaristico. Il fenomeno dello star system rientra perfettamente nelle logiche dello scientismo, perché, costruendo modelli sociali dal peso fittizio e dall’influenza falsamente decisiva, esautora la scienza da quella dimensione autenticamente politica che pure richiederebbe. Nella coda lunga, invece, lo sc. pass. trova una quantità di pareri cui appellarsi per difendere i propri interessi.Kuhn, nella propria teoria dei paradigmi, descriveva la stabilizzazione della conoscenza scientifica come un coagularsi di un paradigma, legato alla trasmissione del sapere (come in una sorta di imbuto) dagli esperti (in forma ancora congetturale e dettagliata) al pubblico, in forma stabile e meno rigorosa attraverso il manuale. Oggi questo modello sociologico è in una fase critica, per due ragioni: La prima, è che alla “testa” dell’imbuto, oltre agli specialisti, si è aggiunta una grande varietà di soggetti attivi: sempre più spesso il pubblico (prima semplice ricettore) è protagonista del dibattito scientifico nel suo farsi (la diffusione online del paper “An exceptionally simple theory of everything”, teoria fisica dal grande fascino, ne precedette addirittura la verifica dei calcoli). Per effetto di simili processi, la verticalità della sequenza comunicativa kuhniana risulta sempre più appiattita in senso orizzontale. Un esempio rivelatore, in proposito, lo offre la questione del cambiamento climatico: di fronte agli inviti di Obama ad accelerare le manovre contro il riscaldamento del pianeta, suffragati menzionando l’indiscutibilità dei dati scientifici in merito, un gruppo di 113 prestigiosi fisici firmò un documento all’indirizzo del Presidente stesso, smentendo quella stessa ostentata certezza dei dati. Come può definirsi un evento del genere? Sono stati gli scienziati ad invadere il campo, o il Presidente?Questo nuovo scenario comunicativo (con i fenomeni di coda lunga e star system) denuncia la fragilità dello scientismo, al punto da ispirare una legge per analizzare in fenomeno del multitecnologicismo “data una posizione X, c’è sempre un parere scientifico Y che la sostenga in pubblico. La sintesi di questo nuovo modello comunicativo la si potrebbe cercare nell’annoso dibattito sull’assegnazione o meno a Plutone del titolo di “pianeta”, viziato da tesi irrazionali, antispecialistiche e caricaturalmente mimanti processi di dibattito pubblico (votazione presso il Congresso di Praga di 400 delegati sull’assegnazione per Plutone del titolo di “pianeta nano”).
PERCHÉ NON POSSIAMO (PIÙ) DIRCI SCIENTISTILo scientismo ebbe un importante ruolo di formazione sociale tra l’Otto e il Novecento, accompagnando l’emergere di una società civile che aveva bisogno di ulteriori punti di riferimento laici da affiancare a quelli religiosi, e costruendo un nuovo ideale di universalismo, dopo il declino dell’etnocentrismo. Lo scientismo, inoltre, rappresenta una valida risorsa in un contesto di comunità scientifiche ristrette e coese. Tuttavia, deformato dal crescente pluralismo multitecnologicista e

dalla trasformazione di risorse tecnoscientifiche in beni di consumo, lo scientismo esplode in una concezione individualista dell’innovazione. Il paradosso scientista è proprio questo: la pretesa di un linguaggio universalista e la concezione della tecnoscienza come bene di consumo individuale. Lo scientismo concepiva la scienza come “scienza di stato” da riversare contro il nemico comune, si trattasse dell’URSS o del cancro. Venuti nel mondo contemporaneo a mancare potenti avversari da colonizzare, ecco che scienza, società e business nel cambiamento climatico trovino un nuovo nemico ed una narrativa comune (2007: premio Nobel ad Al Gore, alfiere dell’ambientalismo).La società contemporanea non è più la società che attende i risultati della scienza, ansiosa di riversarli contro un “muro” (idilliaca immagine scientista), ma è un flusso continuo e ultra-diversificato di desideri e pulsioni: una visione statica della società, paragonata alla mobilità produttiva della tecnoscienza, è una visone funzionale al proliferare dello scientismo, che non potrebbe svilupparsi senza una società pienamente consensuale, disposta a considerare un bambino vivace come un caso di “iperattività”, ad accettare software di rimodellamento fisico. Raramente la società si è consegnata alla colonizzazione detronizzando la propria autonomia morale e politica, nella crescente compenetrazione tra scienza e società.Lo scientismo contemporaneo alimenta l’illusione nel poter ricondurre le continue sfide della tecnoscienza alle categorie decisionali del dibattito pubblico (destra/sinistra, sì/no), alimentando altresì meccanismi come lo star system, in cui specialisti, ridotti a brand pubblicitario, divengono alfieri dell’una o dell’altra posizione. La manovra politica vorrebbe che vi fossero fronti scientisti opposti a fronti antiscientisti. Lo scientismo vive a proprio agio in una “scienza di stato” in quanto bene pubblico, oggi, invece, si trova spiazzato in un contesto che sfugge alle maglie di una regolazione statale. es. di un fallimento emblematico è il “caso islandese”: nel 1998 il parlamento concesse ad un’azienda privata il mantenimento degli accessi ad un database completo di dati genealogici, clinici e genetici dell’intera popolazione islandese. La crisi dell’azienda stesso rivelò fallimentare questo esperimento di scienza, politica, e business, nel quale i cittadini rivestivano il ruolo di personaggio al confine tra azionista e soggetto sperimentale.
La domanda, infine, di fronte alla quale lo scientismo si è rivelato pateticamente impotente è: Che cosa significa essere umani? Fino a che punto è umano colui che si sottopone al trapianto di tessuti animali ? Nello sport l’unità di misura è l’uomo, o l’uomo + tecnologia (costumi da bagno, bicicletta)? Che confine esiste tra uomo e macchina, uomo e animale? Quale è il confine che separa la vita dalla morte? La miopia del discorso scientista non consente riposte precise a tali domanda, e la società (illusoriamente considerata un blocco monolitico opposto al blocco Scienza) deve prendere atto dell’obsolescenza di sistemi di valore invecchiati di fronte alle innovazioni tecnoscientifiche. Basterà, forse, spostare la linea di tolleranza un po’ più in là, verso la direzione in cui la tecnoscienza ci spinge? In questa visione, che accomuna, univocamente, sc. att. e sc. pass,. il progresso della scienza nella società viene ritenuto un costante spostamento di limiti e confini. La differenza tra le due fazioni sta solo nella valutazione che si dà di questo spostamento. In secondo luogo, lo scientismo concepisce lo spostamento del limite solo in senso “verticale” o diacronico (i limiti di oggi saranno spostati dalle tecnologia di domani), mai “orizzontale”: i paesi con misure più restrittive sono semplicemente “in ritardo”. Sc. att. e sc. pass. concordano sulla necessità di un limite: il limite dei primi e remoto e compete fissarlo alla scienza, il limite dei secondi è prossimo e compete fissarlo alla società. Se, però, la missione della tecnoscienza è spostare sempre più in là il limite, perché non accettare serenamente il doping nel ciclismo? Oppure, paradossalmente, a cosa sono dovute le affermazioni che non si affermerà mai alla clonazione a scopo riproduttivo, se questo rappresenta un ulteriore spostamento del limite?Lo scientismo è impraticabile perché implica che la società sia universalista nell’accettare la tecnoscienza, ma relativista nell’utilizzarla. Una concezione della società come peso morto di fronte alla tecnoscienza è intrinsecamente inefficiente di fronte al tentativo di comprenderne le sfide. Da un lato, in ambito scientifico, abbiamo la scoperta della struttura del DNA umano e la sua

interazione con le scienze matematiche e fisiche, dall’altro non è possibile cogliere la portata di questi sviluppi senza una riflessione critica attorno ai temi di identità e differenza.La tecnologia, da questione pubblica magnificata nelle Esposizioni universali dell’Otto e Novecento, è divenuta un fatto meramente privato. Il pregiudizio scientista porta a vedere la società come una controfigura inerziale, lo scientismo passivo a concepire la scienza come entità foriera di problemi. Entrambi sono incapaci di comprendere che aspettative sociali possano sostanziarsi in innovazioni tecnoscientifiche. A questo punto, anche il concetto di limite risulta inservibile, giacché una società in tutto attraversata dalla concezione di superamento del limite non può pretendere di porre limiti al progresso tecnoscientifico.Il modello secondo cui la storia dei rapporti tra scienza e società non sarebbe altro che la storia di una progressiva accettazione dei prodotti della tecnoscienza assomiglia a una concezione progressiva (l’accettazione della scienza come marcia lineare verso la verità) dello sviluppo della scienza, pre-kuhniana. La storia dei rapporti tra scienza e società rivela la fallacia di questa concezione, a favore di una concezione di sviluppo come transizione tra paradigmi ( si pensi all’amianto: nuova opportunità tecnoscientifica accettata in modo “normale”, fin quando studi sulla sua pericolosità lo rendono uno dei nemici numero uno della salute comunitaria). L’analogia con il modello kuhniano regge fintantoché il salto da un paradigma all’altro sono fatti in modo condiviso, passando attraverso momenti di “rivoluzione” per trovare poi un nuovo paradigma su base consensuale (anche “incapsulando” un paradigma scientifico entro un più ampio paradigma politico-religioso, come nel caso dell’”etere” presso i fisici di Cambridge o della fisica quantistica negli anni Venti, come reazione al concetto di causalità che caratterizzava le élite intellettuali della repubblica di Weimar). Naturalmente il cambio di paradigma non necessita di un consenso unidimensionale, quanto più della disponibilità di scienza e società ad operare dialogicamente entro uno stesso quadro metodologico. Le resistenze più grandi ad abbandonare un paradigma non si mostravano presso gli specialisti o il pubblico, ma proprio nell’intersezione tra scienza e società (es. Galileo non seppe accettare orbite ellittiche perché confliggevano con l’idea della circolarità come sinonimo di perfezione). Lo scientismo tuttavia tende ad occultarle, coltivando l’illusione che le tensioni tra scienza e società siano frutto di una crescente distanza tra le due, più che di una loro intersezione.La ragione più importante per abbandonare lo scientismo è legata alla possibilità per la scienza di continuare ad adempiere all’insostituibile ruolo sociale COMUNICATIVO. Gran parte dello scientismo colonizzatore si fonda su una concezione della comunicazione come trasferimento di informazioni, dando, però, per scontato che nessuna alterazione (come una comprensione selettiva) avvenga nel messaggio durante il trasferimento comunicativo, e che la stessa conoscenza in posti diversi produca gli stessi comportamenti. Uscire dalla metafora del trasferimento per comprendere le interazioni multiple tra discorso specialistico e pubblico può portare ad una comprensione più articolata del lessico tecnoscientifico: la comunicazione potrebbe essere vista come una “interferenza” che avviene in certe circostanze discutendo attorno ad “oggetti liminali” (Dna, Big Bang ecc) che si trovano nell’intersezione tra lessico specialistico e popolare, generando così un reale linguaggio comune ed auto rafforzativo, in grado di circolare su più livelli.Lo sc. att. pretende di appiattire la società sulla scienza, lo sc. pass. il contrario. Scienza e società non si capiscono perché si capiscono fin troppo bene, ed “il venire incontro costituisce un avvicinarsi troppo” (Simmel). La società usa la scienza come scusa per non interrogarsi su di sé, la tecnoscienza si fa carico delle paure e desideri sociali. Credendo di scontrarsi, si proteggono l’un l’altra e, nel gioco scientista delle parti, scambiano reciprocamente i ruoli sino a confonderli.