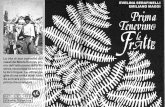AGATHON 2008 def:AGATHON.qxd - UniPa · 2019-11-12 · greci che si esercitavano nella ginnastica e...
Transcript of AGATHON 2008 def:AGATHON.qxd - UniPa · 2019-11-12 · greci che si esercitavano nella ginnastica e...

U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a l e r m oDipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia
AGATHÓNAGATHÓNR e c u p e r o e F r u i z i o n e d e i C o n t e s t i A n t i c h iN o t i z i a r i o d e l D o t t o r a t o d i R i c e r c a
2008/1
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.38 Pagina 1

Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia,Università degli Studi di Palermo
Pubblicazione effettuata con fondidi Ricerca Scientifica ex 60%
A cura diAlberto Sposito
Comitato Scientifico Maria Clara Ruggieri Tricoli Giuseppe De Giovanni Maria Luisa Germanà
Progetto graficoGiovanni Battista PrestileoAldo R. D. Accardi
RedazioneMaria Clara Ruggieri TricoliAldo R. D. Accardi
Coordinamento e SegreteriaAldo R. D. Accardi
Collegio dei Docentiprof. arch. Alberto Sposito (Coordinatore)prof. arch. Antonino Alagnaprof. arch. Giuseppe Cartaprof. arch. Giuseppe De Giovanniprof. arch.Tiziana Firroneprof. arch. Liliana Gargaglianoprof. arch. Maria Luisa Germanàprof. arch. Giuseppe Guerreraprof. arch. Alessandra Maniaciprof. ing. Angelo Miloneprof. ing. Maria Clara Ruggieri Tricoliprof. arch. Cesare Spositoprof. Amedeo Tullioprof. arch. Rosa Maria Vitrano
Finito di stamparenel mese di Aprile 2008da OFFSET STUDIO S.n.c.Palermo
Il notiziario è consultabile sul sitowww.contestiantichi.unipa.it
Con un rinnovato Collegio dei Docenti, questo volume di Agathón documenta l’attivitàistituzionale del Dottorato, ad oggi svolta, che con selezione viene presentata alla comunitàscientifica. Ricordiamo che con il termine tò agathón vogliamo indicare che questo notiziario èun bene, come prodotto, senz’altro utile agli stessi Dottorandi. Esso è suddiviso in tre sezioni.
La prima sezione, Agorá, come lo spazio centrale e collettivo della polis greca, ospita icontributi offerti da illustri studiosi nazionali ed internazionali, esterni all’Università o di altriAtenei, su tematiche umanistiche e scientifiche, che si riferiscono alla letteratura, all’arte, allastoria e all’architettura. Qui sono pubblicati i contributi presentati a un seminario sul temaTeatro e Teatralità, con la partecipazione degli attori drammatici Galatea Ranzi e LucaLazzareschi, e quelli relativi a questioni museografiche a cura di Sandro Pittini, docente a con-tratto alla Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena e di Micaela Sposito, docente a con-tratto all’Università degli Studi di Trento.
La seconda sezione, Stoá, come il portico in cui il filosofo Zenone insegnava ai suoi disce-poli, riporta i temi presentati dai Docenti del Collegio di Dottorato, su questioni che si riferi-scono all’ambito disciplinare di loro pertinenza; qui sono pubblicati i contributi di Maria ClaraRuggieri Tricoli, Alberto e Cesare Pierluigi Sposito, Maria Luisa Germanà, Francesco Asta eGiuseppe Guerrera.
Infine la terza sezione, denominata Gymnàsion come il luogo del cimento per i giovanigreci che si esercitavano nella ginnastica e venivano educati alle arti e alla filosofia, riporta deicontributi presentati dai Dottori di Ricerca Maria Daniela Tantillo, Vanna Lisa Ruggirello,Federica Fernandez, Francesca Scalisi, Aldo R. D. Accardi e Rosa Maria Zito e dai Dottorandi,come estratti delle loro ricerche in itinere, Alessandro Tricoli, Carmelo Cipriano e MariaDésirée Vacirca. Particolari i contributi sullo stato dell’arte per la ricerca nanotecnologica,nelle nostre Sedi Universitarie, negli Istituti del CNR, nel Consorzio I.N.S.T.M. e nell’industriaitaliana.
Questa iniziativa e l’attività editoriale sono state possibili grazie all’impegno del Collegiodei Docenti, in particolare al lavoro straordinario del Dottore di Ricerca Aldo R. D. Accardi eal supporto indispensabile di tutto il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento.
(Alberto Sposito)
AGORÀSandro PittiniLE SOGLIE DEL TEMPO ...................................................................................................................................... 3Micaela SpositoCULTURA, NATURA E MUSEO: ALCUNI CASI IN TRENTINO .................................................................................... 7Alberto Sposito, Galatea Ranzi, Luca LazzareschiUNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL TEATRO ........................................................................................................ 13
STOÀGiuseppe GuerreraIL RECUPERO DEL QUARTIERE GABELLUCCIA A CROTONE ................................................................................ 16Maria Clara Ruggieri TricoliGHOST STRUCTURES: ESEMPI E RIFLESSIONI ...................................................................................................... 19Cesare Pierluigi SpositoLA TORRE DI FALCONARA: MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI ........................................................................ 27Maria Luisa GermanàARCHITETTURA IN TERRA CRUDA IN SICILIA: PROCESSI CONOSCITIVI E CONSERVATIVI ...................................... 31Francesco AstaIL TEATRO COMUNALE DI CEFALÙ TRA STORIA E RESTAURO .............................................................................. 35Alberto SpositoSUL PAESAGGIO “EOLICO”................................................................................................................................ 37
GYMNÁSIONMaria Daniela TantilloLA RICERCA UNIVERSITARIA E LE NANOTECNOLOGIE ........................................................................................ 41Vanna Lisa RuggirelloGLI ISTITUTI DEL CNR E LE NANOTECNOLOGIE................................................................................................ 45Federica FernandezLA RICERCA NANOTECNOLOGICA DEL CONSORZIO I.N.S.T.M. .......................................................................... 49Francesca ScalisiINDUSTRIA ITALIANA E NANOTECNOLOGIE ........................................................................................................ 53Aldo R. D. AccardiLA GLASS-BOX NELLA DEFINIZIONE DEGLI INTERNI MUSEALI: IL MUSÉE DES TUMULUS A BOUGON .................... 57Alessandro TricoliINTEGRARE CITTÀ E ARCHEOLOGIA: UN PROBLEMA APERTO .............................................................................. 63Carmelo CiprianoLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE NELLA RUHR ............................................................ 67Rosa Maria ZitoCOPERTURE, INTERNI, RICONFIGURAZIONI ........................................................................................................ 69Maria Désirée VacircaIL CASO ANOMALO DEL MUSÉE ROMAIN DE NYON .......................................................................................... 73
In copertinaG. B. Piranesi, Rovine con statua mutiladi Pallade, 1745, acquaforte.
A G A T H Ó NNotiziario del Dottorato di Ricerca inRecupero e Fruizione dei Contesti Antichi
2008/1
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.38 Pagina 2

57
LA GLASS-BOX E LA DEFINIZIONEDEGLI INTERNI MUSEALI:IL MUSÉE DES TUMULUS A BOUGON
Aldo R. D. Accardi*
L’architettura contemporanea è connotatada una sempre più accentuata trasparen-
za, frutto di una continua sperimentazioneorientata verso la ricerca della leggerezza delcostruito, ovvero verso la smaterializzazionedell’architettura e la conseguente perdita diponderosità connessa all’eccesso di forma.Detta smaterializzazione costituisce uno deipresupposti più suggestivi oggi configurati nelpanorama della progettazione architettonica, lacui leggerezza viene spesso ricercata sfruttandole potenzialità del vetro e la peculiare caratteri-stica di trasparenza1. Nell’immaginario corren-te il vetro costituisce l’espediente ideale perabolire visivamente la pelle ed il peso di un edi-ficio, ma si scontra con una pratica interventistain cui l’utilizzo di grandi superfici vetrate inmolti casi ha dato prova di un risultato contrap-posto, rivelando un’estrema difficoltà di rende-re percettivamente ‘trasparente’ un edificio.
Da un punto di vista semantico pare che ilvetro possa far ottenere «una delle possibiliconfigurazioni dell’immaterialità architettoni-ca»2; tuttavia è comunque un materiale dotato diuna sua fisicità e quindi, quasi paradossalmen-te, di una sua opacità. Realmente, le superfici invetro si prestano ad un duplice ruolo: neutraleed al tempo stesso mutevole. In determinatecondizioni di illuminazione (naturale e/o artifi-ciale), la proverbiale caratteristica di “leggerez-za” del vetro può difatti tramutarsi in un indesi-derato ed invalicabile effetto specchiante, con-trastando in tal modo tutti i possibili principimetaforici derivabili dall’idea di trasparenza,altresì teorizzati dalla rivista di Bruno Taut,Frühlicht (1918)3, secondo cui l’impiego dellaGlass Architecture, proprio in funzione dell’as-soluta purezza, dovrebbe fare scaturire un pre-ciso effetto catartico4.
L’intenzione di conferire all’architetturaquesto senso di immaterialità non è certo ispi-rata dalle sole esigenze contemporanee, anzitrova radici profonde in un passato non propriorecente. È nell’esperienza ottocentesca cheprende vita l’Era Architettonica della traspa-renza – della quale il “Crystal Palace” diJoseph Paxton costituisce l’emblema – la qualeha indirizzato verso una pratica di sperimenta-zione del vetro come elemento architettonico,strutturale e di design.
È innegabile come l’applicazione di que-sta tecnologia innovativa abbia costretto allaridefinizione culturale, costruttiva e percettivadel concetto di involucro e, conseguentemente,
del suo contenuto. Invero, lo spazio interno nonpuò essere percepito come tale se non è dotatodi un confine, di un limen5. Un confine che, perdefinizione, disciplina le relazioni che intercor-rono tra spazio indoor e outdoor. Utilizzarestrutture in vetro per ottenere “involucri evane-scenti”, comporta una seria riflessione sull’am-biguità di un elemento di separazione il quale,pur delimitando, non impone visivamente la suaconcretezza. O almeno così dovrebbe essere.
Si pensi ad esempio al noto progetto delThermenmuseum (Treviri) di Oswald MathiasUngers, concepito per restituire alla città lerovine sotterranee di un impianto termale pub-blico del sec. III d.C., dove però la scelta diinstallare una struttura di protezione trasparentenon si è rivelata una strategia vincente. La lucesolare riflette i prospetti degli altri edifici suquesto grande “coperchio di vetro”, rendendoquasi invisibili gli ambienti all’interno6. Stessasorte di invisibilità la ritroviamo nel raffinatointervento di Bruxella 1238 (Bruxelles), per ilquale si è scelto di intervenire con una strutturamuseale interamente vetrata, posta a protezionedi un convento francescano del sec. XIII7. Maancora una volta l’inesorabile riflesso sullevetrate impedisce materialmente la visione ditutto ciò che esse in realtà invitano a guardare8.
Ormai da tempo, la sperimentazione dellaGlass Architecture trova applicazione in alcuniinterventi di copertura, protezione e comunica-zione in situ delle rovine archeologiche e di unpiù generico patrimonio storico-architettonico9.Sono anch’essi espressioni che danno consi-stenza ad un’architettura definita da una forteidentità ed un proprio linguaggio. In questi casila “scatola di vetro”, auspicando di risolvere glianzidetti inconvenienti, può giocare un ruolodeterminante nella definizione tanto dello spa-zio interno, quanto dell’atmosfera che avvolgel’antica preesistenza.
Da sempre la pratica museografia contem-poranea si trova a dovere affrontare problemati-che di relazione tra involucro e contenuto. Inalcuni casi si è spesso proposta la dissolvenzadel contenitore espositivo in favore di una piùautentica rappresentazione delle “cose” in essocontenute10. Una dissolvenza che in talune realtàè servita a ricucire il rapporto spazio-temporale,altrimenti perduto, tra rovine “in scatola” e con-testo circostante, ossia tra ciò che sta fuori e ciòche sta dentro.
Ad esempio, con il progetto di valorizza-zione della Domus des Bouquets (sec. I a.C.) a
Dall’alto:Treviri, Germania, Museo delle Terme: vista del museodalla Viehmarktplatz.Bruxelles, Belgio, Bruxella 1238: vista sulle rovinedalla rue de la Bourse.
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.41 Pagina 57

58
Périgueux, Jean Nouvel, avvalendosi di unastruttura interamente vetrata, è riuscito ad otte-nere una soluzione di continuità spaziale e sto-rica tra i resti della domus e le limitrofe traccedell’antica città. Il sito archeologico su cui insi-ste la rovina, sostiene Nouvel, meritava ad ognicosto di essere révélée et protégée11 per mezzodi un’architettura museale trasparente segnatadal difficile compito di confrontarsi con i vari“fantasmi del passato”. L’intervento si proponecome schermo artificiale di un parco archeolo-gico che integra visivamente sia la Tour deVésone, posta a fianco, sia la stessa Domus desBouquets12, rendendo leggibile ciò che in realtàrisulterebbe indecifrabile: il vetro “cattura” lerovine. Questo grande schermo perimetrale,sorretto da esili colonne in acciaio, mette inrelazione la struttura delle domus con i restidella città antica estesi oltre il limen trasparen-te13, ed i frammenti delle rovine indoor si pro-lungano visivamente al di fuori dell’edificionell’inquadratura della città circostante14.Tuttavia permangono inconvenienti di mise enscene delle rovine ed una più evidente incom-pleta comunicazione delle stesse.
Quando si interviene in antichi contesti, ilgesto architettonico e le esigenze di tutela, qua-lora affrontati senza riflettere attentamente sulsignificato delle emergenze archeologiche, pos-sono condurre all’edificazione di puri conteni-tori, la cui caratteristica preminente sembraessere la negazione dello spazio interno e ladecontestualizzazione dei resti archeologici,anziché l’auspicata leggerezza della nuovaarchitettura15.
Discostandosi dal riferire interventi sullerovine romane – o gallo-romane – e nel ritenereche certe ideologie museologiche, posto cheverificate e ad uopo riadattate, trovano applica-zione anche nella valorizzazione di soggettidiversi, si deve menzionare un’altra realtà nellaquale l’insediamento del musée de site non èchiamato ad interpretare o contestualizzare l’e-mergenza da valorizzare, ma piuttosto si “acco-sta” ad essa quasi fagocitandola. È questo ilcaso del Musée des Tumulus di Bougon, in cuila preesistenza tutelata non è il frutto di un’in-tensa campagna di scavi archeologici ma un’ar-chitettura medievale che da sempre si erge intutta la sua interezza.
Simile nell’aspetto al museo di JeanNouvel, il Musée des Tumulus di Bougon, pro-gettato da Jean François Milou16, combinadegnamente espressività architettonica edistanze museologiche, sfruttando il modellotipologico della “scatola di vetro”, già utilizza-to nell’anzidetto caso di Périgueux. Situato nel-l’omonimo parco archeologico (départementDeux-Sèvres), il museo esibisce tutti gli aspet-ti dell’architettura megalitica presenti in un ter-ritorio di grande valore paesaggistico, segnatodalla presenza di numerosi tumuli e da quercecentenarie17.
Qui a Bougon, come già anticipato, laglass-skin, tradotta in un peristilio di metallo evetro, ingloba un’intera sala monastica la cuicopertura è stata sostituita da una chiusurariconfigurativa in legno. Il grande involucro tra-sparente estende la propria struttura fino a cir-coscrivere l’attigua cappella cistercense, dandoforma ad un portico aperto su tre lati. Entrambele preesistenze – la prima riconfigurata e laseconda preservata nel suo stato originale –sono così divenute parti costituenti degli appa-rati espositivi. L’incastro volumetrico tra ilcomplesso monastico e la nuova edificazioneconferisce all’insieme un tocco pacato di vir-tuosismo, ma genera in qualche misura diffi-coltà d’interpretazione dell’antico, che, di fatto,
viene decontestualizzato. L’avere sacrificatol’aspetto interpretativo ha in buona parte smi-nuito il più dignitoso intento di perennità dellapreesistenza, ricercata nella sua pedissequa pro-tezione sotto scatola18. Jean-Paul Robert sostie-ne che la volontà di realizzare un’architetturatanto elementare, quanto ardimentosa, richiedegeneralmente un linguaggio formale semplifi-cato che possiede in sé il rischio di produrreeffetti espositivi traviati, ma pur sempre resilegittimi dalla prevalente esigenza di protezio-ne, peraltro conseguita19.
L’edificio si presenta come un volume sca-tolare puro e non mira ad alcuna sofisticazioneformale. Esso è stato concepito come una gran-de hall coperta, la quale, attraverso l’estesa pare-te in vetro, esibisce la cappella cistercense delsec. XII, percepibile anche dall’esterno. Ciò èreso possibile dallo sfruttamento delle tecnichedell’acciaio e del vetro, le quali contribuiscononella definizione dell’impianto rettangolare econferiscono alla struttura un’impronta di legge-rezza, nonché una morbida integrazione con lamacchia boschiva dentro la quale si colloca. Daun lato, la copertura a trame quadrate rinvia sim-bolicamente alla quadrettatura archeologica tipi-ca delle campagne di scavo, mentre la strutturametallica, realizzata con profilati laccati, nonevidenzia alcun estro compositivo ma rispondeunicamente alla sua funzione portante.
Il sistema di servizi museali presenti nelparco comprende anche l’utilizzo di un fienilead uopo recuperato, il quale, pur rimanendo unvolume indipendente, si connette all’insiemegrazie ad un passaggio coperto da una pensilinaa rete. Rimuovendo parte dello strato calcareopresente nel sottosuolo, è stato ricavato, a circa4 metri al disotto della quota del terreno, ilpiano di acceso al museo; lo stesso materialecalcareo proveniente dallo scavo è stato impie-gato come rivestimento delle murature, contri-buendo sensibilmente alla definizione dellaqualità cromatica e materica dell’interno.
Anche davanti l’ingresso del museo, alcu-ni strati in pietra, spogli ed erosi, si porgonocome base agli spessi muri in cemento a facciavista, qui mitigati dall’innesto di listelli oriz-zontali in mogano. Nell’insieme, la ricercataattenzione al dettaglio mira al raggiungimentodi un effetto ‘rudimentale’ contrapposto alla‘evanescente’ modernità del contenitore.
Probabilmente l’ambizione reale di questahall coperta, apparentemente sproporzionata inrapporto al suo oggetto, risponde ad una più
Bougon, Francia, Parco archeologico Bougon BurialMounds: vista del tumulus A.
Musée de Vesunna: lo schermo vetrato integra visiva-mente le rovine e la Tour de Vésone (foto di Denis Nidos).
Périgueux, Francia, Musée de Vesunna: vista del prospetto di ingresso, dalla cui vetrata traspaiono i resti della Domusdes bouquets.
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.41 Pagina 58

59
grande dimensione paesaggistica ed invita allapasseggiata tra i tumuli, dai quali saggiamentesi discosta20. Si è scelto pertanto di impiantare ilmuseo a circa ottocento metri dalla necropolineolitica, così da proteggere il sito da ogni pos-sibile interferenza visuale che potesse compro-metterne l’integrità21. Realizzato nell’area diun’antica fattoria medievale, il museo funzionacome un padiglione per l’accoglienza di unpubblico orientato alla scoperta del parco edella necropoli.
Il museo dispone di uno spazio destinatoalle esposizioni temporanee nell’ammezzato(circa 500 mq) e di una vasta esposizione per-manente al livello inferiore (circa 800 mq), ilcui apparato museografico si compone di unaserie di ricostituzioni e dispositivi audiovisiviche presentano ognuno dei reperti22. Le colle-zioni provenienti dagli scavi realizzati intorno aBougon e nel resto della regione Poitou-Charentes sono presentate parallelamente adun’esposizione generale sulle culture neolitichenel mondo.
L’organizzazione degli interni, in partico-lare del seminterrato, propone al visitatore unpercorso museale vario, caratterizzato da un’in-trigante alternanza di spazi “chiari” – che pren-dono luce direttamente dall’esterno – e spazi“scuri” – la cui luce artificiale rimanda ad atmo-sfere incorporee e suggestive. La scelta di strut-turare lo spazio interno in grandi sale e gallerieparallele, messe in relazione da un sistema diaperture regolari, consente un’organizzazionelibera del percorso, in cui le murature di cemen-to calcareo si prestano ad una serie di inaspetta-te “variazioni” espositive. Le pareti del museo,difatti, sono state concepite con uno spessoretale da consentire all’occorrenza di accoglierepannelli e vetrine letteralmente “innestate” e dievitare di frastagliare il percorso con bachechetradizionali. La corposità delle tramezzature sipresta allo sfruttamento dei vani delle bucature,le quali, oltre a collegare un ambiente all’altro,integrano nicchie e piccole teche destinate all’e-sposizione di reperti e documenti.
Lo Studio Milou Architecture ha effettuatoun intenso lavoro di “design” destinato proprioall’integrazione/immersione delle vetrine nellospessore dei muri. Queste, costituite da unastruttura di legno grigio lasciato a vista, si inca-strano nelle pareti seguendo il gioco regolare deiricorsi in legno e pietra calcarea. L’anta di vetrodegli espositori – serigrafata al fine di ottenereun effetto di opacizzazione degradante – consen-
te un facile accesso alla collezione composta ingran parte da piccoli oggetti (Amigdale delpaleolitico, attrezzi di pietra levigata, vasi etc.)presentati in serie su pannelli grigi di fondo. Ilvetro smerigliato, con un gioco di illuminazionea doppia sorgente, contribuisce alla definizionedell’oggetto esposto e alleggerisce le stessevetrine, le quali, nella prospettiva della galleria,paiono eclissarsi.
Il sistema di presentazione delle collezioninon è stato concepito per rimanere immutato neltempo, al contrario può essere adattato in funzio-ne delle nuove deduzioni e dei nuovi reperimen-ti provenienti dalle continue campagne di scavo edalle pratiche di campo dell’archeologia speri-mentale. Pur nella sua modernità, il carattereflessibile dell’allestimento del museo di Bougonsi abbina ad un’impostazione piuttosto classicadegli ambienti, che richiama la rigida successio-ne delle Grandes Galeries dell’Ottocento.L’ausilio di supporti museografici molto innova-tivi – che ricordiamo ancora una volta si com-pongono principalmente di ricostituzioni, dispo-sitivi audiovisivi ma anche di oggetti in vetrina– assicurano che la rievocazione e la ricomposi-zione della cultura neolitica di quel territoriopossano avvenire senza incongruenze.
L’attenzione al dettaglio raggiunge ungrande livello di raffinatezza, in funzione dellaquale l’accostamento dei colori e dei materiali –pietra calcarea, cemento a faccia vista, ricorsi inlegno etc. – è stato congeniato per far sì chel’architettura degli interni affidi il proprio valo-re comunicativo alla vitalità organica dei mate-riali stessi, i quali spiccano per effetto della lucenaturale proveniente dall’esterno. La “pelle tra-sparente” consente alla luce naturale di incideresui diversi materiali adoperati, producendo uneffetto di “unificazione materica” tra nuovo edantico, i quali, pur mantenendo palesi le proprieidentità, si compongono in un insieme unitarioe coerente.
Le questioni sorte intorno al concetto dilimen immateriale, nell’esperienza del gruppoMilou, pare avere trovato una risposta priva dicontraddizioni, maggiormente enfatizzata dallagiustapposizione del portico perimetrale, ilquale, interpretato come spazio di esposizione,luogo di passaggio e di transizione tra internoed esterno, si è imposto sin dall’origine nel pro-getto del Musée des tumulus di Bougon.
Derrière cette démarche, s’esquissel’idée d’un musée ouvert sur un parc
Bougon, Francia, Bougon Burial Mounds: foto aereacon vista sul parco delle ricostruzioni.
Bougon, France, Musée des Tumulus: veduta d’insieme.
Bougon, France, Musée des Tumulus: la cappella cister-cense.
paysager, piéton et silencieux, où laprésentation de la recherche actuelles’accompagne d’une promenade médi-tative sur l’homme dans son paysage23.Nei casi sopra esposti, segnatamente
Buogon e Périguex, la luce che dall’esterno per-mea la cosiddetta glass-box, definisce lo spaziointerno in cui le rovine e/o gli oggetti ritrovanonuovi spazi di dialogo con il nuovo intervento,ma spesso a scapito di un già carente progetto dicomunicazione delle rovine. Questa maniera diintervenire sulla preesistenza non rappresental’unica soluzione possibile, anzi le strade per-corribili sono numerose, diverse e tutte ugual-mente valide.
Un approccio più tecnologico, dove lacopertura protettiva costituisce un esempio diperfetta armonia tra l’antico ed il moderno24,eccetto che per gli aspetti museografici, è quellodel Römerbad Museum Badenweiler25. La coper-tura, costruita sulle rovine dei bagni termaliromani di Badenweiler (sec. I d.C.), propone unalettura differente del monumento e sfrutta le qua-lità ottiche del vetro e l’elasticità dell’acciaio,proponendo una nuova contestualizzazione26.
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.41 Pagina 59

60
L’Archäologischer Park Xanten, conside-rato un laboratorio di ricerca sulla comunicazio-ne archeologica, fornisce un’ulteriore chiave diintervento sulle rovine. Contrariamente alle altrepreesistenze del parco, per la musealizzazionedelle Grandi Terme si è preferito rievocare piut-tosto che ricostruire, poiché qualsiasi “aggiunta”avrebbe falsificato la lettura delle varie stratifi-cazioni. La copertura realizzata sulle rovine èforse una delle più coinvolgenti e discrete ricon-figurazioni presenti27, il cui telaio d’acciaioripropone lo scheletro delle antiche terme, e lenuove pareti vetrate configurano l’effetto dimassa dell’edificio originario.
Infine, molto sinteticamente, si ricorda unulteriore esempio di uso del vetro per fini con-servativi e di valorizzazione, ovvero quello delRömermuseum di Heitersheim (progettato daWerner Höfler e Richard Stoll, 2001/2002),costruito sulle rovine di una villa romana delsec. I d.C., nel quale è riconoscibile una letturadifferente del monumento, che sfrutta le qualitàdel vetro per suggerire una sua riconfigurazione.
Se nell’ambito della progettazione architet-tonica contemporanea l’uso del vetro conferisceleggerezza, smaterializzazione ed esprime raffi-natamente la dualità del rapporto interno/ester-
no, in ambito archeologico l’utilizzo della archi-tettura di vetro, se non supportata da efficaciespedienti tecnologici e museografici, mostraancora parecchie contraddizioni.
Nouvelle muséologie e nouvelle archéolo-gie oggi concordano nel mettere in primo pianole esigenze di evocazione delle preesistenze,particolarmente archeologiche, ed esortano allaricerca di un linguaggio ed un simbolismo piùappropriati, soprattutto quando l’intervento diprotezione e valorizzazione delle rovine simuove in canali di assoluta modernità espressi-va e di grande evoluzione tecnologica.
NOTE1) E. RE, Trasparenza al limite. Tecniche e linguaggiper un’architettura del vetro strutturale, Alinea,Firenze 1997.2) Ibidem, p. 11.3) W. NERDINGER et Al., Bruno Taut: 1880-1938,Milano 2001 (tit. orig.: Bruno Taut 1880 - 1938.Architektur zwischen. Tradition und Avantgarde,Monaco di Baviera 2001.4) È un concetto già teorizzato da Paul Scheerbart,poeta visionario di Danzica, nelle sue pagine visionariedi “Glass architecture”; P. SCHEERBART, Glass architec-ture, translated by James Palmes, with an introductionby Dennis Sharp, Praeger, New York 1972; si confron-
ti anche con U. KOHNLE, Paul Scheerbart. EineBibliographie, Edition Phantasia, Bellheim 1994.5) L’uso del termine latino limen, ovvero “soglia”, sipresta ad esprimere pienamente la reciprocità tra “limi-te” ed “eccesso”; cfr. O. CALABRESE, “Limite ed ecces-so: due geometrie”, in IDEM, L’età neobarocca, Einaudi,Torino 1987, pp. 52-55.6) Qui a Treviri, probabilmente, la difficoltà di oltrepas-sare la facciata per effetto del forte riflesso non è l’unicone il principale problema irrisolto. Invero, per ottempera-re ad una precisa espressione linguistica della nuovaarchitettura, la maglia strutturale ha finito con l’interagi-re in modo invasivo sulla materia archeologica; cfr. R. M.ZITO, “Austria e Germania: Il Limes, le ville romane el’archeologia urbana”, in M. C. RUGGIERI TRICOLI, Museisulle rovine. Architetture nel contesto archeologico,Lybra, Milano 2007, pp. 287 e ss.7) Nel 1990, in modo molto innovativo, l’architettoJean-Paul Jourdain ha portato a compimento la sceltamuseografica di rendere trasparente la strada (rue de laBourse), per consentire ai passanti di cogliere la presen-za nel sottosuolo del passato e comprendere la ricca stra-tificazione della storia antica di Bruxelles.8) V. MINUCCIANI, M. LERMA, “Belgio e Lussemburgo:musealizzazioni fra archeologia romana e medievale”, inM. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetturenel contesto archeologico, cit., pp. 196 e ss.9) Naturalmente l’applicazione del vetro per realizzarele anzidette strutture di protezione – e di valorizzazione– è resa possibile dai continui miglioramenti dei proces-si produttivi, i quali hanno potenziato le prestazioni mec-
Bougon, France, Musée des Tumulus: il piano di ingresso in una vista notturna (foto di Javier Urquijo).
Bougon, France, Musée des Tumulus: fienile recuperato.Bougon, France, Musée des Tumulus: il portico in acciaio, aperto su tre lati, avvolge il complesso monastico.
Bougon, France, Musée des Tumulus: vista interna. Ilmuseo ingloba un’intera sala monastica.
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.41 Pagina 60

61
caniche del materiale e superato il limite di fragilità,ottenendo vetri temperati e stratificati molto più resi-stenti alle tensioni di compressione e trazione. Cfr. F.MADEO, Nuvole e piume di cristallo. Trasparenza in con-tinua evoluzione, articolo online al sito Internet:www.architetturaamica.it.10) M. C. RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cose. Lamessa in scena della storia nella comunicazione musea-le, Lybra immagine, Milano 2000.11) V. LASSERRE, F. PANNETIER (curs.), L’Inattendumuséal selon Jean Nouvel, Le Festin, Bordeaux 2002.12) Il museo, denominato Vesunna, è sormontato da unafalda di protezione piana (imponente e lineare), la cuigeometria marcata ripropone l’ingombro dell’interoimpianto gallo-romano, ma allo stesso tempo mette alriparo le rovine dall’irraggiamento diretto del sole e, conun gioco di proiezioni, suggerisce il disegno dell’im-pianto e gli stadi evolutivi della villa.13) Cfr. R. SUCH, Un tetto per la storia [Musée deVésone], in “Domus”, 864, Nov. 2003, pp. 58-71.14) Qui a Périgueux, il penalizzante problema di rifles-sione è stato risolto maggiormente. Sfruttando la capa-cità di ombreggiamento della copertura notevolmenteaggettante rispetto al perimetro vetrato, un sofisticatosistema di illuminazione autoregolante, consente di rag-giungere l’intento originario di trasparenza, cosicché,anche la notte, si offre sia dall’interno che dall’esternouna visione chiara del complesso archeologico. E.CARDANI, Rivelare e proteggere: musée Vesunna,Périgueux, in “Arca”, 189, Feb. 2004, pp. 6-13.15) M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine.
Architetture nel contesto archeologico, cit.16) L’edificio museale, progettato da Jean FrançoisMilou (Studio Milou Architecture) è stato inaugurato nel1993, ma sia il museo che l’intero parco archeologicohanno subito una lunga evoluzione conclusasi nel 2004,che ha visto, tra l’altro, la realizzazione di una caffette-ria nel 1997, nuovi allestimenti nel 1998, la gestione dicerti villaggi intorno al museo.17) È sintomatico dei nuovi indirizzi francesi, più apertialla valorizzazione del territorio extra-urbano, il fattoche un intervento così complesso, che ha a lungo impe-gnato la pubblica amministrazione, sia avvenuto in unsito lontano dagli usuali poli di richiamo turistico.18) La giustificazione di questa scelta museograficainappropriata è ancora una volta rintracciabile nel pen-siero espresso da Jean-Paul Robert; cfr. J. P. ROBERT,Architecture d’aujourd’hui, n. 289, oct. 1993.19) Ibidem, p. 21.20) Molti gli esempi nei quali si è deciso di installare ilmusée de site a debita distanza dal parco stesso per ilquale è stato ideato, come nel caso del Museo della civi-lizzazione celtica di Bibracte sul Mont-Beuvray(Borgogna), il visitors centre del parco preistorico diAltamira (Cantabria), l’Archaeolink Visitor Centre diEdward Cullinan (Aberdeenshire) ed ancora il NavanFort Center (contea di Armagh). Generalmente le moti-vazioni sono da ricondurre ad esigenze di miglioreaccessibilità e/o alla volontà di non interferire con l’am-biente circostante o per non compromettere eventualiprogetti di contestualizzazione, magari attuando precisestrategie mimetiche; cfr. ALDO. R. D. ACCARDI, “I par-
chi preistorici: esperienze internazionali di presentazio-ne del paesaggio come riscoperta delle valenze immate-riali”, in P. PERSI (cur.), Recondita armonia. Il paesaggiotra progetto e governo del territorio. Segni sogni e biso-gni delle popolazioni locali, Atti del 3rd InternationalConference on Cultural Heritage (2006), IstitutoInterfacoltà di Geografia - Università degli Studi “CarloBo” di Urbino, pp. 174-83.21) Nel 1991, il Consiglio generale dei Deux-Sèvresha organizzato un concorso di architettura di cui JeanFrançois Milou è risultato il vincitore. Il programma diquesto concorso definiva sia la natura dei lavori, sia lalocalizzazione del museo sul sito del fienile monasticomedievale. Lo Studio Milou Architecture ha assunto,oltre all’incarico di progettare il nuovo edificio musea-le, il coordinamento dell’insieme degli interventi con-dotti sul sito del museo e della necropoli ed ha realiz-zato ad oggi anche una caffetteria, alcuni allestimenti,elementi di copertura per ospitare le attività pedagogi-che, moduli di scavo ed un nuovo edificio di ingressoal parco.22) La cultura neolitica di Bougon è rappresentata met-tendo in luce tre differenti aspetti, tutti e tre configuraticon una specifico allestimento: il primo tratta l’evolu-zione degli uomini in relazione al paesaggio della regio-ne, il secondo l’insieme complesso di tradizioni e costu-mi, mentre l’ultimo presenta Bougon come uno dei tanticentri ferventi di cultura neolitica.23) Citazione estratta dalla “Fiches descriptives desprojets” dello Studio Milou Architecture, Musée destumulus de Bougon, musée de site archéologique,
Bougon, France, Musée des Tumulus: uno dei modulirecuperati e riconfigurati da una struttura lignea.
Bougon, France, Musée des Tumulus: interno. Vista dell’incastro volumetrico tra l’antico edificio cistercense e la nuovastruttura museale in acciaio e vetro (foto di Javier Urquijo).
Bougon, France, Musée des Tumulus: il portico e lacosiddetta passeggiata di “connesione”.
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.41 Pagina 61

62
(sito online), altresì pubblicata in “Architectured’aujourd’hui”, n. 289, oct. 1993, dalla quale emerge ilpensiero degli stessi progettisti in merito ad alcuniaspetti caratteristici del Musée des tumulus di Bougon.24) H. K. GANS, «Badenweiler/Heitersheim: Römerbadund Villa Urbana», in A. POMPER et Al., ArchäologieErleben, Theiss, Stuttgard 2004, pp. 39-42.25) R. M. ZITO, “Austria e Germania: Il Limes, le villeromane e l’archeologia urbana”, in M. C. RUGGIERI
TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture nel contestoarcheologico, cit., pp. 264 e ss.; S. RANELLUCCI,Strutture protettive e conservazione dei siti archeologici,Carsa Edizioni, Pescara 1996; M. W THOMPSON, Ruins:their preservation and display, British MuseumPublications, London 1981.26) Progetto di Schlaich, Bergermann und Partner diStuttgart; cfr. M. C. RUGGIERI TRICOLI, Teatri e anfitea-tri romani: gli interventi recenti sullo sfondo dell’espe-rienza di alcuni paesi europei, in “Dioniso”, n. 5 (2006),pp. 306-33.27) M. C. RUGGIERI TRICOLI, “Lo Xanten Archäolo-gischer Park: un caso di sperimentazione”, in EADEM eS. RUGINO, Luoghi, storie, musei. Percorsi e prospettivedei musei del luogo nell’epoca della globalizzazione,Dario Flaccovio, Palermo 2005, pp. 105-13; M. C.RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cose. La messa inscena della storia nella comunicazione museale, cit., pp.211-12; EADEM, Siti archeologici: problemi di reinte-grazione culturale e nuove forme di teatralizzazione, in“Dioniso”, n. 2 (2003).
RINGRAZIAMENTISi ringrazia lo studio Milou Architecture per averegentilmente fornito le “Fiches descriptives desprojets” con immagini del Musée des Tumulus.
* Aldo R. D. Accardi è Dottore di Ricerca in “Recuperoe Fruizione dei Contesti Antichi” e professore a contrat-to di “Architettura degli Interni e degli Allestimenti”presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.
Bougon, France, Musée des Tumulus:1 - l’architettura di vetro si confronta con l’antico. Ilgioco virtuoso di incastri è esaltato dall’accostamentodei materiali e dalla raffinata ricerca del dettaglio;2 - l’allestimento interno visto dal mezzanino;3 - lo spazio destinato all’accoglienza del pubblico (fotodi Javier Urquijo, da Milou, 1995);4 - allestimento interno con pareti didattiche (foto diJavier Urquijo, da Milou, 1995).;5 - il sistema di vetrine innestate nelle pareti (foto diJavier Urquijo, da Milou, 1995);6 - sezione trasversale e planimetria del piano ammez-zato (da Milou, 1995).
64
3
5
2
1
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.41 Pagina 62

Febbraio 2008 Galatea Ranzi, Luca LazzareschiAttoriTeatro e Teatralità*
Marzo 2008 prof. Emilio FaroldiPolitecnico di MilanoCostruire l’Architettura. Teorie, Progetti, Tecnologie
Aprile 2008 prof. Amedeo TullioFacoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di PalermoFinalità, Metodologia e Strategie della Ricerca Archeologica, Oggi
arch. Salvatore TringaliEsperto di Restauro ArchitettonicoLa rinascita della Cattedrale di Noto
Maggio 2008 prof. Giuseppina BaroneUniversità degli Studi di PalermoLa ricerca archeologica nei contesti urbani
prof. Giuseppe De GiovanniOrdinario, Università degli Studi di PalermoTavola Rotonda: Valorizzazione e Fruizione del Sito Archeologico di Agrigento*
prof. Mosè RicciOrdinario, Università degli Studi di GenovaL.E.D. - Landscape, Environment and Design
prof. Giuseppe GaetaUniversità degli Studi di CataniaRistabilimento Strutturale per i Beni Culturali
prof. Roberto PietroforteWorcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachussets, USAInnovazione Tecnologica e Management
Giugno 2008 arch. Carmelo CiprianoDottorando in “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi”Aree dismesse a Barcellona, Torino, Milano, Genova e Napoli, OSDOTTA 2007
Settembre 2008 prof. Aldo NorsaOrdinario, IUAV di VeneziaIl Mercato delle Costruzioni
prof. Maria Clara Ruggieri TricoliOrdinario, Università degli Studi di Palermo“Ghost structures” e “Lining out”
prof. Giuseppe GuerreraOrdinario, Università degli Studi di PalermoTemi di architettura urbana
prof. Oscar BelvedereOrdinario, Università degli Studi di PalermoCittà antiche, topografia, storia e tessiture
Ottobre 2008 prof. Alberto SpositoOrdinario, Università degli Studi di PalermoNanotecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali
prof. Francesco AstaUniversità degli Studi di PalermoIl Restauro del Teatro di Cefalù
prof. Paolo PortoghesiOrdinario, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università “La Sapienza”, RomaRecupero del Quartiere latino a Treviso*
prof. Salvatore NicosiaOrdinario, Università degli Studi di PalermoLo Specchio della vita: La Ceramica Greca
Novembre 2008 prof. Sandro PittiniFacoltà di Architettura “Aldo Rossi” di CesenaEsperienze di recupero archeologico in Romagna
prof. Eugenio GaldieriUniversità “La Sapienza” di RomaL’Architettura in Terra Cruda
DOTTORATO DI RICERCA – CALENDARIO DEI SEMINARI ANNO 2008 – AULA BASILE – D.P.C.E.
ISBN 978–88–89683–11–8
Finito di stamparenel mese di Aprile 2008 * Seminari in sedi diverse: “Teatro e Teatralità” e “Recupero del Quartiere latino a Treviso”
presso la sala Consiglio della Facoltà di Ingegneria di Palermo; “Valorizzazione e Fruizione delSito Archeologico di Agrigento” presso la Casa S. Filippo del Parco Archeologico di Agrigento.
AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd 08/04/2008 10.42 Pagina 76