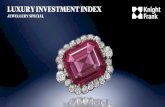10-ottobre_2004
description
Transcript of 10-ottobre_2004

www.allenatore.net - Magazine n.13 Ottobre 2004
FOCUS A R T I C O L O 1
Speciale Mesociclo. La presentazione del palinsesto mensile. A cura di Roberto Bonacini A R T I C O L O 2
Come allenare la forza nel mesociclo. Indicazioni, sugge-rimenti per l’allena-mento della forza nel gioco del calcio. A cura di Giovanni Bonocore A R T I C O L O 3
Come allenare la velocità nel meso-ciclo. Considerazioni e consigli pratici per allenare la velocità del calciatore. A cura di Walter Bucci A R T I C O L O 4
Come allenare la resistenza nel me-sociclo. Esercizi e principi per l’allenamento della potenza aerobica. A cura di Daniele Nervi A R T I C O L O 5
La preparazione atletica nel meso-ciclo.
Come programmare la preparazione condizio-nale nel mesociclo ago-nistico. A cura di Cristian Mazzurana A R T I C O L O 6
Difendere con il 4-3-3: l’Atalanta di Mandorlini. Principi e movimenti difensivi del 4-3-3 nerazzurro. A cura di Massimo Lucchesi A R T I C O L O 7
L’atleta motivato è vincente? L’importanza della motivazione nella performance sportiva. A cura di Fausto Garcea A R T I C O L O 8
Come analizzare il gesto tecnico del controllo palla e migliorarlo. Analisi degli aspetti fondamentali che assicurano una buona ricezione di palla. A cura di M.Mazzantini e E.Guidi A R T I C O L O 9
L’allenamento del portiere nel microciclo. Un esauriente programma didattico per la programmazione dell’allenamento settimanale. A cura di Claudio Rapacioli
A R T I C O L O 1 0
Nello Marano racconta, da un punto di vista tecnico-tattico, la sta-gione 2003/2004 alla guida del Tavagnacco Udine. Intervista speciale al mister friulano. A cura di Roberto Bonacini
SOMMARIO
WWW.ALLENATORE.NET - MAGAZINE è una pubblicazione
mensile edita da edizioni www.allenatore.net ed iscritta nel registro Periodici del Tribunale di Lucca con il n.785 del 15/07/03
Direttore Responsabile: Fabrizio Ferrari; Coordinatore tecnico:
Roberto Bonacini Luogo di stampa: Bozzano, via
Francalanci 418 (LU) Provider-stampatore: I.NET SpA (Web: www.inet.it) via Caldera
21/D - 20153 Milano
EDIZIONI WWW.ALLENATORE.NET SEDE: Via E.Francalanci, 418 -
55050 Bozzano (LU) Partita IVA: 01781660467, C.C.I.A.A. Lucca, R.E.A. 170681, Reg. Imp. 21776
Tel: 0584 976585 Fax: 0584 977273
Alla realizzazione del presente numero hanno collaborato: Bucci W., Nervi D., Lucchesi M., Bonacini R., Rapacioli C., Mazzantini M., Guidi E., Mazzurana C., Garcea F., Bonocore G.

Speciale mesociclo. A cura di ROBERTO BONACINI
La presentazione del palinsesto mensile.
FFinalmente è iniziato…
una frase non certo pronunciata da mogli e fidanzate ma sicuramente da coloro che, a forza di parlare di una palla che corre, che si alza e che si “insacca”, devono a volte, anche giustamente, fare i conti col gentil sesso.
In tutti i modi il campionato è iniziato per davvero, con belle squadre al nastro di partenza, con dei bei goal già realizzati e in generale con quel costume, quella
tradizione e quel fascino che accompagnano e girano intorno al mondo del calcio.
E’ proprio iniziato veramente il campionato e anche questo lo notiamo dai fatti e dalle polemiche, negativi, che inevitabilmente anche quest’anno hanno detto: ci siamo ancora.
E così assistiamo al caso Cassano, al caso Totti/Capello, a più o meno giustificati errori arbitrali (Pieri in Bologna – Roma), alla pressante e talvolta mal usata moviola (alla ricerca di quel qualcosa che ogni tanto non esiste). Intendiamoci solo a volte, in quanto quando lo “strumento” sbircia e scova il calcio di rigore o il fallo (ma dalla posizione e alla velocità da dove e che vede l’arbitro) o ancora meglio il pugno o lo sputo vigliacco, è ben accetta.
Assistiamo poi ancora a squadre che non si sa se giocano o non giocano (Napoli), a una gran voglia di fairplay (Udinese – Brescia) e a monetine o accendini (e qui siamo in Coppa) impazziti.
Nonostante tutto questo, e siamo solo all’inizio, abbiamo il dovere di essere ottimisti, di avere fiducia e di credere in questo sport, con la speranza di assistere finalmente ad un bel calcio e a quello spettacolo che il gioco più bello del mondo può dare.
AArrttiiccoolloo
11
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
RRRR EEEE DDDD AAAA ZZZZ IIII OOOO NNNN AAAA LLLL EEEE

www.allenatore.net
22
Gli auspici ci sono. Grandi campioni, giovani promesse, tecnici competenti; campionato equilibrato, con squadre preparate e con la bella sorpresa delle provinciali pronte da subito a farsi valere e a dimostrare che con la voglia, il lavoro e l’umiltà (vedi anche Grecia Europei 2004) si può anche e forse arrivare lontano; anche e forse in quanto si è appena agli inizi e pertanto affermazioni e convinzioni di oggi lasciano il tempo che trovano.
Bella sorpresa, oltre alle squadre provinciali, è anche e sempre www.allenatore.net magazine. Dal mese di Ottobre cambia un po’ la “veste” e si arricchisce di nuovi collaboratori/autori che vanno ad affiancare i “vecchi”, allo scopo di dare sempre più competenza e qualità alla rivista, analizzando al 100% il calcio con speciali e rubriche mensili. Ma www.allenatore.net, oltre al magazine, è tanto tanto altro. In vista nuove pubblicazioni, nuovi stage di aggiornamento, un archivio dati/argomenti sempre più vasto e completo e altro ancora in “cantiere”.
Ne parleremo più diffusamente nel prossimo numero andando ora a vedere cosa ci riserva la rivista di Ottobre.
Lo speciale di questo mese, Speciale Mesociclo, propone quattro articoli che analizzano in modo dettagliato l’allenamento appunto mensile di una squadra di calcio. Tre di questi trattano singolarmente e analiticamente una singola capacità condizionale; il quarto, strutturato in forma più generale, attraverso un mix dei diversi mezzi di allenamento, analizza la programmazione e la strutturazione di un mesociclo completo.
Giovanni Bonocore ci parla quindi della Forza, Massimo Bucci della Velocità, Daniele Nervi della Resistenza e infine Cristian Mazzurana della programazzione generale del mese agonistico.
La parte tattica di Ottobre è riservata a Massimo Lucchesi. Nella rubrica “Tattica” il nostro esperto ci parla e ci svela le tematiche di gioco e i segreti della fase difensiva dell’Atalanta di Mandorlini.
Ancora tanto materiale da leggere…
Fausto Garcea “esplora” l’argomento motivazione evidenziando gli accorgimenti, utili all’istruttore di calcio, per ottimizzare il rendimento dell’allievo.
Per il settore giovanile Mirko Mazzantini e Federico Guidi ci permettono un ripasso sulla tecnica di base analizzando il gesto della ricezione e/o controllo palla.
Appuntamento poi fisso, e sempre atteso, con Claudio Rapacioli nella rubrica “Il numero Uno”. L’argomento preso in esame, collegandosi anche con lo speciale del mese, riguarda la strutturazione del microciclo del portiere, attraverso tabelle di allenamento alla portata sia di coloro che svolgono sei sedute settimanali sia di coloro che di sedute hanno la possibilità di svolgerne molto meno.
Per finire, non per importanza, anzi, ma per strutturazione del palinsesto, lo spazio riservato al sempre importante e crescente calcio femminile è occupato dall’articolo di Roberto Bonacini che attraverso un’intervista tecnico-tattica ci fa conoscere e apprezzare il tecnico friulano Nello Marano.♦♦

Come allenare la forza nel mesociclo. A cura di GIOVANNI BONOCORE – Sett. Giov. EMPOLI F.C.
L’importanza della forza nel gioco del calcio. Principi generali ed esempi pratici per conoscerla ed allenarla in modo corretto nel mesociclo.
Profilo fisiologico del calciatore.
BBisogna osservare che il carico che un atleta deve sostenere durante un’attività sportiva produce modificazioni profonde sul sistema biologico generale dell’individuo.
Atleti di endurance presentano un consumo di VO2 max molto elevato, mentre atleti impegnati in attività sportive, prevalentemente di forza esplosiva, presentano valori altissimi nei test di valutazione della forza esplosiva.
I dati riguardanti le dimensioni del corpo e quelli relativi alla percentuale di grasso, quando rientrano entro i limiti fisiologici, non sono di grande importanza per il calciatore.
Importante i dati, da un punto di vista calcistico, riguardanti l’analisi (tale studio, anche se non di facile realizzazione, è stato fatto da più autori) del reclutamento muscolare e dell’intervento dei vari tipi di fibre durante la contrazione muscolare.
Quando si effettua uno scatto o un movimento rapido le fibre per prime interessate sono quelle veloci (FT); successivamente durante il recupero sono reclutate le fibre lente (ST). Le fibre veloci FT producono acido lattico, mentre le fibre lente ST hanno una funzione rigenerante e di purificazione.
Nel muscolo abbiamo un mosaico costituito sia da fibre veloci FT sia da fibre lente ST. Ogni unità motrice è costituita da un nervo motore e dalle miofibrille da questo innervate. Generalmente le fibre veloci sono formate da poche fibre muscolari mentre le fibre lente possono avere moltissime miofibrille. Le varie unità motrici sono correlate con la frequenza di emissioni di treni di impulsi; questa frequenza è bassa per le fibre lente (10-50 i/sec) ed alta per le fibre veloci (30-80i/sec). Ciò significa che i muscoli lenti per raggiungere il massimo del loro potenziale non devono essere
aarrttiiccoolloo
22
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
SSSS PPPP EEEE CCCC IIII AAAA LLLL EEEE MMMM EEEE SSSS OOOO CCCC IIII CCCC LLLL OOOO

www.allenatore.net
22
stimolati con frequenze molto alte, cosa che invece avviene per le fibre rapide. Infatti se per le fibre veloci la frequenza di stimolo non è alta, nel momento in cui sono raggiunte da un secondo stimolo hanno già quasi completato la loro fase di produzione di forza; pertanto, dato che si parte da una tensione bassa e non elevata, l’inserimento del secondo stimolo è in ritardo ai fini di sviluppare livelli elevati di tensione. Al contrario le fibre lente ST hanno un’attività di sviluppo e decadimento della forza che dura per un periodo molto lungo e pertanto quando arriva un secondo stimolo successivo la tensione, su cui si inserisce, è già molto alta, favorendo una produzione di forza massimale.
Abbiamo parlato di fibre lente ST; vediamo ora come queste fibre possono essere distribuite, percentualmente, in discipline sportive differenti:
Atleti di discipline caratterizzate da
attività/distanze lunghe
Maratona, sci di fondo, nuoto ecc. Fibre lente 75%
Atleti di discipline caratterizzate da attività
esplosive Pallavolo ecc. Fibre lente 45%
E vediamo ora, sempre percentualmente, la distribuzione di fibre lente ST e fibre veloci FT nella disciplina del calcio:
Fibre lente 50%
Fibre veloci (Jacobs 1982) 60%
Fibre veloci (Apor 1988) 52%
Atleti della disciplina calcio Calcio ecc.
Fibre veloci (Bosco) 55%
Osservando i dati, possiamo affermare che il calcio è una attività in cui sono impegnate in modo rilevante entrambi i tipi di fibre (ST e FT).

www.allenatore.net
33
Studio della prestazione nel calcio.
Il calcio è caratterizzato da sollecitazioni di tipo “intermittente” che sono in gran parte di natura esplosiva.
Uno studio statistico condotto da Mombaerts (1991) dimostra che il 33% delle sequenze o azioni durante una partita hanno una durata di 15 secondi (o meno), e che il 50% delle pause di gioco hanno una durata inferiore ai 15 secondi. Ciò lo spinge a definire il calcio d’alto livello come “un gioco di tipo esplosivo”.
Secondo Dufour (1990), dal passato ad oggi, il numero degli sprint brevi (10-15metri, da 2 a 3 secondi) è stato sempre in crescita.
Anno 1947 N° 70
Anno 1970 N° 145 Scatti a partita
Anno 1989 N° 195
Interessantissimo inoltre è lo studio che negli ultimi anni è stato fatto, con l’ausilio delle telecamere, allo scopo di registrare tutti gli spostamenti dei giocatori e le loro velocità di movimento.
Il dato rilevante ha confermato come le variazioni di velocità al quale è soggetto il calciatore siano veramente elevate.
N° 1000 variazioni di velocità in 90 minuti
N° 11 variazioni di velocità al minuto
Dati medi relativi agli spostamenti e alle variazioni di velocità del calciatore (Colli 2003, mod.
Bonocore)
N° 1 variazione di velocità ogni 5,5 secondi
Quindi il calciatore ogni volta che cambia velocità applica una forza, o per frenare o per accelerare, coinvolgendo fibre muscolari di qualità che utilizzano glicogeno. E’ chiaro quindi che la corsa del calciatore non potrà mai essere economica, poiché non applica forza costante.

www.allenatore.net
44
Definizione della forza.
La forza è definita in fisica la causa dello stato di quiete o di moto di un corpo. La velocità invece è una grandezza fisica, la cui misura, in prima istanza, scaturisce dal rapporto tra lo spazio percorso da un corpo e il tempo impiegato a percorrerlo; si esprime in metri al secondo(m/sec). La velocità quindi come l’effetto dell’applicazione di una forza che ne è la causa “ (Vittori).
Vari tipi di forza.
La forza muscolare, a seconda di come è espressa, può essere classificata in attiva e reattiva.
Forza Attiva
E’ quel tipo di forza che si produce in un singolo ciclo di lavoro muscolare denominato contrattile CONCENTRICO; si realizza con la muscolatura in stato di quiete come per esempio quando un soggetto da seduto si alza in piedi.
Distinguiamo la forza attiva in:
q forza massima: è la forza che permette, di spostare, da fermo, in un singolo movimento e senza limitazioni di tempo, il carico massimo;
q forza massima dinamica: è il modo di esprimere il più velocemente possibile la forza massima, usando un carico standard rappresentato dal doppio del peso del corpo;
q forza esplosiva: si evidenzia quando la muscolatura, in condizioni di immobilità, si contrae tanto velocemente da sembrare un’esplosione.
Forza Reattiva
E’ quella forza che si produce in un doppio ciclo di lavoro muscolare: ciclo di stiramento (lavoro eccentrico) e ciclo di accorciamento (lavoro concentrico); le due fasi di lavoro, eccentrico-concentrico, possono succedersi in un tempo più o meno lungo. Quando si succedono in un tempo lungo si parla di forza “esplosivo-elastica” (per esempio quando un salto verso l’alto è preceduto da un semipiegamento). Quando le due fasi di lavoro si succedono in un tempo breve si parla di forza “eccentrico-riflessa” (per esempio quando si effettua un salto in alto a piedi uniti rimbalzando a terra). L’utilizzo di una o l’altra espressione di forza dipende dalle esigenze dell’obiettivo che si vuole raggiungere.

www.allenatore.net
55
Mezzi di allenamento e categoria allenata.
Categoria Giovanissimi Periodo della stagione: fase iniziale
Squatt didattico 3x15 Salita step conc+ecc. 2x15 Molleggio piedi 3x20 SJ + CMJ 3x10 Glutei corpo libero 3x15 Periodo della stagione: fase centrale Squatt con bilancere scarico 3x10 Molleggio piedi 3x15 SJ con balzo 3x10 CMJ con balzo 2x10 Periodo della stagione: fase finale – fine stagione Squatt con leggero carico 3x8 Addutori con elastici 3x15 Glutei con cavigliere 3x15 Moleggio piedi con sovraccarico 3x10
Categoria Allievi Periodo della stagione: fase iniziale Squatt per ipertrofia 3x10 Salita step con bilancere 3x10 Molleggio piedi con sovraccarico 3x15
Periodo della stagione: fase centrale SJ con bilancere 2x10 CMJ con bilancere 2x8 Circuiti di resistenza forza veloce (RFV) 15”/15”
Periodo della stagione: fase finale – fine stagione Squatt per ipertrofia 3x10 Moleggio piedi con sovraccarico 3x15 Adduttori macchina 3x15 Leg Curl macchina 3x12

www.allenatore.net
66
Categoria Juniores Periodo della stagione: fase iniziale Squatt per ipertrofia 4x10 Squatt per forza max dinamica 3x6
Periodo della stagione: fase centrale Squatt per forza max dinamica 3x6 CMJ per forza esplosiva 3x10 Circuiti di resistenza forza veloce (RFV) 15”/15”
Periodo della stagione: fase finale – fine stagione Squatt per ipertrofia 4x10 Squatt per forza max dinamica 4x6
Categoria Prima Squadra Periodo della stagione: fase iniziale Squatt per forza max dinamica 4x6 Squatt per forza esplosiva 4x10 Periodo della stagione: fase centrale Squatt per forza esplosiva 4x10 Periodo della stagione: fase finale – fine stagione Squatt per ipertrofia 4x10 Sqatt per forza max dinamica 4x6
Periodizzazione del Mesociclo: fasi di carico e scarico.
Squadre con due allenamenti settimanali
1^ settimana n. 2 sedute di forza
2^ settimana n. 1 seduta di forza
3^ settimana n. 2 sedute di forza
4^ settimana n. 1 seduta di forza

www.allenatore.net
77
Squadre con tre allenamenti settimanali
1^ settimana n. 2 sedute di forza
2^ settimana n. 3 sedute di forza
3^ settimana n. 2 sedute di forza
4^ settimana n. 1 seduta di forza
Squadre con quattro allenamenti settimanali
1^ settimana n. 3 sedute di forza
2^ settimana n. 2 sedute di forza
3^ settimana n. 1 seduta di forza
4^ settimana n. 3 sedute di forza
Squadre con cinque allenamenti settimanali
1^ settimana n. 1 seduta di forza
2^ settimana n. 2 sedute di forza
3^ settimana n. 3 sedute di forza
4^ settimana n. 2 sedute di forza
BIBLIOGRAFIA
Aspetti fisiologici della preparazione fisica del calciatore Bosco S.S.S
Calcio e potenziamento muscolare Cometti Calzetti & Mariucci Ed.
La pratica dell’allenamento Vittori S.S.S

www.allenatore.net
88
Breve descrizione di alcune esercitazioni – A cura della redazione.
SQUAT - In piedi, gambe divaricate alla larghezza del bacino; piedi paralleli separati (alla stessa ampiezza delle spalle), con le punte rivolte in avanti e leggermente all’esterno; bilancere sulle spalle dietro la nuca appoggiato sul muscolo trapezio. La presa deve essere un po’ più larga della larghezza delle spalle (può anche essere variata se ci si rende conto che non è confortevole). Il peso del corpo deve essere distribuito ugualmente sui due piedi. In generale comunque ognuno deve adattare la posizione di partenza in funzione della propria costituzione. Inspirare e trattenere il respiro mentre si flettono le ginocchia e si abbassa lentamente il corpo fino alla posizione di flessione sulle gambe. Mantenere i talloni a contatto del pavimento per tutto il tempo. Nel caso i piedi si alzassero controllare che il problema non sia o a livello delle spalle (blocco scapolo omerale, incapacità meccanica di ruotare esternamente l’omero, tensione dei rotatori interni dell’omero), per questo motivo avviene una modificazione delle curve naturali della schiena, o a livello del bacino (il bacino non riesce a ruotare correttamente durante la discesa), o a livello delle caviglie (blocco meccanico o insufficiente elasticità del tricipite surale). Bisogna pertanto risolvere prima questi problemi e successivamente passare all’esecuzione dello squatt. Durante l’esecuzione le ginocchia devono andare leggermente in avanti, i glutei devono muoversi leggermente verso dietro e quindi diritti verso il basso con il tronco che deve inclinarsi in avanti fino a 45° della verticale. Tenere la colonna vertebrale inarcata nella sua posizione normale fino al raggiungimento della posizione finale dell’esercizio (cosce quasi orizzontali). Gli occhi devono essere fissi in avanti. Quando si raggiunge la posizione finale, mantenere il respiro mentre si cambia lentamente direzione distendendo con forza (raddrizzandosi) le gambe mediante l’estensione delle articolazioni dell’anca e del ginocchio. Quando si è raggiunto il punto d’arresto, mentre si risale, cominciare ad espirare e completare questa espirazione quando si raggiunge la completa posizione eretta. Durante i piegamenti, mantenere sempre la colonna vertebrale allungata e i muscoli addominali leggermente contratti
SJ - L’esecuzione corretta prevede un angolo di flessione al ginocchio di 90 gradi. La posizione di partenza è con le gambe divaricate alla larghezza del spalle, talloni a terra, busto eretto il più possibile (senza inarcare la schiena), sguardo in avanti e mani sui fianchi (servono a localizzare lo sforzo sugli arti inferiori limitando al minimo l’utilizzo delle braccia). Dalla posizione di semi accosciata a 90 gradi, senza effettuare contromovimento (senza molleggiare o ulteriori piegamenti sulle gambe), il giocatore deve saltare più in alto possibile (in verticale) a ginocchia estese evitando di richiamare le gambe o di fletterle avanti. Arrivati a terra è consigliabile cercare di ammortizzare l’impatto eseguendo dei saltelli. CMJ - La posizione di partenza è eretta con le mani sui fianchi, talloni a terra, gambe divaricate poco meno della larghezza delle spalle e piedi paralleli. Si scende con veloce piegamento delle gambe a formare un angolo di circa 90° e poi si esegue un balzo massimale verso l’alto a ginocchia estese evitando di richiamare le gambe o

www.allenatore.net
99
un balzo massimale verso l’alto a ginocchia estese evitando di richiamare le gambe o di fletterle in avanti. Arrivati a terra è consigliabile cercare di ammortizzare l’impatto eseguendo dei saltelli minimi (2-3 balzi sulla punta dei piedi per ammortizzare il ritorno a terra). Molleggio sui piedi - Con il molleggio abbiamo l’elevazione sulla punta dei piedi. L’esercizio consiste semplicemente, con carico o senza, nel sollevarsi ritmicamente sulle punte dei piedi riservando molto importanza alla completezza dell’esecuzione. I muscoli maggiormente coinvolti sono; tricipite della sura (gastrocnemio), il peroneo breve e il tibiale posteriore. L’esercizio può anche essere eseguito ricercando l’appoggio sul margine mediale o laterale del piede. Nel primo caso si accentua l’azione sul peroneo breve, mentre nel secondo (appoggio sul margine laterale) è particolarmente stimolato il lavoro sul tibiale posteriore. Se disponiamo di un calf machine possiamo operare in questo modo: posizionare le spalle sugli appoggi del calf machine, portare il tallone all’esterno della piattaforma d’appoggio, rimanendo a contatto solo con l’avampiede. Spingere sulla punta del piede e ritornare poi con il tallone nel punto più basso possibile. Anche in questo caso l’esecuzione deve essere effettuata al massimi ritmo esecutivo e interrotta non appena questo ritmo accenna a diminuire. Glutei a corpo libero - Posizione di quadrupedia. E’ importante che in questa postura ci sia una distanza adeguata tra le ginocchia e le mani; in questo modo si evita di imporre alla colonna vertebrale un atteggiamento in cifosi o in iperlordosi. L’esercizio si realizza estendendo progressivamente la coscia fino al punto che tronco e arto inferiore si trovano in asse. Successivamente si richiama la gamba e si ripete l’esercizio. I soggetti più allenati, dalla posizione raggiunta precedentemente in estensione, possono continuare l’esercizio portando l’arto ancora più in alto per alcuni gradi. In questa fase una parte dell’estensione è realizzata anche dal tratto lombare della colonna che progressivamente diminuisce il raggio di curvatura della lordosi In questo esercizio è il peso della gamba a rappresentare la resistenza contro la quale lavorano i glutei. Una variante dell’esercizio appena descritto, semplice ma efficace, consiste nell’appoggiare i gomiti a terra invece delle mani. Questo permette di inclinare il tronco in basso consentendo, nell’estensione, di portare l’arto più in alto, senza che si verifichi alcun atteggiamento di iperestensione. Per aumentare l’intensità dell’esercizio possono poi essere utilizzate le apposite cavigliere aventi lo scopo di aumentare la resistenza. Salita step con bilancere - Caricare il bilancere sulle spalle e quindi salire sullo step (o un qualsiasi piano rialzato) spingendo alternativamente su di un arto per volta. Espirare ad ogni estensione della gamba e curare la ritmicità dell’esecuzione e la corretta postura. Le ripetizione nell’ambito di ogni serie possono essere eseguite alternando ad ogni estensione della gamba l’arto sinistro al destro o utilizzando sempre lo stesso e poi invertire alla fine della serie. In quest’ultimo caso si

www.allenatore.net
1010
compie un lavoro con effetti più localizzati sugli estensori della gamba, mentre nel primo caso si fanno molte più ripetizioni per serie e quindi il lavoro estende i suoi effetti anche all’apparato cardio-respiratorio. I muscoli maggiormente coinvolti sono; erettori spinali, addominali, glutei, quadricipiti, adduttori, tensore fascia lata e tricipite della sura. Adduttori macchina o con elastici - Seduti all’adductor machine, addurre completamente le cosce ritornando poi in abduzione completa. Ripetere la sequenza. Lo stesso esercizio può essere svolto anche senza l’ausilio della macchina utilizzando la resistenza creata da appositi elastici fissati agli arti; l’esercizio è sempre di adduzione – abduzione delle cosce. I muscoli maggiormente coinvolti sono: grande adduttore, adduttore lungo e l’adduttore breve.

Come allenare la velocità nel mesociclo. A cura di MASSIMO BUCCI – Sett. Giov. CHIEVO VERONA
Conosciamo la capacità condizionale che permette ai nostri calciatori di arrivare sempre per primi rispetto agli avversari. Considerazioni e consigli pratici per allenare la velocità nel calcio.
Velocità uguale forza.
La velocità è un fenomeno che dipende da diversi fattori e principalmente dalla forza. Per definizione la velocità nel moto rettilineo uniforme è data dalla formula Spazio/Tempo, ma sappiamo benissimo che nel calcio non esiste una velocità di spostamento costante, per questo possiamo definire il moto di un giocatore di calcio come accelerato e decelerato. Da qui possiamo affermare che la capacità di accelerazione di un calciatore è data dal rapporto tra forza e massa corporea (a=F/m). Si può dedurre quindi che a parità di massa, un atleta che esprime maggiore forza sarà quindi più veloce.
Fattori che determinano la velocità.
I fattori da cui dipende la velocità sono:
q muscolari;
q metabolici;
q neuromuscolari;
q genetici.
Il diverso numero e sezione di fibre di tipo FT o STt nei muscoli determina un diverso estrinsecarsi della forza e quindi della velocità stessa. La sezione trasversa di un muscolo è direttamente proporzionale allo sviluppo di forza. Inoltre una miglior
aarrttiiccoolloo
33
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
SSSS PPPP EEEE CCCC IIII AAAA LLLL EEEE MMMM EEEE SSSS OOOO CCCC IIII CCCC LLLL OOOO

www.allenatore.net
22
velocità di scorrimento delle guaine connettivali favorisce lo svilupparsi della velocità senza l’opposizione di forze intramuscolari.
I fattori metabolici che incidono su prestazioni di velocità, sono la capacità di un rapido smaltimento di cataboliti e di lattato prodotto nei muscoli e la continua disponibilità di substrati del metabolismo anaerobico alattacido e lattacido.
Gli aspetti principali dal punto di vista neuromuscolare sono un’alta velocità di conduzione dello stimolo (più velocemente arriva lo stimolo al SNC e a sua volta al SNP prima si riesce ad eseguire il gesto), un alto reclutamento di fibre (permette di esprimere più forza), l’allontanamento della fatica sinaptica (carenza di glucosio, di enzimi, in attivazione di recettori), una miglior coordinazione intramuscolare. Su questo punto mi vorrei soffermare per accentuare l’importanza di questo aspetto molte volte trascurato. E’ molto importante per un atleta riuscire ad esprimere alti parametri di forza utilizzando la muscolatura agonista di un gesto, ma è altrettanto importante la contemporanea inibizione della muscolatura antagonista.
Per aumentare la velocità di un atleta dobbiamo quindi migliorare le sue prestazioni di forza ed fornirlo di una buona coordinazione generale e specifica.
L’allenamento ci permette quindi di cambiare, anche se in modo limitato, il volume e la coordinazione delle fibre, ma non può cambiare la loro distribuzione percentuale. Geneticamente un atleta è più o meno predisposto a prestazioni di velocità di alto livello.
Possiamo concludere quindi che mentre le prime tre caratteristiche (muscolari, metaboliche e neuromuscolari) sono allenabili e quindi migliorabili, non lo è il quarto fattore (genetica).
Allenamento della velocità.
Per velocità intendiamo la capacità di realizzare azioni motorie nel più breve tempo possibile (Schnabel, Tiess 1993).
Esistono diverse forme di velocità; in questo articolo prenderemo in considerazione la velocità intesa come la capacità di spostarsi nello spazio nel minor tempo possibile.
E’ preferibile allenare la velocità con esercitazioni a secco, in quanto avendo bisogno di prestazioni massimali e sovramassimali l’utilizzo della palla da questo punto di vista diventa un ostacolo.
La velocità all’interno del mesociclo può essere inserita in ogni seduta d’allenamento rimanendo fondamentale però che il suo svolgimento non avvenga in condizioni di affaticamento. Questo per evitare di incorrere in qualche infortunio, ma soprattutto per evitare, in caso di stanchezza, l’esaurimento o il calo delle risorse energetiche sufficienti per allenarla in modo adeguato. La velocità di contrazione di un muscolo è direttamente proporzionale alla quantità di riserve energetiche disponibili. E’ per questo che l‘allenamento mirato a migliorare la velocità deve essere svolto nella prima parte della seduta e non quando i giocatori iniziano ad accumulare fatica. Di conseguenza è preferibile che l’allenamento di questa capacità condizionale preceda anche le esercitazioni che riguardano le altre altre forme di allenamento atletico.

www.allenatore.net
33
Constatato che per allenare la velocità ho bisogno di prestazioni massimali, ritengo che sia fondamentale ricercare nei giocatori gli stimoli e le motivazioni giuste. Se un giocatore si “abitua” a certi stimoli non si allena, in quanto fatica a svolgere gli esercizi proposti con la necessaria intensità, non ricevendo stimoli allenanti. Bisogna cercare di essere il meno ripetitivi possibile e proporre esercizi che invoglino i giocatori a dare il massimo. Un metodo per ottenere ciò, è quello di proporre piani di lavoro sempre diversi e stimolanti, sfruttando anche il fattore della competizione. Nessun atleta quando è messo in relazione ad un compagno è disposto a fare la figura del perdente di fronte alla squadra e cerca quindi di prevalere sull’altro. Consiglio inoltre di inserire periodicamente esercizi in forma ludica per ottenere un buon allenamento facendo divertire allo stesso tempo i ragazzi, di qualsiasi età essi siano, soprattutto in periodi della settimana o della stagione in cui viene a mancare la necessaria concentrazione e perché no, anche dopo una sconfitta, allo scopo di risollevare un po’ il morale del gruppo.
Per ottenere prestazioni massimali negli allenamenti è anche importante saper proporre esercizi di facile apprendimento e dare ad essi la giusta progressività nei carichi e nella difficoltà. Si inizierà quindi con esercizi semplici e facilmente eseguibili per arrivare poi a quelli più complessi e difficili da svolgere, aumentando di conseguenza il numero di variabili.
La velocità, a differenza delle altre capacità condizionali, non necessita di particolari periodi di scarico. Per allenarla occorrono sempre prestazioni massimali e quindi con un'intensità elevata. Posso eventualmente, nelle settimane cosiddette di scarico, ridurre il volume delle esercitazioni (anche se non deve mai essere troppo ampio) e allenarla in contesti differenti come per esempio nella forma ludica di cui abbiamo parlato precedentemente.
Si consiglia di riservare in ogni piano di lavoro uno spazio per allenare questa capacità, indipendentemente dall’età e dalla categoria, tenendo sempre presente che:
q il volume delle esercitazioni non sia troppo ampio;
q venga dato agli atleti un recupero adeguato per non entrare in uno stato di affaticamento;
q l’intensità degli esercizi sia sempre molto alta.
Velocità e mezzi per allenarla.
Vediamo ora una serie di mezzi d’allenamento che vanno a migliorare direttamente o indirettamente la velocità di un atleta:
q sprint in piano sui 10-20-30mt.;
q sprint in salita su distanze brevi (esempio 10mt.);
q corsa in discesa con pendenze intorno al 5%;
q sprint con sovraccarico (esempio traino, paracadute, ecc…);
q circuiti di tipo elastico-reattivo (esempio skip, appoggi, toccate, balzelli, ecc…);

www.allenatore.net
44
q circuiti di agilità e destrezza (esempio slalom, corsa laterale, salti, capovolte, rotolamenti, ecc…);
q esercizi coordinativi;
q esercizi per migliorare la tecnica di corsa (schema crociato);
q ginnastica propriocettiva.
Microciclo di allenamento per categoria.
Giovanissimi e Allievi (in squadre che svolgono 2 o 3 sedute settimanali)
q Seduta 1:
10’ esercizi coordinativi;
3x4 circuiti elastico-reattivi.
q Seduta 2:
10’ propriocettiva;
sprint in piano 3x5 10mt.
q Seduta 3:
10’ tecnica di corsa;
3x4 circuiti di agilità e destrezza.
(In ogni esercizio è previsto un recupero completo).
Juniores e prime squadre (in squadre che svolgono 3 o 4 sedute settimanali)
q Seduta 1:
15’ propriocettiva;
3x5 sprint con sovraccarico;
10’ circuiti elastico-reattivi.
q Seduta 2:
15’ esercizi coordinativi;
4x4 sprint in salita sui 15mt.;
2x5 sprint in piano sui 10mt. + 2x5 sui 20mt.
q Seduta 3:
10’ circuiti di agilità e destrezza;
3x4 sprint sui 10mt. + 3x4 sui 20mt. + 3x4 sui 30mt.

www.allenatore.net
55
q Seduta 4:
10’ skip vari sui 10mt. (frequenza alta di movimenti);
3x4 sprint brevi con reazione a stimoli.
(In ogni esercizio è previsto un recupero completo).
Squadre professionistiche e Primavera (squadre che svolgono 5 o 6 sedute settimanali)
Solitamente nella programmazione settimanale, viene inserita una seduta dedicata all’allenamento della velocità, ma in ogni piano di lavoro sono presenti esercitazioni che riguardano direttamente o indirettamente questa capacità.♦

Come allenare la resistenza nel mesociclo. A cura di DANIELE NERVI
Dalla sua esperienza di campo Daniele Nervi analizza, in modo approfondito e dettagliato, l’allenamento nel mesociclo, di quella capacità condizionale, la resistenza, che “alla lunga”, sia durante la partita sia durante tutta la stagione agonistica, fa sentire il suo peso.
Introduzione.
Il calcio, come gioco di situazione, richiede un ritmo agonistico che è molto più complesso di una specialità in cui i meccanismi di produzione dell’energia sono più costanti; e per questo che è molto più complesso pianificare la preparazione fisica nel gioco del calcio. Parlando in particolare della resistenza, ravvisiamo che le comuni azioni di gioco sono caratterizzate da un continuo variare d’accelerazioni massimali e submassimali, con cambi di direzione, arresti, recuperi a velocità blanda, recuperi a velocità elevata, recuperi di passo, allunghi ad andatura costante, salti, balzi, contrasti e spostamenti improvvisi in ogni direzione e senso. La programmazione dell’allenamento richiede quindi un impegno d’analisi, valutazione, comprensione e ricerca di una soluzione che possa soddisfare più obiettivi.
Capacità a erobiche ed anaerobiche.
Si tratta di due concetti fondamentali per l’organizzazione del lavoro. Il calciatore, durante la sua prestazione (la partita), consuma energia. Questa energia, in termini biochimici, è attinta dall’ATP (adenosintrifosfato). Quest’ultimo, durante il lavoro muscolare, si trasforma in un sottoprodotto detto ADP (adenosindifosfato). L’ADP, in sé, non può produrre altra energia. L’ATP, quindi, deve continuamente essere risentitizzato attraverso il passaggio ADP-ATP. Evidentemente in questa riconversione è richiesta ulteriore energia, che per l’appunto è fornita dai meccanismi aerobici ed
aarrttiiccoolloo
44
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
SSSS PPPP EEEE CCCC IIII AAAA LLLL EEEE MMMM EEEE SSSS OOOO CCCC IIII CCCC LLLL OOOO

www.allenatore.net
22
anaerobici insieme. L’ATP può essere paragonato al combustibile essenziale per l’esercizio fisico.
Sistema anaerobico alattacido.
Questo primo meccanismo energetico, ha la peculiarità di fornire elevatissimi valori di energia nell’unità di tempo. D’altra parte, però, la sua azione può durare solo 7-8 secondi e non oltre. Dopo tale periodo di lavoro ad intensità massimale, è necessario il riposo perché si ripristini la sua potenzialità. Il sistema anaerobico alattacido nello sport del calcio interviene: nelle accelerazioni massimali, nei balzi e salti, oltre che nella quasi totalità delle azioni del portiere.
Sistema anaerobico lattacido.
Questo sistema, sebbene in potenza sia minore del precedente, genera un cospicuo rifornimento energetico negli sforzi a ripetuta massimale che si protraggono fino a 1-3 minuti. Il meccanismo lattacido agisce sul metabolismo degli zuccheri (o glicidi) e per questo motivo è conosciuto anche come glicolisi anaerobica. Esso possiede una caratteristica peculiare: nella produzione di energia, necessaria alla risintesi dell’ATP, si costituisce acido lattico nei muscoli e nel sangue. Tale accumulo di lattato è responsabile della sensazione di fatica muscolare, la quale si accompagna alla perdita di efficacia dei movimenti. Si può osservare che durante una partita possono essere raggiunte concentrazioni di lattato fino a 12mmol/l che testimoniano dell’importanza di un adeguato miglioramento della potenza anaerobica lattacida.
Distinzioni all’interno del sistema anaerobico lattacido
q Capacità Lattacida - Corrisponde alla quantità di lavoro che si riesce ad effettuare utilizzando come fonte di energia il solo meccanismo anaerobico-lattacido e, pertanto, tollerare l’accumulo di lattato nei muscoli e nel sangue.
q Potenza Lattacida – E’ la quantità di energia prodotta anaerobicamente, nell’unità
di tempo, dalla scissione del glicogeno. E' strettamente collegata al processo energetico anaerobico alattacido nei cui confronti svolge un vero e proprio ruolo di supporto. In condizioni di massima potenza anaerobica lattacida è possibile mantenere lo sforzo per poche decine di secondi. Il miglioramento della capacità aerobica si effettua con lavoro prolungato e, quindi, tale da comportare il giusto utilizzo della miscela energetica glicogeno-grassi. Il miglioramento della potenza aerobica si effettua con lavoro in prove ripetute ove le tensioni muscolari e la durata (quindi velocità esecutiva) portano molto vicino alla soglia anaerobica (mai superiore per non accumulare lattato con conseguente riduzione della attività dei mitocondri cellulari, le centrali "energetiche" dove avvengono le reazioni ossidative aerobiche).

www.allenatore.net
33
Sistema aerobico.
Questo sistema produce energia mediante un processo ossidativo. Ciò sta a significare che il sistema aerobico utilizza l’ossigeno che respiriamo (contrariamente ai meccanismi anaerobici, che per l’appunto agiscono in assenza di ossigeno). Nel calcio la capacità aerobica ha un’importanza indiretta e si riconduce essenzialmente alla rapidità dei tempi di recupero e al ripristino continuo della potenzialità del meccanismo anaerobico.
Distinzione all’interno del Sistema Aerobico
q Capacità Aerobica (o resistenza aerobica) - Possibilità di protrarre a lungo il lavoro grazie alla presenza ottimale delle sostanze energetiche (glicogeno muscolare ed epatico).
q Potenza Aerobica – E’ strettamente legata alla quantità di ATP (Adenosintrifosfato) che il metabolismo aerobico del soggetto è in grado di sintetizzare nell'unità di tempo. Sono determinanti il massimo consumo di ossigeno (detto VO2 max), che è la più grande quantità di ossigeno che si riesce a consumare nell'unità di tempo riferendosi ad 1 Kg. di peso corporeo (ovvero aumento dell'ossigeno nel sangue e maniera ottimale in cui giunge ai muscoli), e la massima intensità di lavoro realizzabile al di sotto della soglia anaerobica (massima intensità di lavoro che può essere effettuata senza ricorrere alla glicolisi anaerobica e, quindi, senza accumulo di lattato nei muscoli).
Responsabili del VO2 max sono principalmente:
q la ventilazione respiratoria; q la gittata cardiaca (quantità di sangue pompata in un minuto); q il trasporto periferico di ossigeno da parte dell’emoglobina del sangue; q la capillarizzazione muscolare; q la differenza arterio-venosa della concentrazione di ossigeno; q l’attività enzimatica a livello dei mitocondri delle cellule muscolari.
Il VO2 max raggiunge il suo valore naturale massimo intorno ai 16-17 anni per poi diminuire progressivamente.
I processi di recupero.
Questo è un argomento che non deve essere assolutamente sottovalutato nella fase di progettazione del lavoro. Si deve sempre avere in mente il concetto che l’allenamento è costituito dalla corretta alternanza tra lavoro e riposo. Il recupero contribuisce esplicitamente all’acquisizione della forma. Prendiamo ora in esame alcune nozioni relative alla programmazione dei tempi e dei tipi di recupero.
Il debito di ossigeno
Le attività anaerobiche provocano da un lato il depauperamento delle scorte di ATP e fosfocreatina (un composto fosforico ricco di energia che ha funzioni simili a quelle dell’ATP), e dall’altro, producono l’accumulo di lattato. Tale situazione organica

www.allenatore.net
44
richiede un quantitativo extra di ossigeno, che è fornito mediante l’aumento della frequenza ed ampiezza respiratoria, oltrechè dalla gittata e frequenza cardiaca.
Ora teniamo presente questi due dati:
q il debito di ossigeno alattacido è “pagato” nel giro di 2-3 minuti; q la rimozione del lattato avviene con un ora di riposo.
Espressioni di resistenza richieste durante una partita di calcio.
Alcuni dati statistici di una partita di calcio:
q Minuti di gioco: 90
q Minuti di gioco effettivo 50-60 in cui il giocatore compie: Ø 3 km di passo; Ø 8 km di corsa.
Il problema è capire quali sistemi di produzione di energia il giocatore utilizza in questi 11 km.
Fondamentalmente distinguiamo:
q accelerazioni massimali; q corse a medie velocità; q corse o camminate in regime aerobico.
Accelerazioni massimali
Il dato più importante sono il numero di accelerazioni (massimali o submassimali) che il giocatore solitamente esegue durante la partita. Queste sono sempre collegate alle giocate importanti, che essenzialmente sono:
q accelerazioni con possesso di palla per superare l’avversario; q accelerazioni in fase difensiva; q accelerazioni per smarcarsi; q accelerazioni per impedire lo smarcamento dell’avversario.
Evidentemente le accelerazioni massimali o submassimali utilizzano i meccanismi anaerobici (alattacido e lattacido), poiché da un punto di vista energetico richiedono la produzione massima di energia nell’unità di tempo.
Ecco quali sono le distanze che compiono di solito i calciatori durante la partita:
q le accelerazioni massimali sono su distanze da 7 a 15 metri; q il numero delle accelerazioni massimali oscilla tra le 30 e le 60.
Corsa a media velocità
Indicativamente, queste corse a medie velocità si compiono su distanze da 15 a 30 metri e sono ripetute per circa 40-80 volte.
Nel contesto tattico della partita, queste corse a media velocità, si compiono per:
q scalare dei giocatori in fase difensiva;

www.allenatore.net
55
q spostamenti di compensazione in fase di attacco su azione manovrata; q azioni di temporeggiamento; q corse in cui il giocatore riprende la posizione originaria.
Corse o camminate in regime aerobico
Durante la partita, il giocatore compie dei tratti di corsa a bassa velocità e di passo (suddivise in 200-300 frazioni) per un tempo complessivo di circa 30 minuti. L’andatura di questa corsa è talmente lenta da indurre a pensare che investa la capacità aerobica. Da quanto sopra esposto, risulta che sostanzialmente il ritmo agonistico della partita dipende dalla ripetitività e dalla intensità delle accelerazioni massimali. Una singola accelerazione massimale di 7-15 metri è valutata da un punto di vista energetico nel regime anaerobico alattacido. In ogni caso, il punto fondamentale della questione, è il ripetersi di questi sforzi ed il tempo di recupero a disposizione, dipendente dalle situazioni di gioco. Nella partita, il calciatore è chiamato a produrre degli sforzi massimali anche quando non ha recuperato completamente quello precedente; per questo motivo questi sforzi massimali si collocano talmente ravvicinati tra loro che il sistema energetico spesso cambia di qualità. Frequentemente è chiamato in causa il meccanismo lattacido, anche se le concentrazioni di lattato non sono quasi mai molto elevate nel calciatore. Peraltro, osserviamo che il calciatore durante la partita si trova alcune volte in stato di totale debito di ossigeno e che in ogni caso è chiamato dalla situazione di gioco a fornire un ulteriore sforzo massimale. Quindi il meccanismo lattacido entra costantemente in azione durante la partita, anche se a bassa intensità, con 2-3 picchi massimali nel corso dei 90 minuti complessivi. In ogni caso evidenziamo che la possibilità di ripetere degli sforzi massimali durante la partita dipende dall’efficienza del recupero che è strettamente correlato alla potenza aerobica. Dopo aver detto tutto questo, possiamo valutare in modo più appropriato quei 30 minuti di corsa a bassa velocità, la quale da una visione superficiale potrebbe far supporre che il calciatore necessita di bassi livelli di potenza aerobica. Il giocatore durante la partita, anche quando corre lentamente o cammina per il campo, sta sollecitando i suoi meccanismi aerobici a lavorare a pieno ritmo per pagare i debiti di ossigeno contratti durante le accelerazioni massimali. Ci si può quindi rendere conto che la partita di calcio in sé costituisce un notevole stimolo sul meccanismo aerobico, anche se agisce in modo indiretto, ovvero costringendo il meccanismo aerobico a lavorare per conto del meccanismo anaerobico.
Espressioni della resistenza
Classificazione della resistenza in base alla durata dello sforzo:
q Resistenza a brevissimo termine (lo sforzo si mantiene entro i 10 secondi). La capacità prestativa dipende essenzialmente dai meccanismi anaerobici alattacidi.
q Resistenza a breve termine (lo sforzo è contenuto entro i 30 secondi). La capacità prestativa dipende: Ø dai meccanismi anaerobici alattacidi; Ø dalla tolleranza al lattato.

www.allenatore.net
66
q Resistenza a medio termine (lo sforzo è contenuto nei 10 minuti). La capacità prestativa dipende essenzialmente: Ø dalla potenza aerobica; Ø dalla tolleranza al lattato.
q Resistenza a lungo termine (lo sforzo è contenuto nei 30 minuti). La capacità prestativa dipende essenzialmente: Ø dalla potenza aerobica; Ø dalle riserve di glicogeno; Ø dalla tolleranza al lattato.
q Resistenza a lunghissimo termine (lo sforzo è superiore ai 30 minuti). La capacità prestativa dipende essenzialmente: Ø dalle riserve di glicogeno; Ø dalla potenza aerobica; Ø dall’efficienza della termoregolazione (ricordiamo che l’aumento di 1 grado della
temperatura corporea riduce del 30% la capacità della prestazione).
Mezzi allenanti utilizzati.
q Lavoro Aerobico Intermittente con una variazione che si colloca circa al 70/80% della velocità max.
E’ consigliabile creare dei gruppi omogenei (magari quelli creati dopo il V.A.M. Test proposto dal Dott. G.Nicola Bisciotti, quindi con una Velocità Aerobica Massimale abbastanza simile tra loro).
Ecco di seguito i vari tipi di Intermittente usati:
Ø Intermittente 2’00”/1’00” - Si alternano 2’00” in corsa lenta ed 1’00” in allungo.
Ø Intermittente 1’30”/30” - Si alternano 1’30” in corsa lenta e 30” in allungo.
Ø Intermittente 1’00”/1’00” - Si alternano 1’00” in corsa lenta ed 1’00” in allungo.
Ø Intermittente 30”/30” - Si alternano 30” in corsa lenta ed 30” in allungo. q Ripetute su distanze medio/lunghe (600-1000mt.) a gruppi differenziati con
tempi di percorrenza diversi a seconda della V.A.M.
q Ripetute su distanze medio/brevi (100-400mt.) a gruppi differenziati a seconda della V.A.M.
q Percorso Organico di Capacità Aerobica da 220mt.
q Percorso Organico di Potenza Aerobica da 140mt.
q Corsa in % della Fc Max: una corsa continua con ritmo in % (dal 95 al 110%) della Fc Max (rilevata per ogni singolo atleta con il cardiofrequenzimetro al termine del VAM Test).

www.allenatore.net
77
q Lavori con palla, a reparti o di squadra, con finalità atletiche di tipo Aerobico o Lattacido.
Questi tipi di lavori però necessitano di una sperimentazione ed un monitoraggio specifico con cardiofrequenzimetro per capire con quale meccanismo energetico stiamo lavorando. Questa parte sarà probabilmente oggetto di un futuro articolo.
Periodizzazione dei lavori di tipo aerobico all’interno del mesociclo.
Come già detto in precedenza, lavorando nel settore dilettantistico da parecchi anni, mi trovo ad impostare programmi d’allenamento per soggetti che si allenano di sera, dovendo di giorno lavorare o studiare. Solitamente i giorni settimanali scelti per gli allenamenti sono: martedì, giovedì (solo in rari casi il mercoledì), venerdì (nel caso di n. 3 allenamenti settimanali). Di solito durante la settimana di carico si inseriscono i lavori organici nel primo giorno di allenamento settimanale (martedì). Può capitare di programmarli anche nella giornata di giovedì (magari con un carico non eccessivo, per evitare di lasciare troppe “scorie”), quando il martedì si voglia lavorare sulla forza. Bisogna anche tenere presente che a volte nella giornata di martedì non tutti i giocatori hanno completamente recuperato dopo lo sforzo della partita domenicale ed un lavoro di forza nella giornata del Martedì andrebbe a peggiorare ulteriormente la condizione muscolare dell’atleta. Quindi se si propone un lavoro di forza, il carico non deve essere eccessivo. Tra le varie soluzioni e opzioni può poi anche capitare di inserire al martedì tutti e due tipi lavori (ovviamente prima quello di forza ed a fine allenamento il lavoro organico).
Fasi di carico e scarico nel Mesociclo
Solitamente utilizzo la proporzione:
q 3 settimane di carico
q 1 settimana di scarico
nella quale vengono effettuati lavori quasi interamente con palla ad intensità medio/alta. L’unica deroga alla proporzione 3 carico/1 scarico, è quando nel periodo invernale, ci si trova di fronte a campi molto pesanti, dove le 3 settimane consecutive di carico possono risultare molto impegnative (ricordiamo sempre che siamo di fronte a persone che lavorano tutto il giorno o ragazzi che studiano) e si può correre il rischio di aumentare il numero degli infortuni. In questo periodo utilizzo la proporzione 2 carico/1 scarico fino a quando le condizioni dei campi di allenamento non tornano a livelli più accettabili.
Per meglio capire come inserire in un Mesociclo “tipo” i vari lavori di Potenza Aerobica con gli altri lavori di forza, velocità, reattività ecc… è forse più esplicativo, chiaro e pratico riportare un vero mesociclo (con rapporto 3 settimane di carico ed 1 settimana di scarico) da me strutturato nell’anno 2002/2003 nella società U.S. Caravaggio (Bg), partecipante al Campionato di Eccellenza.

www.allenatore.net
88
SETTIMANA DI CARICO 1/3
Mar 17/09/02
Forza Veloce + Potenza Aerobica
min Tipo di lavoro 8 Analisi partita precedente 5 Corsa lenta continua 10 Stretching generale 2 Skip vari 25 Multibalzi in staffetta con partenza ed arrivo in accelerazione [5+20+5mt] 3 x 5 MP= 4'00" 2 Skip vari ad intensità elevata 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica di media intensità 20 Tira e molla 50+50mt X 6 rip continue: medio forte. N°2serie MP=
4'00" 5 Defaticamento e scarico colonna.
117 Gio
19/09/02 Resistenza alla Velocità
25 Riscaldamento con palla 10 Stretching generale 3 Skip vari 25 Navetta: 5+5mt/10+10mt/ X 5 serie MP=1'30" 45 Parte tecnico-tattica 3 Corsa lenta continua.
111 Ven
20/09/02 Velocità
20 Riscaldamento con palla + stretching 3 Skip vari 20 Accelerazioni max su 20mt: 2 X 5 rip R=1'00" MP= 3'00" 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica 5 Defaticamento e scarico colonna.
96 Dom
22/09/02 Campionato di Eccellenza Girone B Ore 15,30.
2a Giornata di Andata Caravaggio - Pontirolese 2 - 1

www.allenatore.net
99
SETTIMANA DI CARICO 2/3
Mar 24/09/02
Forza Veloce + Potenza Aerobica
15 Corsa lenta continua + mob. Articolare 6 Stretching generale 3 Skip vari 25 Accelerazioni in staffetta con sovraccarico sui 25 mt. 3 X 5 MP=
4'00" 3 Stretching generale 50 Partitella su campo ridotto di buona intensità 12 Lavoro intermittente: 45"/15" + 40"/20" 2 Corsa lenta continua defaticante
116
Note: Lavoro intermittente ridotto da 15'00" a 12'00". Fondo pesante per la pioggia.
Gio 26/09/02
Velocità
25 Riscaldamento con palla 10 Stretching generale 3 Skip vari 25 Prove di accelerazione con cambi di direzione, con aumento
progressivo della distanza: 5+6+7+8+9+10 mt X 3 serie MP= 3'00".
45 Parte tecnico-tattica 4 Corsa lenta defaticante e stretching generale
112 Note: Fondo leggermente allentato. Nel lavoro di cambi di direzione alcune
difficoltà di equilibrio. Squadra molto più reattiva. Buona intensità per tutto l'allenamento.
Ven 27/09/02
Reattività/Rapidità
20 Riscaldamento con palla + stretching 3 Skip vari 20 Percorso di reattività, rapidità (accel.+slalom paletti+accel+skip
basso paletti + accel.) 2X5 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica 5 Defaticamento e scarico colonna.
96 Dom
29/09/02 Campionato di Eccellenza Girone B Ore 15,30.
3a Giornata di Andata Tribiano - Caravaggio 1 - 0

www.allenatore.net
1010
SETTIMANA DI CARICO 3/3
Mar 01/10/02
Potenza Aerobica
15 Analisi partita precedente 12 Corsa lenta continua + mob. Articolare 10 Stretching generale 5 Skip in varie forme con brevi accelerazioni 50 Parte tecnico-tattica 15 Intermittente: 30”/30” 8 Defaticamento e scarico colonna.
115 Gio
03/10/02 Forza Veloce
25 Riscaldamento con palla 10 Stretching generale 3 Skip vari 25 Percorso di Forza Veloce: ostacoli/navetta10+10/allungo 30mt.
all'80%del max. 2X5 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica 4 Corsa lenta defaticante e stretching generale.
115 Ven
04/10/02 Reattività/Rapidità
20 Riscaldamento con palla + stretching 3 Skip vari 20 Percorso di reattività, rapidità. 2X5 R= completi 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica 5 Defaticamento e scarico colonna.
96 Dom
06/10/02 Campionato di Eccellenza Girone B Ore 15,30.
4a Giornata di Andata Caravaggio - Colognese 2 - 6

www.allenatore.net
1111
S E T T I M A N A D I S C A R I C O Mar 08/10/02
Test Aerobico 8 Analisi partita precedente 12 Corsa lenta continua + mob. Articolare 6 Stretching generale 3 Skip in varie forme con brevi accelerazioni 3 Stretching generale 40 Parte tecnico-tattica 5 Recupero con stretching generale 15 Yo-Yo Endurance Test ( livello 2) 6 Corsa lenta continua.
98 Gio
10/10/02
25 Riscaldamento con palla 10 Stretching generale 10 Skip vari con brevi sprint 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica di media intensità 4 Corsa lenta defaticante e stretching generale.
97
Note: Pioggia molto forte. Terreno pesantissimo. Ven
11/10/02 Velocità
20 Riscaldamento con palla + stretching 3 Skip vari 20 Accelerazioni massimali: 10-15-20-20-15-10 mt X 2 serie R=
completi MP= 3'00" 3 Stretching generale 45 Parte tecnico-tattica 5 Defaticamento e scarico colonna.
96 Dom
13/10/02 Campionato di Eccellenza Girone B Ore 15,30.
5a Giornata di Andata Casati Arcore - Caravaggio 2 - 4

www.allenatore.net
1212
Indicazioni generali e tabelle sulla programmazione del lavoro di resistenza.
Prima di impostare un lavoro organico, di qualsiasi tipo esso sia, si dovrebbe fare un test per capire che tipo di giocatori abbiamo davanti e qual è il loro “motore” aerobico.
Per fare dei gruppi di lavoro omogenei faccio effettuare il V.A.M. Test proposto dal Dott. G.Nicola Bisciotti.
Attraverso questo semplice test si possono ricavare dati importantissimi per impostare un piano di allenamento mirato ed il più possibile differenziato:
q la V.A.M. (Velocità Aerobica Massimale) di ogni giocatore;
q la soglia Anaerobica;
q il VO2Max (ricavato con una semplice formula).
Avendo a disposizione questi dati è possibile impostare e pianificare un programma di allenamento mirato, magari dividendo i giocatori in gruppi (poiché penso sia impossibile creare un allenamento personalizzato per ogni giocatore) omogenei fra di loro.
Presenterò ora alcuni miei lavori di tipo organico proposti in questi anni di lavoro nel settore dilettantistico. Dobbiamo sempre ricordare che ci troviamo davanti a giocatori che per lavoro (e con le più svariate tipologie di lavoro, più o meno pesanti) o studio, sono impegnati tutto il giorno, e si devono allenare di sera.
Quindi un piccolo consiglio che mi permetto di dare a chi lavora con i dilettanti è di usare moltissimo buon senso nel preparare i programmi di allenamento, nel stabilire i carichi di lavoro e soprattutto essere pronto a cambiare “al volo” il programma prefissato (o magari ridurne il carico) nel caso ci si rendesse conto che, vista la condizione particolare generale di stanchezza di quella serata, eseguire il lavoro prefissato potrebbe causare più danni che il non farlo addirittura.
Lavori allenanti
I seguenti lavori sono quelli che propongo alla Prima Squadra, ma sono attuabili anche nelle categorie giovanili Juniores ed Allievi senza nessuna controindicazione.
I lavori dovranno essere adeguati, nella determinazione dei carichi di lavoro, nel numero delle serie e delle ripetizioni, nel calcolare i tempi di percorrenza ed i recuperi, a seconda della categoria giovanile che si va ad allenare.
Precisazioni per chi opera nel settore giovanile.
q Categoria Juniores
Si possono mantenere praticamente invariati i carichi di lavoro, le serie, le ripetizioni, i tempi di recupero proposti per la Prima Squadra. A scopo cautelativo si può ridurre il carico totale del 5/10% circa.

www.allenatore.net
1313
q Categoria Allievi
Diminuire il carico totale proposto per la Prima Squadra del 15/20%. In caso di palese difficoltà da parte dei ragazzi si possono aumentare i tempi di recupero del 20% circa.
Percorso Organico da 220mt. (Capacità Aerobica)
20 mt.
Corsa lenta 20mt.
Corsa le
nta 20mt.
Allungo all’80% per 60 mt.
Allungo all’8
0% del m
axAllungo all’80%
del max
+ +
Da utilizzare nei primissimi giorni del Precampionato.
N° Serie: 2
N° Ripetizioni: 10/12
Recupero tra le ripetizioni: 15”/1’30”
Recupero tra le serie: 4’00”/5’00”
Frequenza Cardiaca rilevata: da 150 a 165 b.m.
Percorso Organico da 140mt. (Potenza Aerobica)
15 mt.
Corsa lenta 20mt.
Allungo all’8
0% del maxAllungo all’80% del max
Accelerazione 12mt.
Corsa lenta 20mt.
Corsa lenta 20mt.
Accelerazione 12mt.
+ + ++
Da utilizzare nella seconda parte della fase Precampionato dopo aver proposto il Percorso di Capacità Aerobica (lavoro n.1).
N° Serie: 2
N° Ripetizioni: 5/8
Recupero tra le ripetizioni: 1’30”/1’45”
Recupero tra le serie: 4’00”/5’00”

www.allenatore.net
1414
Tira e Molla 50+50mt. X 10 ripetute continue (Capacità Aerobica)
Sul campo di calcio (ipotizziamo la lunghezza di 100mt.) si alternano 50mt. in corsa lenta e 50mt. in allungo all’80% della max velocità. Arrivati in fondo al campo, si effettua un cambio di direzione e si riparte con un altro 50mt. in corsa lenta ed uno in allungo. Così per n. 10 lati del campo.
Da utilizzare nei primissimi giorni del Precampionato.
N° Serie: 4/6
Recupero tra le serie: 4’00”/5’00”
Frequenza Cardiaca rilevata: da 140 a 160 b.m.
Tira e Molla 50+50mt. X 6 ripetute continue (Potenza Aerobica)
Sul campo di calcio (ipotizziamo la lunghezza di 100mt.) si alternano 50mt. in allungo al 50% e 50mt. in allungo all’80% della max velocità. Arrivati in fondo al campo, si effettua un cambio di direzione e si riparte. Così per n. 6 lati del campo.
Da utilizzare nella seconda parte della fase Precampionato e durante l’annata nella programmazione dei vari mesocicli.
N° Serie: 3/5
Recupero tra le serie: 4’00”/5’00”
Frequenza Cardiaca rilevata: da 155 a 180 b.m.
Tira e Molla 30+30+30mt. X 5 ripetute continue (Potenza Aerobica)
Sul campo di calcio (ipotizziamo la lunghezza di circa 90mt.) si alternano 30mt. in allungo al 50% e 30mt. in allungo all’80% della max velocità. Arrivati in fondo al campo, si effettua un cambio di direzione e si riparte. Così per n. 5 lati del campo.
Da utilizzare nella seconda parte della fase Precampionato e durante l’annata nella programmazione dei vari mesocicli.
N° Serie: 3/5
Recupero tra le serie: 4’00”/5’00”.
Tira e Molla 20+20+20+20mt. X 3 ripetute continue (Potenza Lattacida)
Sul campo di calcio (ipotizziamo la lunghezza di circa 80mt.) si alternano 20mt. in corsa lenta e 20mt. in accelerazione max. Arrivati in fondo al campo, si effettua un cambio di direzione e si riparte. Così per n. 3 lati del campo.
Da utilizzare nella seconda parte della fase Precampionato e durante l’annata nella programmazione dei vari mesocicli.
N° Serie: 1/3
Recupero tra le serie: 5’00”/6’00”.

www.allenatore.net
1515
Ripetute in linea su distanze medio-lunghe (Capacità Aerobica)
GRUPPO L
Tempo Recupero dist rip. vel.Gr L min sec min sec
1.000 1 12,0 5 0 5 0 800 2 11,8 4 4 4 4 600 1 11,8 3 3 3 3 600 1 11,8 3 3 3 3 800 2 11,8 4 4 4 4
1.000 1 12,0 5 0 5 0 6.400 8 Totale Min/Sec 56 36
GRUPPO M
Tempo Recupero dist rip. vel.Gr
M min sec min sec
1.000 1 12,0 5 0 5 0 800 2 12,3 3 54 3 54 600 1 12,3 2 56 2 56 600 1 12,3 2 56 2 56 800 2 12,3 3 54 3 54
1.000 1 12,0 5 0 5 0 6.400 8 Totale Min/Sec 55 8
GRUPPO V
Tempo Recupero dist rip. vel.Gr V min sec min sec
1.000 1 12,0 5 0 5 0 800 2 12,8 3 45 3 45 600 1 12,8 2 49 2 49 600 1 12,8 2 49 2 49 800 2 12,8 3 45 3 45
1.000 1 12,0 5 0 5 0 6.400 8 Totale Min/Sec 53 46
Esempio di seduta di allenamento:
Da utilizzare nei primissimi giorni del Precampionato.
Come si nota nella scheda allenamento sopra esposta, sono stati formati (con il V.A.M. Test) n. 3 gruppi di lavoro omogenei (denominati Lento, Medio e Veloce) con delle velocità (appunto la VAM) molto simili tra di loro.
Ogni gruppo ha delle velocità diverse e di conseguenza dei tempi di percorrenza e di recupero diversi.
Recuperi = 1: 1.

www.allenatore.net
1616
Ripetute in linea su distanze brevi (Potenza Aerobica)
GRUPPO L
Tempo Recupero dist rip. vel.Gr L min sec min sec 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 18,0 0 20 1 20 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 18,0 0 20 1 20 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 18,0 0 20 1 20 200 1 15,0 0 48 1 36
18,0 0 0 0 0 15,0 0 0
2.300 19 Totale Min/Sec 18 36 GRUPPO M
Tempo Recupero dist rip. vel.Gr M min sec min sec 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 19,5 0 18 1 12 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 19,5 0 18 1 12 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 19,5 0 18 1 12 200 1 15,0 0 48 1 36
19,5 0 0 0 0 15,0 0 0
2.300 19 Totale Min/Sec 17 42
GRUPPO V
Tempo Recupero dist rip. vel.Gr v min sec min sec 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 21,9 0 16 1 4 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 21,9 0 16 1 4 200 1 15,0 0 48 1 36 100 5 21,9 0 16 1 4 200 1 15,0 0 48 1 36
21,9 0 0 0 0 15,0 0 0
2.300 19 Totale Min/Sec 16 48
Esempio di seduta di allenamento:
Da utilizzare dopo i primissimi giorni del Precampionato dopo aver svolto il lavoro di Capacità aerobica.
Come si nota nella scheda allenamento sopra esposta, sono stati formati (con il V.A.M. Test) n.3 gruppi di lavoro omogenei (denominati Lento, Medio e Veloce) con delle velocità molto simili tra di loro.
Ogni gruppo ha delle velocità diverse e di conseguenza dei tempi di percorrenza e di recupero diversi.
Recuperi = 1: 2 per la distanza dei 200mt.
1:4 per la distanza dei 100mt.

www.allenatore.net
1717
C.C.V.V.
Metodo studiato ed introdotto dal biomeccanico Carmelo Bosco (recentemente scomparso) per migliorare la potenza aerobica negli sport di squadra, e particolarmente nel calcio.
E’ costituito da rapide accelerazioni eseguite con sforzo massimale di 3” – 5” – 7” , seguite da pause di recupero attivo in cui si corre a velocità submassimale (per chi non ha strumentazioni specifiche per determinarla, si può intendere un buon allungo al 70/80% del max), che è quella più efficace a favorire lo smaltimento del lattato prodotto durante le accelerazioni. Quindi da una parte si avrà una produzione di lattato e dall’altra si abituerà l’organismo ad utilizzarlo, fenomeno che verosimilmente avviene durante una partita vera e propria di calcio.
Ecco di seguito la tabella per eseguire il CCVV; è stata apportata una piccola modifica alla formula originale del Prof. Carmelo Bosco. E’ stato infatti inserito, all’inizio ed alla fine, 1’00 in corsa lenta, questo per iniziare e finire il lavoro (già abbastanza impegnativo) nel modo meno traumatico possibile.
da a velocità durata 0'00" 1'00" corsa lenta 1'00" 1'00" 2'40" allungo 1'40" 2'40" 2'43" accelerazione 3" 2'43" 3'13" allungo 30" 3'13" 3'18" accelerazione 5" 3'18" 4'38" allungo 1'20" 4'38" 4'45" accelerazione 7" 4'45" 6'25" allungo 1'40" 6'25" 6'28" accelerazione 3" 6'28" 6'58" allungo 30" 6'58" 8'00" corsa lenta 1'02"
Da utilizzare dopo i primissimi giorni del Precampionato dopo aver svolto il lavoro di Capacità aerobica e durante l’anno nella normale programmazione dei mesocicli.
Serie da 8’00”/12’00”
N° Serie: 1/2
Recupero tra le serie: 5’00”/8’00”.
Lavoro Intermittente
Lo scopo principale di questo metodo è mantenere il consumo d’ossigeno il più vicino possibile al livello massimale e, contemporaneamente, ottenere un elevato ritmo di sforzo per una certa durata.
La velocità di corsa ottimale, non avendo a disposizione strumenti specifici, si può individuare in un allungo all’80% del max.

www.allenatore.net
1818
E’ secondo me consigliabile, come già detto precedentemente, suddividere la squadra in almeno 3 gruppi omogenei per velocità.
Tipo di sforzo:
q intermittente 2’00”/1’00” si alternano 2’00” in corsa lenta ed 1’00” in allungo (Capacità Aerobica); solo nei primissimi giorni di precampionato;
q Intermittente 1’30”/30”: si alternano 1’30” in corsa lenta e 30” in allungo (Capacità Aerobica); solo nei primissimi giorni di precampionato;
q Intermittente 1’00”/1’00” si alternano 1’00” in corsa lenta ed 1’00” in allungo (Potenza aerobica);
q Intermittente 30”/30” si alternano 30” in corsa lenta ed 30” in allungo (Potenza aerobica);
q Intermittente 15”/30” si alternano 30” in corsa lenta ed 15” in allungo (Potenza aerobica);
q Intermittente 15”/15” si alternano 15” in corsa lenta ed 15” in allungo (Potenza aerobica).
Durata: da 6’00” per i lavori di Potenza aerobica a 20’00” per quelli di Capacità aerobica.
N° 1/3 serie a seconda del tipo di intermittente e del periodo.
Recupero tra le serie: 5’00”/8’00”.
Fartlek Svedese
Si alternano degli allunghi di 80-150mt., con delle corse a bassa velocità di circa 150-200mt.
Durata: 20’00”/30’00”.
Da svolgere nei primissimi giorni di allenamento del precampionato.
Interval training
Si tratta di un mezzo di allenamento che investe principalmente il meccanismo lattacido.
I giocatori devono correre una distanza (dai 100 ai 600 mt.) ad una velocità tale che i battiti del cuore giungano al 95-100% della max frequenza cardiaca.
La prova va ripetuta nel momento in cui il giocatore si trova nuovamente in regime aerobico.
Indicativamente il periodo di recupero tra una prova e la successiva deve essere prolungata fino a quando le pulsazioni cardiache non sono scese al 70-75% della frequenza max. E’ evidente che se accorciamo il tempo di recupero tra una prova e l’altra il lavoro diventerà sempre più a carico della capacità lattacida, mentre se allunghiamo il tempo di recupero, aumenteremo l’intensità delle singole ripetute ed il lavoro effettuato sarà maggiormente a carico della potenza lattacida.
Quindi i 4 elementi fondamentali dell’interval training sono:

www.allenatore.net
1919
q intensità: aumenta col diminuire la lunghezza della distanza;
q distanza: può oscillare dai 100 ai 600 mt.;
q tempo di recupero: in relazione all’intensità dello sforzo ed alla lunghezza della prova;
q numero delle ripetizioni: varia a seconda dell’intensità dello sforzo ed alla lunghezza della prova.
Esempio di seduta di Interval Training sui 100mt.:
Tempo: 16”/17”
Recupero: 1’00”/1’20”
N° ripetute: 6/10.♦

La preparazione atletica nel mesociclo. A cura di CRISTIAN MAZZURANA – Sett. Giov. HELLAS VERONA
Principi, concetti ed esempi pratici per programmare l’allenamento condizionale nel mesociclo agonistico.
Organizzazione dell’allenamento.
E’ cosa nota che la stagione sportiva viene suddivisa in cicli o periodi:
q periodo preparatorio;
q periodo agonistico;
q periodo di transizione.
In questo articolo ci vogliamo occupare di una fase particolare del periodo agonistico (cioè di quello che contraddistingue la maggior parte del tempo impiegato in una stagione) della durata di un mese (da cui mesociclo) suddiviso quindi in 4 settimane di lavoro (per convenienza chiamate microcicli).
Così come per il periodo preparatorio, anche per quello agonistico dobbiamo analizzare almeno tre punti:
q gli obiettivi;
q i carichi di lavoro;
q i mezzi di allenamento.
Gli obiettivi fondamentali del periodo agonistico sono:
q il raggiungimento;
q il perfezionamento;
q il mantenimento
della massima capacità di prestazione. Se il lavoro effettuato durante il ciclo pre-agonistico è stato programmato oculatamente e le tabelle che ci siamo prefissi sono
aarrttiiccoolloo
55
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
SSSS PPPP EEEE CCCC IIII AAAA LLLL EEEE MMMM EEEE SSSS OOOO CCCC IIII CCCC LLLL OOOO

www.allenatore.net
22
state il più possibile rispettate, avremo minori difficoltà nel raggiungere in poco tempo lo stato di forma ideale che ci consentirà di affrontare nel migliore dei modi l’intera stagione sportiva. In ogni caso, aggiustamenti e perfezionamenti dei carichi di lavoro immediatamente successivi a questo periodo sono ovviamente da considerarsi necessari. Così come, è utile ricordare, il volume del carico di lavoro del ciclo preparatorio scenderà sensibilmente mentre aumenterà il lavoro relativo all’intensità. All’interno del nostro mesociclo dobbiamo poi tenere conto dell’alternanza dei carichi di lavoro. Non si può certo pensare ad un carico sempre crescente dall’inizio alla fine dell’intera stagione sportiva (macrociclo). Ecco perché dopo un ciclo di costruzione in cui il volume è predominante, si passa ad una fase di mantenimento in cui necessariamente ci saranno dei momenti (o microcicli) a carico elevato ma anche dei momenti (o microcicli) cosiddetti di scarico. Per ciò che riguarda i mezzi di allenamento, essi saranno soprattutto a carattere speciale e il più possibile simili alla gara sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico-atletico.
Ho pensato di semplificare le cose sottopononendo un esempio di mesociclo suddiviso in 4 microcicli (A, B, C, D) composto ciascuno di tre allenamenti (1, 2, 3). Come si potrà notare, nel primo allenamento di ciascun microciclo, il lavoro atletico è rivolto soprattutto allo sviluppo della forza esplosiva, della velocità e della potenza aerobica; nel secondo si dà spazio alla resistenza lattacida e alla velocità; nel terzo all’esaltazione della velocità pura. In ciascun allenamento sono previsti momenti dedicati alle esercitazioni di rapidità/reattività e alle componenti coordinative.
Considerazioni sul mesociclo considerando la categoria allenata.
Il mesociclo in questione, rivolto alla categoria juniores, può essere applicato con alcuni accorgimenti anche ad una categoria superiore e ad una inferiore. Non è a mio avviso utilizzabile per i giovanissimi in quanto questa categoria non prevede un carico di forza così elevato e dove l’aspetto lattacido non deve essere esaltato se non con l’utilizzo del mezzo e per periodi di lavoro decisamente inferiori; si può magari apportare qualche modifica solo per ciò che riguarda la potenza aerobica. Per la categoria allievi si può modificare il carico di forza sviluppandolo con quantità inferiori e per solo due microcicli la settimana o al massimo tre, mentre sarà utile ridurre anche il minutaggio della potenza aerobica e sostituire l’interval-training (le ripetute su distanze predeterminate) con una Corsa con variazione di velocità (CCVV); per l’aspetto lattacido opterei per lavori con la palla svolgendo percorsi situazionali. La categoria superiore invece necessita di cambiamenti in “rialzo” dei carichi di lavoro. Sicuramente saranno da aumentare il minutaggio della potenza aerobica (diminuendo il tempo di percorrenza delle ripetute nell’interval-training), la quantità di multibalzi, le serie dedicate al momento lattacido.
Mesociclo. Proposta pratica di programmazione.
Microciclo A Allenamento 1 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività su ostacolini bassi.

www.allenatore.net
33
q 15’ PTT (Preparazione Tecnico-Tattica). q 10’ Forza esplosiva: sprint in salita con pendenza del 15% circa 3x5x10mt. (con
recupero tra una ripetuta e l’altra di almeno 50” e di 2’ tra le serie). Alla fine della terza serie effettuare 5 allunghi sui 40mt. (max 8”) sul piano con recupero di 20”.
q 20’ PTT. q 10’ Potenza aerobica CCVV: alternare nei minuti dispari (al 1°, 3°…) 55” di corsa
lenta e 5” di sprint e nei minuti pari (al 2°, 4°…) 52” di corsa lenta e 8” di sprint. q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 2 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività/coordinazione con cerchi e paletti. q 10’ PTT. q 5’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x20mt. (con recupero di 30” tra le
ripetute e di 2’ tra le serie). q 25’ PTT. q 15’ Resistenza lattacida 1 < 1 (5x25”): su un campo di 25x20mt. con 2 portieri e
palla sempre in gioco si alternano coppie nell’1 < 1 per 5 volte ciascuna. q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 3 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 10’ Andature in skip ed esercizi di reattività vari. q 15’ PTT. q 10’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x15mt. (con recupero di 25” tra
le ripetute e di 2’ tra le serie). q 50’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Microciclo B Allenamento 1 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività su ostacolini bassi. q 15’ PTT. q 15’ Forza esplosiva multibalzi: a) 6x4 balzi alternati frontali + velocità 10mt. ad
ogni serie (descrizione 1 a fine articolo); b) 3x4 CMJ non continuati + velocità 15mt. ad ogni serie (descrizione 2 a fine articolo); c) 6 x pliometria in caduta da max 50cm. rimbalzando a terra sulle punte dei piedi (minor tempo di contatto possibile) piegando al minimo le gambe e passando un ostacolo di max 20cm. + velocità 15mt.; d) 6x4 balzi successivi su ostacoli di altezza variabile ma non superiori ai 60-70cm. + velocità 20mt. (descrizione 3 a fine articolo); e) 4x5 balzelli successivi a piedi paralleli e gambe tese (minor tempo di contatto e max

www.allenatore.net
44
tempo di volo) su ostacolini max 20cm. + velocità 15mt.; f) 2x4 CMJ continuati + velocità 20mt. (descrizione 4 a fine articolo).
q 5’ Decompressione della colonna (esercizi in scarico) (descrizione 5 a fine articolo).
q 15’ PTT. q 18’ Potenza aerobica 2700mt. così suddivisi: 1x300mt. + 1x400mt. + 1x500mt. +
1x600mt. + 1x500mt. + 1x400mt. sui tempi stabiliti in base ad un test di resistenza (il recupero è pari al tempo di percorrenza della ripetuta). Ad esempio 300mt. in 1’04”-1’08”, 400mt. in 1’25”-1’30”, 500mt. in 1’49”-1’55”, 600mt. in 2’10”-2’18”.
q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 2 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività con cerchi e paletti. q 10’ PTT. q 5’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x20mt. (con recupero di 30” tra le
ripetute e di 2’ tra le serie). q 25’ PTT. q 10’ Resistenza lattacida sui 50mt.: 6x(10mt. sprint + 40mt. recupero + 20mt.
sprint + 30mt. recupero + 10mt. sprint + 40mt. recupero + 20mt. sprint + 30mt. recupero + allungo di 50mt.) con recupero di 1’30” tra le serie.
q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 3 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 10’ Andature in skip ed esercizi di reattività/coordinazione vari. q 15’ PTT. q 10’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x15mt. (con recupero di 25” tra
le ripetute e di 2’ tra le serie). q 50’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Microciclo C Allenamento 1 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching).
q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività su ostacolini bassi. q 15’ PTT. q 10’ Forza esplosiva: sprint in salita con pendenza 12-15% 3x5x20mt. (con
recupero tra una ripetuta e l’altra di almeno 55” e di 2’ tra le serie). Alla fine della terza serie effettuare 5 allunghi sui 40mt. (max 8”) sul piano con recupero di 20”.
q 20’ PTT.

www.allenatore.net
55
q 10’ Circuito a secco di potenza aerobica lungo il perimetro del campo (100x60): 10mt. sprint in linea + 50mt. corsa lenta + 15mt. sprint con cambi di direzione + 50mt. corsa lenta + 15mt. sprint a navetta (5+5+5mt.) + 50mt. corsa lenta + 20mt. sprint in linea + 50mt. corsa lenta + 30mt. sprint a navetta (10+10+10mt.) + 60mt. corsa lenta, quindi si ricomincia il percorso fino allo scadere dei 10’. Consiglio di far partire più gruppi distanziati in modo da non ammassarsi tutti nelle varie stazioni.
q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 2 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività/coordinazione con cerchi e paletti. q 10’ PTT. q 5’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x20mt. (con recupero di 30” tra le
ripetute e di 2’ tra le serie). q 25’ PTT. q 15’ Resistenza lattacida 2 > 2 (5x55”): su un campo di 25x20mt. con 2 portieri e
palla sempre in gioco si alternano coppie nel 2 > 2 per 5 volte ciascuna. q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 3 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 10’ Andature in skip ed esercizi di reattività vari. q 15’ PTT. q 10’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x15mt. (con recupero di 25” tra
le ripetute e di 2’ tra le serie). q 50’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Microciclo D Allenamento 1 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching).
q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività su ostacolini bassi.
q 15’ PTT.
q 15’ Forza esplosiva multibalzi: a) 3x4 CMJ non continuati con spostamento più in lungo che in alto + velocità 15mt. ad ogni serie; b) 5 x pliometria in caduta da max 50cm. rimbalzando a terra sulle punte dei piedi (minor tempo di contatto possibile) piegando al minimo le gambe e passando un ostacolo di max 20cm. + velocità 15mt.; c) 6 x corsa balzata (corsa effettuando dei balzi alternati più in lungo che in alto) sui 20mt. (descrizione 6 a fine articolo); d) 4x5 balzelli successivi a piedi paralleli e gambe tese (minor tempo di contatto e max tempo di volo) con spostamento in alto e in lungo + velocità 15mt.; e) 2x4 CMJ continuati con spostamento laterale + velocità 20mt.

www.allenatore.net
66
q 5’ Decompressione della colonna (esercizi in scarico). q 15’ PTT. q 10’ Circuito con la palla di potenza aerobica: nel campo costruire cinque stazioni di
cui una a metà campo di forma circolare (il cerchio di centrocampo) e quattro negli angoli: una rettangolare (30x15mt.), una quadrata (20x20mt.), una triangolare (30mt. ogni lato), una esagonale (20mt. per lato) dove si sviluppa un possesso palla in 3 > 2 quindi con 15 giocatori. La durata dell’esercitazione è di 30”- 40” mentre il recupero si effettua in corsa lenta per un giro di campo completo fino a sistemarsi nella stazione immediatamente successiva a quella appena occupata, cambiando ogni volta i componenti del 3 > 2 in modo che ciascuno, alla fine delle cinque stazioni, abbia fatto parte 2 volte del gruppo in inferiorità numerica. Ad esempio: se i giocatori nella prima stazione sono A-B-C contro D-E, nella seconda stazione avremo E-A-B contro C-D, nella terza D-E-A contro B-C, nella quarta C-D-E contro A-B e nella quinta B-C-D contro E-A.
q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 2 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 5’ Andature in skip ed esercizi di reattività con cerchi e paletti. q 10’ PTT. q 5’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x20mt. (con recupero di 30” tra le
ripetute e di 2’ tra le serie). q 25’ PTT. q 10’ Resistenza lattacida a navetta 6x(10+10mt.) e 5x(20+20mt.). Si formano 5
gruppi di tre giocatori ciascuno. Il primo gruppo fa uno sprint di andata e ritorno sui 10+10mt., poi parte il secondo gruppo e così via fino all’ultimo gruppo, quindi ricomincia subito il primo ecc. per un totale di 6 prove. Dopo un recupero di 2’ si effettua lo stesso tipo di lavoro sui 20+20mt.
q 15’ PTT. q 10’ Defaticamento.
Allenamento 3 q 15’ Riscaldamento generale (tecnica, mobilità articolare e stretching). q 10’ Andature in skip ed esercizi di reattività vari. q 15’ PTT. q 10’ Velocità in linea e con cambi di direzione: 3x4x15mt. (con recupero di 25” tra
le ripetute e di 2’ tra le serie). q 50’ PTT.
q 10’ Defaticamento.♦

www.allenatore.net
77
Descrizione di alcune esercitazioni.
Balzi alternati: stacco con il destro, atterro sul sinistro, ristacco ecc.
CMJ non continuato: dalla posizione eretta a gambe divaricate la larghezza delle spalle effettuare un piegamento veloce sulle gambe fino ad un massimo di 90° angolo al ginocchio e spiccare un balzo verso l’avanti-alto estendendo le gambe, quindi ritornare a terra sull’avampiede ammortizzando con balzelli minori.
Balzi su ostacoli: superare l’ostacolo portando il busto leggermente flesso in avanti senza portare i talloni ai glutei ma avanzando con le ginocchia e atterrando sull’avampiede che dà l’elasticità necessaria per effettuare un balzo successivo.
CMJ continuati: come il precedente esercizio solo che non c’è interruzione. Avere cura di atterrare con l’angolo al ginocchio come in figura per non causare danni articolari.
Esercizi di scarico e decompressione della colonna vertebrale.
Corsa balzata: da eseguire come per i balzi alternati solo che lo stacco viene fatto in lungo più che in alto proprio come fosse una corsa in lungo.
descrizione 1
descrizione 2
descrizione 4
descrizione 3
descrizione 5
descrizione 6

Difendere con il 4-3-3: l’Atalanta di Mandorlini. A cura di MASSIMO LUCCHESI
I movimenti difensivi del 4-3-3 nerazurro.
Andrea Mandorlini, ex difensore di Torino, Atalanta, Ascoli, Inter (ha vinto proprio con l’Inter lo scudetto giocando da libero), debutta in questa stagione in serie A nelle vesti di allenatore dell’Atalanta dopo le buone stagioni con Spezia, Vicenza ed Atalanta appunto, riportata nella massima serie la scorsa stagione. Il modulo tattico adottato da Mandorlini in questo primo scorcio di campionato è stato il 4-3-3 con cui si è contrapposto, per la verità con poca fortuna, contro Juventus ed Inter. L’Atalanta, malgrado le sconfitte rimediate contro le squadre di Torino e Milano, è
riuscita comunque a far soffrire sia il team di Capello che quello di Mancini, confermandosi compagine organizzata ed in grado di ben figurare nel massimo campionato.
Gli accorgimenti difensivi del 4-3-3 in contrapposizione al 4-4-2. Il quadro tattico che si sviluppa dalla contrapposizione tattica del 4-3-3 a riguardi del 4-4-2 è quello riscontrabile in figura 1. I 4 difensori del 4-3-3 devono vedersela con le due punte centrali del 4-4-2 e fronteggiare gli inserimenti laterali dei centrocampisti esterni della squadra rivale. In mezzo al campo i 3 centrocampisti (1 mediano e 2 interni) del 4-3-3 sono in superiorità numerica
aarrttiiccoolloo
66
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
TTTT AAAA TTTT TTTT IIII CCCC AAAA
2
Fig.1Fig.1
9
5
4
36
7
8
10
11
1
1110
9
87
6 5
4
32
1

www.allenatore.net
22
rispetto ai due mediani avversari mentre le ali sono impegnate a fronteggiare le discese dei difensori esterni antagonisti. Analizziamo adesso compiutamente gli accorgimenti tattici adottati dall’Atalanta per contrapporsi al 4-4-2 di Juve ed Inter (per maggiori dettagli sulle gare è possibile visualizzare i report presenti nella sezione Studios). Il primo obiettivo della squadra di Mandorlini è stato quello di togliere spazio agli avversari mantenendo vicini i reparti. Lo schieramento difensivo dell’Atalanta utilizzato sia contro la Juventus che contro l’Inter ha visto scendere in campo 4 difensori (oltre a Taibi in porta, hanno giocato Rivalta-Gonnella-Natali-Bellini in difesa), 3 centrocampisti (Zenoni contro la Juve e Mingazzini contro l’Inter + Albertini e Marcolini) e due giocatori d’attacco (Gautieri e Montolivo contro la Juve, Montolivo e Pià contro l’Inter) a supporto di un’unica punta (Pazzini contro la Juve, Budan contro l’Inter).
Foto 1
Foto 2 In ambedue la foto è possibile visualizzare lo schieramento difensivo adottato dalla squadra bergamasca. Dopo aver evidenziato la capacità della squadra di schierarsi in modo corto e compatto vediamo i movimenti difensivi attuati dalla squadra di Mandorlini in funzione del possessore avversario.

www.allenatore.net
33
MOVIMENTI COLLETTIVI CON PALLA IN POSSESSO DI UN DIFENSORE CENTRALE. L’Inter e la Juve avevano la possibilità di poter sfruttare il 2 vs 1 dei difensori centrali nei confronti del centrattacco. L’Atalanta per prevenire tale eventualità cercava di mantenere i due attaccanti laterali “dentro al campo” in modo da forzare la giocata avversaria verso la fascia (vedi Fig.2). Nella foto 3 si vede Budan che attacca la palla con Montolivo e Pià piuttosto vicini ed in grado di tamponare efficacemente il giropalla.
Foto 3 MOVIMENTI COLLETTIVI CON PALLA IN POSSESSO DI UN DIFENSORE LATERALE.
Una volta orientato il gioco sull’esterno l’Atalanta adottava due diverse risposte a seconda sia della posizione in cui il ricevitore avversario veniva a prender palla sia della dislocazione in campo degli uomini di Mandolini. Con i ripiegamenti laterali di Montolivo e Pià sugli esterni, come mostra la foto 4, l’atteggiamento dei bergamaschi era quello serrare la maglie del centrocampo che si contrapponeva agli avversari secondo i classici movimenti del reparto a 5 giocatori. Quindi con palla in possesso del terzino avversario erano Montolivo (o Gautieri) e Pià ad uscire a pressione con Mingazzini (o Zenoni) e Marcolini orientati al controllo del mediano avversario, il difensore laterale sul lato forte che accorcia sul centrocampista esterno avversario ed Albertini a far filtro davanti la difesa (vedi Fig.3).
Foto 4

www.allenatore.net
44
Quando invece Montolivo, Gautieri o Pià andavano a chiudere centralmente sul mediano avversario, l’eventuale apertura verso l’esterno era di competenza di Mingazzini (o Zenoni) a destra e Marcolini a sinistra. I due interni stringevano meno verso il centro ed erano pronti ad aprire in fascia al momento dell’apertura - vedi fig.4. MOVIMENTI COLLETTIVI CON PALLA IN POSSESSO DI UN CENTROCAMPISTA ESTERNO. Quando il centrocampista esterno riceve in posizione arretrata è l’interno di centrocampo che si apre (vedi figura 5 a seguire). Quando invece il centrocampista laterale avversario riceve in posizione avanzata e il difensore laterale a chiudere con il centrocampista interno che accorcia in zona palla per portare il raddoppio (vedi Fig.6). MOVIMENTI COLLETTIVI CON PALLA IN POSSESSO DI UN ATTACCANTE. Qualora i centrocampisti si vedessero superati dalla palla diretta verso un attaccante avversario è priorità di costoro accorciare immediatamente verso la palla per limitare al massimo la zona di ricezione di quest’ultimo ed eventualmente poter raddoppiare. Importante tatticamente è il filtro davanti alla difesa operato da Albertini. I due difensori centrali (Gonnella e Natali) non possono giocare in modo estremamente aggressivo sulle punte rivali dovendo far attenzione ad impedire agli avversari di ricevere in profondità. Ecco quindi che fondamentale diventa l’interdizione del mediano nerazzurro al fine di tamponare la “palla addosso” alle punte. SCALATE DIFENSIVE Le foto 5 e 6 mostrano il ricorso alla scalata difensiva atalantina per parare l’incursione interista sull’out di sinistra. Emre in posizione di interno sinistro (il turco veniva spesso a ricevere in tale zona di campo per sottrarsi dal controllo del terzino destro Rivalta) viene sostenuto dal movimento in sovrapposizione di Favalli. Il turco appoggia quindi su Adriano, venuto a ricevere tra le linee, che può aprire per il laterale interista in fascia. L’Atalanta per fronteggiare utilizza il movimento in apertura di Rivalta che non si è fatto portar fuori zona da Emre.
Foto 5

www.allenatore.net
55
Foto 6
Nelle foto 7 ed 8 è inoltre possibile apprezzare il lavoro tattico di Albertini che accorcia immediatamente su Adriano e quello di Mingazzini che immediatamente si porta al raddoppio una volta che il passaggio è stato indirizzato verso Favalli.
Foto 7
Foto 8

www.allenatore.net
66
Nelle figure a seguire viene riportato graficamente quanto esposto in precedenza.
2
Fig.2Fig.2
9
5
4
36
7
810
11
1
11
10
9
8
7
6 5
4
3
2
1
2
Fig.3Fig.3
9
5
4
3
6
7
8
10
11
1
11 10
9
8
7
6 5
4
3
2
1
2
Fig.4Fig.4
9
5
4
3
6
7
8
10
11
1
10
11
9
8
7
6 5
4
3
2
1
2
Fig.5Fig.5
9
5
4
3
6
7
8
10
11
1
10
11
9
8
7
6 5
4
32
1
2
Fig.6Fig.6
9
5
4
3
6
7
8
1011
1
11
10
9
8
7
65
4
3 2
1
2
Fig.7Fig.7
9
5
4
3
6
7
8
1011
1
11
10
9
8
7
6 5
4
3 2
1
Mettere in difficoltà una squadra che si difende con il 4-3-3. Dopo aver visto come possa difendersi una squadra che adotta il 4-3-3 vado ad analizzare alcuni possibili accorgimenti per poter mettere in difficoltà tale sistema di gioco. Durante la fase di costruzione è possibile utilizzare l’incrocio dei centrocampisti centrali (quello vicino alla palla si inserisce in avanti creando il “buco” per la ricezione del compagno).

www.allenatore.net
77
Foto 9 La foto 9 mostra Stankovic inserirsci in avanti liberando lo spazio (zona gialla) per la ricezione di Cambiasso. E’ utile realizzare questo accorgimento quando i centrocampisti centrali avversari godono di superiorità numerica e possono essere molto aggressivi. La figura 10 a pagina successiva mostra il completamento della giocata.
Foto 10 Una seconda soluzione utilizzabile per creare difficoltà al 4-3-3 è quella di abbassare i centrocampisti esterni in modo da poterli far ricevere agevolmente o, nel caso il terzino avversario si alzi molto, creare i presupposti per l’apertura profonda in zona laterale per una punta. Infine, come ha mostrato Stankovic a Bergamo, è possibile superare il reparto difensivo del 4-3-3 (che spesso non gode dell’abbassamento a copertura del lato debole di un centrocampista), con il cambio di fronte (Foto 11 e 12). ♦

www.allenatore.net
88
Foto 11
Foto 12
COVERCIANO 11/10/04
LA DIDATTICA DEI MODULI 4-3-3 E 4-3-2-1 :::
con Massimo Lucchesi
TUTTE LE INFO ON LINE NELLA SEZIONE CORSI/EVENTI

L’atleta motivato è vincente? A cura del Prof. FAUSTO GARCEA Docente di Calcio per la materia “Teoria, tecnica e didattica degli Sport di squadra” presso l’università di Scienze Motorie di Firenze. Istruttore nel Settore Giovanile del PISA CALCIO.
L’importanza della motivazione nella performance sportiva.
Introduzione.
“La squadra non è apparsa adeguatamente motivata”.
“Gli avversari sembravano avere più motivazioni”.
“Se quel giocatore trova le motivazioni giuste diventa imprendibile”.
Quante volte abbiamo sentito frasi di questo genere?
Spesso si abusa del termine motivazione, servendosene in maniera impropria o anche solo per giustificare semplicisticamente una prestazione non all’altezza.
Definizione
Innanzitutto cosa è la “motivazione”?
Vediamo alcune delle decine di definizioni che si possono trovare in letteratura:
q E’ uno stato psichico nel quale si manifestano dei fattori stimolanti che tendono a ridurre una tensione (Correl).
q E’ la conseguenza di uno stato organico di bisogno, che tende ad essere soddisfatto al fine di ristabilire uno stato di equilibrio detto osmosi (teoria biologica di Cannon, Miller, Hull).
q E’ la necessità per l’uomo di rendere esplicito il suo sistema energetico, dove le pulsioni hanno il compito della ricerca di gratificazioni (Freud).
aarrttiiccoolloo
77
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
PPPP SSSS IIII CCCC OOOO LLLL OOOO GGGG IIII AAAA

www.allenatore.net
22
q E’ la conseguenza della spinta degli istinti (teoria etologica di Lorenz).
q E’ l’agente psicologico, fisiologico e cognitivo che guida il comportamento individuale verso uno scopo (C.O.N.I.).
Tipi di motivazione.
Esistono, generalmente, due tipi di motivazione:
q la motivazione primaria, per la quale un soggetto, svolgendo una determinata attività, nel nostro caso giocare a calcio o allenarsi, prova gioia e soddisfazione;
q la motivazione secondaria, è quella che, tramite il processo d’apprendimento finalizzato, porta un soggetto al raggiungimento di un determinato target.
Nel primo caso, il calciatore non ha bisogno di essere stimolato o sollecitato all’impegno, perché autonomamente produce sforzi tesi al miglioramento, anzi spesso trova gratificanti gli sforzi stessi.
Nel secondo caso, l’obiettivo rappresenta l’input per applicarsi sia in allenamento che in gara.
La prestazione diventa un mezzo per il raggiungimento del target. Questo può essere individuale, ma può diventare collettivo: dal farsi apprezzare dal proprio allenatore e dai compagni di squadra, al “firmare” un contratto importante, dal senso di onnipotenza nel fare un goal, al vincere una gara o un campionato.
E’ chiaro che questi due tipi di motivazione spesso viaggiano insieme e l’una è spinta essenziale per l’altra.
Ovvio anche che carriere lunghissime come quelle di Baggio, Costacurta, Ferrara, Maldini o Zola, per rimanere al presente, sono splendidi esempi di motivazione primaria che più primaria non si può. Impossibile trovare un altro motivo oltre al piacere di giocare per giocare, nel continuare a calcare i campi dopo avere vinto e guadagnato il possibile e qualcosa di più.
Nei campioni citati vi è un qualcosa di intimo, di intrinseco, proprio come rileva Martens, cui spetta la divisione, appunto, tra motivazione intrinseca e quella estrinseca. Il calciatore motivato “intrinsecamente” non gioca per soldi, fama o gloria, mentre lo fa il giocatore che lo è “estrinsecamente”.
Interessantissimo, a riguardo, il pensiero di Bouet. Egli ritiene che la motivazione si basi su due traini motivazionali: la lotta contro l’avversario e la lotta contro la natura.
Questi traini sono supportati da altri cinque motori fondamentali, a mio avviso tutti presenti nel calcio:
q il bisogno di movimento;
q l’affermazione di sé;
q la compensazione;
q l’aggressività;
q l’affiliazione sociale.

www.allenatore.net
33
Allenatore – psicologo.
Per qualsiasi essere umano, però, esistono dei momenti in cui le motivazioni, di qualsiasi tipo siano, appaiono flebili, inconsistenti o, addirittura, non appaiono più.
In questi casi quasi al limite, ma anche nel giornaliero processo d’apprendimento, la figura dell’allenatore assume un’importanza fondamentale, perché, checché se ne dica, è sempre il “mister” che deve trovare la maniera giusta per fare scoccare la scintilla.
Ed anche nei casi più fortunati di un’organizzazione professionalmente all’avanguardia che preveda la presenza di altre figure specifiche, come lo psicologo, lo psicoterapeuta, i “motivatori” appunto, ritengo sempre l’istruttore-allenatore il vero filtro catalizzatore dell’intervento.
Attività sportiva e motivazione.
In età evolutiva le motivazioni all’attività motoria ad indirizzo sportivo possono essere considerate di due tipi:
q motivazioni di I° livello (gioco ed agonismo);
q motivazioni di II° livello (biologiche; psicologiche; socio-culturali; psicopatologiche e compensative).
Motivazione di I° livello
Gioco
Il gioco è presente in tutte le età dell’essere umano: il bambino gioca per scoprire e conoscere, l’adulto gioca per rimanere bambino e continuare a mettersi in relazione con il mondo esterno e con gli altri. Il giovanissimo calciatore, nelle sue performance ludiche simbolizza, immagina di essere il campione preferito, nel contempo conosce le regole e soprattutto impara a rispettarle.
Sapendo questo, l’istruttore dovrà cercare di aiutarlo a maturare psicologicamente evitando l’automatizzazione del gesto sportivo, mutandogli continuamente il ruolo e la posizione di gioco per ignorare la specializzazione.
Inoltre, cercherà di allontanare le negative sollecitazioni ambientali dal giusto agonismo, utilizzando i feedback appropriati, rinforzando i comportamenti positivi e correggendo “allegramente” quelli negativi ed infine, oggi più di ieri, gestendo al meglio le spesso egoistiche illusorie aspettative dei genitori del bambino-calciatore.
Il gioco vissuto in maniera serena permette l’estrinsecazione della creatività, della fantasia, aiutando l’apprendimento, la conoscenza e la competenza. Sedute d’allenamento noiose, sempre uguali, con esercizi scimmiottati dal mondo degli adulti sono la morte per l’invenzione, per “l’idea intelligente” che può nascere quando si ha il pallone tra i piedi.
Non a caso Piaget affermava che sviluppo del gioco e sviluppo dell’intelligenza viaggiano di pari passo, e se lo diceva lui…

www.allenatore.net
44
Agonismo
Il nostro mondo è basato ormai sull’agonismo, ovvio che lo sport non può rimanere un’isola a sé stante, quindi, un tecnico deve tenere nella dovuta considerazione anche la motivazione agonistica.
L’agonismo corretto rappresenta il vivere la competizione, non come guerra personale, ma come confronto.
L’ideale sarebbe riuscire a considerare l’avversario non un nemico da combattere a tutti i costi, bensì il proprio banco di prova, l’esame che mette a nudo pregi, limiti e difetti.
Un tecnico serio e consapevole saprà preparare all’agonismo il proprio giocatore e la propria squadra a seconda dell’età evolutiva e delle caratteristiche fisiche, caratteriali e della personalità cui si trova di fronte. La gestione della spinta agonistica dell’adulto non può non essere differente da quella del bambino o dell’adolescente.
L’agonismo comunque esiste, non può essere nascosto o dimenticato, anzi rappresenta un giusto e positivo incanalamento dell’aggressività, altrimenti pericolosa sia a livello sportivo che sociale.
Motivazioni di II°livello
Senza soffermarsi in maniera approfondita su quest’ultime, ritengo opportuno sottolineare che esse sono la risultante della realtà del soggetto, dell’ambiente in cui è cresciuto ed in cui vive, dell’educazione familiare e sociale; in altre parole, la lettura della storia del soggetto stesso.
Ed anche in questo caso un istruttore, un allenatore competente spesso riesce a capire su quale tasto cliccare, se su quello puramente “estetico”, per l’atleta che ha bisogno di sentirsi forte, preciso, equilibrato, oppure sul tasto “successo”, per il soggetto che vuole migliorare sé stesso, che non accetta di sentirsi inferiore agli altri, di avere performance non all’altezza.
Magari il giocatore desidera essere integrato nel gruppo, oppure ha bisogno di compensare qualche sentimento d’inferiorità presunto o effettivo, ed allora la molla motivazionale è la voglia di riscatto, di sfuggire all’emarginazione, di sentirsi uguale agli altri, di essere accettati dagli altri.
Allenatore-psicologo dicevamo, che cerca, sperimenta, crea motivazioni valide per le singole personalità del gruppo, in base all’età, alla classe sociale di derivazione e d’appartenenza, al bagaglio di esperienze e cultura, al sesso.
Motivazione sportiva al “femminile”
Già, una breve parentesi riguardo al sesso è doverosa.
Mentre fino a pochi anni fa le differenze tra gli aspetti motivazionali maschili e quelli femminili erano marcate e facilmente riconoscibili, adesso lo sono molto meno.
Pur essendo ancora maggiormente spinte da fattori socio-affettivi, come il bisogno di aggregazione o il desiderio di divertirsi insieme alle coetanee, le calciatrici stanno iniziando ad assumere alcune caratteristiche tipiche del mondo maschile. L’immagine della donna moderna è più aggressiva, meno dolce e aggraziata, più androgina, meno mamma dalle forme tondeggianti.

www.allenatore.net
55
Il tecnico del calcio al femminile dovrebbe dare una mano, nel suo piccolo, affinché la calciatrice assuma la consapevolezza dei propri bisogni senza scimmiottare atteggiamenti e comportamenti, il più delle volte negativi, del calciatore maschio.
Come operare ed insegnare.
Cosa fare con i piccolissimi
Divertire, perché abbiamo già detto che la noia durante l’allenamento uccide l’apprendimento.
L’istruttore non può mai dimenticare che rappresenta un modello da imitare, quindi deve essere coerente, disponibile, entusiasta e collaborativo, se crede che questi siano i “messaggi” da trasmettere.
Cosa fare con i piccoli
Si può iniziare a invogliare gli allievi all’autostima.
Si cercherà di motivare attraverso un messaggio chiaro e deciso: “se ti impegni ci riesci”.
Il divertimento è ancora il motore del processo educativo, ma l’agonismo inizia ad affiorare e va accolto con la giusta misura. Assolutamente non il risultato, ma il senso del miglioramento della performance deve rappresentare il target da raggiungere.
Cosa fare con i grandicelli
A questo punto, l’istruttore si fa un po’ da parte e lascia il campo all’allenatore.
Si cerca di agire sulle motivazioni intrinseche e su quelle estrinseche a seconda delle situazioni e del contesto in cui si opera. Si dà fondo a tutte le proprie conoscenze per esprimere al meglio le competenze. Si cerca di sviluppare, potenziare e consolidare lo spirito di squadra, lavorando a fondo sui valori del singolo, del singolo integrato nel gruppo e del gruppo stesso.
Il “giocatorino” adesso ha bisogno di essere informato costantemente del proprio rendimento perché desidera autocriticarsi ed autovalutarsi prima di essere criticato e valutato.
Il divertimento non deve mai mancare, perché la sua assenza durante le sedute d’allenamento risulta essere una tra le cause d’abbandono precoce dell’attività sportiva in età pre-adolescenziale e adolescenziale, tuttavia impegno e fatica, se orientati verso target comprensibili, diventano pane quotidiano gradito.
Cosa fare con i grandi
Tutto quello che si fa con piccoli, piccolissimi e grandicelli.
A parte gli scherzi, esistono grandi e grandi.
A calcio giocano amatori, dilettanti e professionisti, quindi l’allenatore di coloro i quali si allenano alle nove di sera dopo una giornata di lavoro non potrà agire sulle stesse

www.allenatore.net
66
motivazioni sulle quali punta il professionista superpagato che allena giocatori professionisti superpagati, e viceversa.
Concludiamo riproponendo la domanda: atleta motivato = performance migliore? Alle ultime Olimpiadi greche un certo Yuri Chechi ha provato a darci una risposta.♦♦

Come analizzare il gesto tecnico del controllo palla e migliorarlo. A cura di M. MAZZANTINI – F. GUIDI – Sett. Giov. EMPOLI F.C.
Un pratico ripasso della tecnica di base. Analisi generale degli aspetti principali che caratterizzano un buona ricezione della palla.
Introduzione.
Il controllo di palla o ricezione del pallone è uno dei gesti tecnici fondamentali del gioco del calcio e come tale necessita di un allenamento continuo e specifico. La buona riuscita di tale gesto, unitamente agli altri fondamentali (calciare, colpire di testa, guidare la palla ecc…), risulta decisivo per l’esatto svolgimento delle azioni di gioco e, di conseguenza, per il raggiungimento di quell’obiettivo, il goal, che creandoci emozioni, ci fa balzare in piedi allo stadio, ci fa urlare di gioia e che inevitabilmente ci fa amare questo sport.
Il gesto tecnico del controllo di palla assume, oggi ancor più di ieri, un importanza fondamentale considerando l’attuale importanza, sulla scia dei grandi club a livello mondiale (Milan, Real Madrid ecc…), riservata alla cultura del possesso di palla per la quale è chiaramente indispensabile avere piena e totale padronanza di questo fondamentale.
Come effettuare il controllo e la ricezione del pallone.
Il controllo della palla si può effettuare con una molteplicità di parti del corpo e può essere:
q “orientato” (o a seguire) con lo scopo di proseguire velocemente un azione di gioco;
q “bloccato” con lo scopo di “addomesticare” la palla sul posto.
E’ importante sottolineare come la ricezione della palla non è mai un gesto fine a se stesso ma è sempre un gesto abbinato ad un successivo fondamentale (ricezione e
aarrttiiccoolloo
88
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
SSSS EEEE TTTT TTTT OOOO RRRR EEEE GGGG IIII OOOO VVVV AAAA NNNN IIII LLLL EEEE

www.allenatore.net
22
tiro, ricezione e passaggio, ricezione e guida ecc...) ed è pertanto in questa direzione che va allenato.
Le parti del corpo con cui il regolamento permette di eseguire il gesto tecnico della ricezione della palla sono:
q la testa
q il petto
q la gamba (interno piede, esterno piede, pianta del piede, collo piede e coscia).
In funzione di questo è quindi possibile eseguire tutta una serie di controlli palla come la:
q ricezione con la testa;
q ricezione con il petto;
q ricezione con la coscia;
q ricezione d’ interno piede;
q ricezione d’ esterno piede;
q ricezione con la pianta del piede;
q ricezione con il collo del piede.
Modalità e tecnica di ricezione.
Ricezione con la testa Per una corretta esecuzione di questo tipo di ricezione è necessaria un impostazione antero-posteriore delle gambe che si flettono al momento dell’impatto con la sfera; nel medesimo istante è importante che i muscoli del collo e delle spalle non siano rigidi al fine di consentire il fondamentale effetto ammortizzante sulla palla in arrivo.
Ricezione con il petto L’impostazione da tenere per tale gesto tecnico prevede che le gambe siano leggermente divaricate e che il peso del corpo sia sostenuto leggermente stando sulle punte dei piedi; il busto è leggermente inclinato in avanti con azione delle spalle a chiudersi nel momento dell’ impatto con il pallone; in questo modo la palla è immediatamente pronta per essere giocata poiché la parabola della stessa “muore” sui piedi del giocatore.
Ricezione con la coscia In questo tipo di ricezione è importantissimo il movimento ricevente che, in sequenza, prima va incontro al pallone e successivamente, al momento dell’impatto, si ritira velocemente all’indietro. Esempio classico di utilizzo di questo fondamentale è dopo il rinvio del portiere.

www.allenatore.net
33
Ricezione con il collo del piede Per una buona riuscita di questo tipo di ricezione deve essere sviluppata una marcata sensibilità nel piede ricevente. In questo caso è essenziale il movimento della punta del piede che si alza verso l’alto e al momento dell’impatto con la sfera si abbassa verso il terreno rendendo cosi la palla immediatamente giocabile dal calciatore. Anche in questo caso la gamba ricevente deve effettuare, in sequenza, un movimento incontro – indietro come gia osservato precedentemente.
Queste quattro tipologie di controllo (con la testa, con il petto, con la coscia e con il collo piede) riguardano le ricezioni con palla che arriva da parabola alta.
Quelle che analizzeremo adesso riguardano invece controlli e ricezioni da effettuare sia con palla che arriva da parabola alta, sia con palla ricevuta rasoterra.
Ricezione con l’interno del piede (da parabola alta) Fondamentale per questo tipo di ricezione è il movimento del piede di appoggio che si stacca leggermente dal terreno al momento dell’impatto con la palla da parte del piede ricevente. Quest’ultimo deve anche in questo caso andare leggermente incontro alla palla per poi ritirarsi velocemente. La punta del piede deve essere poi rivolta verso l’alto in modo da aumentare la superficie d’impatto.
Ricezione con l’interno del piede (da palla rasoterra) E’ sicuramente uno dei controlli più importanti per il gioco del calcio; il suo valore è ancor più rilevante per determinate categorie di giocatori quali i centrocampisti e i difensori centrali che, con il calcio attuale, sono sempre maggiormente costretti a giocare in maniera velocissima il pallone allo scopo di eludere il pressing avversario. Caratteristiche importanti per la buona riuscita di questo gesto tecnico sono: la punta del piede rivolta verso l’alto e il movimento della gamba ricevente; tale movimento inizia andando a prendere il pallone davanti al piede di appoggio per poi terminare dietro di esso, facendo in questo modo ” morire” la sfera tra i piedi e proteggendola dall’ attacco avversario.
Ricezione con l’esterno del piede (da parabola alta) La posizione del corpo in questo tipo di arresto è sotto la palla ed è necessario compiere un movimento rotatorio di 180 gradi con il piede di appoggio che si stacca leggermente dal suolo.
Ricezione con l’esterno del piede (da palla rasoterra) La postura di questo tipologia di controllo è simile a quella della ricezione con l’interno piede. La differenza la troviamo nella gamba ricevente che effettua un movimento diagonale (con il destro da sinistra verso destra e viceversa).
Ricezione con la pianta del piede (da parabola alta) In questo caso il punto di arresto della palla è davanti al piede di appoggio; la postura del corpo in questo tipo di ricezione è con la punta del piede rivolta verso l’alto. Risulta fondamentale ammorbidire l’articolazione della caviglia per poter dare un leggero “schiaffetto” alla sfera dopo che ha toccato il terreno. L’errore più evidente, soprattutto nelle categorie più piccole, è quello di avere un impatto violento con la sfera cosicché essa invece di rimanere davanti al giocatore, per potere essere

www.allenatore.net
44
immediatamente rigiocata, si allontana dando la sensazione di una scarsa sensibilità e morbidezza.
Consigli importanti per un buon controllo palla.
Come per tutti gli altri fondamentali del calcio è senza ombra di dubbio necessaria un attenta cura degli aspetti coordinativi. Per quanto riguarda il gesto del controllo della palla sono di primaria importanza le capacità coordinative di equilibrio, di combinazione e di orientamento spazio temporale (per la lettura delle traiettorie).
Partendo dal presupposto che la tecnica va sempre allenata, il lavoro che ogni singolo allenatore deve portare avanti dipende dal contesto nel quale si trova a lavorare. E’ chiaro che nelle fasce di età quali Pulcini ed Esordienti il lavoro tecnico sul controllo dovrà essere preceduto da un gran lavoro sulle gia citate capacità coordinative. Nelle fasce più grandi il lavoro di mantenimento e miglioramento della tecnica va svolto inizialmente esercitandosi senza avversari (“a secco”) e successivamente proponendolo in situazione di gioco.
Per un corretto ed efficace controllo di palla non va trascurata la respirazione; in ogni tipo di ricezione è infatti necessario espirare al momento dell’impatto con la palla; in questo modo il corpo va all’impatto con la sfera in modo più rilassato.
Un buon istruttore non tralascia poi nemmeno di osservare con attenzione la posizione e il movimento del piede portante o di appoggio.
Un paragone che deve far riflettere tecnici e giocatori, al fine di comprendere gli errori commessi nel gesto tecnico, e’ quello del calcio del pallone contro un muro o contro una rete di recinzione. Notiamo infatti che se si calcia una palla contro un muro essa rimbalza, al contrario di quanto accade, se si calcia violentemente il pallone contro la rete dove l’impatto della sfera viene ammortizzato. In questo esempio ci sono tutte le particolarità che caratterizzano il controllo della palla. Gli errori più frequenti infatti sono quelli di assistere a ricezioni con giocatori troppo rigidi (esempio del muro) e che non ammortizzano mai il pallone (esempio della rete di recinzione). L’ esempio sopra riportato può essere veramente importante al fine della memorizzazione di quelle che sono le peculiarità fondamentali del controllo di palla.
Esercitazioni.
Proponiamo adesso alcune esercitazioni sia individuali che collettive per il miglioramento e il perfezionamento del gesto del controllo della palla.
Esercitazione per il miglioramento del gesto tecnico del controllo della palla ad aprire o a chiudere su palla rasoterra (figura 1). Il giocatore numero 2 si trova all’interno di un quadrato di 3 mt. di lato; il numero 3 è posizionato di fronte ad una distanza di 5 mt.; 3 trasmette la palla a 2 e nel contempo chiama un colore; 2 ricevuta la palla deve effettuare una ricezione verso il colore chiamato dal compagno. L’esercitazione continua ininterrottamente con 3 che prende il posto di 2 e viceversa.

www.allenatore.net
55
Varianti: q controllo con l’interno piede;
q controllo con l’esterno piede;
q controllo con palla proveniente da parabola alta ricevendo con il petto, con l’interno o con l’esterno piede.
Fig. 1Fig. 1
3 2
Rosso
4 5
Gioco a confronto per esercitare la ricezione su parabola alta (figura 2). Si fronteggiano 2 squadre (rossi e gialli); i gialli effettuano un lancio nel quadrato dove i compagni ricevono ed effettuano il tiro in porta. I rossi invece, si scambiano la palla con passaggi a parabola alta dopo aver effettuato la ricezione. Devono effettuare 30 passaggi, al termine dei quali le due squadre invertono ruoli e compiti. Vince la squadra che effettua più goal nel tempo a disposizione, rappresentato dal tempo necessario agli avversari per compiere i 30 passaggi. Anche in questo caso possiamo lasciare alla discrezione dei giocatori la modalità della ricezione oppure renderla obbligata e vincolante ad un certo tipo di controllo.
1
Fig. 2Fig. 2
AC
B
ROSSO
GIALLO
BLU

www.allenatore.net
66
Psicocinetica a 3 colori (figura 3).
Gruppo diviso in 3 gruppi contraddistinti da colori diversi (gialli, bianchi e rossi). I giocatori si devono trasmettere la palla effettuando 2 tocchi obbligatori (ricezione e passaggio) tra colori diversi, scambiandosi poi di posizione. Colui che calcia la palla chiama il compagno ricevente.
Fig. 3Fig. 3
Rosso
Bianco
B
A
Varianti: q aumentare il numero dei palloni fino ad un massimo di 3;
q passare la palla (giallo) a un colore (rosso) e scambiarsi con l’altro (bianco); in questo caso il giocatore che calcia la palla chiamerà non il giocatore ricevente ma bensì un altro compagno a caso purché di un terzo colore;
q con 3 palloni (il pallone 1 giocato rasoterra, il pallone 2 giocato con rimessa laterale e stoppato di petto, il pallone 3 giocato di testa e ricevuto a piacere (coscia, petto, testa, interno, esterno ecc…).♦

L’allenamento del portiere nel microciclo. A cura di CLAUDIO RAPACIOLI – Prep. Portieri Sett. Giov. BRESCIA CALCIO
Dalle sei sedute settimanali per le squadre professionistiche alle due sedute per le categorie inferiori, un esauriente programma, didattico e pratico, per allenare il nostro portiere nel microciclo.
DDopo aver visto come programmare macrocicli e cicli, vediamo con il presente articolo come è possibile organizzare il microciclo del portiere. Questo pezzo è la normale prosecuzione di quello pubblicato nel mese precedente del quale ne è parte integrante e che consiglio di leggere per meglio comprendere la filosofia sotto esposta.
Terminato il periodo della preparazione pre-campionato si entra nella vera e propria fase agonistica, dove il risultato inizia ad avere un peso rilevante. Di questo risultato il
portiere deve essere sempre più un protagonista positivo al suo raggiungimento. Oltre agli obiettivi (tecnici, tattici, condizionali) a lungo termine che ci si è prefissi all’inizio della stagione per ciascun portiere che alleniamo, ne esiste uno con una collocazione temporale molto più immediata e ripetitiva: portare il nostro portiere nelle migliori condizioni possibili a disputare la gara
settimanale. Per fare questo è necessaria una pianificazione attenta e ben strutturata del microciclo, che tenga conto delle esigenze personali del portiere e di quelle del gruppo – squadra.
aarrttiiccoolloo
99
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
IIII LLLL NNNN UUUU MMMM EEEE RRRR OOOO 1111

www.allenatore.net
22
A seconda della categoria dove si opera varia ovviamente il numero degli allenamenti settimanali e di conseguenza i contenuti devono essere più o meno ridotti e sintetizzati.
L’analisi inizia dal microciclo completo con un allenamento doppio nella giornata di mercoledì, adottato solitamente dalle società professionistiche.
I microcicli composti da 5 e 4 sedute rappresentano un’ottima organizzazione per svolgere un lavoro sufficientemente completo.
L’analisi termina con i microcicli che sono maggiormente utilizzati nelle realtà giovanili e dilettantistiche. Sono solitamente composti da 3 o 2 allenamenti settimanali, il minimo numero di sedute con le quali si può sperare di raggiungere verosimilmente tutti gli obiettivi prefissati.
Ho volutamente tralasciato di illustrare la programmazione che prevede una sola seduta settimanale, anche se purtroppo molto spesso adottata da numerose società, in quanto la considero, nella maggior parte dei casi, una scelta di facciata che risulta quasi sempre poco allenante e insufficiente per sviluppare un fruttuoso programma di allenamento specifico.
Nell’esposizione dei programmi, la partita è stata convenzionalmente indicata sempre alla domenica. Nel caso la giornata di gara sia diversa, si deve riadattare la cronologia degli allenamenti. Ad esempio la categoria Primavera gioca il sabato, il giorno di riposo è solitamente la domenica e gli allenamenti sono distribuita dal lunedì al venerdì.
Si tenga comunque presente che nei primi giorni del microciclo si devono collocare le sedute più impegnative a livello di forza, mentre nella seconda parte si deve lavorare principalmente sulla velocità e sulla brillantezza dei gesti.
Per quanto riguarda le esercitazioni condizionali a secco per la parte alta o per gli arti inferiori, si faccia riferimento alle tabelle pubblicate nel numero 10 e 11 di questa rivista.
Una serie di esercitazioni tecniche con componenti condizionali sono state trattate nel numero 11.

www.allenatore.net
33
Microciclo per chi svolge 6 sedute di allenamento.
E’ il ciclo più completo e permette di allenare tutte le componenti tecniche, tattiche e condizionali con la possibilità di curare con la massima attenzione ogni minimo particolare. La forza viene toccata il martedì (con le esercitazioni specifiche) e il giovedì (con le uscite alte). Il mercoledì viene dedicato alla trasformazione del lavoro del giorno precedente con alcune componenti acrobatiche. Il venerdì alla velocità pura di intervento, mentre il sabato alla capacità di reazione. La completezza del programma viene data anche dal tempo a disposizione per le esercitazioni situazioni da svolgere con la squadra. E’ il programma settimanale solitamente utilizzato dalle prime squadre professionistiche.
Lunedì q Riposo.
Martedì q Corsa lenta x smaltire la gara e rimettersi in moto 10-15 minuti oppure tecnica
podalica in forma dinamica a ritmo blando. q Mobilità arti inferiori statica e dinamica. q Esercizi di coordinazione e preparazione alla forza anche con l’ausilio della tavoletta
propriocettiva. q Forza per la parte bassa. Carico e esercitazioni a seconda che si utilizzino
esercitazioni a secco o con componente tecnica. q Lavoro con squadra. q Scarico colonna vertebrale e addominali.
Mercoledì mattina q Posture e addominali. q Forza per la parte alta. q Mobilità parte alta e rapidità delle braccia o esercitazioni di destrezza con la palla. q Skip vari e/o velocità con sprint. q Lavoro con squadra.
Mercoledì pomeriggio q Riscaldamento con esercitazioni di destrezza con le mani o per la tecnica di presa
alla figura o tecnica podalica. q Esercitazioni tecniche di adattamento a terra. q Lavoro sulla porta con parate combinate (max 3-4) eseguite alla massima rapidità
con tempo recupero totale. Obiettivo la posizione e la copertura della porta, il gesto tecnico (presa o deviazione). A seconda del periodo o delle necessità dei portieri.
q Situazioni e tiri in porta con la squadra. q Partita con la squadra. q Tecnica sui rilanci con piedi e mani.

www.allenatore.net
44
Giovedì q Riscaldamento con i piedi, esercizi di destrezza e tecnica fine. q Situazioni per controllo e rilancio con i piedi, sia con avversari passivi che attivi e
con obiettivi statici o dinamici. q Esercitazioni di tecnica di spostamento e coordinazione in approccio alle palle alte. q Cross da tutte le posizioni per uscite alte con o senza avversari con vari tipi di
traiettoria, corta, lunga, tesa, parabola, ecc… inserendo talvolta anche combinazioni che prevedono tiri verso la porta prima o dopo l’intervento in uscita.
q Un tempo della partita amichevole. q Addominali.
Venerdì q Riscaldamento tecnico in destrezza con 1 o più palloni sia con le mani che con i
piedi q Skip vari. q Rapidità con partenze a comando visivo, sonoro, tattile che possono essere seguiti
da un gesto tecnico. q Esercitazioni in porta con 1-2 parate max dopo spostamento rapidissimo o partenza
variata. q Situazione di gara con cross bassi dal fondo, situazioni 1>1, uscita bassa a seconda
del periodo o delle esigenza del portiere. q Lavoro con squadra in situazioni gara: cross, tiri in porta, e partitella. q Cross da tutte le posizioni con contrasto attivo, per fare gol da parte di tutti gli altri
portieri, anche del settore giovanile, presenti all’allenamento.
Sabato q Riscaldamento con esercizi di presa alla figura con varie traiettorie. q Stretching e mobilità statica. q Psicocinetica con palloni colorati, numeri, coni o cinesini colorati. Ricerca dello
stimolo di tutte le componenti della velocità e di tutte le capacità sensoriali. q Reattività con esercitazioni eseguite con palloni deviati da avversari, coni, palle da
rugby. Palloni calciati da breve distanza ecc. q Situazioni tattiche con squadra in vista della partita del giorno dopo. q Situazioni di palla inattiva con squadra.
Domenica q Partita di campionato.

www.allenatore.net
55
Microciclo per chi svolge 5 sedute di allenamento.
E’ un ciclo completo e permette di allenare in modo abbastanza completo tutte le componenti della prestazione del portiere. Anche in questo caso la forza viene toccata il martedì (con le esercitazioni specifiche) e il giovedì (con le uscite alte). Il mercoledì viene dedicato alla trasformazione del lavoro del giorno precedente con alcune componenti acrobatiche. Il venerdì alla velocità pura di intervento, mentre il sabato alla capacità di reazione. La completezza del programma viene data anche dal tempo a disposizione per le esercitazioni situazioni da svolgere con la squadra. E’ il programma settimanale solitamente utilizzato dalle categorie più alte dei settori giovanile professionistiche o dalle società che partecipano al campionato di serie D.
Lunedì q Riposo.
Martedì q Tecnica podalica in forma dinamica a ritmo blando come forma di riscaldamento. q Mobilità arti inferiori statica e dinamica. q Esercizi di coordinazione e preparazione alla forza anche in forma propriocettiva
con l’utilizzo delle apposite tavolette. q Forza per la parte bassa. Carico e esercitazioni a seconda che si utilizzino
esercitazioni a secco o con componente tecnica. q Lavoro con squadra o trasformazione del lavoro precedente con esercitazioni
tecniche sulla porta con componenti di agilità, acrobatica. q Scarico colonna vertebrale e addominali.
Mercoledì q Forza a circuito per la parte alta. q Riscaldamento con esercitazioni di destrezza con le mani o per la tecnica di presa
alla figura anche sotto forma di trasformazione del lavoro precedente. q Esercitazioni tecniche di adattamento a terra. q Esercitazioni per le uscite basse anche susseguenti a skip o partenze rapide. q Lavoro sulla porta con parate combinate (max 3-4) eseguite alla massima rapidità
con tempo di recupero totale. Obiettivo la posizione e la copertura della porta, il gesto tecnico (presa o deviazione). A seconda del periodo o delle necessità dei portieri.
q Situazioni e tiri in porta con la squadra. q Partita con la squadra. q Tecnica sui rilanci con piedi e mani.

www.allenatore.net
66
Giovedì q Riscaldamento con i piedi, esercizi di destrezza e tecnica fine. q Situazioni per controllo e rilancio con i piedi, sia con avversari passivi che attivi. q Esercitazioni di tecnica di spostamento e coordinazione in approccio alle palle alte. q Cross da tutte le posizioni per uscite alte con o senza avversari con vari tipi di
traiettoria, corta, lunga, tesa, parabola, ecc… q Un tempo della partita amichevole. q Addominali.
Venerdì q Riscaldamento tecnico in destrezza con 1 o più palloni sia con mani che con piedi. q Skip vari con o senza gesto tecnico successivo. q Rapidità con partenze a comando visivo, sonoro, tattile con successivo gesto
tecnico. q Esercitazioni in porta con 1-2 parate max dopo spostamento rapidissimo o partenza
variata. q Situazione di gara con cross bassi dal fondo, situazioni 1>1, uscita bassa a seconda
del periodo o delle esigenza del portiere. q Lavoro con squadra in situazioni gara: cross, tiri in porta, e partitella. q Cross da tutte le posizioni con contrasto attivo, per fare gol da parte di tutti gli altri
portieri, anche del settore giovanile, presenti all’allenamento.
Sabato q Riscaldamento con esercizi di presa alla figura con varie traiettorie. q Stretching e mobilità statica. q Psicocinetica con palloni colorati, numeri, coni o cinesini colorati. Ricerca dello
stimolo di tutte le componenti della velocità e di tutte le capacità sensoriali. q Reattività con esercitazioni eseguite con palloni deviati da avversari, coni, palle da
rugby. Palloni calciati da breve distanza ecc. q Situazioni tattiche con squadra in vista della partita del giorno dopo. q Situazioni di palla inattiva con squadra.
Domenica q Partita di campionato.

www.allenatore.net
77
Microciclo per chi svolge 4 sedute di allenamento.
E’ un ciclo settimanale abbastanza completo che viene utilizzato solitamente dalle squadre giovanili dei settori professionistici o dalle prime squadre dilettantistiche di alto livello (serie D o Eccellenza). Rispetto al precedente, gli argomenti vengono maggiormente concentrati. La forza viene allenata anche in questo caso il martedì e il giovedì. Il mercoledì è previsto il grosso del lavoro tecnico e sulla porta mentre il venerdì viene fatto un misto tra la velocità di intervento e la capacità di reazione.
Lunedì q Riposo.
Martedì q Riscaldamento tecnico con i piedi sia in forma statica che dinamica. q Mobilità arti inferiori statica e dinamica. q Esercizi di coordinazione e preparazione alla forza. q Forza per la parte bassa. Carico e esercitazioni a seconda che si utilizzino
esercitazioni a secco o con componente tecnica. q Lavoro con squadra. q Addominali e scarico colonna vertebrale. Mercoledì q Forza per la parte alta. q Mobilità parte alta e rapidità delle braccia. q Skip vari e/o velocità con sprint. q Tecnica di presa alla figura o destrezza con 1 o più palloni. q Esercitazioni sulla porta con parate combinate (max 3-4) eseguite alla massima
rapidità con tempo di recupero totale. Obiettivo la posizione, la copertura della porta, il gesto tecnico (presa o deviazione). A seconda del periodo o delle necessità dei portieri.
q Situazioni e tiri in porta con la squadra. q Partita con la squadra. q Tecnica sui rilanci con piedi e mani. Giovedì q Riscaldamento con i piedi, esercizi di destrezza e tecnica fine. q Situazioni per controllo e rilancio con i piedi, sia con avversari passivi che attivi. q Esercitazioni di tecnica di spostamento e coordinazione in approccio alle palle alte. q Cross da tutte le posizioni per uscite alte con o senza avversari con vari tipi di
traiettoria, corta, lunga, tesa, parabola, ecc. q Lavoro con squadra o un tempo di una partita amichevole.

www.allenatore.net
88
Venerdì q Riscaldamento tecnico in destrezza con 1 o più palloni sia con mani che con piedi. q Skip vari. q Esercitazioni in porta con 1-2 parate max dopo spostamento rapidissimo o partenza
variata o componente reattiva o psicocinetica. q Situazione di gara con cross bassi dal fondo, situazioni 1>1, uscita bassa a seconda
del periodo o delle esigenza del portiere. q Lavoro con squadra in situazioni gara: cross, tiri in porta, e partitella. Sabato q Riposo.
Domenica q Partita di campionato. Nel caso il giorno di riposo non sia il sabato ma un altro giorno della settimana il programma slitta ma mantiene i contenuti inalterati.

www.allenatore.net
99
Microciclo per chi svolge 3 sedute di allenamento.
E’ un ciclo settimanale che viene utilizzato solitamente dalle squadre dilettantistiche di livello medio o medio alto. Questa settimana tipo prevede nella seduta del martedì un lavoro di forza, il giovedì viene eseguito un mix tra forza e velocità mentre il venerdì vengono trattate la velocità pura e la capacità di reazione. Per completare la programmazione settimanale potrebbe essere necessario integrare al termine di alcune sedute, se il tempo e la situazione meteorologica lo permettono, alcune esercitazioni che probabilmente non potrebbero trovare spazio nella normale seduta.
Lunedì q Riposo.
Martedì q Riscaldamento tecnico con i piedi. q Mobilità arti inferiori sia statica che dinamica. q Esercizi di coordinazione e preparazione alla forza. q Forza per la parte bassa. Carico e esercitazioni a seconda che si utilizzino
esercitazioni a secco o con componente tecnica. q Lavoro con squadra. q Addominali e scarico colonna vertebrale.
Mercoledì q Riposo.
Giovedì q Tecnica sui rilanci con piedi e mani. q Skip vari e/o velocità con sprint. q Lavoro sulla porta con parate combinate (max 3-4) eseguite alla massima rapidità
con tempo di recupero totale. Obiettivo la copertura della porta, il gesto tecnico (presa o deviazione). A seconda del periodo o delle necessità dei portieri.
q Situazione e tiri in porta con la squadra. q Partita con la squadra. q Cross da tutte le posizioni per uscite senza avversari con vari tipi di traiettoria,
corta, lunga, tesa, parabola, ecc…
Venerdì q Riscaldamento tecnico in destrezza con 1 o più palloni sia con mani che con piedi. q Skip vari. q Esercitazioni in porta con 1-2 parate max dopo spostamento rapidissimo o partenza
variata o componente reattiva o psicocinetica. q Situazione di gara con cross bassi dal fondo, situazioni 1>1, uscita bassa a seconda
del periodo o delle esigenza del portiere. q Lavoro con squadra in situazioni gara: cross, tiri in porta, e partitella.
Sabato q Riposo.
Domenica q Partita di campionato.

www.allenatore.net
1010
Microciclo per chi svolge 2 sedute di allenamento.
E’ il ciclo settimanale minimo utilizzato da parecchie squadre di livello dilettantistico. Siamo proprio al limite di sedute per poter svolgere una preparazione redditizia. Nel primo allenamento viene sviluppata una seduta con una spiccata componente di forza mentre il venerdì viene eseguito un piccolo richiamo tramite le uscite alte ma sviluppando particolarmente la velocità. Per completare al meglio il programma ritengo sia necessario fermarsi al termine dell’allenamento con la squadra eseguendo alcune esercitazione per integrare quello che nella prima parte della seduta non si trova il tempo di fare.
Lunedì q Riposo.
Martedì q Riscaldamento tecnico con i piedi sia in forma statica che dinamica. q Mobilità arti inferiori statica e dinamica. q Esercizi di coordinazione e preparazione alla forza. q Forza per la parte bassa. Carico e esercitazioni a seconda che si utilizzino
esercitazioni a secco o con componente tecnica. q Lavoro con squadra. q Addominali e scarico colonna vertebrale.
Mercoledì q Riposo.
Giovedì q Tecnica sui rilanci con piedi e mani. q Skip vari e/o velocità con sprint con o senza gesto tecnico successivo. q Lavoro sulla porta con parate combinate (max 3-4) eseguite alla massima rapidità
con tempo di recupero totale. Obiettivo la copertura della porta, il gesto tecnico (presa o deviazione). A seconda del periodo o delle necessità dei portieri.
q Situazione e tiri in porta con la squadra. q Partita con la squadra. q Esercitazioni per le palle alte, uscite basse in attacco al pallone, situazioni 1>1.
Venerdì q Riposo.
Sabato q Riposo.
Domenica q Partita di campionato.♦

Nello Marano racconta, da un punto di vista tecnico-tattico, la stagione 2003-2004 alla guida del Tavagnacco Udine. A cura di ROBERTO BONACINI
Scopriamo in questa intervista la professionalità e la competenza calcistica del Mister friulano, uno tra i tecnici più preparati presente la scorsa stagione nel massimo campionato nazionale femminile.
MMister, il suo curriculum da allenatore? Prima di passare al calcio femminile ho lavorato molto nelle scuole calcio e nei settori giovanili; successivamente ho allenato entrambi (scuola calcio e femminile), per poi dedicarmi negli ultimi anni al calcio femminile. Ecco comunque il dettaglio:
q 1991/1992 Comunale Lestizza cat. Pulcini;
q 1992/1993 Comunale Lestizza cat. Esordienti;
q 1993/1994 Buttrio cat. Pulcini;
q 1994/1995 Buttrio cat. Esordienti;
q 1995/1996 Comunale Lestizza cat. Pulcini;
q 1996/1997 Tavagnacco cat. Pulcini e serie C femminile;
q 1997/1998 Tavagnacco cat. serie C femminile;
q 1998/1999 Tavagnacco serie B femminile;
q 1999/2000 Tavagnacco serie B femminile;
q 2000/2001 Tavagnacco serie B femminile;
q 2001/2002 Tavagnacco serie A femminile;
q 2002/2003 Tavagnacco serie A femminile (richiamato ultime 3 giornate);
aarrttiiccoolloo
1100
N . 1 3 O T T O B R E 2 0 0 4
RIVISTA ELETTRONICA DELLA CASA EDITRICE WWW.ALLENATORE.NET
REG. TRIBUNALE DI LUCCA N° 785 DEL 15/07/03 DIRETTORE RESPONSABILE: FERRARI FABRIZIO COORDINATORE TECNICO: BONACINI ROBERTO
SEDE VIA E.FRANCALANCI 418 – 55050 BOZZANO (LU) TEL. 0584 976585 - FAX 0584 977273
CCCC AAAA LLLL CCCC IIII OOOO FFFF EEEE MMMM MMMM IIII NNNN IIII LLLL EEEE

www.allenatore.net
22
q 2003/2004 Tavagnacco serie A femminile (esonerato termine girone andata e poi richiamato ultime 4 giornate).
Dal 1996 al 2000 responsabile provinciale FIGC – Comitato di Udine prima come delegato per l’attività scolastica e poi per l’attività di base.
L’allenatore e il collettivo.
Quali qualità deve avere un buon allenatore? Deve essere serio, preparato e paziente e deve sempre fare della professionalità il suo punto di forza.
Che tipo di rapporto cerca di instaurare con la squadra? Il rapporto con la squadra deve essere improntato alla massima chiarezza, alla collaborazione, all’equilibrio ed al rispetto reciproco. Inoltre tutti devono essere a conoscenza del programma, degli obiettivi e del ruolo che ciascuno, per le sue competenze, capacità e caratteristiche, riveste all’interno della struttura.
Un buon gruppo, un buon collettivo cosa deve e non deve avere? Un buon gruppo, pur facendo tesoro delle individualità e delle personalità definite, deve tendere ad essere “una cosa sola”. Perché il gruppo funzioni non si deve dar luogo a frammentazioni in tante cellule che spesso, se non controllate, possono minarne la serenità. In ogni caso sta nella bravura dell’allenatore e del suo staff far sì che ciò non avvenga e questo rappresenta sicuramente uno degli aspetti più difficili del lavoro di allenatore.
La preparazione e il periodo agonistico.
Quanto è durata la preparazione pre-campionato e quali gli obiettivi ricercati in questa preparazione iniziale (ottenere risultati a breve termine con previsione di un secondo periodo preparatorio, oppure risultati a medio lungo termine)? La preparazione è durata quattro settimane: dal 16 Agosto a metà Settembre. All’inizio, nel corso della prima settimana, oltre al lavoro di verifica con vari test di valutazione delle condizioni fisiche (Leger, Capanna, velocità lineare e a navetta sui 20mt., rilevazione del peso e plicometria con indicazione della massa magra e della massa grassa, test di forza con macchine isocinetiche) si è puntato sullo sviluppo progressivo dello stato di forma con un lavoro di tipo generale. Nella seconda settimana (ritiro a Paluzza località in provincia di Udine a 600 metri di altitudine) e nella terza settimana si è puntato allo sviluppo ulteriore dello stato di forma con un lavoro più specifico, prima con mantenimento della quantità ed aumento dell’intensità, e successivamente con diminuzione della quantità ed aumento dell’intensità. Poi si è arrivati, a ridosso dell’inizio del campionato, alla fase di stabilizzazione di quantità ed intensità, avvicinandoci in pratica a quella che poi sarebbe diventata la settimana tipo.
La periodizzazione dell’intera annata è stata comunque cosi scandita:

www.allenatore.net
33
q Periodo preparatorio o precampionato dal 16 Agosto a metà Settembre (prima del quale le giocatrici, dopo un periodo di completo riposo post-campionato, hanno svolto un programma individuale pre-ritiro strutturato su venti sedute);
q primo periodo competitivo da Settembre alla sosta natalizia;
q primo periodo transitorio (richiamo e recupero) dalla sosta alla ripresa del campionato;
q secondo periodo competitivo dal 6 Gennaio a fine Marzo;
q secondo periodo transitorio dovuto ad una sosta lunga per gli impegni ufficiali delle squadre nazionali;
q periodo di riposo nella pausa estiva.
Quanti allenamenti alla settimana e in che orari sono svolti? Tre o quattro sedute, dalle ore 19.15 alle ore 21.15.
Mi descriva un attimo la settimana tipo di lavoro dal punto di vista della preparazione fisica? La nostra settimana tipo è strutturata su quattro sedute settimanali di cui tre in campo, della durata di due ore circa, ed una facoltativa in palestra agli ordini del preparatore atletico Prof. Sergio Tomadini (collaboratore esterno); queste sedute sono condotte dal sottoscritto (mi occupo anche della preparazione fisica essendo insegnante di Educazione Fisica) in collaborazione con il vice allenatore Ruggero Di Giusto.
q Prima seduta (Lunedì) nel corso della quale metà del tempo viene dedicato alla parte atletica con interessamento ciclico settimanale delle componenti centrali e periferiche della resistenza (potenza aerobica) e con esercitazioni di forza di tipo esplosiva - elastica ed elastica – reattiva;
q seconda seduta (Martedì) prevalentemente basata sull'incremento delle qualità lattacide (resistenza alla velocità e potenza lattacida);
q terza seduta in palestra (facoltativa di Mercoledì) basata prevalentemente su lavori individualizzati di ripristino fisiologico e/o recupero infortuni, lavori di recupero della forza resistente o specifica oppure su un programma di ginnastica propriocettiva come prevenzione infortunistica personalizzata. In alternativa (e soprattutto nel periodo iniziale e finale del campionato) questa giornata viene sfruttata per svolgere una partita amichevole;
q quarta seduta (Giovedì) nel corso della quale vengono proposte sempre delle esercitazioni di reattività neuro-muscolare, rapidità, velocità e agilità;
q sabato partita di campionato.
Durante uno degli allenamenti settimanali viene spesso inserita la partita amichevole? Quali sono secondo lei le squadre da ricercare per trarre benefici da queste gare (giovanili, dilettanti, amatori)? Quella degli amatori è una categoria che si presta molto per le nostre esigenze e quindi sovente incontriamo squadre di questo tipo. Delle categorie giovanili diciamo che si possono incontrare squadre di allievi purché le partite vengano giocate privilegiando gli aspetti tecnici e tattici e non solo quelli fisici che, soprattutto contro questi avversari, ci

www.allenatore.net
44
vedrebbero in difficoltà dal punto di vista della forza e della velocità. In ogni caso sono molto utili perché abituano a ritmi molto vicini a quelli delle partite di campionato.
Considerazioni tecnico-tattiche.
Nell’organizzare il gioco a zona preferisce partire dall’analitico (esempio 1>1, 2>1, 2>2 ecc.) por poi gradatamente arrivare all’organizzazione di tutta la squadra o viceversa partire con il movimento di tutta la squadra e conseguentemente analizzare i problemi di tecnica e tattica individuale e tattica collettiva di reparto? Io parto di solito da situazioni analitiche per poi arrivare a quelle globali. Ritengo fondamentale l’acquisizione dei principi dell’ 1>1 in fase di possesso e non possesso e pongo molta attenzione in fase difensiva al posizionamento (soprattutto dei piedi e del corpo) rispetto all’asse palla-porta ed in fase offensiva al controllo della palla in corsa, alle finte ed al cambio di velocità. Utilizzo molto le combinazioni 2>1 e 2>2 finalizzandole: all’aiuto reciproco; alla presa di posizione rispetto alla palla, alla porta e agli avversari; allo smarcamento; alla conquista dello spazio in avanti e alla conclusione a rete. Le esercitazioni per reparto e quelle collettive vengono svolte prima senza la presenza di avversari e poi con l’inserimento progressivo di avversari attivi. Rispetto al passato, in cui avevo la tendenza a codificare solo la fase difensiva, ho provato (con buoni esiti) a strutturare in maniera organizzata anche la fase offensiva partendo o dalla rimessa con le mani o con i piedi del nostro portiere, o dalla conquista palla dei nostri difensori o dalla conquista palla di nostri centrocampisti per poi creare delle combinazioni che, con pochi passaggi, permettano di arrivare rapidamente vicino alla porta avversaria e quindi ad una possibile conclusione a rete. Il giocatore che è in campo deve essere messo in condizione di saper sempre cosa fare, non solo quando la palla è gestita dagli avversari, ma anche quando la palla è in proprio possesso. Chiaramente lascio sempre la possibilità alle giocatrici di essere creative e fantasiose in zona d’attacco di modo che, in base alla lettura delle situazioni di gioco, possano cercare soluzioni alternative personali ed efficaci (e sovente accade che sono proprio queste che fanno vincere la partita).
Quale modulo adottate solitamente? Il modulo è quello a zona mentre la dislocazione sul terreno di gioco è quella che prevede il classico 4-4-2 (figura 1 ). Ritengo questo sistema di gioco didatticamente più semplice da insegnare e più facilmente assimilabile anche in campo femminile.
Quali secondo lei i vantaggi e gli eventuali svantaggi di questo modulo? q Vantaggi - La squadra riesce a coprire in maniera compatta ed equilibrata tutti i
settori del campo sia in senso verticale che orizzontale. Inoltre si creano delle catene di giocatori (esterno difensivo con esterno di centrocampo, difensore centrale con centrocampista centrale ecc.) (figura 2 ) che favoriscono in maniera quasi del tutto naturale l’intercambiabilità dei ruoli e l’aiuto reciproco.
q Svantaggi - Risiedono nel fatto che se si è poco dinamici e non si fa del movimento senza palla e della velocità il punto di forza si diventa prevedibili e si finisce per fare il gioco degli avversari.

www.allenatore.net
55
11
8
7
65
4
3 2
10
9
1Fig. 1Fig. 1
11
8
7
65
43
2
10
9
1Fig. 2Fig. 2
Utilizzate solo questo o a seconda degli avversari o dell’organico a disposizione utilizzate altri moduli? Ci può fare qualche esempio? Utilizziamo anche alcune varianti. L’anno scorso ad esempio sono stato richiamato alla guida della squadra nelle ultime tre partite. C’era ovviamente la necessità di salvarsi e quindi ho dovuto approntare una squadra più offensiva. La scelta, tenuto conto delle caratteristiche delle giocatrici a disposizione e della posizione in classifica, è caduta sul 3-4-2-1 (figura 3) con il quale abbiamo ottenuto degli ottimi riscontri in quanto siamo riusciti a trovare un assetto equilibrato e le giuste sincronie nelle due fasi di gioco. Un’altra variante che abbiamo inoltre utilizzato spesso quest’anno è stato il 3-4-1-2 con un trequartista molto tecnico che giocava alle spalle di due attaccanti (figura 4) molto mobili ed abili a creare varchi per i suoi inserimenti (figura 5) e bravi a liberarsi in
11
87
65
43
2
10
9
1Fig. 3Fig. 3

www.allenatore.net
66
in area per ricevere i suoi passaggi filtranti e andare alla conclusione (figura 6 e 7).
11
87
65
4
3
2
10
9
1Fig. 4Fig. 4
11
87
65
43
2
10
9
1Fig. 5Fig. 5
A
C
BCC
11
10
9
Fig. 6Fig. 6
A B
A B
11
10
9
Fig. 7Fig. 7
AA
A
11
87
65
4
3
2
10
9
1Fig. 8Fig. 8
653
2
1Fig. 9Fig. 9
11
8
7
4
3
10
9
1Fig.10Fig.10
C
C BA
C A
Ovviamente ho potuto giocare in questo modo perché disponevo di due esterni di centrocampo con polmoni inesauribili che mi garantivano, con un’azione a stantuffo (figura 8), sia il sostegno alla difesa (figura 9), sia l’appoggio ai centrocampisti centrali e agli attaccanti (figura 10).
Capita spesso o di rado di cambiare modulo durante la stessa gara? Certo! Può accadere spesso e questo dipende: da come sta andando la partita (se stai vincendo cerchi di rinfoltire il centrocampo nella convinzione che gli avversari è meglio fermarli il più lontano possibile dalla tua porta; se perdi è ovvio che tenti di rimediare dando più peso all’attacco) oppure da come sono sistemati i tuoi avversari in campo.

www.allenatore.net
77
Faccio un esempio: se incontro una squadra disposta con un 3-5-2 e mi accorgo che pago l’inferiorità numerica nella zona nevralgica del campo posso provare a contrapporre un 3-4-1-2 che mi permetta in fase di non possesso di ristabilire la parità numerica col trequartista che scala opportunamente (figura 11 e 12) e, al contempo, mi da la possibilità, avviando celermente la fase di transizione positiva, di creare situazioni offensive di 3>3 sicuramente più vantaggiose per noi e più rischiose per gli avversari (figura 13).
11
8 7
65
43
2
10
9
1Fig.11Fig.11
87
4
3 10
1
5>5 A CENTROCAMPO
Fig.12Fig.12
11 10 9
3>3 IN ATTACCO
Fig.13Fig.13
La scelta del modulo per lei deve essere una scelta dettata dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione oppure lei è “innamorato” di un tipo di gioco al quale adatta le giocatrici di cui dispone? Un allenatore deve rispettare sempre le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione ma ha anche il dovere di insegnare a vedere le cose da punti di vista diversi e a prospettare soluzioni diverse sempre nell’ottica di una collaborazione reciproca e senza forzature estreme. Nel gioco del calcio, dove le situazioni e i riferimenti senso-percettivi variano costantemente, i processi di assimilazione accomodamento e adattamento sono continui e interdipendenti e proprio per questo inscindibili.

www.allenatore.net
88
La fase difensiva.
Generalmente con quanti giocatori difendete e come è organizzata la squadra in questa fase? Sono convinto che tutti i giocatori in campo devono essere in grado di attaccare e di difendere. L’attaccante che perde palla diventa il primo difensore così come il difensore che conquista il pallone diventa il primo attaccante e non deve buttare via palla. È chiaro che, nel momento in cui gli avversari ripartono, più giocatori si hanno sotto la linea della palla e più possibilità si ha di recuperarne il possesso (linea della palla figura 14). Quindi si cerca di fare in modo di avviare velocemente la fase di transizione negativa mandando un giocatore (quello più vicino al portatore di palla avversario) a disturbarne l’azione e dare così modo agli altri di risistemarsi (figura 15 e successive rappresentazioni grafiche considerando il modulo 4-4-2). In ogni caso (e questo lo proviamo spesso negli allenamenti della fase offensiva) quando attacchiamo ci disponiamo preventivamente in modo da essere sempre pronti al peggio.
11
8 7
65
4
3
2
10
9
1Fig.14Fig.14
A
11
87
65
4
3 2
10
9
1Fig.15Fig.15
BA
BA
A
La fase offensiva.
Generalmente con quanti giocatori attaccate e come è organizzata la squadra in questa fase? Vale lo stesso discorso precedente; non si può attaccare solo con le due punte e la mezza punta perché le difficoltà agli avversari riesci a crearle col movimento sincrono di più giocatori. Di solito i miei due esterni ed uno dei centrocampisti centrali si uniscono agli attaccanti (figura 16) e le combinazioni offensive che proviamo in allenamento molto

www.allenatore.net
99
spesso li vedono direttamente coinvolti non solo in funzione di appoggio o sostegno ma anche per la conclusione a rete personale (figura 17 e 18).
11
8
7
65
4
3 2
10
9
1Fig.16Fig.16
11
8
7
65
4
3 2
10
9
1Fig.17Fig.17
CB
A
AC
C
D
11
8
7
65
4
32
10
9
1Fig.18Fig.18
A
C
B
CC
C
D
Meglio verticalizzare il gioco, allargare sulle fasce o un buon mix di entrambi? Se si creano i presupposti per una verticalizzazione immediata (ad esempio squadra avversaria sbilanciata, ampi spazi che possono essere attaccati da una punta veloce, possibilità di creare superiorità numerica ecc…) autorizzo le giocatrici a farlo immediatamente (figura 19). Se invece la squadra avversaria si è già organizzata per la fase difensiva ritengo sia inutile buttare la palla avanti nella speranza che accada qualcosa e pertanto cerco di privilegiare una soluzione più manovrata che preveda l’aggiramento per vie laterali allo scopo di creare sia varchi temporanei sfruttabili sia per mandare al cross gli esterni (figura 20). Nel corso dell’incontro sovente si presentano queste situazioni pertanto il mio compito è quello di mettere le giocatrici (attraverso allenamenti ed esercitazioni mirate e indicazioni precise) nelle condizioni di capire quando va bene una soluzione e quando invece è più funzionale optare per la seconda.
11
87
65
4
32
10
9
1
COSTRUZIONE IMMEDIATA
Fig.19Fig.19
A
C
B
C C
11
8
7
65
4
3 2
10 9
1
COSTRUZIONE MANOVRATA
Fig.20Fig.20
F
D
D
CBA
FE
Possesso palla, squadra corta, saltare il centrocampo. Quali le sue idee?
La mia idea è molto semplice. Se abbiamo noi il pallino del gioco riusciamo a far sì che gli avversari ci creino meno fastidi. Se concediamo troppo agli avversari è chiaro che aumentano per loro le occasioni per metterci in difficoltà.

www.allenatore.net
1010
Comunque non sempre il possesso dipende solo da te ma (e questo accade spesso nel calcio femminile dove il divario tra alcune squadre è notevole) può dipendere anche dal
11
87
65
4
3 2
10
9
1Fig.21Fig.21
A
11
8 7
65
4
3
2
10
9
1Fig.22Fig.22
11
8 7
65
43
2
10
9
1Fig.23Fig.23
A
11
8 7
6
5
43
2
10
9
1Fig.24Fig.24
B
B
B
valore delle forze in campo. In caso di gara equilibrata la squadra corta permette una più facile riconquista della palla attraverso azioni di pressing (figura 21 e 22) e di raddoppio (figura 23 e 24) , e quindi rende possibile l’aiuto reciproco che ritengo importantissimo nel gioco a zona; per un giocatore in campo sentire alle proprie spalle la presenza di un compagno è confortante e aiuta ad essere più tranquillo. Poi è chiaro che, se in alcuni momenti della gara ti accorgi che sei sovrastato a centrocampo o stai perdendo e manca poco alla fine, fai ricorso anche al lancio
lungo a scavalcare la zona centrale. Ma questo rientra nell’intelligenza calcistica o acume tattico di ciascun giocatore e quindi nella sua capacità di pervenire ad una scelta funzionale e di risoluzione di un problema in reazione al contesto di gioco creatosi.
Mi può descrivere 2 o 3 schemi che provate e adottate poi in partita riguardanti la fase offensiva? q Dopo un giro palla da parte dei centrocampisti 10-8-4-7, l’esterno destro 7 da inizio
all’azione. L’attaccante 9 finta la corsa in profondità e torna a ricevere il passaggio di 7; ricevuta palla 9 triangola al centro con 11 che venuto incontro gli restituisce palla. A questo punto l’azione viene rifinita da 9 con un passaggio sull’esterno 10

www.allenatore.net
1111
che si è inserito con i giusti tempi sul lato cieco. I giocatori 8-4-7 si dispongono a sostegno centralmente per bloccare l’eventuale transizione negativa (figura 25).
1
11
8
7
4
10
9
Fig.25Fig.25
G
D
D
C
BA
GF
F
E
H
q In alternativa 9 dopo aver effettuato il triangolo con 11, ritornato in possesso palla, gioca in profondità per il taglio a convergere dell’esterno di centrocampo 7 che si è inserito con una corsa di sovrapposizione in fascia (figura 26).
q L’esterno di centrocampo 3 gioca per il centrale 4 che di prima intenzione passa a 10 che viene incontro dopo un contromovimento d’inganno. Ricevuta palla 10 scarica di prima intenzione per 8 che sempre di prima lancia in fascia l’esterno 7 che si è sovrapposto. Cross in area di 7 con 11 che taglia sul primo palo, 9 che va sul secondo e con l’esterno 3 che, a sorpresa, si inserisce centralmente (figura 27) (3-4-1-2).
1
11
7
9
Fig.26Fig.26
C
CB
A
A
D
D
11
8
7
4
3
910
Fig.27Fig.27
E
1E
D
DC
B
BA
E
E
q Il trequartista 10 viene incontro a ricevere il passaggio di 8 dopo che i centrocampisti hanno fatto girare la palla. 10 finta di ricevere palla e fa velo per 11 che si è inserito alle sue spalle; 11 ricevuta palla di prima appoggia centralmente (chiude il triangolo) per 8 che si è inserito (sfruttando anche lo spazio

www.allenatore.net
1212
creato in zona centrale da 9 con un movimento verso l’esterno) e va alla conclusione. I giocatori 3, 4 e 7 si dispongono a sostegno per bloccare un eventuale transizione negativa (figura 28) (3-4-1-2).
q Dopo un giro palla tra i centrocampisti l’azione parte dall’esterno 7 che finta il
passaggio a 9, che dopo un contromovimento viene incontro, per poi passare palla sul movimento di 10; 10 fa velo per 11 il quale ricevuta palla la rigioca, chiudendo il triangolo, al centro per 10 che va alla conclusione. I giocatori 11 e 9 seguono l’azione in area di rigore per intervenire su un eventuale ribattuta del portiere; i centrocampisti accompagnano a sostegno l’azione con i due esterni più alti e i due centrali più bassi pronti a recuperare in caso di transizione negativa (figura 29) (3-4-1-2).
1
11
87
4
3
9
10
Fig.28Fig.28
D
C
BA
F
E
E
F
G
G
1
11
8
74
3
9
10
Fig.29Fig.29
D
CBA
F
F
E
D F
Le palle inattive.
Palle inattive. Quale importanza preparativa durante gli allenamenti? Palle inattive a favore - Per ciò che concerne le punizioni dal limite, avendo diversi giocatori che offrono soluzioni sia di forza che di precisione, preferisco la battuta diretta. Di solito metto quasi sempre un giocatore sulla palla spalle alla porta che si sposta solo nel momento che il compagno sta per tirare; questo allo scopo di nascondere la palla al portiere fino al momento della battuta (figura 30). Nel caso di punizioni decentrate optiamo per la palla in mezzo; in questo caso (come pure sui calci d’angolo) salgono due difensori abili colpitori di testa che si muovono in sincronia con gli attaccanti sfruttando i blocchi in area (spesso gli esiti sono positivi) (figura 31). Sempre sui calci d’angolo di solito prevedo un massimo di tre combinazioni contraddistinte da segnali appositi e da movimenti precisi per liberarsi. La prima prevede il lancio sul secondo palo (figura 32); la seconda palla prevede il

www.allenatore.net
1313
lancio a centro area (figura 33) e la terza prevede uno scambio corto del battitore con un attaccante staccatosi e venuto incontro. In questo caso le soluzioni sono due: o il tiro cross del battitore verso il secondo palo (figura 34) oppure l’entrata in area palla al piede dell’attaccante (questo nel caso in cui il difensore che lo ha seguito si sposta marcando il battitore) (figura 35).
1
Fig.30Fig.30
A
B
1
BLOCCO
Fig.31Fig.31
A
A
AB
1
BATTUTA SUL SECONDO PALO
Fig.32Fig.32
1
BATTUTA A CENTRO AREA
Fig.33Fig.33
1
Fig.34Fig.34
A
BB
A
C
1
Fig.35Fig.35
AA
C
B
Palle inattive a sfavore - sulle punizioni lascio al portiere il compito di scegliere quante persone mettere in barriera ed è sempre l’estremo difensore a decidere se farsi affiancare da un compagno sulla linea di porta. Sui calci d’angolo di solito l’attaccante bravo di testa viene chiamato a fare il vertice mentre un'altro viene messo sul primo palo. I difensori più abili nello stacco marcano a uomo i colpitori della squadra avversaria mentre un paio di giocatori vengono sistemati a zona.♦